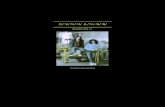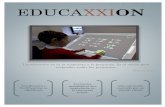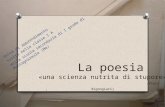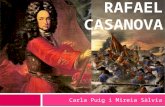Quaderni di storia locale - storiedijeri.altervista.org vol1.pdf · Forse perché la mia vita nata...
Transcript of Quaderni di storia locale - storiedijeri.altervista.org vol1.pdf · Forse perché la mia vita nata...
Quadernidi storia locale
volume I
2006
Comune di Bogliasco Comune di SoriComune di Pieve Ligure
Provincia di Genova
Assessorato alla Cultura
Come uno scrigno di preziose storie
Come uno scrigno di preziose storie si apre questo piccolo magrande volume…
Storie di luoghi, di persone, di cose, di monumenti. La vita di trecittadine e del territorio del Golfo Paradiso si ricompone in un armo-nico mosaico, che cerca le sue tessere nel passato e le fa rivivere nelpresente.
Perché noi siamo fatti di memorie e la nostra stessa vita ne è tra-sparente vetrina. Ma le memorie vanno nutrite da piccoli fuochi diricerca condotta con passione e voglia di trasmettere agli altri quellacosa grande che è il frutto dello studio e quell'altra cosa grande cheè l'esperienza e che diventa quello che si sa. Come i nonni che rac-contano storie. Come un anziano che regala un oggetto che gli è caroa un bambino. Come un giovane che racconta a un altro giovane leesperienze già fatte perché gli siano utili.
Questo è lo spirito con cui i nostri ricercatori hanno esplorato laloro terra. Con voglia di lasciare una traccia dietro di sé perché altripossano conoscere quanto sia stato denso ma anche doloroso il per-corso che ci ha condotti al presente. Un presente che ci mostra lebelle cittadine del Golfo Paradiso nella loro luminosa e solare sceno-grafia ma che non può dimenticare ombre e dolore di un passatoanche recente. Basti pensare ai bombardamenti sistematici sulla lineaferroviaria per distruggere i ponti nella seconda guerra mondiale.Storie che ci raccontavano i nonni che le avevano vissute.
Storie che si ritrovano nel primo dei testi del libro che ho davantia me in bozza di stampa. Mi soffermo un po' di più su questo perchémi pare una chiave di volta per quello che segue. Forse perché la miavita nata dopo la guerra si è nutrita di quelle storie che mi hanno datoguide per il futuro.
Così il primo e gli altri testi mi hanno colpito proprio perché mipareva di essere ancora nel magico momento di comunicazione connonni e zii anziani, che avevano percorso a piedi quelle stesse stradee quella ferrovia (che ora più banalmente portano me ed altri geno-vesi al lavoro o al mare o al gelato serale). E' quella stessa bellissimacosta che vedo ora e che era oggetto di racconto e di storie di guerrache io coloravo sempre di scuro. L'immagine di un ponte che non esi-steva più e della ferrovia interrotta e del cercare spesso le case a tasto-
ni. Ma poi ricompariva il sole. E questo dovrebbe ricordarci quantoinutilmente crudeli siano le guerre…
E, con il sole, ecco riapparire nel libro l'attività umana, volta nonalla distruzione ma al benessere, ed ecco le donazioni dei capitani ele rotte dei bastimenti pievesi a ricordarci quanto la marineria siastata significativa per quelle popolazioni.
Non solo per Pieve quindi. Segue di conseguenza una riflessionedi come, al di là degli ovvi campanilismi, una stessa storia e una stes-sa identità uniscano i bei paesi del Golfo Paradiso. Perché stesse radi-ci e stessi valori li uniscono. E stessi sacrifici dalla guerra all'emigra-zione.
Dalla fatica della terra a quella del viaggio per mare. Ed eccosostituirsi alle immagini di ponti distrutti quelle dei bei bastimentiche portavano spezie, tè, sale, tessuti e tappeti e ceramiche e merciche sapevano di oriente. E i pericoli corsi e le donazioni alla lorobella chiesa per "grazia ricevuta". E quei lunghi viaggi e tanta lonta-nanza ed il pensiero della luminosa ed amata terra lasciata alle spal-le. E una pregevole scultura e un contratto ci fanno tornare ancoraindietro ed ecco apparire l'immagine di una Madonna del Rosario diquelle che ornano le nostre chiese della Riviera. Simboli di una fedeche si racconta con uno sguardo al passato (la statua ricalca tipologiesettecentesche) e che ci ha lasciato preziose tracce nel futuro. E poiecco la lapide dedicata allo sfortunato ed eroico Nazario Sauro e lasua storia che ci riporta ancora a uno scenario di guerra e a messag-gi ufficiali di occasione… che sono da sempre scritti "nella linguache non c'è".
Ma poi ecco ancora il lavoro e la storia dell'ultimo frantoio diSessarego e microstorie che ridanno i nomi in lingua genovese aglioggetti e ci ricordano quanto l'olio sia stato pianta sacra della nostraterra, anch'essa scheggia di Mediterraneo, e di come queste cittadinecome altre della nostra costa abbiano creato una civiltà che sapeva dimare e di terra. Di viaggi lontani e di cura dell'orto e della fascia vici-na. E poi ecco i Canterini di Sessarego e l'importanza della cultura edell'approccio alla musica e della coralità del vivere la cultura musi-cale… Ma mi fermo qui. Che i titoli finali mantengano il loro miste-ro!
Devo però concludere ringraziando tutti quelli che, a diverso tito-lo, hanno fatto sì che questo volume potesse vedere la luce. Li ringra-
zio perché hanno saputo raccontare non solo la storia di Bogliasco,Pieve e Sori ma la nostra storia. La storia di tutti quelli che continua-no a lasciarsi trascinare dall'entusiasmo della ricerca e che credonoche la cultura sia alla base della nostra vita.
Maria Cristina CastellaniAssessore alla CulturaProvincia di Genova
Credo che ogni stagione del tempo abbia pagine da raccontare,perché ognuno di noi interiorizzi la consapevolezza dell'evolversi deltempo stesso e della realtà che sta vivendo, sempre diversa da quellavissuta dai propri cari anche in un passato recente come quello deglianni '30 e '40.
E, a mio avviso, il grandissimo merito degli amici del CentroStudi "Storie di Jeri" è proprio quello di aver portato alla conoscenzadel lettore di come la storia di ogni tempo sia fatta sempre dagliuomini, dalle loro abitudini del momento, dal loro sapersi aggregarein forme sempre diverse e comunque considerate ideali nella lorosemplicità dagli attori dell'epoca, quasi a farci comprendere e ricor-dare come lo status considerato ottimale dei nostri giorni sia destina-to irreversibilmente ad evolversi in altre future forme inimmaginabi-li dalle nostre menti.
Quindi grazie davvero, per aver riportato alla luce racconti,momenti e emozioni da noi, e da me in particolare, vissute esclusiva-mente attraverso gli occhi dei nostri nonni e per averci appassionatoin questo viaggio alla scoperta di ricordi e tradizioni appartenenti adun passato solo recente.
Luca PastorinoSindaco di Bogliasco
La lettura del primo volume di "quaderni di storia locale" mi haportato a ricordare due precedenti opere che hanno raccolto la storiadel nostro paese. Mi riferisco a "Pieve su Pieve giù" pubblicato nel1999 ed "Antologia pievese" del 2003. Questo volume costituiscel'applicazione, in ambito più ampio, di un approccio metodologicogià collaudato e senz'altro adeguato alle nostre realtà. Appare eviden-te che le storie di Bogliasco, Pieve e Sori spesso si intrecciano e sicu-ramente sono accomunate da radici culturali, sociali ed economichedel tutto comparabili. Il Centro Studi Storie di Jeri ha saputo creareun accattivante raccolta, che unisce episodi e documenti significatividi momenti storici e di usi e costumi rilevati nella vita delle nostrecomunità.
La sapiente ricerca documentale è integrata dall'ottimo repertoriofotografico che aiuta il lettore a ripercorrere la storia dei luoghi edelle tradizioni in maniera semplice ed immediata. Leggendo i primicapitoli, mi sono ritrovato bambino ad ascoltare i racconti dei mieigenitori e dei miei nonni: ricordo che la guerra mi sembrava assurdaed irreale, come era stato possibile tanto orrore? E poi, il nonno cheda ragazzino aveva cominciato a navigare per mari lontani. Viaggiche lo portarono distante da casa per mesi e mesi. E' piacevole capi-re che, grazie a questa opera, riaffiorano nella mia memoria episodiremoti. Proseguendo la lettura, cresce in me la convinzione di quan-to sia preziosa, per le nostre comunità, l'appassionata ricerca condot-ta dagli autori. L'amore per la storia, infatti, ci consente di raccoglie-re testimonianze che, col passare del tempo, diventano sempre piùdifficili da trovare e da far emergere. La polvere si accumula nei vec-chi archivi delle parrocchie e nelle soffitte delle case, il trascorreredegli anni riduce inesorabilmente la profondità del "raccontato".
Un caloroso ringraziamento agli autori che, con la loro passione econ l'ottimo lavoro, mantengono viva la conoscenza delle tradizioni,dei personaggi e del patrimonio storico-culturale del nostro territorio,preservando così preziose testimonianze per noi, per i nostri figli eper le generazioni che verranno.
Mi piace paragonare la nostra storia ad un tesoro che noi tuttiabbiamo il dovere di custodire e condividere con chi desidera apprez-zarne il valore.
Grazie Adolfo Olcese
Sindaco Vicario di Pieve Ligure
Indice
- 1 -
Oscure pagine di storia di paese
Alessandro Siena.....................................................................44
I canterini di Sessarego
Luca Sessarego........................................................................39
Agostino Vignolo e La Madonna del Rosario della parrocchiale
di San Michele arcangelo di Pieve Ligure.
Silvia Frattini...........................................................................19
Una lapide di ottanta anni fa a Bogliasco
Pierluigi Gardella...................................................................25
Le donazioni dei capitani e le rotte dei bastimenti pievesi nei 'libri
mastri' della parrocchia di San Michele di Pieve di Sori
Marina De Franceschini........................................................12
L’ultimo frantoio di Sessarego
Valentina Penco.......................................................................31
Bogliasco nella II Guerra Mondiale: la distruzione del ponte fer-
roviario
Giorgio Casanova....................................................................5
Introduzione
...................................................................................................3
Progetto di ampliamento della chiesa di S. Bernardo
Pierino Bonifazio e Nora Marchese.......................................53
‘a carapin-na
Francesco Antola e Luigi Re..................................................58
Prescinseua
Francesco Antola ....................................................................67
Immagini di Jeri (Pieve Ligure)
a cura di Luigi Re....................................................................75
introduzione
- 3 -
Dai primi mesi del 2004, sulla scia del lavoro realizzato con lepubblicazioni "Pieve su, Pieve giù", "Antologia pievese" e"Sessarego, storia di un borgo e di una chiesa", un gruppo di ricerca-tori di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, ha continuato l'attività di ricer-ca e di studio sulla storia, l'arte e le tradizioni dei nostri paesi.Attualmente essi stanno preparando, grazie alla collaborazione delleParrocchie di San Bernardo e di San Michele di Pieve Ligure, unastoria della frazione di Poggio Favaro, mentre collateralmente sonoin corso altre iniziative, come il riordino degli Archivi Parrocchiali diCapreno e di Pieve Ligure, una costante ricerca di antiche e ineditefotografie e la realizzazione di questi Quaderni che ci auguriamo pos-sano essere un regolare appuntamento annuale.
Nel 2006 è stato ufficialmente costituito il "Centro Studi Storie diJeri" con lo scopo, appunto, di studiare ed approfondire la storia, letradizioni e la cultura in genere dei tre paesi del Golfo ParadisoBogliasco, Pieve Ligure e Sori.
Parlando di questi tre centri rivieraschi è facile ricondurli ad unacomune radice culturale, sia per il fatto che in passato in due occasio-ni sono stati aggregati tra loro (l'antica Pieve di Sori, e la più recenteBogliasco-Pieve) sia per i legami umani, i vincoli di parentele, lemigrazioni locali. Tanti sono i Bogliaschini con radici familiari aPieve o a Sori, come pure troviamo a Sori "radici" di Pieve e a Pieve"radici" di Bogliasco. Il tipo di economia sul quale in passato si reg-gevano, prevalentemente contadina, era comune ai tre territori, men-tre comune è stato dalla fine del Settecento e per buona partedell'Ottocento, il diffondersi della marineria tra queste popolazioni.
Popolazioni che hanno vissuto anche in maniera simile il fenome-no dell'emigrazione nelle Americhe della prima metà del Novecento,e che più recentemente hanno vissuto la tragedia della guerra con glistessi problemi e gli stessi drammi.
Certamente è esistito, e forse ancora un poco esiste, il campanili-
- 4 -
smo, ma, salvo pochi casi limite, non sfociò mai in violenze, ed èsempre rimasto un simpatico "sfottimento" tra gli abitanti, magari trai tifosi della pallanuoto.
Questo primo numero dei nostri quaderni prende in esame picco-le e grandi storie di questi paesi, per la maggior parte ricavate dadocumenti inediti degli Archivi storici locali.
Siamo grati all'Assessore alla cultura della Provincia di Genova,Maria Cristina Castellani, al Sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, alSindaco Vicario di Pieve Ligure Adolfo Davide Olcese, e al Sindacodi Sori Luigi Castagnola, che hanno dimostrato grande sensibilità neiconfronti del nostro Centro Studi, collaborando ai costi di stampadella presente pubblicazione ed offrendo comunque il loro importan-te supporto istituzionale.
Un doveroso ringraziamento va fatto anche al Consiglio Direttivodella Confraternita di S. Chiara di Bogliasco che ci ospita nei suoilocali nei nostri incontri settimanali.
Novembre 2006
Centro Studi "Storie di Jeri"Il Presidente
Pier Luigi Gardella
Bogliasco nella II Guerra Mondiale: la distruzione del ponte
ferroviario
Giorgio Casanova
Era lunedì 5 marzo 1945, alle 3 del pomeriggio, mancavano 40giorni alla fine del terribile conflitto. Una forte esplosione scosse ciòche restava di intero a Bogliasco, quando il polverone si diradò ilponte ferroviario non esisteva più: un cumulo di macerie comprese lecase poste sotto di esso e quelle nelle immediate vicinanze: non si eratrattato dell'ennesima incursione aerea compiuta dagli anglo-ameri-cani, a distruggere definitivamente il ponte (già seriamente danneg-giato) erano stati i tedeschi, nel disperato quanto inutile tentativo dirallentare l'avanzata degli alleati versi il Nord-Italia.
Il calvario di Bogliasco, a causa del viadotto ferroviario, duravada almeno due anni cioè dall'inizio dei massicci bombardamentianglo-americani sulle vie di comunicazione dell'Italia settentrionale,in previsione dell'offensiva. Già dal marzo del 1943, una legge comu-nale e provinciale prevedeva lo sgombero delle case vicino ai viadot-ti stradali e ferroviari, il Prefetto di Genova decretò fosse obbligato-rio “ai proprietari ed inquilini delle case site in prossimità dei viadot-ti ferroviari o carrozzabili dei comuni di Bogliasco -Pieve, Sori eRecco di sgomberare dalle proprie abitazioni entro il termine chesarà stabilito dal podestà. Per il collocamento degli sfollandi i pode-stà dei comuni predetti sono autorizzati a far occupare tutti i localidi abitazione esistenti nel Comune”1. Il podestà di Bogliasco nonperse tempo, il 13 novembre ordinò che “i proprietari ed inquilinidelle case site in prossimità del viadotto ferroviario e di quelli car-rozzabili, sgombrassero dalle proprie abitazioni entro oggi”2.
Si trattava di 1200 persone la cui nuova sistemazione si presenta-va problematica per la scarsità di locali disponibili.
A complicare ulteriormente la faccenda ci pensarono i comandigermanici che avevano preso possesso di numerosi stabili, sfrattan-1 Archivio di Stato di Genova, d'ora in poi ASG., Repubblica sociale 28, dal capo della provincia
Bigoni ai podestà di Bogliasco, Sori e Recco, Genova 11 novembre 1943.2 ASG., Repubblica sociale 28, dal commissario prefettizio di Bogliasco 19 novembre 1943. In realtà
l'ordine di sgombero avvenne dopo il primo bombardamento di Recco del 10 novembre: F. Alberico,Recco 1940-1945, autoritratto di una città in guerra, Micro'Arts, Recco 2001, p. 39.
- 5 -
done senza tanti complimenti gli inquilini. Questi avevano dovutopoi essere risistemati dal comune accentuando ulteriormente la crisidegli alloggi. Non mancavano le tensioni tra le autorità e parte dipopolazione, come nel dicembre del '43 “nel pomeriggio del 22 cor-rente 350 operai, inquadrati nell'organizzazione Todt ed addetti ailavori di fortificazione nei comuni di Bogliasco e di Sori, hannoabbandonato il lavoro in segno di protesta per la diminuzione delsalario e per la mancata corresponsione del premio natalizio”3 glioperai ripresero il lavoro il giorno 27, non si erano verificati inciden-ti.
Nel maggio del 1944 il comando del presidio germanico diGenova dispose un nuovo sgombero di case e negozi in alcune zonedi Bogliasco-Pieve, Sori, Recco e Camogli procurando ai loro pro-prietari altre abitazioni o nei detti comuni o fuori di essi questo “per-ché qualora esigenze di ordine militare lo richiedano potrà essereordinato lo sgombro effettivo entro poche ore senza la possibilità dimettere in salvo se non quello che può essere portato a mano”4 i tede-schi infatti erano preoccupati per l'avanzata degli alleati in Italia cen-trale, temendo un possibile sbarco anche in Liguria. Il commissarioCalvi, da Bogliasco, assicurò al prefetto la pronta esecuzione degliordini tedeschi; in via Aurelia a Bogliasco furono sgomberate le casedei numeri civici 20, 22, 24, 26, 26a, 26b, 26c, 26e, 26d, 26g, 28, 30,32, 33, 34, 36, 39, 54 per un totale di 135 persone. In Via Etiopiafurono sgombrate le case con numero civico 44, 46, 48, 50, 52, perun totale di 65 persone5.
I bombardamenti del 1944Dal luglio a dicembre 1944 Bogliasco subì 5 bombardamenti
aerei di cui quello rovinoso del 17 luglio. Il primo fu il 7 luglio l'al-larme durò un'ora e trenta, vennero sganciate a Bogliasco centro trebombe da Kg 500, due case furono danneggiate.
Tre giorni dopo scattò nuovamente l'allarme che durò circa due
3 ASG., Repubblica sociale 29, dalla Questura al Prefetto di Genova 29 dicembre 1943.4 ASG., Repubblica sociale 27, dal capo provincia ai commissari prefettizi di Bogliasco-Pieve-Sori-Recco e Camogli, Genova 10 maggio 1944.5 ASG., Repubblica sociale 27, dal comando tedesco di Genova al Prefetto di Genova, 7 maggio
1944.
- 6 -
ore, non si sa il numero delle bombe sganciate6.Il giorno 17 avvenne l'incursione più distruttiva per Bogliasco, ne
fu mandato un promemoria al capo della provincia “l'attacco aereo èstato effettuato in due ondate di cui una alle ore 11,30 e l'altra alle11,50. Non è stato possibile dare l'allarme con la sirena per man-canza di energia elettrica a causa dell'interruzione dei conduttori perprecedente incursione. Sono state lanciate circa 20 bombe dal pesodi circa 500 Kg e ciò si rileva dai crateri risultati dagli scoppi alcu-ni dei quali hanno il diametro di circa 20 mt. ed una profondità di 7-
8 mt.E' stato colpito il ponte
ferroviario in due punti acirca 200 mt. di distanzauno dall'altro, sono crolla-te completamente duearcate con asportazionetotale della linea aerea ditrazione e dei binari percui il transito ferroviario èinterrotto.
E' stata colpita la stra-da nazionale, che è stataprontamente riattivatadalle squadre locali. Lastrada vecchia è stata col-pita in due punti con inter-ruzioni del traffico. Sonostati danneggiati 1) il cavotelefonico nazionale (incorso di riparazione) 2) laconduttura dell'acqua
potabile 3) le linee elettriche dell'illuminazione. Sono state distrutte6 case in Via Etiopia ed 1 casa in Via Marconi; Le case danneggia-te sono 20, bombe sono pure cadute nella parte alta del comune con
6 ASG., Repubblica sociale 28, relazione bombardamenti mese di luglio, 1944.7 ASG., Repubblica sociale 29, Dal T. Colonnello Guglielmino al capo provincia, Genova, 17 luglio
1944.
Fig. 1: Il vuoto lasciato dal ponte
- 7 -
distruzione di oliveti”7 il numero delle vittime era in corso di accer-tamento, erano arrivate a Bogliasco 3 squadre di vigili del fuoco, 2squadre dell'U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) eun'autoambulanza della C.R.I.. A seguito dell'incursione venne amancare l'acqua ma a risolvere questo problema si poteva provvede-re con la compagnia antincendi speciale, per dare il segnale di allar-me con il suono delle campane. Venne quindi fatto stampare dalcomune il seguente manifesto:
8 1997, P. Schiaffino, Storia di Bogliasco, pp. 169-171, Bogliasco. I dati riportati sul libro sono iseguenti: civili deceduti 20, civili feriti 90, senzatetto o sinistrati 1078, case inabitabili 91, edifici diculto danneggiati 3.
17 luglio 1944 - XXIIincursione aerea nemica
sul capoluogo del comunedi Bogliasco-Pievecivili deceduti 19
civili feriti 74case distrutte 25
case inabitabili 83edifici di culto danneggiati 3
civili rimasti senza casa o sinistrati 1050
Ai “liberatori” anglosassonila gratitudine riconoscente
di questa popolazione
I dati sulle vittime e danni dell'incursione sono riportati anchenella storia di Bogliasco dello Schiaffino8 leggermente maggiorati,ma questo può dipendere da una valutazione successiva dei dannisubiti e quindi più precisa. In seguito allo scompiglio seguito al bom-bardamento il commissario prefettizio Calvi fece alcune ordinanzedirette a far riprendere le attività commerciali sia stabili che ambulan-ti. Stabilì inoltre che tutti gli uomini, dai 14 ai 60 anni, nel caso cheun'incursione nemica colpisse il territorio del comune, dovevano tro-varsi, non oltre un'ora dopo il termine dell'incursione, nella sedecomunale o nelle vicinanze, possibilmente muniti di picchi e pale acompleta disposizione delle autorità locali. Tutti gli automezzi di tra-
- 8 -
sporto animale e i quadrupedi esistenti nel comune e non precettatidall'autorità militare “nel più breve tempo possibile e comunque nonoltre un'ora dal termine di un'azione nemica dovranno incolonnarsinella galleria di via Aureliadal lato della stazione diBogliasco a totale disposi-zione delle autorità”9.
Dopo l'incursione del 17luglio Bogliasco subì altridue bombardamenti aerei,uno il 6 di agosto alle 6,55del mattino. Furono sgancia-te 4 bombe da 250 kg. con ildanneggiamento di 5 case eun ufficio pubblico, ci fu unmorto ed un ferito civile10.
L'ultimo, come augurio dibuon anno nuovo, il 31dicembre alle 4,15 con duebombe. Una colpì una casa,l'altra scoppiò in un prato,questa volta fortunatamentesenza vittime11.
La distruzione del ponte ferroviarioNel novembre del 1944 la popolazione di Bogliasco osservava
inquieta le mosse tedesche riguardanti la ferrovia, già la sera del 17il ponte ferroviario e quello stradale di Sori erano stati distrutti perordine del comando germanico di Nervi “il quale non contento delladistruzione operata dal nemico con le note incursioni, ha voluto farsaltare le arcate superstiti, non solo, ma anche le pile, a mezzo di
9 ASG., Repubblica sociale 29, dal comm. prefettizio E.C. Calvi al Prefetto di Genova, Bogliasco 20luglio 1944.10 ASG., Repubblica sociale 28, rapporto sui bombardamenti, agosto 1944.11 ASG., Repubblica sociale 28, rapporto sui bombardamenti, dicembre 1944.12 ASG., Repubblica sociale 27, dal comm. prefettizio E.C. Calvi al Prefetto di Genova, Bogliasco
18 novembre 1944.
Fig. 2: Si comincia a ricostruire
- 9 -
mine apparecchiate con fornelli alla base di ogni pila”12. Circolavagià la voce che anche il ponte di Bogliasco dovesse fare la stessa fine.Prima di distruggere i ponti, i tedeschi avevano smontato ciò che gliserviva da Levante verso Genova. Già alla fine di settembre i solda-ti tedeschi del genio avevano iniziato “nel tratto di S. Ilario della fer-rovia Genova-Spezia la sbullonatura e rimozione dei binari”13. Ilmateriale era stato lasciato al momento ai margini della linea ma erachiaro che si sarebbe poi passato al trasferimento del materiale. Itedeschi caricavano i treni di macchinari e materiali prelevati dallefabbriche e li trasferivano il più vicino possibile al territorio tedesco.In novembre, ogni giorno, partivano 4 treni che rimanevano poi alnord mentre si continuava a smontare binari, linea elettrica ed adistruggere i ponti come quello sull'Entella tra Chiavari e Lavagna.14
Anche a Bogliasco i tedeschi avevano cominciato a smontarebinari e pali della linea elettrica. Il commissario Calvi scriveva preoc-cupato che se il ponte di Sori “situato ad una certa distanza dall'abi-tato, ha potuto esser fatto saltare senza conseguenza per le case, ciònon potrà avvenire a Bogliasco dove il paese (capoluogo) è tuttosituato sotto il ponte ferroviario”. Non si capiva la ragione della suadistruzione dato che già i ponti di Recco e Sori erano stati distrutti.Ma i tedeschi proseguirono nei loro piani, minarono il ponte diBogliasco non solo nelle arcate ma anche nei piloni. Lunedì 5 marzo1945 il ponte venne fatto saltare, nonostante l'intervento del commis-sario Calvi per limitarne la distruzione alle sole arcate centrali rispar-miando quelle sovrastanti alle case di abitazione. “Lo scoppio è statodi una ampiezza tale che supera ogni immaginazione e gli effetti sonostati per il paese di gran lunga superiori al bombardamento del 17luglio. Il ponte è crollato per intero creando un enorme cumulo dimassi attraverso il torrente, ed in due punti la strada comunale fra-cassando case e l'impianto dell'acquedotto, già riparato dopo ilbombardamento del 17 luglio”15. Scrisse ancora più sconsolato
13 ASG., Repubblica sociale 27, dal comando provinciale della Guardia Nazionale Repubblicana alPrefetto di Genova, 28 settembre 1944.14 1995, F. Rebagliati - M. Siri, La guerra dei ponti, 50° Anniversario della Liberazione, p. 175, ArtiGrafiche Arzani, Pinerolo - Torino.15 ASG., Repubblica sociale 27, dal comm. prefettizio E.C. Calvi al Prefetto di Genova, Bogliasco 5
marzo 1945.
- 10 -
Calvi alla fine di marzo “Non posso persuadermi che il comandogermanico possa ordinare la distruzione dell'attrezzatura ferroviariasenza alcuna necessità di carattere militare, mentre sono propenso acredere che tali operazioni siano operate da comandi inferiori aiquali si siano affiancati anche speculatori nostrani (...) non vorreiche questi ordini, apparentemente del comando germanico, nascon-dessero altri fini politici o interessi di ditte interessate al recupero dimateriali d'accordo con qualche sottoufficiale tedesco troppo inte-ressato. Il traffico della vendita delle traverse di legno avvenuto inBogliasco mi ha convinto che qualche cosa del genere purtroppo esi-ste”16. Venticinque giorni dopo terminò la guerra e cominciò la rico-struzione, molti avevano perso i beni e la vita, altri ci avevano gua-dagnato, così come accade spesso nella vita degli uomini, sia in paceche in guerra.
16 ASG., Repubblica sociale 27, dal comm. prefettizio E.C. Calvi al Prefetto di Genova, Bogliasco31 marzo 1945.
- 11 -
Le donazioni dei capitani e le rotte dei bastimenti pievesi nei
'libri mastri' della parrocchia di San Michele di Pieve di Sori
Marina De Franceschini
Durante le nostre ricerche d'archivio, abbiamo letto e trascrittoalcuni “libri mastri” della Chiesa Parrocchiale di S. Michele dellaPieve di Sori, nei quali venivano scrupolosamente annotate tutte leentrate ed uscite del bilancio della parrocchia. Le uscite riguardava-no spese correnti fra le più varie, per le candele, i mortaretti, il lavag-gio dei paramenti. Poi vi erano spese più onerose per lavori di costru-zione o di restauro, oppure per acquistare nuovi paramenti o oggettisacri per abbellire la chiesa.
Fra le entrate, oltre alle decime e alla vendita di olio, spiccavano idonativi della popolazione locale, che venivano riscossi in occasionedelle varie feste patronali. Altri introiti derivavano dall'affitto di ter-reni o di case, da lasciti testamentari, o da “limosine” di privati citta-dini, in genere indicati come “benestanti”.
I donativi più cospicui si devono però alla generosità di diversicomandanti o armatori di bastimenti o “navigli”. I “libri mastri” chefinora abbiamo letto documentano una sessantina di donazioni, effet-tuate in un periodo di tempo che va dal 1824 al 1873, circa mezzosecolo.
Le annotazioni fanno naturalmente il nome del donatore e talvol-ta citano la sua qualifica (capitano, comandante, armatore); indicanoil nome della nave e la sua tipologia (in termini piuttosto vaghi,“bastimento” o “naviglio”, raramente si parla di un tipo specifico dinave come ad esempio il brigantino). In qualche caso conosciamo l'i-tinerario del viaggio compiuto dalla nave e la meta raggiunta. Lerotte principali erano due: quella verso “il Levante” cioè la Grecia ela Turchia, che toccava importanti empori commerciali come i portidi Costantinopoli, di Salonicco e di Smirne. E poi la rotta versol'Inghilterra, che naturalmente passava da Gibilterra e Madera.
I nomi dei donatori che compaiono nei libri mastri sono in tuttosedici, ed appartenevano ad un gruppo ristretto di cinque o sei fami-glie che evidentemente dominavano e monopolizzavano l'attività delcommercio e del trasporto marittimo a Pieve, in qualità di armatori,oppure comandavano dei bastimenti appartenenti ad altri armatoridei paesi vicini.
- 12 -
I Benvenuto (Emanuele ed Ernesto), donarono parte degli utili deiviaggi del brigantino S. Giuseppe in un periodo compreso fra il 1859ed il 1862. Meta dei viaggi della loro nave era il Levante (cioè l'o-riente) e l'Inghilterra.
Poi viene nominata negli elenchi la famiglia Consigliere (Lorenzoe Pietro) le cui donazioni risalgono ad un periodo che va dal 1839fino al 1862. Loro era il brigantino Secondo Narciso, che battevasoprattutto le rotte d'Oriente fino a Costantinopoli. I proventi delprimo viaggio del Secondo Narciso vennero devoluti per intero allaparrocchia di S. Michele.
Solo una volta compare il nome del capitano Manuello Crovettodi Bogliasco, che versò alla chiesa 4 lire - evidentemente si trattavadi un dona-tivo perso-nale e nondei proventidi un viag-gio permare.
Il Cap.Giovann iD a p u e t ocomandavainvece ilbastimentoA m a b i l eCa te r ina ,che facevarotta versola Turchia o l'Inghilterra nel 1863 e 1864. Donò ben 125, 136 e 64lire, parte degli utili provenienti da tre diversi viaggi.
Il capitano Martin Fravega viaggiava fino in Inghilterra con il suobastimento Giobeterrino, e risultano a suo nome due donativi nel1838 e nel 1843, rispettivamente di 100 e 112 lire.
Particolarmente numerosi e generosi risultano esser stati gli espo-nenti della famiglia Fulle o Folle, i cui donativi sono attestati fra il1841 ed il 1871, con cifre che vanno da 34 a 160 lire. Più di un terzodelle offerte compare sotto il loro nome di Costantino Fulle (o Folle).
Fig. 1: Bombarda 'Concezione', modellino donato nel 1806 comeex-voto all'Oratorio di Pieve
- 13 -
Egli navigava con il brigantino Nostra Signora delle Grazie, o con ilMatotina (o Matutina). Ma nei libri mastri è nominato anche il basti-mento Azoff, che apparteneva agli armatori Antola di Sori e percor-reva le rotte verso l'Inghilterra.
Un altro membro di questa famiglia, Luigi Folle (o Fulle) naviga-va anch'eglicon ilN o s t r aS i g n o r ad e l l eG r a z i e ,oppure conil brigantinoF o r t u n a ;sappiamoche percor-reva le rottefino alDanubio eS m i r n e .A n g e l oFulle, sem-
pre con il Nostra Signora delle Grazie raggiungeva Salonicco, men-tre sulla stessa nave Fortunato Fulle navigava fino a Madera.
Infine i libri mastri fanno il nome della famiglia Stagno: Antonio,Domenico, Emanuele, Ermete e Mario, nominati nei libri per i lorodonativi effettuati in un periodo che va dal 1840 al 1870, con impor-ti che variano da 40 a 126 lire. Navigavano con il brigantino NostraSignora delle Grazie, con il Fortuna e con il Matotina. Evidentementele navi erano sempre le stesse, e vi si avvicendavano comandantiappartenenti a differenti famiglie pievesi.
Mediamente le donazioni erano di 40-50 lire, ma in diversicasi superarono le 100-200 lire per raggiungere il massimo storicodella generosa donazione di Giovanni Dapueto, di ben 1000 lire, chenel 1861 erano una somma non indifferente. In totale, nell'arco di cin-quant'anni, vennero donate alla chiesa di S. Michele ben 6948 lire,una cifra veramente notevole.
Fig. 2: Brigantino 'Nostra Signora delle Grazie' modellino dona-to dal Comandante Antonio Consigliere,all'Oratorio di Pieve
- 14 -
Per quanto riguarda i nomi delle navi che compaiono nei librimastri, va osservato che solo alcuni trovano riscontro negli elenchipubblicati da Gio Bono Ferrari nel suo bel libro Capitani eBastimenti di Liguria del xix secolo. Nel libro sono citate numerosenavi che portavano il nome di Nostra Signora delle Grazie, e sappia-mo che anche a Pieve ve n'era una, armata da Antonio Consigliere.Nei libri mastri parrocchiali, invece, il nome dei Consigliere è legatosolo al brigantino Secondo Narciso.
Esisteva ed è registrato anche il brigantino Azoff, i cui armatorierano i capitani Andrea e Francesco Antola di Sori. Il nome Azoffcompare accanto ai due donativi di Mario Stagno e di CostantinoFolle, entrambi risa-lenti al 1864.
Un pinco a nomeS. Giuseppe apparte-neva al capitanoConsigliere di Sori,ma nei libri mastri siparla invece di unbrigantino, con quel-lo stesso nome, lega-to al donativo diE m a n u e l eBenvenuto. Dovevatrattarsi quindi di duediversi bastimenti.
Gli altri nomi dinavi citati nei “librimastri”, AmabileCaterina, Secondo Narciso, Matotina e Fortuna, non compaionoinvece nel libro di Ferrari, quindi ci sono spazi per ulteriori ricerchestoriche su questo argomento.
Possiamo immaginare quali fossero le merci trasportate dai capi-tani pievesi nei loro viaggi da e per l'Oriente: spezie, tè, sale, tessutie tappeti, ceramiche, merci “esotiche”. A Pieve come a Sori e aBogliasco conosciamo quindi delle piccole dinastie di capitani e/o
Fig. 1: Particolare del modellino di Bombarda 'SantaTeresa' del Capitano Corsanego, il terzo conservatonell'Oratorio di Pieve
- 15 -
armatori, che per lunghi mesi abbandonavano le loro famiglie e siguadagnavano duramente la vita sul mare, affrontando i mille rischie pericoli della navigazione ottocentesca, prevalentemente a vela. Leloro generose donazioni alla chiesa di San Michele erano un modo diesprimere la loro gratitudine per essere tornati sani e salvi a casa darotte tanto lontane e pericolose.
A conferma dello stretto rapporto che intercorreva fra i coman-danti dei bastimenti pievesi e la loro Chiesa, nell'Oratorio di PieveLigure sono conservati tre bellissimi modellini di navi, curati neiminimi particolari: sono degli ex-voto dedicati da altrettanti capitanipievesi. Purtroppo i documenti dell'Oratorio, che pure ne annotano inomi, non dicono per quale scampato pericolo si rendesse grazie,anche se possiamo immaginare tempeste ed uragani.
La prima è il Brigantino Nostra Signora delle Grazie, del coman-dante Antonio Consigliere. E' citata diverse vole nell'elenco delledonazioni, nei quali risulta essere sotto il comdando di Costantinooppure di Luigi Folle. Antonio Consigliere doveva esserne l'armato-re. La seconda è una Bombarda di nome Concezione, comandata daFrancesco Consigliere e donata nel 1806, mentre la terza è un'altraBombarda chiamata Santa Teresa, al comando del capitanoCorsanego. I nomi di questi due bastimenti e dei loro proprietari noncompaiono negli elenchi dei donativi, ma va osservato che non sem-pre viene citato il nome dell'imbarcazione e che il nome del coman-dante può essere diverso da quello del proprietario o dell'armatore.
- 16 -
DONATORE ANNO ITINERARIO NAVE SOMMABenvenuto Emanuele 1859 brig. S. Giuseppe 50 Benvenuto Emanuele 1861 levante e Inghilterra 50 Benvenuto Emanuelle 1862 naviglio 19,8Benvenuto Ernesto 1862 viaggio a levante 46,17Consigliere Lorenzo 1839 1/4 utile viaggio a Trieste 36,10Consigliere Lorenzo 1845 Secondo Narciso 50Consigliere Pietro 1839 (?) Primo viaggio Secondo Narciso 52,12Consigliere Pietro 1839 secondo viaggio Secondo Narciso 34,3Consigliere Pietro 1856 vari viaggi brigantini 225 Consigliere Pietro ? viaggio di Berd Secondo Narciso 56,1Consigliere Pietro Secondo Narciso 42.3Consigliere Pietro ? Secondo Narciso 33,11Consigliere Pietro ? 1847 Costantinopoli Narciso 35Consigliere Pietro 1859 diversi viaggi Bastimenti 279,10Consigliere Pietro 1860 vari viaggi bastimenti 294,36Consigliere Pietro 1861 vari viaggi bastimenti 424,15Consigliere Pietro 1862 navigli 700 Dapueto Giovanni 1861 1000 Dapuetto Giovanni 1861 65,15Dapueto Giovanni 1862 un viaggio bastimento 145,6Dapueto Giovanni 1863 Amabile Caterina 125Dapueto Giovanni 1864 Turchia e Inghilt. S. Giovanni 136 Dapueto Giovanni 1864 viaggio in Inghilterra Amabile Caterina 64,18 Fravega capitano 1838 100Fravega Martin 1843 Gibilterra Giobeterrtino brig 112Folle Costantino 1857 2 viaggi levante N.s. Grazie 160,1Folle Costantino 1859 N.S Grazie 39 Folle Costantino? Viaggio Danubio N.S. Grazie 62,15Folle Costantino 1859 1/4 utile viaggio Levante Londra 109,13Folle Costantino 1861 Salonicco 34,13Folle Costantino 1861 viaggio a levante 59,15Folle Costantino 1861 viaggio a levante 75,06Folle Costantino 1864 viaggio Azoff Inghilt, Genova 145Fulle Costantino 1871 Matotina 47Fulle Costantino Matutina 60Folle Luigi 1858 viaggio Danubio 39,0Folle Luigi 1862 utili bastimento 32,10Folle Luigi 1862 utili brig N.S, Grazie 25Folle Luigi utili brig Fortuna 135 Fulle Luigi 1841 84,6Fulle Luigi 1842 1/2 utile viaggio Smirne 83,15Fulle Luigi 1854 N.S. delle grazie 140,9Fulle Luigi 1856 1/4 utile viagg N.S. delle grazie 135Fulle Angelo 1847 Salonicco N.S. Grazie 147,17
- 17 -
Fulle Fortunato 1837 viaggio mar d'Azov 52,10Fulle Fortunato 1839 due viaggi N.S. delle Grazie 305.10Fulle Fortunato 1840 Madera 119.14Stagno Antonio 1864 1/4 utile viaggi N.S. Grazie 56,5Stagno Antonio 1869 brig Matotina 41Stagno Antonio 1870 brig Matotina 50Stagno Domenico 1839 Fortuna 82,10Stagno Domenico 1840 Fortuna 116Stagno Domenico 1840 a Gibilterra 126,10Stagno Domenico 1845 un viaggio 66,3Stagno Emanuele 1861 a levante 40Stagno Ermete 1859 a Taganrog (?) 52,10Stagno Mario 1864 1/4 utile viaggio Azoff Fortuna 50
- 18 -
Agostino Vignolo e La Madonna del Rosario della parrocchiale
di San Michele Arcangelo di Pieve Ligure.
Silvia Frattini
Il recente ritrovamento nell'archivio par-rocchiale di San Michele di Pieve del con-tratto stipulato il 5 Marzo del 1879 tra il par-roco Nicola Pagano e lo scultore AgostinoVignolo ha permesso di puntualizzare i ter-mini della commissione della Madonna delRosario, tuttoggi visibile nella cappella ditestata destra dell'attuale parrocchia di Pieve,e di poter conoscere meglio la produzionelignea dello scultore, oggi difficilmente indi-viduabile per la scarsa documentazione finoad oggi reperita.
Agostino, nato a Genova da Angelo eRosa Travi il 25 marzo del 18231 riceve unaformazione accademica, nel 1837, all'età di14 anni, si iscrive all'Accademia di Belle artidi Genova, è allievo di Santo Varni per la scultura in marmo e delOlivari per quella in legno2. Lo scultore è noto soprattutto per leopere eseguite in marmo. Una guida del primo Novecento3 ricordaun Busto di Garibaldi eseguito nel 1863 per un caffè in via AndreaDoria, un Busto di Monsignor Giacomo Filippo Gentile, vescovo diNovara, per il monumento funebre di Avezzano. Un Busto diCristoforo Colombo, tuttoggi visibile nella Galleria di Palazzo Realedi Genova, gli fu commissionato dal Principe Oddone di Savoia, susuggerimento del Varni, nel 18644. Federico Alizeri ricorda il
Fig. 1: A. Vignolo, LaMadonna del Rosario1879, S.Michele, Pieve Lig.
1 Agostino viene battezzato nella chiesa di S. Maria Maddalena. Muore il 2 maggio 1912, a 89 anni, aGenova. Leve militari, A.S.C.G. Censimento, A.S.C.G, del 1856 c. 104 e Censimento del 1817 c. 544.2 Ingressi dell'Accademia Ligustica di Belle Arti 1828- 1840, Archivio della Accademia Ligustica diBelle Arti. Genova, La Superba, guide Marini, 1900, p.82.3 1900, Genova, La Superba…op.cit. , p.82.4 1996, C.Olcese Spingardi, Odone di Savoia e la cultura artistica genovese del suo tempo, in La col-lezione di un principe per Genova, Genova, p. 90 e fig. a p. 95. L'opera era stata esposta nel 1895 nel-l'ambito delle manifestazioni della Società promotrice di Belle Arti in Genova. Le Società promotrici diGenova (1850-1955), CD rom, Ares Multimedia. Rimandiamo alla consultazione dei cataloghi per l'in-dividuazione di altre opere scultoree del Vignolo. Lo scultore ebbe alcune commissioni pubbliche come
- 19 -
Vignolo unicamente per i monumenti eseguiti a Staglieno5 di cuisuccessivamente Resasco fornì più precise indicazioni6. I monumen-ti sepolcrali, meritano una menzione anche per la comprensione delladuplice operatività, su legno e marmo, dello scultore. A Staglienoeseguì il cippo per Enrico Riccioli (porticato inferiore a ponente,trentaduesimo arcone), per Giuseppe Tassistro (trentatreesimo arco-ne), per Giovanni Pertica(trentottesimo arcone), di Emilia WannensA m p u g n a n i(1863, quaran-tunesimo arco-ne), di DeSimoni (qua-rantaseiesimoarcone), diGiulia GentileC e n t u r i o n e(1881, sessan-tacinquesimoarcone), e
Carenzio (porticato inferiore a levante trentatreesimo arcone)7. Inqueste opere l’introspezione psicologica del defunto e la resa dei par-ticolari rivelano l’adesione ad un moderato realismo mentre la strut-tura architettonica recupera elementi della tradizione classica.
Informazioni relative alla produzione lignea si ricavano dai cata-loghi delle Società Promotrici di Genova (1850-1955) che però nonillustrano le opere dello scultore. Il Vignolo scolpì principalmentetemi devozionali, con ogni probabilità destinati a una committenzaecclesiastica: nel 1857 espose un modello per La Concezione, nel1859 una Madonnina, nel 1860 due Madonne, statuette in legno, nel1867 un'Immacolata Concezione, nel 1869 La santa infanzia di Gesù,
Fig. 2: A. Vignolo, Teste di cherubino della Madonna del rosa-rio, 1879, S.Michele, Pieve Ligure.
un busto per il Magistrato dell'Orfanotrofio di Genova esposto nel 1860, e un monumento ai pompieridestinato al sud America eseguito nel 1865. Genova, La superba …op.cit. p. 82. 5 1873, F. Alizeri, Notizie dei Professori del disegno, Genova, voll. III, p. 407. 6 1892, F. Resasco, La Necropoli di Staglieno, Genova, pp. 34-36 e pp.38,42.7 1999, F. Sborgi, Staglieno e la scultura funeraria ligure tra Ottocento e Novecento, Torino, p. 422.Le opere del Vignolo a Staglieno sono state in parte schedate dalla Soprintendenza per i Beni StoricoArtistici ed Etnoantropologici della Liguria, schede di L. Albertella e R.Stellato, P. Marica (nn. di cata-logo 00051149, 00051153,00051173, 00051185, 00051209, 00051284, 00051355).
- 20 -
nel 1873 una N. Signora del Rosario, nel 1875 un Salvator Mundi eun Gesù Bambino8.
La Madonna del Rosario (Fig.1) della parrocchiale di Pieve vennecommissionata nel 1879 in coincidenza, secondo i Remondini, a unnuovo vigore devozionale della comunità seguito al termine dellesoppressioni napoleoniche. I due fratelli la riferiscono, erroneamen-te, ad Angelo Vignolo, confondendo il nome con quello del padre9.
Con ogni probabilità la Madonna del Vignolo, oggi collocata nellacappella di testata destra, sostituì una scultura più antica, seicentesca,eseguita in coincidenza della fondazione nel 1604 della Compagniadi N.S. del Rosario e del successivo ampliamento della chiesa conl'aggiunta di due altari tra cui quello destinato ad ospitarla10. IRemondini riportano la notizia di un successivo "ristoro" della chie-sa, che presentava le misure di 13 metri di larghezza per 33 lunghez-za, avvenuto nel 1810 in cui furono portati a nove gli altari della chie-sa, di cui il quarto a destra, corrispondente all'attuale collocazionedella statua, dedicato al SS. Rosario. La chiesa venne ulteriormenteampliata in lunghezza nel 1863.
La scultura lignea presenta tutte le caratteristiche richieste dalcontratto: è alta un metro e quaranta (profonda circa 65 cm, larga57)11 poggia su una nuvola di cui sono tuttoggi conservate due delletre testine di cherubino (Fig. 2) che la adornavano. La cassa chedoveva trasportarla nelle processioni è andata invece perduta.
La Madonna, la cui iconografia ricalca tipologie settecentesche, èimpreziosita da un abito dalla duplice decorazione fitomorfa, dorataeseguita a mordente, a fitti e minuti mazzi di fiorellini nella veste,
8 (1850-1955), Le Società promotrici di Genova, CD rom, Ares Multimedia. 9 1882, A. e M. Remondini, Parrocchie dell'Arcidiocesi di Genova. Notizie storico- ecclesiastiche,Regione II, Genova, p. 162. Dai documenti emerge che Angelo Vignolo, padre di Agostino, nato aGenova il 1792, era un domestico.10 1913, G. Rollino, Memorie storiche della parrocchia di Pieve di Sori e del Santuario di Santa Croce,Genova, pp. 30-31 e pp.35-37. L'ampliamento seicentesco secondo il Rollino sarebbe documentatodagli inventari dell'Arciprete Peragollo del 1748 e dell'Arciprete Montebruno Maria Luigi del 1766.Solo la ricerca d'archivio, in corso di svolgimento sotto la direzione di Pierluigi Gardella, potrebbe daredefinitivo avvallo alle informazioni del Rollino e confutare le tesi dei Remondini (Parrocchiedell'Arcidiocesi di Genova. Regione II, op.cit., p.160) Secondo le informazioni del Rollino (Memorie…op.cit. , p. 53) la cappella del Rosario venne "indorata" nel 1846. L'attuale altare è databile all'ultimoquarto del XIX secolo.11 Scheda dei beni mobili della Diocesi di Genova n. 5AV0034 di Laura Lagomarsino.
- 21 -
fogliacea e stilizzata nel manto. I caratteri geometrici della forme e lastaticità della postura conferiscono alla scultura una ieratica severità.Questi stilemi si riscontrano in un'altra opera documentata dello scul-tore: La Madonna delle Grazie nella parrocchia di S. Ambrogio inFegino. E' una versione ottocentesca della quattrocentesca Madonnadelle Grazie del Santuario di Rovereto presso Chiavari12. Vennecommissionata nel 1871 dal Sac. Antonio Marcone, a cui si deveanche la donazione dell'altare eseguito dall'Ortelli, in occasione delprodigioso movimento degli occhi della Madonna di Chiavari13. Unrealismo di matrice sei settecentesca presenta invece un SanBartolomeo scorticato realizzato nel 1865 per l'oratorio intitolato alsanto martire in Bordighera14. Se la scultura in marmo del Vignolosipresenta aggiornata sulle tendenze realistiche di matrice romantica,pur in considerazione del succinto repertorio delle opere individuatepresenta un revival sei settecentesco in consonanza con le esigenzedidattiche e devozionali della committenza religiosa.
Desidero ringraziare Massimo Bartoletti, Grazia di Natale, Fausta FranchiniGuelfi, Pierluigi Gardella, Alessandro Giacobbe, Franco Sborgi, Caterina OlceseSpingardi, Oscar Uzzolino.
12 1970, G.Marcenaro, F.Repetto, Dizionario delle chiese di Genova, Genova, p. 67. La scultura diChiavari è descritta e illustrata in F.Ragazzi, Il santuario delle Grazie a Chiavari, Genova 1992, pp. 28-36 Scheda d'inventario dei beni mobili della Diocesi di Genova n.57C0006 di Anna Paola Arisi Rota. 13 1897, A. Marcone, Storia del Santuario di Nostra Signora della Grazie presso Chiavari celebre pelmovimento degli occhi manifestatosi in essa il 8 giugno 1871, Siena; Ricordo delle Feste centenariecelebrate nella chiesa prepositurale di Fegino ad onore di S. Ambrogio, Genova 1897, p. 8 e p. 16nota 5.14 1999, S.Giacobbe, La chiesa abbaziale di S.Maria Maddalena a Bordighera, Bordighera, pp. 39-41.
- 22 -
In virtù della presente privata scrittura da valere come atto roga-to dal pubblico notaro, i sottoscritti Rev.do Don Nicola Pagano arci-prete della Parrocchia di Pieve di Sori, e lo scultore AgostinoVignolo da Genova convengono quanto segue:
Lo Scultore Agostino Vignolo si obbliga scolpire in legno di tiglioben stagionato una Madonna col Bambino in braccio, seduta soprauna nuvola con tre teste d'angelo intorno come è indicato nel dise-gno firmato. Detta statua compresa la nuvola e zoccolo sarò altametri 1.40, essa sarà colorita a olio a colori naturali, avrà occhi dicristallo unitamente a putti, e avrà i bordi delle vesti riccamentedorati a lustro con fiori a mordente, sparsi nei manti
Detto Scultore Vignolo si obbliga pure di fare una Cassa, oBancone per portar detta Statua in Processione, la quale sarà inlegno bianco impiallacciata, sagomata in noce lustra con riportid'ornati dorati a lustro della dimensione di metri 1,12 per metri 1,25.Sopra questa cassa vi saranno 4 ornati portanti 15 candele, 4 vasiin legno dorati, più 4 mazzi di fiori finti come nel suddetto disegno,il tutto da eseguirsi con la massima diligenza.
Il tempo per la consegna di tal lavoro alla Stazione di Pieve diSori resta fissato a tutto il giorno 10 del mese di Settembre 1879.
Le spese d'incassamento saranno a carico dello Scultore, al qualperò verranno restituite le casse d'imballaggio.
Il Sullodato Rev.do Nicola Pagano si obbliga pagare per talelavoro allo Scultore Agostino Vignolo la somma convenuta di lire ita-liane millecentocinquanta in tre rate cioè lire cinquecentocinquantasubito per anticipazione, lire trecento alla consegna in Pieve, e lerimanenti lire trecento dopo sei mesi da detta consegna ritenendolecome garanzia in caso che il legno facesse del movimento per obbli-gare lo scultore a ripararne i guasti che avvenissero nel lavoro impu-tabili allo Scultore, al che sarà tenuto per un anno dall'epoca dellaconsegna. Nella predetta somma total di lire 1150 resta compreso unregalo di Cento lire che il Detto Rev.do Pagano si obbliga fare alloScultore Vignolo di sovrappiù qualora il lavoro riesca di suo gradi-mento.
Il Sig. Committente si riserva il diritto di farsi collaudare il lavo-ro dai periti dell'arte prima di far il pagamento totale. Fatto in
Trascrizione del contratto per la Madonna di Pieve di Sori
- 23 -
Genova in doppio originale firmato da ambe le parti contraenti ilgiorno cinque marzo milleottocento settantanove.
Approvo quanto sopra Agostino Vignolo Pagano Nicolò arciprete.
Io sottoscritto dichiaro avere ricevuta dal Molto Rev.do SignorNicolò Pagano la prima rata come sopra di lire cinquecentocinquan-ta per anticipazione a detto lavoro.
Dico L. it. 550Agostino Vignolo ScultoreGenova 4 Marzo 1880
Dichiaro aver ricevuto dal Rv. Sig. Arciprete Nicolò Pagano altrelire ital. Cento per ultima rata avendo già ricevute l altre cinquecen-to a saldo.
Dico L. it. 100.Agostino VignoloScultore
Ricevute con indirizzo e nome impressoAgostino Vignolo, scultore, via Carlo Alberto, N (illeggibile)
Genova Dichiaro aver ricevuto dal M. Rev.do Arciprete Nicolò Pagano
lire ital. Trecento per 2°rata più lire cinquanta acconto della 3°rataper il lavoro della Madonna di Pieve di Sori. Dico L.350
Agostino Vignolo ScultoreGenova, li 18 Sett. 1879
Io sottoscritto dichiaro aver ricevuto dal Molto Rv. Sig. ArcipreteNicolò Pagano la somma di Lire ital.. Centocinquanta acconto dipagamento per avere intagliato la Madonna del Rosario per la par-rocchia di Pieve di Sori.
Dico L. it.150Agostino Vignolo ScultoreGenova, li 6 Dicembre 1879.
- 24 -
Una lapide di ottanta anni fa a Bogliasco
Pierluigi Gardella
Una lapide posta sulla facciata di un palazzo di Piazza 26 aprile aBogliasco ricorda il martirio di Nazario Sauro. Essa recita
NAZARIO SAURODI CAPO D'ISTRIA CAPITANO PEL MARE DI EPICHE IMPRESE
CHE LA LEGGENDA GIÀ CANTAIL 18 AGOSTO DEL MCMXVI IN POLA
CONFERMÒ COL MARTIRIOLA FEDE NELL'UNITÀ ITALIANA
INFELICISSIMO EROECHE COLL'ULTIMA LUCE
PER VOLONTÀ DEL CARNEFICEANCOR TRAVIDE
LA SORELLA E LA MADREAL SUO TRAPASSO
PRESENTI
OH TANTA ALTEZZA DI ARDIMENTITANTO SCEMPIO DI UMANI CUORI
RICORDI LA STORIA
Ci siamo chiesti quando e da chi essa fu posta, ma inutili sonostate le domande fatte agli anziani del paese dei quali nessuno degliinterpellati ha saputo risponderci. Ci ha aiutato la fortuna, sotto formadi una cartolina postale ritrovata su una bancarella. Questa cartolina(Fig. 1) fu stampata, come recita l'intestazione, dal
COMITATO PRO LAPIDE A NAZARIO SAURO IN BOGLIASCOCOSTITUITO E PRESIEDUTO DAL COMM. CESARE GOTUSSOSCOPRIMENTO IV NOVEMBRE 1925GENOVA VICO DEL FIENO 1 INT. B CASELLA POSTALE 115
La cartolina porta il timbro postale del 30.1.1926 ed è indirizzataa tale Illustre dr. Luxardo, San Daniele del Friuli. Nessuna firma del
- 25 -
mittente. Sul retro della stessa cartolina è riportato il testo dell'epigra-fe con la postilla “Epigrafe dettata da Ceccardo RoccatagliataCeccardi”.
A questo punto tutto è diventato più facile ed abbiamo potutoapprofondire l'argomento con qualche ulteriore ricerca pressol ' A r c h i v i oComunale.
I n n a n z itutto, è neces-saria una brevebiografia diNazario Sauro.
La storia ciha tramandatol'eroica figuradi questo istria-no, nato aCapodistria nel1880 e fin dal-l'adolescenzanavigatore suivelieri nell'Adriatico, del quale ben presto imparò a conoscere ogniporto, ogni isola, ogni corrente. Pur cittadino austriaco, si arruola nel1915 volontario nella Regia Marina Italiana e come pilota su unitàsiluranti di superficie e subacquee porta a compimento 60 missioni diguerra in 14 mesi di attività. La notte del 30 luglio 1916 il tenente divascello Nazario Sauro riceve l'ordine di imbarcarsi sul sommergibi-le Pullino che deve uscire dal porto di Venezia per un'operazione disiluramento nella acque di Fiume. Forse ha un presentimento e lasciaad un amico due lettere, una per i figli, una per la moglie. Imbocca ilQuarnaro in una nebbia fittissima, ma le correnti lo portano ad inca-gliarsi su uno scoglio. Vani sono i tentativi per disincagliarsi ed all'al-ba l'equipaggio abbandona il sommergibile. Nazario Sauro imbarca-to su un battello a remi è scoperto da una nave austriaca. Pur condocumenti falsi, come tutti gli irredenti arruolati dall'Italia, Sauro èidentificato, incarcerato e ovviamente condannato a morte. Nega lasua identità, anche di fronte alla madre, sino al momento della con-danna. Il 10 agosto 1916 alle 17,45, Nazario Sauro è condannato
Fig. 1: Cartolina postale del comitato pro lapide a NazarioSauro
- 26 -
all'impiccagione. Due ore dopo, nel cortile del carcere di Pola sale sulpatibolo e le sue ultime parole sono: “Viva l'Italia, morte all'Austria”.La colonna romana che ricordava il luogo del suo martirio, fu tra-sportata a Venezia dagli esuligiuliani nel 1947 e collocata suun lato dell'ingresso del palaz-zo comunale1.
Nel 1925 l'Italia era appenaentrata, dopo le dubbie elezionidell'anno precedente, nell'erafascista e, pur nelle incerte pro-spettive, si respirava un climafortemente patriottico cheovviamente portava a celebrarele gesta dei combattenti dellaguerra vittoriosamente conclu-sasi sette anni prima. Gli eroiirredentisti erano ovunquecelebrati e fra questi appunto,Nazario Sauro. Soprattuttonelle città e nei paesi con tradi-zioni marinare questo corag-gioso marinaio fu, in questoperiodo, ricordato con monu-menti e lapidi. Citiamo a titolod'esempio la lapide posta nel 1926 su un lato di Palazzo San Giorgioa Genova, ma anche altri paesi liguri dedicarono all'epoca un monu-mento, una piazza o una strada al martire istriano.
Bogliasco non volle essere da meno ed il Commendator CesareGotusso si fece promotore del “Comitato pro lapide a Nazario Sauroin Bogliasco”, certamente prima del 1919. Infatti, il testo della lapi-de, come è indicato nella citata cartolina, fu dettato dal poetaCeccardo Roccatagliata Ceccardi che morì appunto nel 1919. Chi eraCesare Gotusso? Di lui ci resta una pittoresca descrizione sul volumepubblicato dal Club Nautico di Bogliasco nel 1975 in occasione del50° anniversario di fondazione. Il testo non è firmato ma lo crediamo
Fig. 2: Nazario Sauro
1 La data indicata sulla lapide di Bogliasco è in realtà il 18 agosto. Non sappiamo spiegarci la discor-danza se non supponendo un errore del compilatore stesso.
- 27 -
uscito dalla penna di Pierin Bozzo:… ritornata la pace, certo Cesare Gotusso, genovese, barbuta
figura imponente dall'abbigliamento di giolittiana memoria che sem-brava uscito da una copertina della “Domenica del Corriere” del-l'epoca venne a stabilirsi a Bogliasco suscitando nei giovani entusia-smi in ogni campo dovuti alla sua esuberante personalità e vasta cul-tura. Conferenziere, patriota e giornalista, fondò qui una sezionedella Lega Navale Italiana organizzando le prime regate del dopo-guerra con giuria dotata… di un tavolino e quattro sedie che veniva-no sistemate sulla “Ginestra”.2
Abbiamo ulteriormente potuto appurare che Cesare Gotusso eraun personaggio ben noto a Genova, quale Presidente dellaFondazione 1899, Controllo Chimico Permanente Italiano, operantea nel campo industriale, ma era altresì noto come esponente dellaLega Navale Italiana, della quale fondò una Sezione a Bogliasco nel1919, come giornalista e come storico; era stato anche il principalepromotore del Monumento ai Caduti di Bogliasco, eretto nel 1924.
Tornando alla lapide di Nazario Sauro, le cronache dell'epoca ciparlano di una solenne giornata prevista per il 4 novembre 1925 aBogliasco. Già da parecchi giorni i manifesti del Comune3, delComitato e del Partito Fascista, posti sui muri del paese pubblicizza-no l'evento che prevede sia lo scoprimento della lapide a NazarioSauro in piazza Umberto I°,4 sia di un'altra lapide posta presso ilCircolo Eolo5 e dedicata al patriota e pubblicista bolognese GiovanniVigna del Ferro.6 Il Monumento ai Caduti di piazzale Trento e Triesteè adorno di fiori e lampadine elettriche che alla sera lo colorano di
2 1975, Club Nautico Bogliasco 1925-1975, Grafica Errebi, Genova, Era, ed è ancora, chiamata "Ginestra" la passeggiata a mare, odierna via Bettolo
3 Archivio Storico del Comune di Bogliasco, Archivio di deposito, Cat.8 Leva e truppa, Cart.173(catalogazione provvisoria)4 Oggi piazza 26 Aprile5 Circolo culturale e ricreativo sorto nel 1921 posto sulla "Ginestra" presso l'odierno civ.7 di via
Bettolo.6 Giovanni Vigna del Ferro, giornalista bolognese, fu direttore del giornale bolognese "La Patria".Purtroppo a tutt'oggi le ricerche fatte per cercare di capire il legame di questo personaggio conBogliasco sono state senza esito. Nella Circolare di invito alla manifestazione, datata 29 ottobre 1925ed inviata dal Comune ad Associazioni e personalità del paese, si fa solo un generico riferimento al"patriota Giovanni Vigna del Ferro". Naturalmente mi auguro, anche con l'aiuto di questa pubblica-zione di poter chiarire prima o poi questa curiosità.
- 28 -
bianco rosso e verde, e dappertutto sventola il tricolore. Alle nove ilparroco don Andrea Dellepiane celebra nella parrocchiale la Messain suffragio ai Caduti, quindi un lungo corteo imbocca via Bettolo. Igiornali riportano un ampio elenco di autorità, personalità locali edassociazioni presenti.7 Innanzi al Circolo Eolo è scoperta la lapide aGiovanni Vigna del Ferro con deposizione di una corona d'alloro.Quindi il corteo riprende per Piazzale Trento e Trieste dove l'annoprecedente era stato inaugurato il Monumento ai Caduti. Dopo un'al-tra breve cerimonia con deposizione della corona d'alloro, il corteo sidirige in Piazza Umberto I per ilmomento culminante della mani-festazione. La lapide è posta sulpalazzo “della compianta signo-ra Samengo vedova Bozzo” oggiciv. 9, il testo già lo abbiamovisto, uno squillo di tromba pre-cede la scoprimento della lapide.Prende quindi la parola il cav.Pirola, membro del Comitato cheparla a nome del comm.Gotusso, promotore dell'iniziati-va, ma assente per una indisposi-zione, il quale consegna formalmente al sindaco, notaio Risso, lalapide marmorea.
A sua volta il sindaco prende la parola accettando il dono e por-tando il proprio compiacimento per l'iniziativa. L'orazione ufficiale ètenuta dall'avv. Felice Tavallini che in un discorso ovviamente riccodi intonazione patriottica, ma comunque ben accolto, elogia le gestadell'eroe istriano. Anche qui stranamente, non è fatto alcun accennoal patriota Vigna del Ferro.
7 Il Secolo XIX, Genova, 5 novembre 1925, Sono citati: Municipio, Partito Fascista, Marinai dellaRegia Marina comandati dal sottufficiale Ronzitti, Carabinieri, Regia Guardia di Finanza, Scuole, laBanda cittadina, le Madri dei Caduti, Enti ed Associazioni. Singolarmente il Sindaco avv. Cav. Not.G. Risso, l'assessore dott. Fravega, l'assessore Filippo Risso, i Consiglieri Comunali tutti colSegretario sig. Vaglio, il sig. Pandolfi, Segretario politico del locale Fascio, il cav. Pirola, Segretariodel Comitato Onoranze, il cav. Uff. Pollo giudice conciliatore, l'avv. Felice Tavallini, il cav. Uff. G.Razeto, il cav. Carbone, il cav. Dott. Risso, il cav. Salvagno, l'avv. Francesco Risso, il colonnelloBuffa, il pittore Ferrari, l'avv. Porrini, il dott. Orengo, il centurione Bestagno, il rev. Arciprete dott.Dellepiane, il rev. F. Fravega, il cappellano militare don Rossi.
Fig. 3: La lapide di Bogliasco
- 29 -
La giornata di festa ha una prosecuzione nel pomeriggio, presso ilocali delle associazioni cattoliche, dove alcune musiciste intrattengoun pubblico numeroso in un concerto di beneficenza a favore degliOrfani di guerra di Padre Semeria. Ricordiamo i nomi di questemusiciste come ci sono stati riportati dal Secolo XIX del giorno:Maria Risso e Maria Ratto al pianoforte, Maria Morelli al violino ela cantante Ines Palmieri. Durante lo spettacolo l'avv. Ettore RizzoPresidente della Sezione Ligure dell'Associazione Nazionale Alpini,da poco tempo allora costituita, presentato dal curato di Bogliasco eCappellano militare Bartolomeo Rossi, intrattiene un pubblico conuna conferenza ispirata ai valori della difesa della Patria.
Sul “Cittadino” del successivo 14 novembre troviamo riportato, amargine della cronaca della manifestazione, il testo del telegrammache il Presidente del Comitato, Gotusso, aveva inviato al Capo delGoverno per informarlo della cerimonia, nonché il testo della rispo-sta ricevuta da parte del Sottosegretario alla Presidenza del ConsiglioSuardo. È interessante riportarne i testi8.
Eccellenza Mussolini, Roma.
Scoprendosi con solenne rito Lapide marmorea perenne ricordomartirio Nazario Sauro pensieri palpiti volano Vostra Eccellenzameraviglioso artefice romana grandezza patria nostra dilettissima,pregandola gradire sincero commosso omaggio ammirazione infini-ta devozione religiosa - Presidente Comitato Comm. CesareGotusso.
E questa fu la risposta del Sottosegretario:
Comm. Cesare Gotusso, Presidente Comitato Pro Lapide NazarioSauro Bogliasco
A S.E. Presidente Consiglio Ministri sono giunti particolarmentegraditi sentimenti espressigli in occasione scoprimento lapide aNazario Sauro. Incaricami inviare suoi ringraziamenti per cortesemanifestazione - Sottosegretario Stato Presidenza ConsiglioMinistri, Suardo.
8 Il Cittadino, Genova, 14 novembre 1925.
- 30 -
L’ultimo frantoio di Sessarego
Valentina Penco
Ulivi e ancora ulivi nel paesaggio e nella storia di Sessarego, anti-co borgo del comprensorio bogliaschino; un binomio che risale aitempi più lontani, come fa capire un atto del 1148, che attesta il dovu-to pagamento di una decima sul raccolto di olive da parte di taleBolgarus di Cesanico, abitante di Sessarego1, a favore delle casse delVescovo di Genova, Siro2 .
Numerosi documenti d'archivio presentano riferimenti ad appez-zamenti olivati o menzioni di località dai nomi eloquenti, come“Oliveto”3, toponimo che indica la coltivazione prevalente; di essosi conoscono anche alcune varianti quali “Beu de l'Oia” o “Vallettadell'Oia”4, quest'ultima sopravvissuta nel comune parlare. Anche lastoria quotidiana della comunità sessareghina fa intendere l'impor-tanza che ebbe l'ulivo; nei documenti d’archivio compaiono, congrande frequenza, notizie di vendite di olio e di olive5 o di attrezza-ture legate alla conservazione del prodotto6.
Ma se la documentazione storico-archivistica è prodiga di richia-mi a terre “messe” ad uliveto e alla produzione locale di olio d'oliva,i riferimenti ai luoghi di produzione, i frantoi, sono, invece, allo statodelle conoscenze, inesistenti; tale lacuna rende assai difficoltoso ipo-tizzarne il numero e la localizzazione, nonché la storia.
L'indagine è stato affrontata, quindi, percorrendo la strada traccia-ta dall'interazione fra le testimonianze orali, sempre più rare, e le evi-denze materiali del ciclo produttivo individuate nel territorio diSessarego.
Sono stati individuati quattro frantoi a Sessarego attivi negli ulti-mi due secoli: in località Arbua, in località Riga, in localitàBonommu e in località Treie.
1 2004, P. L. Gardella - L. Sessarego, Storia di un borgo e di una chiesa, pag. 13, Genova. 2 1862, L.T. Belgrano, Cartario genovese ed Illustrazione del Registro Arcivescovile, Laus Consulumde olivarum decima de Nervi, Genova, ASLP, parte I, Fasc. II.3 Archivio Chiesa Parrocchiale Sessarego, R01, 17624 2004, P.L. Gardella - L. Sessarego. op. cit. pag. 156. 5 Archivio Chiesa Parrocchiale Sessarego, R01, 17676 Archivio Chiesa Parrocchiale Sessarego, R03, 1862
- 31 -
I gradi di conoscenza dei quattro frantoi rilevati sono differenti aseconda della quantità e qualità delle fonti di riferimento. Nel casodei frantoi in località Arbua e Bonommu, ci si può limitare a decre-tarne la localizzazione, resa possibile, già ad una prima ricognizione,dalla presenza di macine presso l'uscio dei due edifici, l'elevato pesodelle quali impediva che fossero allontanate dalla sede dell'opificio,e da testimonianze orali indirette, cioè tramandate di generazione ingenerazione. Sono irreperibili ulteriori informazioni, se non vaghededuzioni temporali prive di riscontri, che consentano di determina-re una plausibile epoca di inizio e fine attività. Per i frantoi in locali-tà Treie e Riga, invece, è possibile ricostruirne il funzionamento, ecollocare una plausibile data di inizio attività alla fine del XIX seco-lo, grazie ai ricordi familiari degli attuali proprietari e ad uno studiodelle attrezzature di servizio sopravvissute.
Purtroppo si deve registrare che il frantoio a Treie, è stato recen-temente smontato: solo alcune attrezzature sono state conservate, fracui le macine, "l'erbu"7 e gli ingranaggi che movimentavano le ruotein pietra della macina, di particolare interesse perché interamente inlegno.
L'ultimo frantoio ad essersi conservato nelle attrezzature, nell'ar-redo e negli utensili connessi alle varie fasi di produzione dell'oliod'oliva, è sito in località Riga, di proprietà del Sig. Carlo Sessarego.L'opificio, in uso sino agli anni 1994-1995, trova alloggio al pianter-reno di un'unità abitativa inserita in un complesso costruttivo che sisviluppa "a schiera" - da cui probabilmente il nome "a Riga" - secon-do i tradizionali canoni architettonici liguri. In tale complesso è statoidentificato il nucleo più antico del borgo di Sessarego8.
Secondo tradizione familiare, l'epoca di realizzazione del frantoio,o più probabilmente della prima attività, risalirebbe alla fine del XIXsecolo, traducendo l'espressione "al tempo del nonno di mio padre"più volte utilizzata dall'attuale proprietario9.
Infatti, a questo periodo va ricondotto l’ampliamento del vano apianterreno, aperto sulla via e funzionale ad attività di carattere pra-tico legate al contesto agricolo, per ottenere un ulteriore spazio cheospitasse un frantoio. Venne realizzato uno sbancamento a monte del
7 Supporto verticale in legno, o metallo, a cui erano fissate le macine atte alla molitura8 2004, P.L. Gardella - L. Sessarego. op. cit., pag. 1609 L’attuale proprietario è classe 1940
- 32 -
vano preesi-stente, doverimangono duemacine a testi-monianza diquesto primo, equindi più anti-co frantoio: unainserita nellapavimentazio-ne “a risseu”10
del locale, edindicata dall'at-
tuale proprieta-rio come “u leitu”, ossia la macina disposta orizzontalmente a costi-tuire il piano molitorio; un'altra abbandonata lungo il muro perime-trale nord. La denominazione del locale, “o giu du cavallu”, traman-datasi sino ad oggi, ci consente di identificare il frantoio ospitato inquesto vano, con la tipologia “a sangue”, ossia con macina azionatada forza animale. Il Sig. Sessarego racconta, attingendo alla propriamemoria familiare, che la macina “a sangue” dovette essere in fun-zione sino agli anni Venti del XX secolo, quando il frantoio iniziò abeneficiare dell'energia elettrica. Non restano invece tracce dell'anti-co torchio, probabilmente anch'esso “a sangue”, impedendoci di rico-struire l'originaria identità e disposizione del primo frantoio.
Negli anni 1948-49 il frantoio cambiò locazione: dal vano piùinterno a quello direttamente affacciato sulla via di passaggio, piùluminoso e più ampio, conservando la stessa destinazione d'uso sinoal 1994-1995, quando l'attività di produzione cessò definitivamente.
Lo spostamento dello spazio produttivo, dal vano retrostante aquello sulla via coincise con l'introduzione di una nuova macina,azionata ad elettricità, con vasca in muratura - così spiega il Sig.Sessarego - con bordo rialzato per evitare che le olive in via di fran-gitura potessero fuoriuscire "da u leitu", piano di macinatura. Sulpiano ruotava la macina mobile di pietra, probabilmente in arenaria,disposta verticalmente a “u leitu”, ed agganciata a un asse metallico“l'erbu”; questo terminava con una corona di ingranaggi ed era fis-10 Pavimentazione in elementi di pietra dalla pezzatura irregolare
Fig. 1: Pavimentazione "a risseu" con macina. Sono visibili resti di sansa
- 33 -
sato con un braccio ligneoorizzontale alle travi inlegno del soffitto, di cui ètraccia il foro a sezione ret-tangolare visibile nellospessore del muro divisoriodei due locali.
All'angolo estremo delvano, di fronte, alla macina,era disposto il torchio, cheera in legno e veniva azio-nato dall'uomo. Con lapasta delle olive, ormaifrante, venivano riempite“e sporte”, i fiscoli, cioècesti di canapa o iuta, chevenivano impilati in nume-ro di otto o nove nel torchio.Del torchio, in uso in questosecondo assetto del fran-toio, l'attuale proprietario hasolo ricordi d'infanzia: unastruttura con quattro mon-tanti su cui era poggiato un pezzo ligneo, “a cuffa”, all'interno delquale scorreva una lunga vite di ferro. La vite, azionata a mano,agiva su una tavola orizzontale “o mastellu”, che, abbassandosi sullapila di fiscoli, li pressava. Se la pila dei fiscoli non raggiungeva l'al-tezza sufficiente da essere direttamente a contatto con “u mastellu”,era integrata da un blocco di legno circolare, “u taccu”, ancora visi-bile.
La prima “stringitura”, cioè la torchiatura di una pila di fiscoli,fruttava il “primo olio”, cioè l'olio di prima qualità, che era ottenuto,se possibile, - così ricorda il Sig. Sessarego - senza la colatura diacqua calda sui fiscoli11. Man mano che si procedeva con le torchia-ture, sempre più faticose, era necessario versare un po' di acqua bol-lente sulla pila per ammorbidire la pasta di olive e favorire la fuoriu-
11 L'acqua calda non mancava mai: era a portata di mano nel "poio", forno a legna presente ancoraoggi nel frantoio.
Fig. 2: “taccu” per concludere la pila di fiscoli al tor-chio. Sullo sfondo “galocci” per il trasporto dell'olio
- 34 -
scita di olio12. Quindi, siprocedeva alla “schiumatu-ra”, cioè alla separazionedella massa d'olio dall'acquadi vegetazione o da quellaaggiunta nel corso dellalavorazione. L'olio venivadepositato nei “trogi”,apposite vasche di decanta-zione, per subire altre“schiumature”.
Seguiva una seconda“stringitura”: la pasta diolive, svuotata dai fiscoli,era rovesciata a terra peressere “ravvivata” a mano,cioè resa più morbida e mal-leabile, quindi, con essa, sipreparava una nuova caricaper il torchio. Nel frantoiodella famiglia Sessarego,sappiamo che per la secon-
da stringitura era utilizzata “a barì”, cioè una sorta di gabbia metal-lica, inserita nel torchio, nello spazio corrispondente alla pila delle“sporte”. All'interno della “barì” erano impilati i “panelli”. Si trat-ta di fiscoli in fibre naturali che non presentano alcuna apertura cen-trale; su di essi veniva spalmata la pasta di olive; incolonnati l'unosull'altro erano poi pressati senza l'uso “du mastellu”, ma diretta-mente dal cilindro del torchio. L'impiego della “barì” era riservatoalla seconda stringitura, cioè quando la torchiatura era più decisa,probabilmente perché dava sicurezza alla pila, che, altrimenti, privadi solidità, avrebbe potuto scomporsi13. Quando l'olio iniziava a“spurgare” dai fiscoli impilati, colava gradualmente nella base in pie-
12 Quando il torchio era ancora azionato "a mano", nelle torchiature più forti, si ricorreva all'uso del-l'argano , una trave verticale con appoggi orizzontali su cui facevano leva gli addetti all'operazione,essendo collegata al torchio con una robusta corda.13 Catalogo "Officine Bacigalupo. Costruzione macchine olearie - Impianti d'oleifici razionali brevet-tati."
Fig. 3: i “panelli”
- 35 -
tra del torchio, e poi nel sottostante recipiente in legno, “u galocciu",che trovava alloggio nella fossa scavata ai piedi del torchio.
Quindi, si procedeva alla schiumatura, cioè alla separazione dellamassa d’oliodall’acqua divegetazioneo da quellaaggiunta nelcorso dellalavorazione.L’olio venivadepos i ta tonei “trogi”,a p p o s i t evasche didecantazioneper subirealtre “schiu-mature”.
L 'ant icotorchio in legno di cui si parla fu sostituito da una pressa metallica,probabilmente negli anni Quaranta del secolo scorso, acquistata pres-so la nota Ditta “Luigi Bacigalupo e Figli” di Lavagna secondo unmodello che manteneva le stesse componenti di quello in legno soloche realizzato in materiale più. durevole.
Ma il frantoio della famiglia Sessarego subì ancora una rivoluzio-ne: nella stagione 1958-59, le sue attrezzature principali furono rin-novate con modelli più produttivi.
Il nuovo assetto fu definitivo. E tale rimase sino alla fine dell'atti-vità, negli anni 1994-1995, conservandosi sino ad oggi, e sopravvi-vendo all'introduzione nel mercato di tecnologie più efficienti.
La macina, luogo deputato alla frangitura delle olive, consiste divasca metallica a pareti rialzate, posta su piedistalli di sostegno, e didue ruote molitorie, “grappate” l'una all'altra, ambedue mobili, ingranito, secondo la tipologia prodotta dalla Ditta "Bacigalupo e Figli"di Lavagna, intorno agli anni 196014. 14Catalogo "Officine Bacigalupo. Costruzione macchine olearie - Impianti d'oleifici razionali brevet-tati"
Fig. 4: le ruote molitorie in granito
- 36 -
Anche la fasedella torchiatura fupotenziata, pur man-tenendo la doppia“stringitura”: al tor-chio già attivo se neaffiancò un secondo,acquistato dallaFamiglia Celle diBogliasco, che a suavolta aveva in attivitàun frantoio. Si tratta-va di un modello pro-dotto dalla Ditta“Bisso e Figli” diUscio, probabilmen-te degli anni Ventidel secolo scorso. Ifiscoli che si sonoconservati, in fibreartificiali, sono carat-terizzati da fori suentrambe le facce,ma di dimensioni dif-ferenti: l'una, piùampia consentiva dimettere la pasta d'oli-ve più comodamenteall'interno della “sporta”, l'altra, dalla circonferenza dimezzata aiu-tava l'azione dello svuotamento dei fiscoli.
Le caratteristiche aperture delle “sporte” fanno capire che nonerano impilate in un supporto verticale ma disposte l'una sopra l'altra,inframmezzate da dischi metallici, per aumentare la resa della tor-chiatura. L'operazione di carica del torchio prevedeva una serie diastuzie e passaggi fondamentali, frutto di un sapere pratico, oggi dif-ficilmente ricostruibile, perché fosse funzionale alla “stringitura”.Alla buona riuscita di una carica, incideva, oltre all'attenzione dell'ad-detto, che usava un bastone per correggere deformazioni della pila,
Fig. 5: il torchio che in origine apparteneva al frantoio della fami-glia Celle
- 37 -
anche la qualità delle olive portate a frangere: se troppo verdi, o trop-po mature, la pasta di olive “aveva un comportamento diverso”durante la torchiatura, tanto da poter esserci il rischio di dover “sca-ricare” la pila di fiscoli.
Se l'operazione filava liscia come… l'olio, si procedeva alla“schiumatura”. Anche quest'ultima fase di produzione venne modifi-cata quando fu abbandonata la sua esecuzione manuale con l’ausiliodi mestoli a base piatta per un separatore azionato meccanicamente.
L'olio, dopo essere stato filtrato, era pronto al trasporto. Si usava-no contenitori di legno o di latta, dalle varie misure, “galocci”, di cuirimangono ancora alcuni esempi nel frantoio. Molto interessante uncontenitore da trasporto in legno, con cinghie in pelle, con due fori:l'uno sul piano del contenitore, come foro per colare il “galoccio”,l'altro sul dorso, come foro d'uscita dell'olio.
Quando l'olio non era destinato ad essere immediatamente vendu-to, veniva conservato in giare; ne rimane visibile una, detta “delleanime” perché ogni cliente del frantoio, dopo aver franto le proprieolive, donava, a discrezione, una certa quantità d'olio, il ricavato dellacui vendita veniva dato in elemosina alla chiesa.
- 38 -
I Canterini di Sessarego
Luca Sessarego
Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando si stava anco-ra cercando di dimenticare le difficoltà della Grande Guerra, la neces-sità principale della gente era soprattutto quella di una tranquillità chepotesse durare a lungo, anche se già si gettavano le basi per lo scop-pio della Seconda Guerra Mondiale.
Erano tempi duri, in cui l'unica cosa da fare era rimboccarsi lemaniche per cercare di tirare avanti, specialmente in una realtà pre-valentemente contadina come era ancora quella di un piccolo paesecome Sessarego.
La vita nei campi era faticosa e impegnativa, e coinvolgeva tutti,dai bambini che avevano appena concluso le scuole elementari allepersone più anziane.
In particolare, intorno alla metà degli anni '30, ci fu a Sessaregoun periodo di grande abbondanza di olive, e questo spinse gli abitan-ti del paese ad avvalersi dell'aiuto di molte donne che nel periododella raccolta venivano appositamente a Sessarego dai paesi dellavicina Val Lentro, come Cisiano e Viganego. La raccolta delle olivea quel tempo era più faticosa di quanto non sia oggi, poiché non siusavano ancora le reti e le olive andavano raccolte anche per terraoltre che dagli alberi; è per questo che in quegli anni quasi ogni fami-glia aveva alle proprie dipendenze delle giovani donne che aiutava-no a degassâ (raccogliere le olive dagli alberi) e a cheugge (racco-gliere le olive cadute a terra). Queste donne molto spesso si fermava-no a Sessarego per tutta la settimana, per fare ritorno ai propri paesisolo al Sabato e alla Domenica, e a volte per il loro lavoro eranopagate anche in olio, un prezioso prodotto che dalle loro parti non siproduceva a causa dell'assenza di alberi d'ulivo.
Nonostante alla sera sopraggiungesse la stanchezza, non manca-vano i momenti per ritrovarsi in compagnia e cercare un po' di svago.
A Sessarego la strada carrozzabile per Bogliasco non esistevaancora (i lavori per la sua costruzione inizieranno solo nel 1956 perterminare nel 1959) e la televisione non era ancora stata inventata, ecosì la gente si ingegnava per trascorrere momenti di divertimento incompagnia. I più giovani, comprese le ragazze della Val Lentro, sirecavano nel salone superiore della Società Operaia di Mutuo
- 39 -
Soccorso dove potevano ballare al suono di una specie di pianofortea manovella, ed è forse a causa di questi frequenti incontri che tantedelle ragazze fureste si sono sposate a Sessarego e vi si sono stabili-te definitivamente. Le altre donne del paese si riunivano invece in scêTreie o sulla piazza della Chiesa a chiacchierare del più e del meno,mentre gli uomini si davano appuntamento ancora nella SocietàOperaia per giocare a carte, discutere o bere un bicchiere in compa-gnia.
È in questo contesto di difficoltà da un lato, ma di serenità e sem-plicità dall'altro, che intorno al 1930 nasce a Sessarego una vera epropria squadra di canto: “I Canterini di Sessarego”.
Ne facevano parte alcuni giovani del paese, che si servivano degliinsegnamenti di un certo Signor Coniolo, abitante a Genova; non sihanno notizie certe su quale fosse stato il motivo che avesse spintoquesto personaggio da Genova fino a Sessarego, ma forse un indiziopuò essere trovato ancora una volta andando ad analizzare le abitudi-ni degli abitanti di Sessarego in quel periodo.
Praticamente tutti a quell'epoca alternavano al lavoro nelle fascequello nelle stalle, dove quasi ogni famiglia teneva almeno un paio dimucche da latte. La quantità di latte prodotta in paese era quindiingente e con gli stagnüìn da venti litri pieni di latte la gente partivaa piedi da Sessarego per arrivare a Bogliasco, da dove con il trenopoteva raggiungere Genova per vendere a domicilio la propria mercealle famiglie genovesi.
Tramite questi frequenti e faticosi viaggi a Genova molti sessare-ghesi instauravano spesso rapporti di amicizia coi propri clienti, ed èfacile che il Signor Coniolo fosse uno di questi.
Fatto sta che la squadra di canto nacque proprio in questo periododalla voglia di divertirsi tutti insieme.
La specialità dei “Canterini di Sessarego” era l'esecuzione di cantiin dialetto genovese e la squadra era composta da parecchi elementi,tutti di Sessarego; purtroppo non è stato possibile reperire tutti i loronomi, ma tra essi ricordiamo per esempio u Bombolo, u Zingu, uTullin e u Russu.
C'erano poi, oltre alle voci, anche coloro che eseguivano l'accom-pagnamento musicale, come Rinâ che suonava la chitarra e uPantalin con il mandurlin (il mandolino).
Le prove della squadra avvenivano di sera, dopo il lavoro, nel
- 40 -
salone superiore della Società Operaia, e il maestro Coniolo venivaogni volta appositamente da Genova per insegnare a cantare ai gio-vani “Canterini di Sessarego”, per i quali si trattava sicuramente diun'esperienza nuova e divertente.
Una delle canzoni che i Canterini intonavano nelle loro esibizioniè giunta fino a noi. Il testo si apre con un simpatico messaggio cheevidenzia come esistesse, fin dai tempi più antichi, una sorta di “cam-panilismo” (in senso buono) tra Sessarego e Bogliasco, con un certoorgoglio da parte dei sessareghesi nel ricordare che secondo la tradi-zione Sessarego era stato fondato prima di Bogliasco.
Possiamo notare inoltre nel testo la presenza dei due cognomi piùdiffusi a Sessarego, e la citazione del Monte Cordona, il monte sullecui pendici sorge l'abitato di Sessarego.
Ma ecco il testo con la relativa traduzione in italiano:
Sessegu l'é fundou za primma de BuggiascuSessarego e Cevasco saveivan navigâ,
de sutta du Curdunn-aciü l'erba a cresce bunn-a
ciü u laete l'emmu bun,cuscì puemmu dî ai zeneixi de vegnîne chì
a çercâ, streppâ e viulette belle prüfümmae;pe-i mangiuìn gh'é i cappuìn
che a Zena de ciü belli nu ghe n'é.
Sessarego è fondato già prima di BogliascoSessarego e Cevasco sapevano navigare,
sotto al Cordonapiù l'erba cresce buona
più il latte l'abbiamo buono,così possiamo dire ai genovesi di venire qui da noi
a cercare, strappare le violette belle profumate;per i mangioni ci sono i capponi
che a Genova di più belli non ce ne sono.
Non esistendo una copia scritta di questo testo, che fino ad ora erarimasto solo nella tradizione orale, non è possibile individuarne l'ori-gine precisa; è probabile che lo stesso Coniolo ne sia stato l'autore,basandosi per il contenuto sui suggerimenti dei sessareghesi, ma è
- 41 -
anche possibile che questa canzone esistesse già nella tradizione diSessarego.
Le esibizioni dei Canterini si tenevano prevalentemente aSessarego, nella Società Operaia o alle feste del paese, ma si presen-tarono anche occasioni in cui la squadra si recò ad esibirsi fuoripaese.
L'attività della squadra di canto va avanti per tutti gli anni '30, fin-ché non ha inizio laSeconda GuerraMondiale. Un cosìdrammatico evento evi-dentemente portò nellavita di tutti i giorni deisostanziali cambiamenti,e la gente si sentì colpitadirettamente dalla trage-dia della guerra; moltigiovani dovettero partireper il servizio militare einoltre per gli abitanti diSessarego si fece semprepiù pericoloso recarsi aGenova per vendere ipropri prodotti.
Con l'inizio dellaguerra si fece inoltreviva nella popolazionedella grande Genova,come anche diBogliasco, la paura pereventuali azioni militari
in prossimità degli abitati; per questo già dai primi anni '40, sebbenenon ci fosse ancora il concreto pericolo di bombardamenti da partedegli americani, iniziarono ad arrivare a Sessarego decine e decine disfollati che fuggivano precauzionalmente dal fondovalle.
Sessarego infatti, essendo un abitato privo di importanti vie dicomunicazione, era considerato un luogo sicuro da quel punto divista, e così i sessareghesi si dimostrarono pronti ad accogliere paren-
Fig. 1: Raccoglitrici di olive di Terrusso
- 42 -
ti e conoscenti di Bogliasco e di Genova che avevano deciso di rifu-giarsi sulle alture. I nuovi arrivati si adattarono come poterono, dor-mendo nelle cantine o su delle brande in casa, e si dice che in quelperiodo gli abitanti di Sessarego arrivarono a toccare quasi le milleunità!
A questo proposito, per offrire alloggio agli sfollati si utilizzò per-sino il salone superiore della Società Operaia, in cui andò ad allog-giare il bogliaschino Virgilio Penco detto u Dragu, col figlio Pinodetto u Pappu e tutta la famiglia.
Ci si ritrovò quindi col principale luogo di incontro, il salone supe-riore della Società Operaia, utilizzato come alloggio circa dal 1940fino al 1945, e quindi inutilizzabile sia per il ballo che per le provedella squadra di canto.
Per il ballo gli abitanti di Sessarego utilizzarono quindi uno spiaz-zo creato in sciâ Rìa già nel 1920, quando la popolazione scelse que-sto luogo per costruire la nuova Sede della Società Operaia di MutuoSoccorso, per poi abbandonare i lavori ed optare per il luogo in cui sitrova tuttora in Co' da Cósta.
Lo spiazzo della Rìa rimase quindi a lungo inutilizzato, finché nonvenne adattato per il ballo; a quel punto la gente poté continuare adincontrarsi in sciâ Rìa per ballare, spesso al suono della fisarmonicasuonata da u Fiffi. Mentre per il ballo si corse ai ripari, al contrario i"Canterini di Sessarego" si ritrovarono senza un luogo in cui poterprovare. Con la complicità della guerra che rese difficile la vita anchea Genova dove abitava il maestro Coniolo, si arrivò allo scioglimen-to della squadra di canto, che ebbe quindi una breve esistenza, dal1930 circa, fino ai primi anni '40; forse, se non fosse stato per la guer-ra, la squadra di canto avrebbe potuto avere vita più lunga, e magarirestare in attività fino ai giorni nostri.
Fino a poco tempo fa il ricordo dell'esistenza della squadra dicanto esisteva solamente nella memoria delle persone più anziane,ma attraverso questa testimonianza speriamo di aver contribuito arendere noto un altro importante frammento della storia di Sessarego.
(Porgo un particolare ringraziamento a Giuseppina Cevasco, poiché senza lasua disponibilità a dedicarmi un po' del suo tempo e senza la sua memoria di ferronon mi sarebbe stato possibile scrivere questo testo).
- 43 -
Oscure pagine di storia di paese
ovvero
Che parte ebbero alcuni bogliaschini nella "Spedizione dei Mille"
Alessandro Siena
Partì da Quarto, Garibaldi, com'è noto, nella notte fra il 5 e il 6maggio del 1860. Quello che è meno noto e, per alcuni aspetti, risul-ta ancora alquanto oscuro, è il fatto che la spedizione - appena parti-ta - avrebbe dovuto fare una tappa alle prime ore dell'alba nello spec-chio di mare fra Sori e Recco per caricare un paio di centinaia di cara-bine, e un cospicuo numero (circa centomila) di cartucce.
Attore principale dell'organizzazione della partenza dei “Mille” fu- come riporta lo stesso generale Garibaldi1 - il genovese Nino Bixio.Questi aveva predisposto l'imbarco di diverse casse di armi e muni-zioni a Sori, dove due uomini di sua fiducia avrebbero dovuto guida-re i trenta Garibaldini, scelti da lui stesso e da Acerbi, in un punto delGolfo Paradiso - fra Sori e Recco - all'appuntamento con i piroscafiPiemonte e Lombardo per caricare, lontani da occhi indiscreti, le pre-ziose casse.
La sera precedente Bixio aveva riferito ai Garibaldini che avreb-bero riconosciuto i suoi emissari - l'appuntamento era presso il pontedi Sori - da una parola d'ordine. Questi avrebbero quindi consegnatoloro delle casse raccolte a Bogliasco e, in seguito, li avrebbero guida-ti sul luogo dell'appuntamento. A questo punto sorsero le perplessitàdi questi uomini, evidentemente abituati a questo tipo di operazioni,che chiesero a Bixio se gli uomini in questione non fossero per casogli stessi che tre anni prima, nel 1857, avevano guidato le barche cari-che di fucili e munizioni per Pisacane comandate da Rosolino Pilo2.Avevano ben di che preoccuparsi poiché quegli uomini avevano gui-dato così male il Pilo per il mare che non riuscirono ad incontrarsicon il piroscafo di Pisacane, che fu così costretto a procedere il suo
1 1973, Marcello Staglieno, "Nino Bixio", pagg.160-161, Rizzoli Milano, "Bixio è certamente il prin-cipale attore della sorprendente impresa. Il suo coraggio, la sua attività, la pratica sua nelle cose di maree massime di Genova, il suo paese nativo, valsero immensamente ad agevolare ogni cosa.", 2 1926, Giuseppe Cesare Abba, "Storia dei Mille", Bemporard & Figlio3 1926, G. C. Abba, op. cit.
- 44 -
viaggio senza armi. Al tale richiesta di sapere qualche cosa in più,Bixio rispose con un secco no, facendo notare loro che dovevanosolo ubbidire, recarsi a Sori ed aspettare: a loro non spettava “saperené il nome né chi vi guiderà, né dove incontrerete i vapori.”3
Fu così che quando questi uomini giunsero a Sori trovarono i dueche - a quanto pare - erano proprio gli stessi dell'episodio di tre anniprima (quando si dice che la storia si ripete…). Tuttavia sembravache le cose procedessero per il meglio: le casse con le armi - duecen-to carabine milanesi, con le munizioni - vennero caricate su duechiatte, ed uno dei due uomini, un certo Celle (o Selle) di Bogliasco,saltò a bordo di un leggero gozzo per guidare i trenta uomini all'ap-puntamento con Garibaldi.4
Qui comincia il giallo: le due chiatte non arrivarono mai all'ap-puntamento con i piroscafi di Garibaldi: “il Celle, quando fu buio, sene andò per i fatti suoi, lasciando i trenta uomini a brancolare allacieca in mezzo al mare”5.
Intanto pare che sui due piroscafi che incrociavano al largo dellacosta iniziasse uno scambio di informazioni a colpi di megafono fraBixio e Garibaldi, nel quale scambio il Generale venne a sapere chea bordo avevano mille e cento fucili circa, ma nessuna munizione.Queste sarebbero state caricate di lì a poco, portate da due chiatte gui-date da un contrabbandiere della zona, ma la storia la sappiamo e lemunizioni non arrivarono. Non potendo aspettare oltre al largo diRecco, poiché il sole si stava alzando e i due piroscafi avrebberopotuto destare i sospetti del console francese, che proprio a Reccoabitava, Garibaldi decise allora di continuare il viaggio senza muni-zioni: una soluzione la si sarebbe trovata.
Le munizioni poi raggiunsero comunque la spedizione dei Mille,i primi di giugno a Marsala, con una piccola spedizione di circa set-tanta uomini guidati dal siciliano Carmelo Agnetta6: duemila fucilibuoni fra i quali anche le duecento carabine Enfield che si credeva-no perdute nelle acque del Golfo Paradiso.
Si ha notizia dell'arrivo delle armi a Marsala anche da una letteradi Nino Bixio indirizzata all'agente di cambio Adolfo Parodi in
4 1960, Luciano Bianciardi, "Da Quarto a Torino", pag. 24, Feltrinelli5 1960, Luciano Bianciardi, op. cit.6 1960, Luciano Bianciardi, op. cit., pag. 98
- 45 -
Genova datata Palermo 4 giugno 1860, conservata presso laBiblioteca Universitaria Genovese7 che riportiamo in appendice.
Dallo stesso archivio di documenti emerge anche una lettera diAlessandro Centurini indirizzata a Bixio datata Genova 29 febbraio1860, nella quale lo stesso Centurini invia a Bixio una distinta di armida visionare. Armi prodotte a Birmingham, in Inghilterra8. Comeindicato sopra, risulta che le carabine “credute perdute” fossero cara-bine “Enfield”9. Da un'accurata indagine è risultato che questo parti-colare modello di carabine veniva prodotto in Inghilterra da diversifabbricanti di armi fra cui “Birmingham Small Arms” e "”Westley -Richards” sempre a Birmingham. Risulta inoltre che queste armi,oltre ad essere prodotte per l'Esercito della Corona Britannica venis-sero destinate all'esportazione, ed usate anche dall'Esercito Francese.
Da ciò sembra facile dedurre la provenienza di queste armi e rico-struirne - con un po' di fantasia - il percorso fatto: offerte a Bixio dalCenturini, importate dall'Inghilterra, passate per Milano, giunte aGenova nelle mani del Centurini, passate a Bixio che le consegneràal Celle il quale le conserverà probabilmente a Bogliasco per poi por-tarle a Sori.
Circa un anno prima, però, Bixio ricevette un'altra lettera, daParigi di pugno di un certo A. Rasi10, nella quale il Rasi, venuto aconoscenza “che si sta organizzando in Piemonte una legione chesarà comandata da Garibaldi e da Bixio, ofre 10.000 carabine model-lo francese 1857”. Queste armi potrebbero essere le stesse carabinedi tipo Enfield, ma dalla stessa lettera risultano prodotte nella mani-fattura di Chatellerault e, quindi, non sarebbero carabine Inglesi;nulla però esclude possano essere le armi che si trovavano già nellestive dei due piroscafi al momento della partenza dal porto diGenova.
Resta un mistero ancora da svelare il nome del Celle in questione,chi fosse veramente e che ruolo abbia giocato in tutta questa vicen-da. Dai dialoghi riportati fra Garibaldi e Bixio e Garibaldi e Turr nelle
7 Nino Bixio, Fondo Nino Bixio, Biblioteca Universitaria Genovese, Cassetta 6 foglio 2368 Alessandro Centurini, Fondo Nino Bixio, Biblioteca Universitaria Genovese, Cassetta 3 foglio 1159 1960, Luciano Bianciardi, op. cit., pag. 9810 A. Rasi, Fondo Nino Bixio, Biblioteca Universitaria Genovese, Cassetta 6 foglio 76
- 46 -
opere citate, emergono tre ipotesi: la prima espressa dal Turr è che ilCelle abbia consegnato le armi alla polizia locale, ma ciò sembraalquanto inverosimile poiché - se così fosse - è logico supporre chele armi non sarebbero mai più giunte a destinazione in Sicilia. Laseconda, forse più realistica, è che il Celle (e il suo compare dal nomeancora sconosciuto, forse Profumo o Perfumo11) avessero abbando-nato i Garibaldini per inseguire affari - ben più remunerativi - di con-trabbando di sete, tabacco e preziose spezie. Una terza riguarda unpossibile - ma non attualmente documentabile - interessamento diCavour nell'affare delle armi.
Nulla si è riuscito a sapere del nome del compagno del Celle, nési è trovato in alcun documento il nome di battesimo di Celle stesso.Da una ricostruzione della genealogia della famiglia Celle diBogliasco12 risulta che in quell'epoca erano vivi i seguenti membridella famiglia: Luigi Bartolomeo Celle (n. 1803 - m. ?), il Cap.Angelo Celle noto per essere stato il primo italiano ad attraversare ilcanale di Suez nel 1869 (n. 1806 - m. 1892), e Giuseppe Celle, tuttie tre figli di tale Gianbattista Celle. Se il Celle in questione era diBogliasco doveva essere, con buona probabilità, uno di questi o unaltro che è sfuggito alle ricerche.
Riportiamo per completezza il testo integrale delle tre lettere cita-te, conservate nella Biblioteca Universitaria Genovese, dal fondo N.Bixio.
11 1933, Carlo Agrati, “I Mille nella storia e nella leggenda”pp. 576 - 579, A. Mondadori, Milano12 Archivio Parrocchia di Bogliasco, registri vari
- 47 -
Cassetta 6 Foglio 236
SignorG. Adolfo ParodiAgente di cambioGenova
Palermo 4 giugno 1860Parte per Cagliari l'avviso l'Anthion e doveva anzi partire la scor-
sa notte. Trovandomi per caso presso il generale ho scritto in frettapoche righe perché seppi da un genovese giunto qui da Marsala evenuto da Genova con i Mile (sic) che da tutte le mie lettere fino al25 non una era giunta a Genova.
E' abbastanza singolare che malgrado tutte le cure per spedirleneppur una sia giunta, ma all'arrivo di questa spero che una almenol'avrà avuta, e sarà così cessata l'ansietà in seguito della diceria cheio fossi morto nel combattimento di Pianto Romano12b pressoCalatafimi. Quello che è certo è che io non fui neppure ferito, luttoche non risparmiassi per nulla la mia povera individualità, ma èsempre così, chi osa molto porta la morte nel campo nemico. E que-sto vi sia da guida per le altre volte. Io sono fortunatissimo e e nonho fin qui che una leggera ferita sotto la clavicola destra, e ferita cheappaia entrò senza toccare l'osso, e quello che mi al passaggio delponte dell'ammiraglio a Porta Termini.
Già passiamo di armistizio in armistizio, chè il Generale per suebuone ragioni concede al nemico. Noi aspettiamo oggi le armi sbar-cate a Marsala in 1700 e 100 mila cartucce.
La città è barricata, spirito è buono e gli armati molti e disposti.Certo l'armata napoletana che accampa il palazzo Reale e portaTermini è in condizioni infelici per demoralizzazione, ma non c'èdubbio che se si reprendono le ostilità possono, valendosi di tutti iloro mezzi terrestri e marittimi, fare molto danno e ridurre Palermoun mucchio di cenere, tanto più col sistema che tengono che ognicasa che abbandonano la incendiano.
Di tutto questo e di tutto il possibile sarà quello che sarà e potrà12b Località nei pressi di Calatafimi dove il 15 maggio 1860 vi fu una battaglia fra i Garibaldini e l'e-sercito Borbonico, nella quale i Garibaldini riportarono una vittoria, grazie alle capacità tattiche diGaribaldi
- 48 -
essere non so come sentano. Certe misure accennano all'imbarco egià stanno i regi imbarcando dal castello a mare tutte le armi e muni-zioni che si hanno in deposito.
D'altra parte questa notte è giunto l'Elettrico con materiale dibombardamento e di più col Generale Nunziante. Da varie voci chesi confermano le truppe di Trapani, Termini, Milazzo ed anche unaparte di Messina moverebbero per mare a Palermo. La rada diPalermo ha 14 legni di guerra pronti a fare quello che hanno fatto il27. 28. cioè a bombardare.
Tutto questo vedremo.Jeri è ripartito per Napoli il Generale Letizia, e il Generale non
crede ad attacco per via della sua … . In termini il G generali,Garibaldi è pieno di confidenza e sereno.
E' certo che a riprendere Palermo dalla 1a all'ultima casa - educcidere tutti, noi, ciò che deve costar loro molto sangue - intanto danoi li preparano molte barche all'Oderici e molte lancie - avremoanche 5 mila uomini armati di fucili, fra buoni e cattivi - se giungo-no i 1700. Saranno tanti di più - Sai addirittura che Medici sia sbar-cato - Medici o altri è certo che in grosso vapore inglese è stato vedu-to da gl'Inglesi all'Oriente di Sicilia, e lo si diè partito da Livorno il26 - e se questo è a quest'ora deve aver sbarcato in qualche punto.
Mandami una riga tua, e dirigila a Cagliari l'AnthionComandante Piola e nostro amico devoto la recherà a Palermo pres-so il Generale. Il Piola offre di far tutto per noi, e non è come quel-l'asino di Daste, il quale si conduce orrendamente da diplomatico.
Jeri mattina è ripartito da qui il Vittorio Emanuele giunto la seraprima.
Cosa fa la flotta nostra? Alcuni comandanti di vapori Napoletanida Guerra passerebbero a noi se vedessero forze marittime e ci avvi-sano degli ordini che ricevono (ma questo bisogna saperlo)
Io saluto tutti coloro che si interessano a noi ed a me in partico-lare (Mario, Adelaide le mie bimbe, e te, Colomba, Mario, Ettore,Papà, Michele, Filippino.
Com'è l'affare Luigi?Nino Bixio
P.S. vuoi una notizia che ti farà piacere e che devi dire alla sola
- 49 -
famiglia? Io sono fatto con ordine del giorno di oggi Generale - simanderà l'ordine del giorno ma sii buono di non dirlo ad altri che aiparenti.
Cassetta 3 Foglio 115Illustrissimo Signore
Questo mio amico Signor Nino Bixio, sotto i di cui auspici mi per-metto di dirigerle la presente, mi ha invitato a proporle varie partitedi fucili Inglesi, di cui tengo i campioni e dei quali le partite più omeno pronte si avrebbero per la fine del prossimo Aprile, Maggio oGiugno.
Dall'unita distinta V. S. rivelerà che nella Cassa Campioni chetengo ve ne sono di maggior o minor prezzo, si degni per altro osser-vare che la fabbrica di Birmingham, che le ha manifatturate, è laprima d'Inghilterra, e per conseguenza sono armi di fiducia.
Mi terrò fortunato poterla servire, ed alla di Lei richiesta stannoin mio magazzino in i campioni suddetti.
Colgo quest'occasione per dichiararmi e protestarmiDi V. S. IllustrissimaGenova 29 Feb.jo 1860Dev.mo Umil. Serv.Aless. Centurini
DistintaArmi di precisione cioè
1mo Un fucile modello francese con canna liscia con baionetta a f.chi 472do Un " " con canna rigata "
(Calcolato portare a 900 metri " 603zo Una bellissima carabina rigata per cavalleria " 604to Una " " " per bersaglieri con
Sciabola per baionetta (calcolata portare a 1000 metri " 80- Armi regolari -
5to Quattro buonissimi fucili a Capsula con baionetta così dettidi munizione, coi numeri seguenti
Num.° 898…………………………… " 25" 899……………………………… " 27" 900……………………………… " 30
- 50 -
" 901……………………………… " 36Suddetti pezzi s'intendono senza sconto per contanti contro con-
segna della merce, garantita uguale al campione nel portofranco diGenova.
Dal 1mo al 4to si possono avere 1000 fucili per quantità ovvero4mila per la fine Aprile: doppia quantità per fine Maggio.
Dei quattro tipi nel 5to, si possono avere 4000 per fine Aprile,8mila per fine Maggio, e 16mila fine Giugno p.v.
Salvi però i casi così detti di forza maggiore.
Genova 29 febbrajo 1860
Cassetta 6 Foglio 76Monsieur Nino Bixioau …de M. Adolphe ParodiAgent de Change a' Genes
Carissimo AmicoParigi, 9 Marzo 1859Ho saputo dal comune nostro amico Frapolli che si sta organi-
zando in Piemonte una Legione ché sarà comandata da Garibaldi eda te. Me ne raleggro sommamente e d'esidero di cercare, che ilnobile vostro esempio sia secondato da tutta la gioventù italiana.
Il 2 corrente spedii al sig. Colonello Cavalli Deputato al CorpoLegislativo di Torino una mia lettera diretta al Ministro della Guerrae lo pregai di presentarla e raccomandarla conteneva una mia offer-ta al Governo di Piemonte per 10,000 carabine modello francese1857 simili in tutto a quelle dei Caciatori Francesi, al prezzo di tarif-fa di questo Governo cioè di F 59 74 cmi più 50 cmi per imballaggioe cassa. Dicevo al Ministro che se il Governo Piemontese desidera-va subito queste armi, la manifattura di Chatellerandt che rappre-sento, le avrebbe chieste al Ministro della Guerra Francese ondeprenderle negli Arsenali dello stato, restando a carico dellaManifattura di restituirle al Governo Francese entro l'anno.
Se tu credi che queste mie Armi scelte possono essere buone perla tua legione scrivami due righe che sono a tua disposizione, e pron-to pure di venire a Turrino.
Ti dirò pure che ho a mia pronta disposizione altre 390 carabine
- 51 -
di commercio eguali al modello 1857 che possono darsi a migliorprezzo, perché non sono state fabbricate alla tariffa del GovernoFrancese però buonissime, come pure 2000 fucili modello 1855 e1857 rigati, ed altri 1842 non rigati.
Scrivimi due righe e cerca se puoi di spingere la mia domanda.Stammi sano e ritrai dal tuo amico mille augurii di sicurezza per
la nostra Italia.36 rue des petits champs A. Rasi
- 52 -
Progetto di ampliamento della Chiesa di San Bernardo
Pierino Bonifazio e Nora Marchese
Nell'Archivio della Chiesa Parrocchiale di Pieve Ligure(ACPPL) è stato rinvenuto un documento, foglio singolo scritto fron-te e retro, datato 1 Dicembre 1863, riferentesi ad una "Perizia dellaspesa per prolungare la Cappella di San Bernardo alla Pieve di Sori".
Il contenuto di questo documento, trascritto in Appendice 1, a unprimo esame superficiale, sembra un mero elenco di numeri in un lin-guaggio tecnico per addetti ai lavori. Approfondendo i dati e osser-vando l'attuale collocazione della Chiesa di S.Bernardo e degli edi-fici circostanti, abbiamo formulato due possibili interpretazioni: 1)alla data del documento (1863) la Cappella aveva dimensioni ridottee quindi i lavori del preventi-vo esaminato sono stati suc-cessivamente realizzati por-tandola alle dimensioni attua-li; 2) alla data del documento(1863) la Cappella aveva giàle dimensioni attuali ed il pre-ventivo non è stato seguitodalla realizzazione dei lavori.
Ad oggi non siamo ancorain grado di ricostruire lamappa e le date di costruzionedegli edifici attorno allaCappella né abbiamo potutodocumentare l'incrementodella popolazione, che vienecitato nello scritto come moti-vazione principale per giusti-ficare l'ampliamento dellaCappella stessa.
Durante l'analisi di altridocumenti provenienti dallostesso archivio, non sono state reperite altre informazioni che si rife-riscano ad interventi di ampliamento della Cappella di San Bernardo
Fig. 1: La prima pagina della perizia
- 53 -
con elementi concreti e precisi come quelli elencati in questo, puressendo stati incontrati riferimenti a diversi lavori di manutenzione edi restauri nel corso dei secoli.
Da qui, in attesa di completare l'analisi dell'archivio, cerchiamo diavallare l'ipotesi 1) con considerazioni e interpretazioni (fino ad oggipersonali) di altre informazioni rinvenute in documenti provenientida diversi Archivi; l'ipotesi è che il documento non è, e non è rima-sto, solamente un progetto ma è l'elenco dei lavori fatti nellaseconda metà del XIX secolo che hanno portato l'ampiezza dellaCappella alle misure odierne.
1) - Dal 1835 al 1875 fu Parroco di Pieve Ligure l'ArcipreteBartolomeo Bacigalupo: di lui, in una pubblicazione del 1913, l'allo-ra Parroco di Pieve Ligure, Sacerdote Gerolamo Rollino, dice che"… era ascoltato e seguito dalla popolazione anche per le opereesterne del culto, delle quali qui appena si stende una breve rasse-gna." 1 E senza dubbio la maggiore delle opere citate nella "rasse-gna" è il prolungamento della Chiesa di Pieve Ligure, avvenuto pro-prio nel 1863, su disegno dell'Architetto Matteo Leoncini (lo stessoche firma, in quell'anno, la "Perizia della spesa per prolungare laCappella di San Bernardo alla Pieve di Sori"!).
2) - Già nel 1839, la Cappella di San Bernardo era diventata suc-cursale della Parrocchia di Pieve Ligure, certamente con l'assenso, senon addirittura su proposta, dell'Arciprete Bartolomeo Bacigalupo2.
3) - Il 7 Agosto 1934, rispondendo ai quesiti della Curia che stavapredisponendo il decreto di elezione della Cappella di San Bernardoa "sede di una Vicaria Autonoma"3, il Cappellano di San Bernardo,Emanuele Re, così descriveva la Chiesa4:
“7 Agosto 1934 - Chiesa Succursale di S. Bernardo (PieveLigure)1) La chiesa fu edificata nel sec. 16° dalla popolazione2) E' una galleria lunga m. 18 alta m. 9 larga m. 7
1 1913, Sac. Gerolamo Rollino, Memorie Storiche della Parrocchia di Pieve di Sori, pagg. 52, 53,Genova,.2 Archivio Chiesa Parrocchiale di S. Bernardo, d’ora innanzi ACPSB, Notizie storiche antiche3 ACPSB, Carte diverse, 5 Dicembre 1934 4 ACPSB, Carte diverse, 7 Agosto 1934
- 54 -
3) E' ad una nave con tre altari di marmo bianco (Maggiore - S.Bernardo - N. S. d. Salute)
4) Le condizioni statiche e di manutenzione sono buone5) Fu allungata circa sessant'anni fa […]”
Da notare che il punto 2) riporta le misure attuali della Chiesa,mentre il "circa sessant'anni fa" del punto 5) potrebbe far collocare ladata di allungamento molto prossima alla data del documento inesame.
4) - Altre informazioni riguardanti l'edificazione e l'allungamentodella Chiesa di San Bernardo, ritrovate in documenti di diversa ori-gine e conservazione, sembrano imprecise, generiche, contradditoriee, forse, inattendibili:
4.1) - Sec. XVII.La chiesa è edificata con il concorso di tutta la popolazione.Lunga 18 m. alta 9 m. larga 7m Unica navata con tre altari dimarmo bianco (ACPSB Notizie storiche antiche).In questa, all'indicazione del periodo dell'edificazione sonoassociate le misure della costruzione che corrispondono a quel-le attuali.
4.2) - L'anno 1620 dalla parrocchia e comune di S. MiahelePieve Sori è stata eretta una cappella sotto il titolo di S.Bernardo fra le due ville del Poggio e Favaro, sogette allasop.a Parochiale abitati da fuochi cinquanta e più d'anime 200circa, tre miglia circa distanti dalla chiesa parochiale per ilcommodo in occasiono d'infermi in quelle parti di celebrare inquella la S. Messa e amministrare il S.S.o viatico come constain qualche urgente bisogno di quei popoli dalla parochia semanca un capellano a celebrare : è sempre stato come… horae sotto il governo di questa parrochia e comune; e … del par-roco senza … sino al presente. (ACPPL, Carte Diverse, 125Teriasca San Bernardo1700)
Attendibile per le informazioni locali e per la data ma senzaalcuna indicazione sulla grandezza della cappella.
- 55 -
4.3) - 1780 La chiesa è allungata di due arcate, verso l'ingresso (ACPSBNotizie storiche antiche).
L'informazione, ad oggi, è priva di alcun riscontro con altridocumenti.
APPENDICE
Perizia della spesa per prolungare la Cappella di San Bernardo alla Pieve di SoriLa cappella succursale di S. Bernardo alla Pieve di Sori, che serve all'uso degli abittanti di una parte di quella Parrocchia, non riesce più capace a contenere quella numerosa parte di popolazione. Pertanto fuprogettato di prolungarla di metri sei dalla parte del piazzale che si trova nanti la sua facciata, e di formarvi due cappelle incavate, con quei lavori accessori che saranno del caso, il tutto come risulta dalla seguente perizia.Metri cubi 36,40 di escavazione per le fondazioni dei muri, a lire 1,00 ciascun metro cubo . lire 36,40 Metri cubi 81,08 di muratura per il progettato prolun=gamento a lire 11,00 a metro cubo avuto riguardo alle forti spese di trasporto . lire 891,88 Metri q.ti 62,41 di tetto finito di armatura e copertura a lire 7,50 al metro quadrato . lire 468,07Metri q.ti 42,40 di soffitto nella nuova aggiunta della stessa forma dell'esistente a lire 2,50 . lire 106,00Metri q.ti 33,50 di pavimento eguale all'esistente a lire 4,00
lire 134,00Metri cubi 42,00 di muratura per incavare le due cappelle, a lire 11,00. lire 462,00Metri q.ti 19,60 di tetto per dette cappelle a lire 7,00.lire 137,20Metri q.ti 15,60 di pavimento per le stesse, a lire 4,00lire 62,40Costruzione di due altari nelle medesime cappelle, di tutto ultimati, a lire 130,00 ciascuno lire 260,00Per trasporto dell'attuale porta a mezzogiorno, e muratura dell'esistente, in complesso lire 26,00
- 56 -
Da riportarsi lire 2583,95
-------------- (Fine pagina)
Riporto lire 2583,85Per demolizioni occorrenti, e trasporto e nuova sistema=zione della porta dalla parte della facciata lire 75,00Per spese accessorie, e impreviste, in complesso lire 160,00Totale lire 2818,85Genova il 1 dicembre 1863Matteo Leoncini Ing.re
Nota: il documento contiene una discordanza fra il "Da riportarsilire 2583,95" dell'ultima riga della pagina 1 e il "Riporto lire2583,85 " trascritto nella prima riga della pagina 2. Il numero corret-to è quello della prima pagina ( 2583,95 ).
- 57 -
Fig. 2: planimetria odierna della chiesa di San Bernardo
‘a carapin-na
Francesco Antola e Luigi Re - illustrazioni Maria Ida Picasso
Durante la corsadella vita ebbi la ventu-ra di incontrare una per-sona molto speciale.Era di età molto avanza-ta, all'epoca aveva supe-rato i novant'anni, matalvolta amava raccon-tare, con molta luciditàe precisione e solo seprovocato, aneddoti edepisodi della sua lungavita, una vita vissuta intensamente e testimone dei grandi eventi sto-rici del secolo scorso.
Il suo nome?…da sempre lo chiamavano Giuvin. Sull'origine delsuo soprannome, un po’ originale, egli amava raccontare che suopadrino di battesimo era stato uno zio di nome Giovanni il quale,pochi mesi prima aveva tenuto a battesimo il figlio di un'altra sorel-la al quale avevano attribuito il nome Giovanni, come lui, in genove-se "Giuva". Quando fu chiamato a far da padrino al nuovo nipote(figlio di un'altra sorella) anche a lui, in suo onore, attribuirono ilnome Giovanni, ma per distinguerlo dal Giuva, di qualche mese piùgrande, gli "diminuirono" il nome riducendolo a Giuvin (Giuva pic-cin).
Giuvin, dunque, era nato, nei primi anni di quel secolo, quindiaveva accolto in sé, nel suo microcosmo, il riflesso dei grandi e pic-coli avvenimenti storici che hanno caratterizzato il "novecento", dallarivoluzione industriale all'industria automobilistica, alle due guerremondiali, al secondo dopoguerra denso di avvenimenti e di fermenticulturali, sociali, politici ed economici che hanno comunque grande-mente influito sul costume dell'uomo comune modificandone glistessi costumi di vita.
Spesso amava raccontare di quando, ancora bambino, andava avendere gelati in scê feste (sulle feste) patronali con la Carapin-na.
- 58 -
Fig. 1: i pezzi che compongono la carapin-na
Egli aveva, allora, forse dieci-dodici anni e, come in tutte le fami-glie numerose, a quel tempo, anche i bambini, anche i più piccoli,dovevano in qualche modo "darsi da fare".
Sua madre preparava il gelato usando uno strumento, che chiama-vano, appunto Carapin-na (forma dialettale della più nota"Carapigna").
La preparazione del gelato era tutt'altro che semplice perché asso-ciava alla conoscenza dei componenti gastronomici, doti di abilità"meccanica" non comuni e la necessità di una certa forza fisica.
Nel volume di Emanuele Rossi: "La Vera Cuciniera Genovese- facile ed economica - (Ed. Bietti di Milano, 1936-XIV) questo pro-cedimento viene illustrato compiutamente .
Si legge a pag. 259, ricetta n. 632 - Istruzioni speciali per fare igelati:
E' da avvertirsi primieramente che i gelati si formano con com-posti liquidi, i quali poi si fanno indurire in guisa di manteca per l'a-zione del ghiaccio frammista a sale.
…per ghiacciare abbisogna un secchio di legno avente inferior-mente un buco per dove si possa far sfuggire l'acqua che si forma dimano in mano nel fondersi del ghiaccio; una sorbettiera di stagno edun mestolo o spatola di legno a lungo manico.
Il "secchio di legno" è, appunto, la Carapin-na o Carapigna.
Continua l'A.: Si forma in fondo del secchio uno strato di ghiac-cio profondo circa 10 centimetri, si sparge su di esso del sale grossocomune, oppure salnitro (se costa meno) e vi si posa sopra la sorbet-tiera ben chiusa col suo coperchio, nella quale si sarà versato primail composto preparato.
L'Autore avverte di usare un secchio di un diametro maggiore diquello della sorbettiera…in guisa che tra le pareti di questo e quel-le della sorbettiera rimanga uno spazio anulare di sette otto centime-tri, il quale si riempie egualmente fino all'orlo del secchio con ghiac-cio e sale alternati…
Si lascia così in riposo la sorbettiera per 10 o 12 minuti, indi la siapre senza ritirarla dal secchio e si distacca col mestolo tutto ciò checomincia a gelarsi sulle pareti: ricondotta al centro la parte gelata,
- 59 -
si batte con lo stesso mestolo tutto il composto, intanto che collamano sinistra si fa girare sul ghiaccio la sorbettiera, la quale chiusanuovamente e impugnato il manico sovrapposto al coperchio, si fagirare ancora e senza interruzione per un quarto d'ora circa…
Queste operazioni di "girare con forza la sorbettiera immersa nelghiaccio, quindi aprirla per rimestare con forza il composto interno"quindi richiuderle per nuovamente girarla, sempre con forza, deveessere ripetuta più volte…finchè il composto siasi abbastanza indu-rito formando come una manteca compatta ed uniforme.
L'A. raccomanda di …aver cura di far sgocciolare di quando inquando, dal buco apposito che abbia accennato sopra, l'acqua cheandrà depositandosi sul fondo del secchio, ricolmando questo conaltro ghiaccio e altro sale.
Quando il gelato è pronto, si distribuisce in bicchieri o in piattiniadatti e si serve subito.
Nella sua accuratezza l'A. raccomanda che…dovendolo lascia-re qualche tempo nella sorbettiera conviene ad ogni poco rimestar-lo e sbatterlo, onde non si formino diacciuoli…
Proseguendo nel racconto della sua infanzia, Giuvin aggiungevache, dopo che sua madre aveva preparato il gelato come descritto,veniva messo in un cilindro di metallo (probabilmente di stagno)chiuso ermeticamente. Il cilindro, a sua volta, veniva posto in un pic-colo mastello a doghe di legno di dimensione maggiore, in modo chetra le pareti dei due recipienti si potesse inserire del ghiaccio (oggidiremmo tritato) alternato a strati di sale. Il tutto quindi (mastellocompreso) veniva avvolto da un sacco di iuta bagnato, affinchè man-tenesse fresche le pareti esterne del mastello, ed infine legato, concinghie a mò di zaino, sul dorso del "bambino" con la raccomanda-zione che, quando si fermasse per riposarsi un po’, lo facesse neipressi di una fontana o di un corso d'acqua, preoccupandosi di rinfre-scare il sacco di iuta per tenere sempre in fresco il mastello.
Allora quel bambino di dieci-dodici anni partiva dal fondovalledi Sori, ovviamente a piedi nudi anche perché…si era d'estate? e conquel fardello sul dorso si avviava là dove ci fosse qualche festa (perlo più patronale) arrampicandosi sugli impervi sentieri, viottoli omulattiere che, a quei tempi, si inerpicavano sui nostri monti perandare a Canepa, oppure sul Monte Cornua, in Becco, oppure scen-deva alla Madonna del Bosco di Pannesi. Privilegiava, però, Pieve
- 60 -
Alta, Santa Croce e San Bernardo non trascurando nemmenoTeriasca o Sessarego e gli altri "Paesi", ora Frazioni, sulle alture checircondano Insomma, tutte le feste erano buone; dalla prima a S.Apollinare di Sori il 19 marzo all'ultima che coincideva con quella diS. Matteo a Sussisa (che allora si festeggiava alla fine di settembre eche chiudeva il ciclo delle feste patronali).
A chi obiettasse che al 19 marzo fosse ancora troppo presto permangiare i gelati, si può rispondere che, evidentemente, non conosceS. Apollinare di Sori, le sue bellezze ed il suo clima. Per la sua parti-colare esposizione a levante in posizione elevata, ma a due passi dalmare, gode in inverno di una temperatura particolarmente mite, tantoche vi si coltivano e si colgono le "primizie" di verdura e di frutta.Appunto il 19 marzo vi si possono gustare le fave, ovviamente colsalame, seduti all'aperto, sui prati, quindi perché no un buon gelato?
Giunto sul luogo della festa, ilpiccolo Giuvin posava il suoumido fardello dove c’era piùgente, cioè nei pressi dell'uscitadella Chiesa, laddove si era siste-mata qualche altra bancarella chevendeva giocattoli, oppure le restedi nocciole infilzate ed i marron-sini ed i gubeletti (sorta di dolcet-ti vagamente somiglianti ai "brut-ti ma buoni" di colore nocciola-bruno, tendente al marrone chia-ro, quindi al marronsino) ed ireganissi di liquirizia od i motti ei çigàri di zucchero alla menta.
Allora Giuvin seduto presso ilsuo mastello, tirava fuori da unasacca i coni di cialda e con unaspatola di legno o di stagno li riempiva di gelato (aveva una conser-vazione maggiore del sorbetto).
Ovviamente la scelta dei "gusti" era piuttosto limitata, essendouno solo, quello che costituisce la base di quasi tutti i gusti, la crema.
Normalmente era accompagnato da una sorella più grande di lui,di forse due anni, che lo coadiuvava occupandosi dell'incasso.
- 61 -
Al ritorno a casa, alla sera, sempre scalzo, era felice di potermostrare alla mamma la Carapin-na vuota e le mani piene, di mone-tine di rame e, come compenso riceveva, oltre alla minestra, voglia-mo pensare, una carezza.
Questo anziano signore raccontava sempre con tenerezza queimomenti della sua vita di quando faceva U sciurbettè e ricordo cheuna volta mi indicò, vicino alla Chiesa di San Bernardo di Bogliascoun masso sul quale appoggiava la Carapin-na ed usava come banco-ne per i suoi gelati.
Parlando di lui, io stesso rammento che qualche "bambino di allo-ra" lo chiamava ancora garbatamente U sciurbettè o, anche , U sciur-bettiè, variandone la parola a seconda della località.
Ora U sciurbettè starà distribuendo i suoi gelati ai suoi coetanei inqualche festa patronale, forse in un remoto angolo di Paradiso e lagiornata è lunga ed il sole è sempre alto…per l'eternità.
Per chi volesse prendersi la briga di provare a fare il gelato nellasuddetta maniera, riportiamo la ricetta integrale ripresa, così com'è,dal citato volume di Emanuele Rossi: “La Vera Cuciniera Genovese- facile ed economica” (Ed. Bietti di Milano, 1936-XIV):
RICETTA N. 632. Istruzioni speciali per fare i gelati - E' daavvertirsi primieramente che i gelati si formano con composti liqui-di, i quali poi si fanno indurire a guisa di manteca per l'azione delghiaccio frammisto a sale. Tali composti hanno il più delle volte perbase o parte predominante il latte, talora il sugo di alcune frutta,qualche volta non sono che l'infusione o decozione di sostanze gra-dite: lo zucchero però vi è sempre unito in più o meno quantità,secondo indicheremo alle singole ricette dei diversi gelati (I).
Per ghiacciare abbisogna un secchio di legno avente inferior-mente un buco per dove si possa far sfuggire l'acqua che si forma dimano in mano nel fondersi del ghiacci; una sorbettiera di stagno, edun mestolo o spatola di legno a lungo manico.
- 62 -
(I) (NDT) I Genovesi distinguono in due specie di gelati, cioè chiamano mantecati quelli che hanno perbase il latte, e sorbetti quelli che risultano dal succo di qualche frutto o da un'infusione acquosa qua-lunque. In conclusione, i mantecati hanno effettivamente l'aspetto e la morbidezza pastosa di una man-teca; mentre i sorbetti, quantunque in apparenza simili a manteca, serbano un impasto granuloso emeno compatto.
Si forma in fondo del secchio uno strato di ghiaccio profondocirca 10 centimetri, si sparge su di esso del sale grosso comune, osalnitro (se costa meno), e vi si posa sopra la sorbettiera ben chiusacol suo coperchio, nella quale si sarà versato prima il composto pre-parato. Avvertite che la sorbettiera dovrà essere d'un diametroalquanto minore di quello del secchio, in guisa che fra le pareti diquesto e quelle della sorbettiera rimanga uno spazio anulare di setteod otto centimetri, il quale si riempie egualmente fino all'orlo delsecchio con ghiaccio e sale alternati, in modo però che quandooccorrerà di aprire la sorbettiera non possa cadervi dentro nulla diciò che la circonda.
Si lascia così in riposo la sorbettiera per 10 o 12 minuti, indi la siapre senza ritirarla dal secchio e si distacca col mestolo tutto ciò checomincia a gelarsi sulle pareti: ricondotta al centro la parte gelata,si batte collo stesso mestolo tutto il composto, intanto che colla manosinistra si fa girare sul ghiaccio la sorbettiera, la quale chiusala nuo-vamente, e impugnato il manico sovrapposto al coperchio, si fa gira-re ancora e senza interruzione per un quarto d'ora circa. Apresiposcia per la seconda volta la sorbettiera, si respinge come prima alcentro la porzione del composto aderente alle pareti, combinandolabene alla parte più liquida collo sbattere fortemente col mestolo tuttoil composto; e rinchiusa la sorbettiera, la si fa continuamente giraresul ghiaccio per indi riaprirla e rimestar con forza, ripetendo edalternando queste manovre finchè il composto siasi abbastanza indu-rito formando come una manteca compatta ed uniforme.
Durante quest'operazione devesi aver cura di far sgocciolare diquando in quando, dal buco apposito che abbiamo accennato sopra,l'acqua che andrà depositandosi sul fondo del secchio, ricolmandoquesto con altro ghiaccio e altro sale.
Quando il gelato è pronto, si distribuisce in bicchieri o in piattiniadatti, e si serve subito. Dovendolo lasciar qualche tempo nella sor-bettiera conviene ad ogni poco rimestarlo e sbatterlo, onde non siformino diacciuoli, essendo pregio del gelato l'uniformità e morbi-dezza del suo impasto.
Volendo dare ai gelati la forma d'un frutto o d'altro, come si usanei caffè, se ne riempiono apposite forme di stagno, le quali poi,chiuse ermeticamente, si pongono nel ghiaccio frammisto a sale, e visi lasciano per tre quarti d'ora onde il gelato indurisca assai.
- 63 -
Quando si vogliono servire questi gelati, detti comunemente pezzigelati o pezzi duri, si ritirano dal ghiaccio le forme, si immergonolestamente e per un istante in acqua calda, indi si asciugano e se nerovescia il contenuto su piattini adatti; si recano insieme ad un pic-colo coltello che serve per tagliare questi gelati troppo duri per esse-re spezzati facilmente da cucchiaino.
Restando in tema gastronomico può essere interessante descrive-re un piatto tipicamente ligure di questa zona, il Golfo Paradiso, que-sta volta è un piatto che si costumava nell’autunno-inverno: si trattadella "Polenta coi cavoli (neri)", da alcuni detta anche "polenta mar-morizzata", perché se tagliata, dopo averla fatta indurire, aveva unaspetto che richiamava vagamente quello di un marmo giallo-verde….
La ricetta, presa dal citato volume di Emanuele Rossi, è quellaindicata al n. 125 che riportiamo pedissequamente:
Polenta con cavoli - Mettete al fuoco in una pentola la quantitàd'acqua di cui abbisognate, salandola a dovere e, quando bolle, get-tatevi dei cavoli neri, o broccoli, onde farveli cuocere. Cotti chesiano, aggiungetevi la farina di formentone (300 grammi per ognilitro di acqua impiegata), rimestando continuamente con appositobastone (cannella) finchè la polenta sia cotta. Allora conditela conolio e alquanto formaggio parmigiano grattato. Rimestate ancora unpoco. E servitela caldissima.
Una variante personalizzata può essere rappresentata dall'aggiun-ta ai cavoli di una patata di pasta bianca tagliata a fette sottili.
Al momento di servire la polenta si raccomanda di aggiungere,nel piatto di portata, un filo d'olio extravergine e, non guasterebbeun cucchiaio di buon pesto, ma va a gusti.
La polenta così condita è qualcosa di sopraffino… ma le parolesono inutili, occorre gustare per poter confermare. La polenta puòessere tenera (molla, o dura (soda)o anche a gnocchetti (se…sba-gliata) ossia a bozzoli (co-i motti); bisogna saperla cuocere. Per gliuomini d'un tempo prendere moglie voleva dire prendere una donna1 1980, A. Schmuckher, Pesto e Mortà, G. Mondani
- 64 -
- 65 -
che sapesse anche fare bene da mangiare e sapesse quindi pure cuci-nare bene la polenta in una con tante altre cose come dice, allusiva-mente, una vecchia canzone popolare, riadattata da Piero Bozzo e nelcorso della quale, la nonna "mentre a stava sciusciando in tufeugo"raccomandava al nipote di prendere una moglie che, oltre alresto, "a no stagghe co-e braççe conzunte; a razionn-e co un po' delçervello… " e infine a…"mançinn-e con gaibo o cannello…". Il cheè tutto dire (A. Schmuckher - Pesto e Mortà - G. Mondani Editore1980).
Sulla tavola della festa non potevano mancare i "canestrelli", conla variante a base di mele ed, infine, i "Galletti", detti anche: "cuccul-li" , con la variante dolce chiamata anche " petti de moneghe" .
La ricetta dei primi è quella ripresa dal citato volume di EmanueleRossi, indicata al n. 325 che riportiamo:
Galletti (cuculli) di farina di ceci - Stemperate mezzo chilogram-mo di farina di ceci in tant'acqua quanta ne occorre per formare unintriso alquanto denso; unitevi un pezzo di lievito (crescente) dellagrossezza d'una noce e lasciatelo riposare per una notte. Indi rime-scolate assai meno con un mestolo, aggiungendovi un po' di sale, e,se vi piace, anche un po' di maggiorana tritata, e friggete questapasta ad olio bollente, gettandola in padella a cucchiaiate. Si servo-no caldi spolverizzati di sale.
La variante dei Galletti detta: "petti de moneghe" è quella che siottiene preparando una pastella a base di farina ed acqua alla qualedovranno essere mescolati uova e zucchero. Quando il tutto sarà benamalgamato e la pastella avrà una certa densità mettere a friggere acucchiaiate in olio. Prima di servire fare passare in carta stracciaaffinchè perdano bene tutto l'olio ed eventualmente spolverizzatecon altro zucchero (Ingredienti per 4 persone: 3 hg. di farina, 2 uova,150 g. di zucchero - A. Schmuckher op. cit.).
Dice il Casaccia che è frittella "grata al gusto". Il Giustinianiricorda che erano solite preparare questi Galletti (forse per ciò, conuna certa ironia, furon poi detti petti de moneghe) le Clarisse di
Rapallo ed erano, aggiunge lo stesso Giustiniani, “dolciumi saporiti”.Sciurbetti, Pulenta cui coi, cucculli, petti de moneghe, canestrel-
li… sono soltanto un "assaggio" della nostra cucina di un tempo enon può non richiamare alla mente quell'altra cucina, intesa per quelluogo dove si preparavano i cibi che le massaie, e non solo, sognava-no grande, con un grande banco dei fornelli tutto decorato con pia-strelle di ceramica bianca, col bordo turchino, u runfò, il forno,sovrastato da una grandissima cappa d'ardesia lunga quanto tutto ilbanco e che occupava la parete tutt'intera.
Non possono,allora, non sovvenire, richiamati dal cuore, iversi di un delicato poeta nostro, l'Acquarone che nel suo "Casa inRivea", canta:
Vorriae due stanse e 'na grande cuxinn-acon tanti ràmmi lucidi e o forno.
Un giardinetto esposto e mezogiornocon due tombe de fresca insalatinn-a
e tante grosse giare misse intornocon e piante da gustu o da mexinn-a:
………………'na toa d'ardesia all'ombra sotto o figo
co' o fiasco e 'n piatto de salamme e fave;un cagnetto bastardo e qualche amico.
- 66 -
Prescinse’ua
(Comme s'ùsa a Soi)
Francesco Antola - illustrazioni Maria Ida Picasso
Prescinsèua. Il Casaccia, nel suo "Vocabolario" ne da la seguentedefinizione:
"s.f. Mascarpina; Qualità di latte rappreso, ma d'un saporealquanto acido, che s'usa da noi in far torte, ravioli, ripieni, o altro.Dicesi anche volg. Quagliata".
Si tratta di un formaggio molle, o meglio, di un formaggio "inembrione", visto che il latte si è appena rappreso, quindi nella suaprima fase di formazione, allorché il latte ha iniziato a coagularsi.
A che cosa serva lo dice sempre il Casaccia nella sua definizio-ne:"…che s'usa da noi in far torte, ravioli, ripieni, o altro."
L'affermazione: "…che s'usa da noi" restringe già di molto ilcampo geografico (il "VocabolarioG e n o v e s e -Italiano, compila-to per la primavolta, da GiovanniCasaccia compar-ve per i tipi deiFratelli Pagano diGenova, nel 1851- n.d.r.), ma, oggi,il "campo" si èancora di più ristretto, considerato che è rimasta nell'uso quotidianoper lo più nel levante genovese, anzi nel Golfo Paradiso, quindi "danoi".
Fino a qualche tempo fa, fare la Prescinsèua , nelle nostre fami-glie era una cosa normale. Si prendeva il latte, magari quattro-cinquelitri e si versava in un grosso contenitore, possibilmente di terracotta(ùn cuncun) perché si riteneva che fosse più caldo, rispetto, ad esem-pio, a quelli di alluminio (l'acciaio era di là da venire). Quindi siaggiungeva al latte una punta di Prezù, per farlo rapprendere, poi siponeva il cuncun, in un angolo della cucina e si ricopriva con un
- 67 -
panno affinché rimanesse “al calduccio”, possibilmente riparato dallecorrenti d'aria.Il giorno dopo il si scopriva il cuncun per controllarese tutto procedeva per il verso giusto e, molte massaie, costumavanosegnarlo con segno di Croce. Trascorse quarantott'ore , si raccoglie-va il latte, che si era nel frattempo rappreso e si metteva su di un telo,possibilmente di lino, che si restringeva annodandolo per i quattroangoli (i quattru pissi) e si appendeva sul lavandino ù lavellu affin-ché ne scolasse il siero (à schèuggia).
I lavelli di allora erano normalmente di marmo scavato, i più dilusso in un unico blocco ed erano sovrastati da una mensola, anch'essa di marmo, della stessa lunghezza, infissa alla parete. Su di essaveniva, di norma, montata una “ringhierina”, di solito di ottone, cheserviva da scolapiatti, sostenuta da alcuni montanti fissati nel marmodella mensola. Appunto ad uno di questi montanti veniva, di norma,appeso per i pissi il “sacchetto” che conteneva la Prescinsèua.
Un discorso a parte deve farsi per il Prezù. Si legge, sempre, nelCasaccia:
“Prezù: s.m. Presame; Quella materia che si mette nel latte perrappigliarlo, o per farne cacio, ossia fior di cardi, o sia gaglio, oaltro…” (Op. cit.- n.d.r.).
Da noi si usava il ventriglio, cioè una parte specifica dello stoma-co dell'agnello o del capretto, che veniva variamente trattata ed essic-cata in un contenitore molto particolare: una parte anatomica tipicadei….tori.
Un'alternativa al Prezù era rappresentata da una spruzzata dilimone , ma si diceva che conferisse alla Prescinsèua un retrogustoamaro.
Il siero del latte, (à schèuggia), ovviamente non si buttava (cimancherebbe!), ma veniva utilizzata in cucina e data da bere a bam-bini perché “rinfrescava”. Quella che avanzava si mescolava al“pastone” per gli animali da cortile.
La Prescinsèua, di cui abbiamo visto la preparazione, veniva,come già detto, utilizzata nella preparazione dei cibi, torte di verdu-ra: “pasqualin-na, di bietola (de gè), negli zucchini e nelle melanza-ne ripiene e soprattutto nella regina delle torte salate: la torta di riso”.
Un tempo, particolarmente a Sori, con la Prescinsèua messa inuna forma apposita e lasciatavi qualche tempo, si producevano delleformaggette denominate: mollane che si usavano particolarmente
- 68 -
nella preparazione delle “focaccette col formaggio”. Ora si usa lostracchino, anche perché a Sori non c'è più chi alleva mucche, nean-che per il latte.
Se la produzione della Prescinsèua era abbondante, oppure se nonveniva consumata tutta al momento, per conservarla si costumavacospargervi sopra del sale fino.
Una tradizione “nostra” è poi quella di mettere la Prescinsèuanella preparazione del pesto che gli conferisce un aspetto cremoso,vellutato ed un sapore più morbido, per noi, più gustoso. Questausanza è criticata dai “cultori” del “pesto alla genovese”, quelli che
lo consideranotale solo se vieneutilizzato il “basi-lico di Prà” chedisdegnano (oignorano) l'usodella Prescinsèua.
Nulla da ecce-pire, ma noi uti-lizziamo il “basi-lico nostro”(importante è chenon sappia dimenta), quindi
lasciateci coltivare le “tradizioni nostre”.Una località, o meglio un Paese, un tempo particolarmente attivo
nella produzione di Prescinsèua era quello di Teriasca di Sori. Gliabitanti di quella zona, una bella valletta nell'entroterra di Sori, untempo erano particolarmente dediti all'agricoltura ed allevamento delbestiame e costumavano portare la Prescinsèua, le bietole e molti altriortaggi di stagione, a Genova per venderli a quei particolari esercizicommerciali che producevano torte e farinata che erano dei forti con-sumatori di Prescinsèua.
Col tempo i “teriaschesi” più intraprendenti (ì Tiaschè) mandaro-no i loro figlioli in quegli esercizi di torte e farinate, a fare i garzonet-ti per apprenderne il mestiere e molti di essi lo fecero con successo.
A proposito di Teriasca, rammento che conobbi un tempo un'an-ziana bottegaia della Rue (o Rovere), una località di Sori situata alla
- 69 -
Fig. 1: località Teriasca (Comune di Sori)
radice dell'antica strada mulattiera per Teriasca, Mari de Cechin,classe 1891, che a noi bambini raccontava una filastrocca che canta-vano i bambini di quando anche lei lo era (lei era originaria, ovvia-mente di un altro Paese, Canepa), per canzonare quelli di Teriasca. Sitenga presente che all'epoca, parliamo della fine del XIX Secolo, le“differenze linguistiche” anche tra le diverse Frazioni, o come sichiamavano allora, Paesi, del pur minuscolo centro di Sori eranopiuttosto rilevanti. C'era infatti un' accentuata dissomiglianza tra laparlata di quei di Teriasca e quelli di Canepa, oppure di Capreno, odi Sori (fino al 1929 i capoluoghi erano due perché due erano i distin-ti Comuni, Sori e Canepa).
I bambini, che ovviamente sono spontanei si canzonavano tra loroe quelli di Canepa cantavano a quei di Teriasca la seguente filastroc-ca:
Buzzi, Buzzi tradituì (1)che d'en pan ne fan duì (2)
e de duì ne fan n'a micca ( 3)che ghe un Diau cu se la picca. (4)Cun ùn massu de terragninn-a (5)
Tutti i Buzzi à marinn-a (6)Cun ùn tissun de feugu (7)
Tutti i Buzzi au séu lèugu… (8)
(1) …traditori è rivolto ai Buzzi (Bozzo), ma vogliamo immagi-nare non come insulto, ma in tono giocoso, come s'usa tra bambi-ni;(2) che di un pane, ne fanno due, quindi scaltri, operosi ed unpo'…fantasiosi;(3) la micca, sempre secondo il Casaccia (op. cit.) è “…vocenostra. Pane di figura bislunga.”;(4) …se la picca: se la prende, o meglio la contende con altri perportarsela via;(5) …terragninn-a: letteralmente: spago. Cordicella;(6) …à marinn.a: alla marina, sulla spiaggia;(7) ....tissun de feugu: tizzone di fuoco(8) …au séu lèugu: al loro luogo d'origine, donde erano venuti.
- 70 -
Ripetiamo che trattavasi di una fraseologia infantile, che nonintendeva certo offendere nessuno, ma la filastrocca non è scevra dalpalesare significati più reconditi.
Intanto è rivolta ai Buzzi dal fatto che la maggioranza degli abitan-ti di Teriasca portavano il cognome: Bozzo, mentre chi la cantava,essendo di Canepa, portava, in prevalenza il cognome: Benvenuto.
Benvenuto era anche, in prevalenza, il cognome della localitàCortino che dista dall'abitato di Teriasca meno di un chilometro.
Il Cognome Bozzo si trova anche in altre località del Levante ligu-re, ma mai così frequente e concentrato come a Teriasca.
Quei bambini, ingenuamente, riportavano un'antica leggenda chesi perde nella notte dei tempi.
I primitivi abitanti di Teriasca pare provenissero da Pieve (oraPieve Ligure) che nel periodo estivo portavano le mucche al pasco-lo nella vallata di Teriasca Estivo potrebbe essere infatti il nome diTeriasca che potrebbe derivare dal greco “terakòs” che significa“estivo”. Di questo parere è il sorese Paolo Benvenuto che avrebberaccolto documenti e testimonianze in tal senso (Storia di Sori di A.Castagnola e P. Schiaffino).
Altri invece lo fanno derivare da “corso d'acqua” e ciò in forzadella desinenza “asca” di Teri-asca che, come altre numerose locali-tà con desinenza “asca” oppure “asco” individuano luoghi normal-mente prossimi ad un corso d'acqua.
Ma tra i cognomi “arcaici” degli abitanti di Teriasca non trovanoriscontro il cognome Bozzo, né quello di Benvenuto.
Secondo la leggenda, ai primi abitanti della località si sonosovrapposti, nel tempo, altre persone che fuggendo dalla costa àmarinn-a si sono inoltrate nel vallone del Rio Cortino per poi fermar-si a Teriasca, poiché là terminava la valle. Avendovi trovando buonipascoli, aria salubre ed acqua corrente, si sono poi stanziati stabil-mente.
Ma esiste un’altra leggenda. che si colloca ai tempi delle numero-se scorrerie di pirati saraceni od algerini che tante volte devastaronoSori.
Una delle più memorabili, anche perché una delle più sanguino-se, fu quella del primo di luglio 1584 quando 1500 pirati Turchi,imbarcati su ventidue galee piombarono su Sori mettendola a ferro efuoco. Erano comandati dal feroce Ernadino, uno dei luogotenenti di
- 71 -
Dragut e dopo essersi abbandonati ad ogni genere di violenza ed averucciso un gran numero di persone se ne andarono perché avevanoavuto sentore che si stava muovendo contro di loro una forte flottagenovese comandata da Gian Andrea Doria, ma non prima di carica-re sulle loro navi una grande quantità di bottino e trascinandovi 134prigionieri di ogni età e condizione.
In una di queste scorrerie, si dice che i galeotti imbarcati su unadi quelle galere fossero riusciti a scio-gliersi dalle catene che li costringeva-no ai remi, quindi venuti a riva àmarinn-a e cercando un rifugio, pos-sibilmente lontano dal mare, si inol-trassero in quel vallone del RioCortino giungendo a Teriasca. E lìvissero e prosperarono nel tempo inuna condizione di parziale isolamen-to. Infatti Teriasca, per la sua naturamorfologica, è un po’ tagliata fuoridalle vie di comunicazione che colle-gavano le altre valli di Sori, ma que-sto isolamento garantiva la sicurezzadei suoi abitanti.
Fino a qualche decennio fa la viapiù rapida per salire a Teriasca dal
fondovalle di Sori era quella che partendo dalla località detta Rue oRovere, dove transitava la strada carrozzabile da Sori a Lago, si attra-versava il Torrente Sori con un ponte al cui altro capo transitava l'an-tica strada pedonale, quindi sottopassando una casa (ù burdigottu) siiniziava la lunga, dura ascensione verso Teriasca. Dopo poco tratto lastrada diviene erta e si incontra una serie di tornanti chiamati: Gi-òteal termine dei quali un'altra lunga salita raggiunge la località Cortinoe da lì con un itinerario quasi pianeggiante, si raggiunge Teriasca.
Ecco perché quei bambini volevano mandare tutti i Buzzi àmarinn-a ed a seu lèugu, forse, perché, inconsapevolmente, ripeteva-no quell'antica leggenda sull'origine degli abitanti di Teriasca.
Un esempio che è emblematico dell'isolamento del Paese, rispet-to agli altri è quello rappresentato dai cortei nuziali.
Infatti prima dell'unificazione fra Sori e Canepa, Teriasca era
- 72 -
compresa nel territorio del Comune di Canepa il cui capoluogo eranella Frazione Lago, situata a fondovalle, alla confluenza di due tor-renti (Levà e Sussisa). Là giungeva (e terminava) la strada carrozza-bile, vi erano mulini, un pastificio, i “lattai” cioè quei negozianti cheraccoglievano il latte dai contadini per portarlo alle centrali del latte,vi erano altresì numerosi negozi, l'Ufficio Postale e, naturalmente, ilMunicipio e la scuola.
I vecchi raccontavano che gli abitanti di Teriasca per sposarsi,anteriormente al Concordato tra l'Italia e la S. Sede, dovevano, cometutti gli altri, prima recarsi in Municipio per contrarre il matrimoniocivile, quindi ritornare al Paese per celebrare quello religioso. Nonera cosa da poco, perché il corteo nuziale doveva da Teriasca saliresulla costa del Monte, quindi proseguire lungo tutta la costa delmonte Quasego, quindi scendere a Lago per la ripida Masgea.Celebrato il rito, dovevano ritornare indietro…per la medesima stra-da…
Una curiosità: ai piedi della salita per Teriasca, alla Rue, in pros-simità del burdigottu esiste ancora una casa, forse un antico mulinoche poggia le fondamenta sul greto proprio alla confluenza tra ilTorrente Sori ed il Rio Cortino. Sulla facciata di levante, poco soprala strada leggesi ancora, un po' a fatica, un'antica scritta:
PRIMA DI FAREE DI DIRE PENSAA QUEL
LO CHE PUO' SEGUIRE1785
Questo “distillato di saggezza”, seconda una leggenda, pare chefosse la frase pronunciata da un Prete che stava fuggendo da Teriascaperché accusato, a torto od a ragione, di qualche nefandezza, ma diràla storia…
E' stato detto che la torta salata “regina” era quella di Riso e cipiace riportare la ricetta di una massaia che abitava a Sori in locali-tà detta “A' Muntà”, ora Via Manin, che costituiva la naturale prose-cuzione del “Carruggio” di Sori che, attraverso di essa, si collegavacon la “crèuza”di S. Gaetano (proprio una “crèuza de mà) che con-duce a Pieve Alta.
- 73 -
Per curiosità, l'abitazione di quella massaia distava poche decinedi metri da quella attribuita ai nonni materni di Pablo Picasso.
Torta di Riso alla moda di Maria Ida, cioè all'uso di Sori:
Ingredienti per 6 persone:
Per la pasta:g. 200 di farinasale2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
Per il ripieno:g. 200 di riso2 uovamezzo l. di latte3 cucchiai di olio extra vergine di olivag. 300 di Prescinsèuag. 50 di formaggio grana grattugiato sale e pepe di mulinello
Impastate la farina con l’olio, un pizzico di sale e tanta acqua perottenere un impasto morbido e liscio. Lasciate riposare per un paiod'ore, coperto da un canovaccio. Lessate il riso nel latte salato; appe-na il riso sarà al dente, versate il riso in una ciotola e lasciate raffred-dare; ora, condite mescolando insieme 3 cucchiai di olio, g. 250 diPrescinsèua , g. 40 di formaggio di grana. Spianate l'impasto con ilmatterello, in una sfoglia non troppo sottile; ungete una teglia, rive-stitene il fondo e le pareti con la sfoglia, versatevi il composto di risoe stendetelo uniformemente;sbattete le uova con la rimanentePrescinsèua ed il formaggio di grana rimasto, il pepe appena macina-to ed un pizzico di sale; il tutto stendetelo sopra al riso, ungete l'orlocon olio, quindi mettete al forno (180°) per circa mezz’ora.
- 74 -
Pieve Ligure: immagini di Jeri
a cura di Luigi Re
Prefazione e ringraziamento:
Quando mi venne proposto di aggiungere a questo quaderno unaserie di fotografie antiche di carattere paesaggistico su Pieve Ligure,rimasi piuttosto perplesso. Pensavo che tra pubblicazioni e mostrefotografiche varie sul tema, avessi dato fondo, salvo cadere nellaripetitività, a tutto quanto d'interessante vi fosse su Pieve com'era unavolta.
Dopo aver controllato quello che mi è rimasto del mio archivio,fotografico e cartaceo, dal quale potevo trarre solo alcune immaginiinedite e degne, e dopo aver passato l'elenco delle persone (Enti odAssociazioni) che negli ultimi decenni ci avevano gentilmente ed avolte con pazienza concesso l'utilizzo di materiali per la bisogna,rimasi ancor più perplesso.
Siccome se faccio un lavoro mi piace farlo bene o, quantomeno,accettabile e comprensibile, pensai: "mi deve venire un'idea." Edecco l'idea: "l'Emporio Capurro".
Il negozio, che ricordo bene, sia da bambino, sia da ragazzo, eraveramente il punto vendita nel quale trovavi-di-tutto: dagli alimenta-ri ai salumi, dai formaggi ai vini e liquori, dalla frutta alla verdura,dai primi detersivi a mano ai giocattoli; all'interno vi era anche unacabina telefonica (dalla quale noi ragazzini facevamo le telefonateche non potevamo o volevamo…fare da casa).
Dai "reganissi ai pascetti", dal necessario per cucire alla cartole-ria, dai tabacchi ai valori bollati…alle cartoline. Il tutto era gestito dalsignor Francesco Capurro e di lui famiglia.
Appunto le "cartoline postali!".Mi rivolsi allora alla figlia Anna Capurro chiedendole se avesse
conservato di quelle antiche immagini. Poco dopo la signora midiede una serie di dette, con la giusta richiesta che, se utilizzate, fos-sero dedicate al ricordo del padre.
Grazie, Anna. Luigi Re
- 75 -
(cartolina postale, prop. Luigi Re)
- 76 -
In alto, verso levante la Parrocchiale di S. Michele Arcangelo, colpiazzale ed il borgo di case ad essa attiguo. Sotto, la recente (all'e-poca) Via Amm. G. Bettolo, strada carrozzabile, che, finalmente,univa Pieve Bassa a quella Alta. Sotto, ancora, le case di Via Besso(località: "Castella") che erano ed sono tuttora attraversate da una"crèuza". Sullo sfondo Camogli e l'inizio del promontorio diPortofino.
Pieve Alta anni 30
(fotografia: prop.Luigi Re)
- 77 -
L'Ammiraglio Giovanni Bettolo con Autorità locali, ecclesiastiche ecivili, sul sagrato della Chiesa di S. Michele A. , in occasione dell'i-naugurazione della nuova strada carozzabile. La strada che, per lalunghezza di 2,5 chilometri unisce la parte bassa a quella alta delPaese, inizialmente era comunale e chiamata "Via G. Bettolo"; suc-cessivamente divenuta strada provinciale e chiamata "Via Roma".
Inaugurazione della nuova strada 1912
La costruzione venne progettata ed edificata (intorno agli anni '20)dall'allor giovane imprenditore sorese Prof. Domingo Rivarola, eraa strapiombo sul mare del più bel Golfo di Pieve e dintorni, tra lo"Scalo", a monte la ferrovia e la "Chiappa".L'audace e bellissima costruzione, terminata nel 1928, fu inaugura-ta con una sfarzosa festa, e divenne l'Hotel "Villa Rigatti".Nel dopoguerra, anni cinquanta, l'albergo venne, con un' adeguatatrasformazione al cambiamento dei tempi (l'orario dei treni erasuperato); furono ampliati i parcheggi e trasferite le cucine sul latodi ponente e soprattutto creata una stupenda piscina coperta e cli-matizzata nel lato mare sottostante, con una magnifica vetrata sulsottostante "Golfetto".L'Hotel Villa Regina, così fu chiamato, divenne uno dei più presti-giosi ed ambiti "Grand Hotel" del levante ligure.Negli ultimi decenni l'albergo è stato trasformato in "residence".
- 79 -
(c. p.: propr. Capurro Francesco, Riv. Tabacchi Pieve Lig.)
- 80 -
In primo piano la sede della "Società di M.S. Ardita" (tra la ViaAurelia e la linea ferroviaria), subito dietro le case di "localitàPertuso", lato mare le prime costruzioni in "Scalo Chiappa", con lascogliera che scende verso il mare, in Paese chiamata "le Punte".Sullo sfondo ed in lontananza, Bogliasco, Genova e la Riviera diPonente.
Panorama verso ponente anni 40/50
(c. p.: propr. Capurro Francesco, Riv. Tabacchi Pieve Lig.)
- 81 -
Veramente un “bel vedere” da uno dei terrazzi della Rotonda: sitacirca a metà strada della Via Roma. Sotto, quella parte di PieveBassa, lato Levante. All'interno si trova il “Parco dellaRimembranza”, con il monumento ai caduti Piovesi della prima eseconda guerra mondiale.Data l'interessante, ma vasta storia dello "Rotonda", mi riservo dipubblicare sul tema, un capitolo apposito in una delle prossime usci-te della presente.
Panorama dalla "Rotonda" Anni 40/50
(c. p. : propr. Capurro Francesco, Riv. Tabacchi Pieve Lig.)
- 82 -
Veduta di Pieve dalla zona "Demola" sede della vecchia stazione fer-roviaria del Paese, sino ai monti (lato ponente). Il territorio, antica-mente chiamato "località Corsanego", andava dallo "ScaloDemola" sino alle case di S. Bernardo (che, all'epoca, faceva partedel Comune di Pieve). Il tutto si può ricavare da antiche mappe della costa (v. M. Vinzoni).
Panorama anni 40/50
(c. p.: propr. Capurro Francesco, Riv. Tabacchi Pieve Lig.)
- 83 -
Un suggestivo colpo d'occhio a levante, dalla Pineta (probabilmen-te quella di S. Gaetano), col nostro mare ed una bella barca a veladell'epoca. Sullo sfondo il Monte di Portofino.
La pineta e il monte di Portofino anni 50