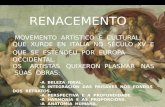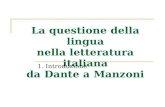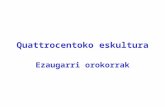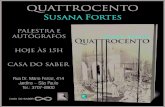La questione della lingua nella letteratura italiana da Dante a Manzoni 3. Il Quattrocento.
-
Upload
nunziatella-nigro -
Category
Documents
-
view
233 -
download
4
Transcript of La questione della lingua nella letteratura italiana da Dante a Manzoni 3. Il Quattrocento.

La questione della lingua
nella letteratura italiana
da Dante a Manzoni3. Il Quattrocento

L’umanesimo le scoperte rivoluzionarie di testi latini Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli Mantova, Vicenza, Padova, Ferrara e Urbino un’apparente mortificazione del volgare
letterario il ritorno alle fonti la purificazione della mente quello petrarchesco-cristiano della valle
padana quello civile-repubblicano della Toscana un netto regresso del fiorentino letterario

L’umanesimo volgare
Ciriaco d’Ancona (1391-1455): Commentaria
la nuova Repubblica Fiorentina de’ Medici
Cosimo il Vecchio la nuova Atene la lingua cortigiana
delle piccole corti dell’Italia settentrionale
Poliziano a Mantova
una progressiva desertificazione del neolatino
una prudente specializzazione di generi
Leon Battista Alberti una precisa
divisione dei compiti l’imitazione del
Boccaccio

Paradiso degli Alberti Giovanni Gherardi di Prato (1367-1443) Scusimi ancora l’ardentissima voglia che
continuamente mi sprona il mio edioma materno con ogni possa sapere essaltare e quello nobilitare, come che da tre corone fiorentine principalmente già nobilitato ed essaltato si sia; le quali io umilissimamente sì seguo non altrementi che’ dottissimi navicanti ne’ loro viaggi pel segno del nostro polo.
un elogio della lingua materna e delle tre corone fiorentine
Antonio Loschi, il cancelliere di Gian Galeazzo Visconti Loschi: Invectiva in Florentinos, 1399 Colluccio Salutati e Leonardo Bruni la prefazione del 1426

Coluccio Salutati (1331-1406) dal 1375 al 1406 cancelliere della
Repubblica il greco Manuele Crisolora lo Studiolo le Università di Parigi, Oxford o Salamanca Johannes Reuchlin (1455-1522) 1403, dopo la morte di Gian Galeazzo Invectiva in Antonium Luschum
Vincentinum un inno alla florentina libertas ed al suo
prestigio culturale

Salutati: Invectiva
Ubinam viri clariores? Et, ut infinitos omittam quos recensere taedium foret, rebus gestis insignes, armis strenuos, potentes iustis dominationibus et famosos? ubi Dantes? ubi Petrarca? ubi Boccaccius? Dic, precor, ubinam summum Italiae loco virisque, foedissima belua, poteris assignare, si Florentini sique Florentia faex Italiae dici possunt?
l’attacco milanese e la risposta fiorentina il prestigio linguistico del proprio territorio l’origine del volgare

Leonardo Bruni (1370-1444) cancelliere fiorentino dal 1427 al 1444 traduttore dal greco Laudatio florentinae Urbis, 1406 Historiae florentini populi libri XII, 1415 an vulgus et litterati eodem modo et
idiomate Romae locuti sint? nella Roma antica due lingue diverse:
una letteraria, l’altra volgare Flavio Biondo: De verbis romanae
locutionis, 1435 Vita di Dante e Vita del Petrarca, 1436 la perizia e l’arte del poeta

Bruni: Dialogi ad Petrum Paulum Histrum De interpretatione recta, 1426 Pier Paolo Vergerio il Vecchio di Capodistria 1401 e 1406 la degradazione della filosofia Salutati: Illud vero cogitare non possum, qua
tua ratione adductus dixeris, neminem fuisse iamdiu, qui aliquam praestantiam in his studiis habuerit; nam potes, ut alios omittam, vel tres viros quos his temporibus nostra civitas tulit, non praestantissimos iudicare: Dantem, Franciscum Petrarcham, Iohannem Boccatium, qui tanto consensu omnium ad caelum tolluntur?

Bruni: Dialogi Niccolò Niccoli: Quos tu mihi Dantes, inquit,
commemoras? quos Petrarchas? quos Boccatios? an tu putas me vulgi opinionibus iudicare, ut ea probem aut improbem quae ipsa multitudo? Non est ita. Ego enim cum quid laudo, etiam atque etiam quamobrem id faciam mihi patere volo.
At, mehercule, nemo est tam rudis, quem tam inepte scripsisse non puderet. Quamobrem, Coluci, ego istum poetam tuum a concilio litteratorum seiungam atque eum lanariis, pistoribus atque eiusmodi turbae relinquam.

Bruni: Dialogi Atque nihil unquam tanta professione praedicatum
est quanta Franciscus Petrarcha Africam suam praedicavit: nullus eius libellus, nulla fere maior epistola reperitur, in quam non istud suum opus decantatum invenias. Quid autem postea? Ex hac tanta professione nonne natus est ridicula mus?
Illud tamen commune eorum vitium est, quod singulari arrogantia fuere, nec putaverunt fore quemquam, qui de suis rebus iudicare posset; tantumque se ab omnibus laturos esse arbitrati sunt, quantum ipsi sibi assumerent. Itaque alter se poetam, alter se laureatum, alter se vatem appellat. Heu, miseros, quanta caligo obcaecat! Ego mehercule unam Ciceronis epistolam atque unum Virgilii carmen omnibus vestris opusculis longissime antepono.

Bruni: Dialogi Nam et Dantem ipsum quodam tempore ita
memoriae mandavi, ut ne hodie quidem sim oblitus, sed etiam nunc magnam partem illius praeclari ac luculenti poematis sine ullis libris referre queo: quod facere non possem sine singulari quadam affectione. Franciscum vero Petrarcham tanti semper feci, ut usque in Patavium profectus sim, ut ex proprio exemplari libros suos transcriberem. Ego enim primus omnium Africam illam hunc adduxi, cuius quidem rei iste Colucius testis est. Iohannem autem Boccatium quomodo odisse possum, qui bibliothecam eius meis sumptibus ornarim propter memoriam tanti viri, et frequentissimus omnium in illa sum apud religiosos heremitarum?

Bruni: Dialogi
Nam quod aiunt, unum Virgilii carmen atque unam Ciceronis epistolam omnibus operibus Petrarchae se anteponere, ego saepe ita converto, ut dicam me orationem Petrarchae omnibus Virgilii epistolis, et carmina eiusdem vatis omnibus Ciceronis carminibus longissime anteferre.
un compromesso politico ad maiorem patriae gloriam
Quis igitur hunc non amet? quis non observet, quis non in caelum tollat, quis non hos omnes vates maximam gloriae partem nostrae civitatis putet?

Lorenzo Valla (1407-57)
trattati di filosofia morale traduttore dal greco in latino riformatore del latino umanistico Elegantiarum linguae latinae libri VI la gloria dell’impero romano: Itaque nostri
maiores rebus bellicis pluribusque laudibus ceteros homines superaverunt, linguae vero suae ampliatione seipsis superiores fuerunt, tamquam relicto in terris imperio consortium deorum in caelo consecuti.

La nobile lingua dei maiores
Amisimus Romam, amisimus regnum atque dominatum; tametsi non nostra sed temporum culpa; verum tamen per hunc splendidiorem dominatum in magna adhuc parte regnamus. Nostra est Italia, nostra Gallia, nostra Hispania, nostra Germania, Pannonia, Dalmatia, Illyricum, multaeque aliae nationes. Ibi namque romanum imperium est ubicumque romana lingua dominatur.
l’umanesimo ciceroniano ↔ l’umanesimo civile

La letteratura maccheronica
una deformazione caricaturale Teofilo Folengo (1491-1544):
Baldus, 1521 Phantasia mihi plus quam phantastica venit
historiam Baldi grassis cantare Camoenis.Altisonam cuius phamam, nomenque gaiardumterra tremat, baratrumque metu sibi cagat adossum.

Francesco Colonna(1434-1527)
Hypnerotomachia Poliphili, 1499

Leon Battista Alberti (1404-1472) Giovanni Cavalcanti (1381-1451):
Istorie fiorentine in volgare dal 1420 al 1440 Grammatichetta vaticana, ~1450 Della Famiglia (1435-41) Ben confesso quella antica latina
lingua essere copiosa molto eornatissima, ma non però veggoin che sia la nostra oggi toscanatanto d’averla in odio, che in essaqualunque benché ottima cosa scrittaci dispiaccia. A me par assai di presso dire quel ch’io voglio, e in modo ch’io sono pur inteso, ove questi biasimatori in quella antica sanno se non tacere, e in questa moderna sanno se non biasimare chi non tace.

Alberti: Della Famiglia E sento io questo: chi fusse più di me dotto, o
tale quale molti vogliono essere riputati, costui in questa oggi commune troverebbe non meno ornamenti che in quella, quale essi tanto prepongono e tanto in altri desiderano. Né posso io patire che a molti dispiaccia quello che pur usano, e pur lodino quello che né intendono, né in sé curano d’intendere. Troppo biasima chi richiede in altri quello che in sé stessi recusa. E sia quanto dicono quella antica apresso di tutte le genti piena d’autorità, solo perché in essa molti dotti scrissero, simile certo sarà la nostra s’e’ dotti la vorranno molto con suo studio e vigilie essere elimata e polita.

Angelo Poliziano (1454-1494) Cristoforo Landino (1424-1498): Comento sopra la
Comedia di Dante, 1481 Epistola a Federico d’Aragona, 1476: Né sia però nessuno che questa toscana lingua
come poco ornata e copiosa disprezzi. Imperocché sì bene e giustamente le sue ricchezze ed ornamenti saranno estimati, non povera questa lingua, non rozza, ma abundante e pulitissima sarà reputata. Nessuna cosa gentile, florida, leggiadra, ornata; nessuna acuta, distinta, ingegnosa, sottile; nessuna alta, magnifica, sonora; nessuna finalmente ardente, animosa, concitata si puote immaginare, della quale non pure in quelli duo primi, Dante e Petrarca, ma in questi altri ancora, i quali tu, signore, hai suscitati, infiniti e chiarissimi esempli non risplendino.

Lorenzo de’ Medici il Magnifico (1449-
1492) discepolo del Landini,
amico del Pulci Comenti de’ miei
sonetti E però non pare che
l’essere comune in tutta Italia la nostra materna lingua li tolga dignità, ma è da pensare in fatto la perfezione o imperfezione di detta lingua.

Lorenzo de’ Medici le caratteristiche interne ed esterne del
fiorentino la sua perfezione linguistica e tradizione
letteraria la sua base politica radicata nel potere di Firenze E per queste medesime ragioni nessuno mi può
riprendere se io ho scritto in quella lingua nella quale io sono nato e nutrito, massime perché e la ebrea e la greca e la latina erono nel tempo loro tutte lingue materne e naturali, ma parlate o scritte più accuratamente e con qualche regola o ragione da quelli che ne sono in onore e in prezzo, che generalmente dal vulgo e turba populare.
pater patriae uno dei patres linguae communis