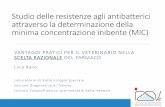antibatterici
-
Upload
ambra-salamandra -
Category
Documents
-
view
240 -
download
0
description
Transcript of antibatterici

Chimica Farmaceutica 1
ANTIBATTERICI
Variazioni strutturali

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Classificazione Classificazione in FAMIGLIE • famiglie di molecole che presentano caratteristiche simili (es. penicilline,
cefalosporine etc.) Classificazione secondo lo SPETTRO D'AZIONE • ampio: attività verso batteri Gram+ e Gram-
• medio: attività ad es. verso batteri Gram+ e verso taluni Gram- • ristretto: attività ad es. solamente verso batteri Gram+ o solo verso Gram-
Classificazione secondo il TIPO D'AZIONE • batteriostatica: l'antibiotico blocca la riproduzione dei batteri • battericida: l'antibiotico determina la morte dei batteri. Si definisce battericida l'antibiotico il quale dopo 24 h di contatto "in vitro” determina una sopravvivenza uguale o inferiore allo 0.01%

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Inibizione della sintesi della parete batterica • nella prima fase di sintesi: Fosfomicina • nella seconda fase: Vancomicina • a livello terminale: Penicilline, Cefalosporine Inibizione delle funzioni della membrana batterica • Polipeptidi (Capreomicina, Viomicina) • Lipopeptidi (Daptomicina) Inibizione della sintesi proteica • Subunità 30S dei ribosomi (aminoglicosidi, tetracicline) • Subunità 50S dei ribosomi (cloramfenicolo, macrolidi…) Inibizione della sintesi e della funzione del DNA/RNA • Inibizione della sintesi dei precursori (Sulfamidici, Trimetoprima) • Inibizione della replicazione del DNA ( Chinoloni) • Inibitori della RNA-polimerasi (Ansamicine, Metronidazolo)
Classificazione in base al bersaglio molecolare/meccanismo d’azione
Classificazione

Chimica Farmaceutica 1
Antibiotico Metaboliti microbici secondari di basso peso molecolare o sostanze la cui sintesi è ispirata ad essi, capaci di inibire, a basse concentrazioni, la crescita di altri microrganismi
Antimicrobico Sostanza attiva di origine naturale o sintetica che distrugge i batteri, ne sopprime la crescita o la capacità di riprodursi negli animali o negli esseri umani, a esclusione di antivirali e farmaci antiparassitari
Antibatterici
Terminologia

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Capacità di risultare tossici esclusivamente nei confronti dei microrganismi e non nei confronti delle cellule eucariotiche
Gli antibiotici debbono la loro tossicità selettiva:
• Assenza nelle cellule eucariotiche del bersaglio dell'azione degli antibiotici (es. parete cellulare)
• Diversa affinità del farmaco per strutture simili funzionalmente, ma non strutturalmente (es ribosomi)
• Diversa capacità di penetrazione del farmaco nelle cellule eucariotiche e procariotiche (es. tetracicline)
Tossicità selettiva

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Tossicità selettiva Gli antibatterici non possiedono attività nei confronti dei virus per l'assenza in quest'ultimi di bersagli specifici che possono indirizzare un'azione specificatamente tossica. Non si cura un raffreddore con gli antibiotici!

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Mercato
Nuovi antibatterici approvati negli USA, negli ultimi 30 anni
Vendite di antibatterici

Comunemente utilizzato il termine "antibiotico", in luogo di "chemioterapico antibatterico".
Catalogazione basata sul loro meccanismo d'azione (es.: inibizione della sintesi proteica) e, all'interno dello stesso meccanismo d'azione, in base alla loro struttura chimica (es.: inibizione della sintesi proteica - Macrolidi, Tetracicline, Aminoglicosidi, ........). • Scelta della adeguata terapia antibatterica dopo aver identificato l’agente
infettante • Nella pratica: intervento iniziale empirico, tenendo presente le tipologie
locali di infezione e chemioresistenza, oltre alla tipologia dei tessuti interessati.
• Profilassi antibatterica ristretta (interventi chirurgici, pazienti ad elevato rischio di endocarditi, sofferenti di febbri reumatiche, splenoctomizzati o comunque immunocompromessi).
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Antibatterici

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Batteri

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Batteri A: Batterio Gram positivo. Spesso strato di peptidoglicano contenente acidi teicoici e lipoteicoici. B: Batterio Gram negativo. Sottile strato strato di peptidoglicano e membrana esterna con lipopolisaccaride, fosfolipidi e proteine. Lo spazio periplasmatico e la membrana esterna contengono proteine di trasporto. La membrana esterna ha alcuni punti di adesione con la membrana citoplasmatica ed è legata al peptidoglicano mediante lipoproteine

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
PARETE BATTERICA: uno dei target più sfruttati anche perchè grazie alle differenze sostanziali con le membrane delle cellule eucariote permette una buona selettività
capsulacitoplasma
materiale nucleico
cell wall
membrana plasmatica
ribosomi
flagello
!Cellule procariote Cellule eucariote
membrana cellulare membrana cellulare
cell wall, indispensabile per la sopravvivenza
cellulare per la regolazione osmotica
---
materiale genetico senza nucleo definito nucleo ben definito
cellula “semplice” organelli (mitocondri...)
biochimica diversa (sintesi di vitamine) biochimica diversa (vitamine assunte dall’esterno)
Batteri

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
capsula citoplasma
materiale nucleico
cell wall
membrana plasmatica
ribosomi
flagello
SULFAMIDICI
POLIMIXINE
PENICILLINECEFALOSPORINECICLOSERINE
CLORAMFENICOLOSTREPTOMICINETETRACICLINE
RIFAMICINE
!
Batteri

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Target selettivi

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Resistenza Resistenza intrinseca Presente prima e indipendente dall’assunzione del farmaco Resistenza acquisita Compare in seguito all’esposizione della colonia al farmaco Fattori di resistenza (R) Plasmide caratterizzato dalla presenza di uno o più geni che conferiscono resistenza

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Batteri: identificati per la prima volta nel 1670 (dopo l’invenzione del microscopio). Padre della chemioterapia: Paul Ehrlich. Studiò istologia, immunochimica (studi per i quali ha ottenuto il Nobel). Nel 1904 postula il “Principio della Chemioterapia”: un agente chimico può interferire direttamente con la proliferazione di microorganismi a concentrazioni che siano tollerate dall’organismo ospite. Idea del “proiettile magico” con tossicità selettiva 1910: SALVARSAN, primo farmaco antimicrobico di sintesi attivo verso poche infezioni batteriche quali la sifilide e la malattia del sonno provocata dal tripanosoma. Usato sino allo sviluppo della penicillina, nel 1945.
Antibatterici
H2N
HO As As
NH2
OH 2 HCl
!
1934: PROFLAVINA (aminoacridina), attiva contro infezioni batteriche utilizzato durante la seconda guerra mondiale. Attivo contro il DNA batterico. N NH2H2N !

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Target selettivi

Chimica Farmaceutica 1
SULFAMIDICI
(Solfonamidi)
Variazioni strutturali
R1HN SO
NHR2O

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Solo nei batteri
Nei batteri e nell’uomo
• Fondamentale per la sintesi delle basi azotate (Timina ma anche purine) e quindi del DNA
• Fondamentale per la produzione di nuove cellule • Importante via metabolica in sistemi in marcata proliferazione
Acido Folico

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Solo nei batteri
Nei batteri e nell’uomo
Acido Folico
Sulfamidici Trimetroprim

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
• Composti di origine sintetica contenenti nella propria struttura una porzione p-aminobenzensolfonamidica.
• Analogia strutturale con l’acido p-aminobenzoico (PABA) • inibitori competitivi dell’enzima diidropteroato sintetasi, che catalizza la
formazione dell’acido diidropteroico nel ciclo biosintetico dei folati (l’affinità dell’enzima per i sulfamidici è 10.000 volte più grande di quella per l’acido p-aminobenzoico).
Sulfamidici
• Prontosil – colorante rosso • Attivita antibatterica in vivo (1935) • Inattivo in vitro • Metabolizzato a sulfonamide • Funge da profarmaco • Sulfanilamide – primo antibatterico attivo su un vasto range d’infezioni
H2N
NH2
NN S
O
NH2
O
Prontosil
Metabolism
Sulfanilamide
H2N SO
NH2
O

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici Viene inaugurata l’era moderna degli antiinfettivi
Anni ’30, Bayer: esame le proprietà antibattariche di una serie di coloranti al fine di trovare efficaci antibatterici Premio Nobel per la Medicina nel 1939 per la scoperta delle sulfonamidi

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Active site" Active site"
Ionic bond"
H-Bond"van der Waals"interactions"
O"C"
O"H" 2" N" S"
O"
O"N"R"H" 2" N"
• Diidropteroato sintetasi - enzima batterico • Non presente nelle cellule umane • Importante nella biosintesi del cofattore tetraidrofolato • Cofattore fondamentale per pirimidina e la biosintesi del DNA • Fondamentale per la crescita e divisione cellulare
• Inibitori competitivi • Agenti batteriostatici • Non ideale per i pazienti con sistema immunitario indebolito • Imita il substrato enzimatico - acido para-aminobenzoico • Lega il sito attivo e blocca l'accesso a PABA • Inibizione reversibile • Ceppi resistenti producono più PABA
Sulfamidici

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Active site" Active site"
O"C"
O"H" 2" N" S"
O"
O"N"R"H" 2" N"
Sulfamidici
I sulfamidici inibiscono la sintesi dell’acido diidrofolico nei batteri per competizione con il PABA alla 7,8-diidropteroato sintasi (DHPS) Si possono anche formare falsi metaboliti Tossicità selettiva: i batteri sensibili non sono in grado di assumere da fonti esterne l’acido folico

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici
HN
N NH
N
O
H2N
NH
COOH
HN
N NH
N
O
H2N
O P O P OH
O O
OH OH12
34 5
6
78
2-Amino-6-idrossimetil-7,8-diidro-3H-pteridin-4-one
acido diidropteroico
HN
N NH
N
O
H2N
NH
NH COOH
COOHO
acido diidrofolico

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici
HN
N NH
HN
O
H2N
NH
NH COOH
COOHO
acido tetraidrofolico
HN
N NH
N
O
H2N
CHO
acido folinico
L’acido folinico funziona da trasportatore di unità monocarboniose (1C) e pertanto partecipa a molte reazioni in diversi settori metabolici, fra cui la sintesi delle basi puriniche (C2 e C8) e pirimidiniche (sintesi della timina catalizzata dalla timidilato sintetasi). L’inibizione quindi della sintesi degli acidi folici impedisce la sintesi degli acidi nucleici batterici e quindi la loro replicazione.
I sulfamidici inibiscono solo gli organismi in fase di crescita e la loro azione batteriostatica è preceduta da una fase di latenza che può essere spiegata dai folati e dal PABA accumulati nella cellula. Il periodo di latenza continua fino a quando la riserva di acido folico non è esaurita.
Gli inibitori della diidropteroato sintetasi (sulfamidici e sulfoni) non esercitano effetto antifolico nell'uomo, in quanto nell’uomo tale enzima è assente.

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici Le solfonamidi sono chemioterapici batteriostatici nei confronti della maggior parte dei microrganismi gram(+) e verso molti gram(-). I microrganismi che non utilizzano la via biosintetica dell'acido diidrofolico (enterococchi, lactobacilli) presentano una naturale resistenza ai sulfamidici.
Il forte carattere elettron-attrattore del gruppo SO2 accresce l’acidità degli atomi di idrogeno legati all’azoto, rendendo così il gruppo funzionale leggermente acido (pKa = 10.4; pKa del gruppo carbossilico del PABA ≈ 6.5). La sostituzione di uno dei protoni del gruppo NH2 con un anello eterociclico elettron-attrattore aumenta l’acidità del protone residuo, portando il pKa fino a valori simili a quelli del PABA. Ciò potenzia l’attività antibatterica ed incrementa la solubilità in acqua di tali sostanze a pH fisiologico. Molte solfonamidi sono state quindi sintetizzate legando l'azoto solfonamidico (N1) a diversi etererocicli a cinque o sei termini.
H2N
SNHR
O O

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici: SAR
H2N
SNHR
O O• Influenza la pKa (bassa per
maggiore affinità, alta per penetrazione cellulare)
• Massimo di efficacia per un pKa di compromesso: 5.5-7.0
• Influenza il LogP (farmacocinetica)
• L’anello non deve essere sostituito • -NH2 e -SO2 devono essere in para • -NH2 libero (o gruppi labili)
• La disostituzione annulla l’attività • La forma attiva è la forma anionica

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Applicazioni terapeutiche • Batteriostatici a spettro ampio • Infezioni urinarie, gastrointestinali, respiratorie non complicate
Resistenza • Molto comune attraverso diversi meccanismi: • Sovra-produzione di PABA • Diminuzione della affinità della DHPS • Inattivazione del farmaco • Diminuzione della permeabilità cellulare
Farmacocinetica • Buon assorbimento po • Buona distribuzione tissutale
Effetti distribuzione tissutale-collaterali • Farmaci sicuri • Reazioni di ipersensibilità (sindrome di Stevens–Johnson)
Sulfamidici

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici
Sulfanilammide
Sulfametizolo
Sulfametossazolo
Sulfadiazina
Sulfafurazolo Sulfisossazolo
Trattamento delle infezioni del tratto urinario Trattamento delle infezioni intestinali Trattamento delle infezioni delle mucose Preparazione di lavande oculari

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici • L’attività antimicrobica delle diverse solfonamidi differisce di poco • Variano notevolmente le proprietà farmacocinetiche • Classificati in base al loro tempo di escrezione in sulfamidici ad azione breve (corta o
media) ed azione protratta (lunga o ultra-lunga) • Quelli ad azione breve, considerato che l’escrezione avviene principalmente per via renale
attraverso filtrazione glomerulare, sono escreti con le urine in elevata concentrazione e vengono utilizzati quindi nelle infezioni delle vie urinarie
• La solubilità nelle urine di alcuni sulfamidici (e di loro metaboliti: acetilderivati) ad azione breve (sulfapiridina e sulfadiazina) è piuttosto scarsa, dando luogo a fenomeni di cristalluria; preferibile somministrare una miscela di sulfamidici, evitando saturazione e conseguente precipitazione
• Soppiantate da sulfamidici ad azione breve maggiormente solubili (sulfadimidina e sulfafurazolo)
• Sulfametossazolo (azione media), sulfadimetossina, sulfametossipiridazina e sulfametossidiazina (azione lunga) e sulfadossina o sulfametopirazina (azione ultra-lunga) non raggiungono nelle urine elevate concentrazioni e raramente producono cristalluria; in compenso il loro uso è maggiormente associato a reazioni da ipersensibilità (compreso l’eritema multiforme o sindrome di Stevens-Johnson).
• La maggior parte dei sulfamidici N1-sostituiti viene ben assorbita dopo somministrazione orale, ma è possibile la somministrazione parenterale sotto forma di sali sodici solubili (a livello dell’azoto amidico), che presenta però l’inconveniente che i sali solubili sono altamente alcalini e provocano irritazione.

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici e profarmaci
HN SO
NHR2O
MeO
H2N SO
NHR2O
- CH3CO2H
Enzyme
• Gruppo ammidico: diminuisce la polarità della solfonamide • Gruppo ammidico: non può ionizzare • Gruppo alchilico aumenta il carattere idrofobico • Attraversamento della parete intestinale più facile • Metabolizzato ad ammina primaria da enzimi (ad esempio peptidasi) in vivo • Ammina primaria ionizza e può formare interazioni ioniche o agire come un forte
HBD
• R2 è variabile: diversi anelli aromatici e eteroaromatici • Influisce legame alle proteine plasmatiche • Determina i livelli ematici e la durata d’azione del farmaco • Influisce sulla solubilità • Influenza la farmacocinetica piuttosto che la farmacodinamica

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici HN S
O
HNO
S
NCMeO
H2N SO
HNO
S
N
Sulfatiazolo Insoluble metabolite Renal toxicity (precipitation)
N-Acetylation
• Metabolizzati con N-acetilazione, che aumenta il carattere idrofobico • Conseguente ridotta solubilità in acqua • Può portare ad effetti collaterali tossici: cristalluria
H2N SO
HNO
N
N
Sulfadiazina
• Tiazolo sostituito con un anello pirimidinico • Anello pirimidinico è più elettron-attrattore • Il protone della solfonamide è più acido e ionizzabile • Sulfadiazina e suo metabolita: più solubili in acqua,
ridotta tossicità • Sulfadiazina d'argento: uso locale per prevenire
infezioni delle ustioni
H2N SO
HNO
N
NH2N S
O
NO
N
NpKa 6.48
86% Ionized

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
+O
O
H3C
C2H5OOC
O
OH
H3C
C2H5OOC
N
OH
H
H
N
O
H3C
N3OC
N
O
H3C
NOC
Trasposizione di Curtius
N
O
H3C
C2H5OOC
O2N SO2Cl
N O
CH3H2N SO2NH
N
O
H3C
H2N
Sulfametossazolo
Δ

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
N
N
H2N
O
H
H
C2H5O
O
H
H
NH2
NH
H2N
O2N SO2Cl
O2N SO2NH
N
N
H2N SO2NH
N
N
Sulfadiazina
+ oppure

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Sulfamidici
H2N SO
HNO
NN
MeO OMe
N
N
ClNH2
NH2H3C
Pirimetamina
• Nuova generazione di solfonamidi • Antibatterico “long lasting” • Una somministrazione settimanale • Sulfadossina + pirimetamina = Fanisdar • Usato per il trattamento della malaria
Sulfadossina
Succinil sulfatiazolo
HN
OO2C
SO
HNO
S
N
• Agisce come un profarmaco del sulfatiazolo • Ionizzato nelle condizioni alcaline
dell'intestino • Troppo polare per attraversare la parete
intestinale • Concentrato nell'intestino • Lentamente idrolizzato dagli enzimi intestinali • Usato contro le infezioni intestinali

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Blocca la produzione di acido folico legando e inibendo reversibilmente la diidrofolato reduttasi (DHFR)
Lega selettivamente la DHFR batterica (non quella dei mammiferi)
Trimetoprim
USO Da solo: Trattamento delle infezioni non complicate del tratto urinario (da E. coli e altri G-) In associazione con sulfametossazolo (Co-trimoxazole, Bactrim): prima scelta per la polmonite da Pneumocystis jiroveci, indicato per la toxoplasmosi e la nocardiosi; per le esacerbazioni acute della bronchite cronica e le infezioni delle vie urinarie
La scoperta di nuovi antibiotici, a largo spettro e meno tossici, ha segnato una battuta d’arresto nell’impiego dei sulfamidici ed attualmente essi trovano maggiore uso nelle associazioni con trimetoprim, con la quale manifestano sinergismo d’azione. Anche trimetoprim inibisce la sintesi dei folati, agendo però in una tappa succesiva della biosintesi, in particolare a livello dell’enzima diidrofolato reduttasi, che catalizza la trasformazione dell’acido diidrofolico in tetraidrofolico.

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Trimetoprim
+CH3ONa
O
H3CO
H3CO
OCH3
H
N
H2N
H3CO
H3CO
OCH3
N
N
NH2
N
H3CO
H3CO
OCH3
OCH3
H
NH2
N
NH
H
H

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Altre associazioni
H2N
HO O
NH2
OO
OH
OH
NH2
O
O
HO
HO
HO
H2N
O
OH
HO
NH2
H2N SO2NH
S
N
Neomicina Sulfatiazolo
• Profilassi di ferite e abrasioni • Cura di infezioni cutanee e mucose

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Altre associazioni • Effetto antiinfiammatorio, antibatterico
ed immunodepressivo • Usata negli stati infiammatori, in
particolare quelli della mucosa intestinale (colite ulcerosa)
• Somministrazione per via orale • Assorbimento parziale nell'intestino
tenue, con successiva escrezione dalle vie biliari tramite il circolo enteroepatico. Nel lume del colon, la sulfasalazina viene scissa in due metaboliti principali: sulfapiridina e acido 5-aminosalicilico
Si ritiene che l'effetto principale del farmaco sia l'azione antiinfiammatoria dell'acido 5-aminosalicilico formatosi localmente. E` stato evidenziato un effetto immunodepressivo il cui meccanismo si basa sulla inibizione del metabolismo dei linfociti e granulociti, nonché di vari sistemi enzimatici da parte dei tre componenti (sulfasalazina, sulfapiridina, acido 5-aminosalicilico). Effetti collaterali: nausea, anoressia, sofferenza gastrica, emicrania, oligospermia.
N
N
N OH
COOH
HN S
O
O
Sulfasalazina

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Altre associazioni
Sulfamazone N N
OCH3HN SO2NHN
N
CH
O
H3C CH3
SO3Na
Prodotto di sintesi che comprende: • nucleo pirazolico dell’antipirina e • nucleo sulfamidico della sulfametossipiridazina
• Azione antipiretica, antiflogistica e antibatterica • Attività antibatterica paragonabile a quella svolta dai sulfamidici a basso dosaggio
e lenta eliminazione • Indicato nella cura delle malattie respiratorie acute: faringotonsilliti e
tracheobronchiti batteriche primitive o complicanti l'influenza o le altre malattie virali delle prime vie respiratorie
• Ben assorbito sia per via orale che per via rettale; le concentrazioni ematiche terapeuticamente efficaci si mantengono per lungo tempo
• Controindicazioni tipiche dei sulfamidici (raccomandati periodici controlli della funzionalita' epatica, renale e della crasi ematica).

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Solfoni
N
NH2N
NH2
S
NHR1
OO
• Si pensa inibiscano la diidropteroato sintasi • Usati nel trattamento della lebbra

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Target selettivi

Chimica Farmaceutica 1
ANTIBATTERICI CHINOLONICI
Variazioni strutturali

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni
Chemioterapici battericidi che agiscono, come la novobiocina, inibendo la DNA-girasi e/o la topoisomerasi IV. La DNA-girasi batterica è una DNA-topoisomerasi di tipo II che catalizza il superavvolgimento negativo del DNA procariotico. La DNA-girasi è formata da due proteine (A and B) e la specie attiva è rappresentata da un eterotetramero (A2B2). La topoisomerasi IV è un altro enzima di tipo II riscontrabile nei batteri, ma a differenza della girasi è incapace di catalizzare il superavvolgimento: il ruolo di tale enzima sembra essere quello di liberare i cromosomi nello stadio finale della replicazione del DNA.

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
DNA Topoisomerasi DNA topoisomerases are the magicians of the DNA world
• Enzimi essenziali nella modificazione della topologia del DNA in modo che questo possa esprimere le sue funzioni.
• Nelle cellule il DNA è super-avvolto • Il grado di super-avvolgimento è quantificato dal numero di legame Lk (numero di
volte che un filamento di DNA si avvolge attorno all’altro in maniera destrogira) Topoisomeri: • Due molecole di DNA che differiscono tra loro soltanto per una variazione del numero
di legame Lk • Le topoisomerasi catalizzano la conversione tra topoisomeri
Reazioni di transesterificazione
• Rottura legame fosfodiestereo • Formazione legame fosforo-tirosinico • Un’opposta reazione di
transesterificazione determina la riformazione del legame fosfodiestereo
Due classi: DNA topoisomerasi di Tipo I (TOPO1) DNA topoisomerasi di Tipo II (TOPO2)

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Topoisomerasi I • Rompono una sola catena del DNA, la ruotano attorno a
quella integra e riuniscono le estremità interrotte, modificando il numero di legame Lk con incrementi di 1
• Il processo termodinamicamente favorevole
Meccanismo delle TOPO1
Reazioni catalizzate dalle TOPO1

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Topoisomerasi II (ATP dipendenti)
Meccanismo delle TOPO2 Reazioni catalizzate dalle TOPO2
• Rompono entrambe le catene di DNA e modificano Lk con incremento di 2
• Il processo è termodinamicamente sfavorito: necessita di energia, prodotta attraverso l'idrolisi di una molecola di ATP

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Topoisomerasi
Chinoloni
Selettività
NR
O
OH
O
R'
X
Enzimi fondamentali per la crescita cellulare ma potenzialmente dannosi

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Topoisomerasi
DNA-girasi batterica: • DNA-topoisomerasi di tipo II che
ca ta l i z za i l supe ravvo lg imen to negativo del DNA procariotico.
• Formata da due proteine (A and B) • La specie attiva è rappresentata da un
eterotetramero (A2B2) Topoisomerasi IV: • Altro enzima di tipo II riscontrabile nei
batteri • A differenza della girasi è incapace di
catalizzare il superavvolgimento • Ruolo potrebbe essere quello di liberare
i cromosomi nello stadio finale della replicazione del DNA

DNA Girasi
Chinolone
Complesso ternario
Blocco della replicazione Blocco della trascrizione
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Topoisomerasi

R7: Consente ottimizzazione Favoriti: anelli eterociclici azotati con sostituenti basici (piperazina)
Essenziali per l’attività
R1: Piccoli gruppi alchilici Sostituente migliore è il ciclopropile; buona attività i derivati fenilici alogenati (ma più tossici)
R2: attività ottimale: -H
R6 -F: Fluorochinoloni Aumenta inibizione della girasi e penetrazione cellulare
R5: -H o –NH2, -CH3, -OH
X: Controlla spettro ed efficacia in vivo CH-F(Cl): buona attività ma fototossicità CH-OCH3: buona attività con minori effetti tossici
X N
R6
R7R1
O
OH
O
R2
R5
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni: SAR

NR1
O
OEt
O
R
X
O
OEt
O
RNH
Metodo Bayer Metodo Gould-Jacobs
NR1
O
OEt
O
R
EtO
Chiusura base-catalizzata di 2-(2-alobenzoil-amminoacrilati)
Chiusura acido-catalizzata di anilinometilen-malonati
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni

• Non fluorurati • Attivi solo contro gli enterobacilli G- • Rapidamente escreti nelle urine • Non più utilizzati
N N
O
OH
O
CH3
H3C
Acido Nalidixico (1965-1998) • Capostipite • Genotossico cancerogeno • Elevato legame con le proteine plasmatiche • Usato per il trattamento infezioni urinarie • Basse concentrazioni plasmatiche, non presenta effetto
sistemico
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni: I generazione
N X
O
OH
O
CH3
O
O
X= CH; Acido Oxolinico X = N; Cinoxacina
• Poco più potenti del capostipite ed uno spettro d’azione leggermente più ampio
• Rapidamente eliminati

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Acido Nalidissico
+ C2H5O
OC2H5
OC2H5
C2H5OOC COOC2H5
C2H5O
C2H5OOC COOC2H5
N NH
C2H5OOC COOC2H5
H3C
N NH2H3C
N NH
COOC2H5
O
H3C N N
COOC2H5
O
H3C
N N
COOH
O
H3C
Δ

Acido Piromidico • Attivo verso i G(-) • Non presenta effetto sistemico
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni: I generazione
Acido Pipemidico
• Terapia delle infezioni del tratto urinario • Ampliamento dello spettro con attività anche verso G(+)
N
N N
O
N
COOH
N N
O
COOH
N
N N
O
N
COOH
N
N N
O
N
COOH
HNN X
O
OH
O
CH3
O
O

• Fluorurati • Maggiore attività nei confronti degli enterobatteri; attivi verso P. aeruginosa,
stafilococchi, micoplasmi, clamidie ed alcuni streptococchi • L'anello piperazinico in posizione 7 sembra conferire l’attività contro lo
Pseudomonas aeruginosa • La contemporanea presenza dell'atomo di fluoro in posizione 6 sembra
conferire un allargamento dello spettro e una farmacocinetica più idonea per l’uso sistemico.
N
O
OH
O
CH3
N
F
HN
Norfloxacina (1986) • Capostipite • Spettro comparabile a quello degli antibatterici naturali • Utile anche nelle infezioni enteriche • Non attiva verso gli anaerobi e non danneggia la flora
intestinale • Elevata escrezione biliare (adatta per sepsi biliari)
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni: II generazione

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Norfloxacina

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Norfloxacina

N
O
OH
O
CH3
N
F
HN
Pefloxacina
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni: II generazione
CH3-N
• Profilo simile a quelli della norfloxacina, ma con una maggiore attività contro i Gram-positivi quali lo Staphylococcus aureus
• Ampia distribuzione del farmaco nei tessuti • Adatta alla cura delle infezioni del tratto
respiratorio, al trattamento delle meningiti, delle endocarditi e delle mediastiniti
Ciprofloxacina (1991) • Fluorochinolone più usato • Ben assorbito per via orale • Basso legame con le proteine plasmatiche • Indicato per il trattamento delle infezioni complicate del
tratto urinario, infezioni delle vie respiratorie, delle ossa, endocarditi, otiti, osteoartriti
N
O
OH
O
N
F
HN

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ciprofloxacina

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ciprofloxacina

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ciprofloxacina
HN
COOC2H5
O
Cl
F
ClOC2H5
COOC2H5
O
Cl
F
Cl
COOC2H5
O
Cl
F
Cl
COOC2H5
O
Cl
F
ClCOOC2H5
Cl
O
Cl
F
Cl
C2H5O
OC2H5
OC2H5
N
COOC2H5
O
Cl
F
N
COOC2H5
O
N
HN
F
N
COOH
O
N
HN
F
C2H5OOC COOC2H5
NaH, Δ

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni: III generazione
Levofloxacina (1996) • Racemo: Ofloxacina (ER=10-20) • S(-) • L'etile in posizione N1 della chinolina è bloccato
tramite la formazione un ciclo, l’ossazina
• Attività nei confronti degli streptococchi e anaerobi; aumenta la potenza verso Pneumococchi
Grepafloxacina (1997-1999)
N
O
OH
O
CH3
N
F
NH3CO H
Temafloxacina (Gen 1992-Giu 1992) • Ritirato a causa della tossicità renale e fenomeni
emolitici
N
O
OH
O
N
F
HN
H3C
CH3
N
O
OH
O
N
F
HN
H3C
F
F
• Ritirato a causa della tossicità cardiovascolare

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ofloxacina
10% KOH, r.t.
i: CH3COCH2Cl, K2CO3, KI, acetone, reflux
ii: a) Diethyl ethoxymethylenemalonate, 135 – 140 °C, b) ethyl polyphosphate, 135 – 140 °C
H2, Raney Nickel
HCl conc, CH3COOH, reflux
N-methylPiperazine, dimethylsulfoxide, 100 – 110 °C
i
ii

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Levofloxacina (a)

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Levofloxacina (a)

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Levofloxacina (b)

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Levofloxacina (c)

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni: IV generazione
Gemifloxacina
• Aumentata potenza verso Streptococchi, Pneumococchi e anaerobi
Trovafloxacina
Moxifloxacina (1999)
N
O
OH
O
N
F
F
F
H
HH2N
N N
O
OH
O
N
F
NOH3C
NH2
N
O
OH
O
N
F
NHOH3C
• Particolarmente indicata nel trattamento di bronchiti acute e polmoniti causate da ceppi sensibili
• FDA ne ha limitato l’uso a causa di possibili fenomeni di grave tossicità epatica
• 2009: FDA ne ha limitato l’uso a causa di possibili fenomeni di grave tossicità epatica

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni
• Assorbimento: ottimo per via orale (70% ciprofloxacina, 95% levofloxacina) • Cmax: raggiunta dopo 1-3 h • Eliminazione: renale (generalmente non modificati) • Distribuzione: buona per la 2° - 4° generazione (macrofagi alveolari, mucosa
bronchiale)
• Danni epatici (in particolare con Trovafloxacina e Moxifloxacina) • Nausea, vomito, dolori addominali, diarrea • Dolore osteoarticolare, tendiniti: non somministrati in bambini e in gravidanza • Effetti SNC (azione pro-convulsivante, ansia, depressione, allucinazioni, tremori,
insonnia, deficit cognitivi, …) • Fotosensibilità e fototossicità (aumenta se il sostituente in 1 o in 8 è alogenato) • Cardiotossicità (Sindrome del QT lungo); effetto associato ad alcuni chinoloni
(Grepafloxacina è stata ritirata dal commercio per questa tossicità) • Anemia emolitica (Associata solo a Temafloxacina)

• Ridotta funzionalità renale • Epilessia o disturbi psichiatrici • Donne in gravidanza e bambini
Associazioni da evitare: • Teofillina, warfarina (inibizione della clearance) • Cationi polivalenti (assunzione di antiacidi, tonici e prodotti caseari diminuisce
la solubilità e l’efficacia del chinolone) • FANS (effetto proconvulsivante. Interazione farmacodinamica: effetto sinergico
nell’inibizione del legame del GABA)
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chinoloni (limitazioni e interazioni)
• Sistemi di efflusso cellulare: diminuzione della concentrazione intracellulare di farmaco
• Mutazioni della topoisomerasi: diminuzione dell’affinità target/farmaco • Proteine Qnr (quinolone resistance): proteggono la DNA girasi dall’azione del
farmaco
Resistenza

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Target selettivi

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Novobiocina
• Antibiotico cumarinico (fondamentale anche il gruppo carbamoilico) • Scoperta nel 1950 (da Streptomyces) e commercializzata nel 1960 • Inibisce la girasi interagendo con un sito (GyrB) diverso da quello dei
chinoloni: azione sinergica • Modesta attività verso i G- (bassa permeabilità cellulare), tossicità per le
cellule dell’ospite e scarsa solubilità in acqua • Farmaco non più usato

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Target selettivi

Chimica Farmaceutica 1
ANSAMICINE
Variazioni strutturali

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ansamicine
rifamicina B
Rifamicine • Solo la rifamicina B è stata isolata
come sostanza cristallina pura • In soluzioni acquose ossigenate
tende a trasformarsi in altri prodotti che presentano una maggiore attività antibatterica (rifamicina O e S)
• Streptomyces mediterranei
NH
OOHOH
O
O
OCH2COOHO
OH
HO
O
O
O
NH
OOOH
O
O
OO
OH
HO
O
O
ONH
OOOH
O
OO
OH
HO
O
O
O
O O
Orifamicina O rifamicina S

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ansamicine
rifamicina B
• Agenti attivi verso i micobatteri (cfr. antitubercolari), i gram(+) e i gram(-) (in minor entità)
• Inibizione della RNA polimerasi D N A d i p e n d e n t e t r a m i t e formazione di legami π-π tra il sistema naftalenico e gli anelli aromatici degli aminoacidi della DDRP
• Gli atomi di ossigeno C1 e C8 possono inoltre chelare lo zinco dell’enzima, contribuendo ai legami con l’enzima in addizione ai forti legami idrogeno che si instaurano con gli ossigeni C21 e C23
123
456
7 89
10
111213
14
15
16
17
181920
21222324
25
26
27
28
29
NH
OOHOH
O
O
OCH2COOHO
OH
HO
O
O
O

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ansamicine
rifamicina SV
• elevata attività antibatterica in vitro • Parzialmente ed irregolarmente
assorbita dal tratto gastrointestinale • Dopo somministrazione per via
parenterale viene rapidamente eliminata attraverso la bile
• Sebbene fortemente attiva in vitro contro il M. tubercolosis, le dosi richieste in vivo sono troppo elevate
• Sale sodico (per via parenterale): trattamento di infezioni da G(+) soprattutto delle vie biliari, o per applicazione topica nei processi infettivi da M. tuberculosis e infezioni da piogeni (congiuntiviti, cheratiti, infezioni acute e croniche dell'orecchio esterno medio
NH
OOHOH
O
O
OHO
OH
HO
O
O
O
Altre rifamicine antitubercolari: vedi antimicobatterici

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Target selettivi

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ribosomi
(S = Svedberg, unità di misura del coefficiente di sedimentazione)

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
AMFENICOLI

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
• Famiglia di antibiotici batteriostatici • Battericidi su Haemophilus influenzae,
meningococco e pneumococco • Capostipite: cloramfenicolo • Attività: legame alla subunità ribosomiale 50S,
inibendo l’azione dell’enzima peptidiltransferasi e quindi la sintesi proteica batterica
Amfenicoli
• Isolato nel 1947 da culture di Streptomyces venezuelae • Attualmente viene prodotto per sintesi totale • Esistono quattro diasteroisomeri • 1R,2R{(-)-treo-1-p-nitrofenil-2-dicloroacetamido -1,3-propandiolo} risulta attivo • Spettro di attività che include batteri Gram(+) e Gram(-) • Principale uso terapeutico per le febbri tifoidi, per le meningiti da Haemophilus • Gravi e talvolta fatali effetti depressivi sul midollo osseo • Elevata tossicità, uso MOLTO ridotto • Somministrato oralmente (generalmente sotto forma di palmitato) • Diffonde nel liquido cerebrospinale anche quando le meningi non sono
infiammate • Somministrato per via endovenosa sotto forma di succinato sodico

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Cloramfenicolo
N
NNN
O2N
O
CH3 CH3
O2N
O2N
O
NH2
O2N
O
Br
CH2CH2, AlCl3, HCl HNO3, H2SO4 VO5
Br2, CH3COOH Esametilentetramina
reazione di Delepine HCl
Esametilentetramina = urotropina
O2N
O
NHCOCH3
O2N
O
NHCOCH3
OH
(HCOH)n *

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
O2N
O
NHCOCH3
OH
* Al(iPrO)3, iPrOH
O2N
OH
NHCOCH3
OH
(+/-) treo (+/-) eritro
* *
O2N
OH
NHCOCH3
OH
(+/-) treo
Cristallizzazione
O2N
OH
NH2
OH
(-) treo
O2N
OH
NHCOCHCl2
OH
(-) treo
H3CCH3
OS
O
OHO
1 2345
6
7
89
10*
*
H+ Cl2CHCOOCH3
Cloramfenicolo

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Riduzione Meerwein–Ponndorf–Verley

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
• Derivato semisintetico del cloramfenicolo • Nitrogruppo rimpiazzato da un raggruppamento
metilsolfonico • Perdita di attività in vitro • Meno tossico del cloramfenicolo • Casi di anemia aplastica meno frequenti • Depressione midollare reversibile • Non metabolizzato dal fegato • (Il CAF viene pressoché completamente
metabolizzato dal fegato) • Eliminato con le urine pressoché inalterato.
Tiamfenicolo
HNCl
OSOO
OH OH
Cl
HNCl
OSOO
OH OH
Cl
HNCl
O
OH OH
Cl
N+–O
O

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
TETRACICLINE

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Tetracicline • Antibiotici antibatterici prodotti da alcuni
ceppi di Streptomyces spp. • Comune s t ru t t u ra t e t rac i c l i ca :
naftacene (o tetracene) • Proprietà antimicrobiche molto simili • Clortetraciclina: prima tetraciclina
entrata nella pratica clinica (Aureomicina)
• Ossitetraciclina • Tetraciclina (prodotto di riduzione della
clortetraciclina)
OH O OH
OH N
O
OHR2
R3 R1
NH2
O
OH O OH
OH N
O
OHH3CCl H
NH2
OClortetraciclina
OH O OH
OH N
O
OHH3CH OH
NH2
OOssitetraciclina
OH O OH
OH N
O
OHH3CH H
NH2
OTetraciclina

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
• Generalmente batteriostatiche alle concentrazioni raggiungibili nell’organismo umano
• Interferiscono con la sintesi proteica batterica, legandosi alla subunità 30S ribosomiale.
• Clortetraciclina: ampio spettro di attività • Somministrazione per os (gli altri antibiotici dell’epoca – anni ’40-’50 – no) • Ossitetraciclina e tetraciclina: proprietà molto simili alla clortetraciclina ma
con migliore assorbimento • ossitetraciclina provoca in minor entità la pigmentazione dei denti • Fototossicità
TETRACICLINE più recenti
Tetracicline
OH O OH
N
O
OHH OH
NH2
OMetaciclina
OH O OH
H N
O
OHH3CH OH
NH2
ODoxiciclina
OH O OH
H N
O
OHHN H
NH2
OMinociclina

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
OH O OH
H N
O
OHHN H
NH2
O
Minociclina
OH O OH
H N
O
OHH3CH OH
NH2
O
Doxiciclina
OH O OH
N
O
OHH OH
NH2
O
Metaciclina
Tetracicline • Tempo di emivita maggiore di quella della tetraciclina • Doxiciclina: può essere somministrata una sola volta al
giorno • Doxiciclina e minociclina: possono essere somministrate in
dosi inferiori rispetto alle tetracicline precedenti perché, essendo più liposolubili, penetrano bene nei tessuti
• Non presentano fenomeni di accumulo nei pazienti con danno renale
• Entrambe più attive in vitro della tetraciclina verso molti tipi di batteri
• Minociclina: attiva anche verso alcuni ceppi divenuti resistenti alle altre tetracicline, inclusi ceppi di stafilococco
• Minociclina: uso limitato dai suoi effetti collaterali a livello vestibolare
• Uso indiscriminato (anche negli alimenti per animali): insorgenza di fenomeni di resistenza, dovuta alla capacità dei batteri di evitare l’accumulo dell’antibiotico nella cellula (- trasporto attivo + efflusso)

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
• Se necessaria la via parenterale: somministrazione endovenosa • Distribuzione: nella maggior parte dei tessuti e dei fluidi corporei • Concentrazione a livello del fluido cerebro-spinale non tale da produrre effetto
terapeutico • Spettro d’azione ampio: clamidie, micoplasmi, rickettsie, spirochete, molti batteri
patogeni Gram(+) e Gram(-) sia aerobi che anaerobi e alcuni protozoi • Non sono farmaci di prima scelta nelle infezioni da Stafilococchi o in quelle delle
prime vie aeree (faringotonsilliti, ecc.) da Streptococco beta emolitico • Utilizzate principalmente nelle infezioni dl tratto urogenitale, nelle esacerbazioni acute
di bronchiti croniche, nella malattia di Lyme, come alternativa alla penicillina nella sifilide.
• Dossiciclina: usata nella chemioprofilassi antimalarica da Plasmodium falciparum resistente alla clorochina.
• Possono portare a superinfezioni da agenti batterici resistenti o da miceti. • Nel tessuto osseo in via di formazione: formazione di un complesso stabile di calcio. • Uso delle tetracicline durante il periodo della formazione dei denti può causare
pigmentazione dentaria permanente (giallo-bruna). • Reazioni di fotosensibilizzazione possono manifestarsi in corso di trattamento in
soggetti predisposti. • In soggetti con insufficienza renale, anche dosi normali di tetracicline possono dare
luogo ad accumulo in circolo con possibili danni epatici.
Tetracicline

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
AMINOGLICOSIDI

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Aminoglicosidi • Antibiotici battericidi, strettamente correlati strutturalmente • Prodotti da Streptomyces e Micromonospora • Composti policationici • Contengono nella propria struttura un amminociclitolo (di solito la 2-
desossistreptamina, o la streptidina nella streptomicina, o la spectinamina nella spectinomicina)
• Contengono un’unità glicidica • Contengono un amminozucchero legato tramite legame glicosidico • Vengono anche denominati amminociclitoli amminoglucosidici
2-desossistreptamina streptidina spectinamina
HN
OHOH
OH
NHOH
NH
NH2NH
H2NNH
OHOH
OH
NHOH
NH2
OHOH
OH
H2NOH

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
N-Metil-2-glucosamina
Streptosio
Streptidina
Aminoglicosidi - streptomicina

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
• Generalmente utilizzati come solfati • Si legano alla subunità 30S ribosomiale • Resistenza batterica dovuta a enzimi che N-
acetilano, O-fosforilano o O-adenilano specifici gruppi funzionali, prevenendo il legame alla porzione proteica ribosomiale
• Scarsamente assorbiti per via orale, per infezioni sistemiche somministrazione parenterale
• Marcata ototossicità e nefrotossicità • Utilizzati esclusivamente nel caso di gravi
infezioni causate da microrganismi sensibili
O
OO
OH
OH
NH2
O
O
HO
H2N NH2
OH
HOO
NH2
OHHO
H2N
HO
O
O
O
O
CH3
OHHO
NH
OH
NH
CH3H3C
O
OH
HO
HN
OHHN
NH
NH2NHH2N
O
OO
OH
HO
OH
NH
CH3
CH3
HOCHO
Neomicina
Streptomicina
Spectinomicina
Aminoglicosidi

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
• Introduzione di nuovi gruppi funzionali (amikacina): più stabili all’attacco enzimatico
• Attivi verso i bacilli aerobi G(-) e gli stafilococchi [aerobi G(+)]
• Streptomicina, neomicina e kanamicina non presentano attività nei confronti dello P. aeruginosa, mentre gentamicina, tobramicina, amikacina e netilmicina presentano una buona attività verso tale microrganismo
• Nelle infezioni gravi da P. aeruginosa un aminoglicoside va sempre aggiunto a un antibiotico beta-lattamico, anche se le penicilline anti-pseudomonas (ticarcillina) possono inattivare in vitro gli aminoglicosidi
• Neomicina e kanamicina: spettro antibatterico limitato, più tossici degli altri aminoglicosidici. Usati solo topicamente (neomicina + sulfatiazolo), o per uso orale nella preparazione preoperatoria del tratto intestinale
amikacina
Aminoglicosidi

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
MACROLIDI e CHETOLIDI

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Macrolidi
• Attivi contro i cocchi G(+), sia aerobi che anaerobi, con l’eccezione degli enterococchi, e contro gli anaerobi G(-), ma molti ceppi di Staphylococcus aureus sono divenuti resistenti
• Alternativa nelle infezioni streptococciche e pneumococciche, quando non possa essere utilizzata una penicillina
• Pneumococchi resistenti alla penicillina sono spesso resistenti alla eritromicina
• Struttura lattonica a 14,15 o 16 atomi • Principalmente batteriostatici • Inibizione della sintesi proteica batterica • Legame alla subunità ribosomile 50S • Ben assorbiti dopo somministrazione orale • Eritromicina e azitromicina: possono essere
somministrate anche per via parenterale • Diffondono bene nei fluidi e nei tessuti corporei • Non nel fluido cerebrospinale (non vanno quindi
usati per trattare le meningiti)
O
O
O
OO
O
O

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Macrolidi • Eritromicina: causa intolleranza gastrica e viene
s p e s s o s o s t i t u i t a d a l l a c l a r i t r o m i c i n a o dall’azitromicina, per quanto notevolmente più costose
Meccanismi di resistenza • Alterazione del bersaglio RNA ribosomiale 23S • Pompa di efflusso (ATP- dipendente): produzione di
una proteina di membrana • Resistenza intrinseca nei G(-) (enterobatteri,
Pseudomonas) per impermeabilità della membrana esterna
O
O
O
OO
O
O
OHHO
HO
HON
OH
OCH3
Eritromicina
O
O
O
OO
O
O
OCH3HO
HO
HON
OH
OCH3
Claritromicina
N
O O
OO
O
O
OCH3
HO
HO
HON
OH
OCH3
Azitromicina
*
* *
* *
* * *
*
*

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Chetolidi
Eritromicina
O O
O
OOO
H3C CH3H3CO
NCH3H3C
OH
H3C
O
CH3CH3
H3C
H3C
H3C
H
N
ONN
N 6 3
1112
Telitromicina • Strutturalmente correlati all’eritromicina • Differiscono dagli altri macrolidi in quanto nella
posizione 3 del macrolattone a 14 termini presentano una funzione chetonica in luogo dello zucchero cladinosio
• Telitromicina: presenta una catena carbammica in C(11)-C(12), che lega tramite un raggruppamento butirrico un anello imidazolico e uno piridinico
• Attiva verso batteri Gram(+) (i.e. streptococchi, inclusi ceppi di Streptococcus pneumoniae eritromicino-resistenti)
• Buona attività anche contro batteri Gram(-), quali Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis.
• Attiva verso Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae quanto i macrolidi
• Risultano anche sensibil i alcuni ceppi di Staphylococcus aureus
• Risponde alla necessità di trovare composti con attività nei confronti del maggior numero di patogeni associati alle infezioni del tratto respiratorio acquisite in comunità, compresi quelli resistenti ai macrolidi
O
O
O O
O
O O
HO
OHOH
HO
NHO
H3CO
O O
O
OOO
H3C CH3H3CO
NCH3H3C
OH
H3C
O
CH3CH3
H3C
H3C
H3C
H
N
ONN
N 6 3
1112

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
ALTRI INIBITORI (ribosomiali)

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Lincosamidi • Principalmente batteriostatiche • Legame alla subunità 50S (nello stesso sito
dei macrolidi) • Attive verso cocchi G(+), sia aerobi che
anaerobi (con l’eccezione degli enterococchi) e contro gli anaerobi G(-)
• Sembrano inoltre avere una certa attività contro i protozoi
• Chemioresistenza condivisa da macrolidi e streptogramine
• Alternativa alla penicillina
HN
CH3
RO
O
S
OHCH3
OH
OH
NCH3
H3C
H
Lincomicina: R = OH
Clindamicina: R = Cl
• Possibile di sviluppo di coliti pseudo-membranose anche fatali (causate da Clostridium difficile): uso solo quando non esista un’alternativa efficace
• Possono causare fenomeni d’ipersensibilità • Somministrazione orale e parenterale • Diffondono bene nei fluidi e nei tessuti corporei, tranne nel fluido cerebrospinale • Buona penetrabilità ossea: efficaci nelle osteomieliti. • Clindamicina: profilassi delle endocarditi

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Acido fusidico
• Antibatterico a struttura steroidica • Configurazione trans-sin-trans-anti-trans • Saturazione del doppio legame C17-C20: quattro
stereoisomeri. Solo uno di essi esibisce un’attività antimicrobica comparabile a quella dell’acido fusidico
• Orientazione della catena laterale cruciale • L’acido fusidico agisce inibendo la sintesi
proteica batterica
COOH
O
HOH
H
HHO
O
• Non lega le unità ribosomiali, inibisce un fattore necessario alla translocazione delle subunità peptidiche, necessaria per l’elongazione della catena peptidica
• Interagisce anche con la sintesi proteica nei mammiferi, ma esercita un’azione selettiva nei confronti dell’agente infettante in quanto la sua penetrazione nella cella dell’ospite è scarsa

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Acido fusidico • Attività verso i batteri G(+) in particolare verso lo S. aureus e
S. epidermidis, inclusi i ceppi resistenti alla meticillina. La maggior parte dei batteri Gram(-) sono resistenti
• Attività verso il Mycobacterium leprae, presenta anche una certa attività nei confronti di alcuni ceppi di Mycobacterium tuberculosis.
• Trattamento di ascessi, anche cerebrali, di infezioni midollari e delle giunture, nelle endocarditi stafilococciche, nelle infezioni stafilococciche in pazienti affetti da fibrosi cistica e, topicamente, nelle infezioni dell’occhio e della pelle.
• Somministrato per bocca o localmente come acido o sale sodico e per via intravenosa come sodio fusidato.
• In Italia attualmente viene commercializzato come crema per uso topico (dermatologici) per la cura di piodermiti in genere, impetigini, foruncoli, follicoliti, ascessi, ferite o abrasioni infette, tutte se provocate da stafilococco o come gocce oftalmiche per le infezioni oculari. In associazione con corticosteroidi viene utilizzato nelle dermatiti eczematose
COOH
O
HOH
H
HHO
O

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ossazolidinoni
N ONO
O FCH3
HN
O• Linezolid: agente antibatterico
sintetico di provata efficacia clinica, appartenente agli ossazolidinoni
• Inibizione selettiva della sintesi delle proteica legandosi ad un sito del ribosoma batterico (23S della subunità 50S) e blocco della f o r m a z i o n e d e l c o m p l e s s o funzionale 70S
Linezolid
• Attivo in vitro contro Gram(+) comprese specie resistenti a penicilline e vancomicina
• Se sospettata la presenza concomitante di patogeni Gram(-) è necessaria una terapia combinata Indicato nel trattamento di infezioni sospette o accertate causate da batteri Gram(+) sensibili, quali polmonite nosocomiale o acquisita in comunità e infezioni complicate della cute e dei tessuti molli
• Inibitore reversibile, non selettivo, delle monoamino-ossidasi (MAOI), ma alle dosi utilizzate per la terapia antibatterica non esercita effetto antidepressivo.

FO2N
F
HN O N OO2N
F
N OH2N
F
HCOONH4, Zn
Cl
O
O
N OHN
FO
O
TEA +
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ossazolidinoni: linezolid
O
O
O
BuLi
N ON
FO
O- O
O
O
N ONO
O F
HO

MsCl
Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Ossazolidinoni: linezolid
H2, PtO2
F
N ONO
HO
OF
N ONO
O
OS
O
O
F
N ONO
O
N3
NaN3
F
N ONO
O
H2N
(CH3CO)2O
F
N ONO
O
HN
H3C
O

Chimica Farmaceutica 1
Antibatterici
Tigeciclina
O O
NH2
OH O OHOH
OH
CH3N
H3C
H
CH3NH3C
H
NH
HN
CH3
O
H3C
H3C
• Antibiotico della classe delle glicilcicline sono strutturalmente simili alle tetracicline
• Immissione in commercio nel 2006 • Polvere per soluzione per infusione • Inibitore della sintesi proteica
mediante legame alla subunità ribosomiale 30S
• Significativo progresso nella terapia antibatterica: attività nei confronti di microorganismi resistenti G(+) e G(-)
• Indicato per il trattamento di infezioni complicate della cute e dei tessuti molli e infezioni complicate intra-addominali
• Reazioni avverse simili a quelle delle tetracicline: fotosensibilità, pseudotumor cerebri (ipertensione endocranica benigna), pancreatite, azione anti-anabolica che porta a un aumento dell’azoto ureico, azotemia, acidosi e ipofosfatemia