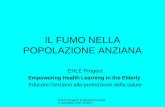Angelini, M.I., Niente è Senza Voce, Magnago, Ed. Qiqajon, 2007
-
Upload
piero-pertusati -
Category
Documents
-
view
36 -
download
0
Transcript of Angelini, M.I., Niente è Senza Voce, Magnago, Ed. Qiqajon, 2007
-
Nella stessa collana SPIRITUALIT OCCIDENTALE E. Bianchi, Non siamo migliori. lA vita religiosa 11ef!a chiesa, tra gli uomil1i Piccola sorella Annie di Ges, Char!es de Foucau!d A. Chatelard, Charles de Foucau!d. Ve1s0 Tamammset AA.Vv., Cbar!es de Foucau!d. L'eloquenza di una vita secondo l'evangelo C. Falchini, Volto del monaco, volto dell'uomo L."A. Lassus, Elogio de! nascondimento J. Ledercq, San Bemardo e lo spirito cisterceiiSe A. Louf, Generati dallo Spirito, !'accompagllamento spirituale oggi A. Louf, Sotto la guida de !lo Spirito A. Louf, Lo Spirito prega in noi A. Louf, La vita spirituale L. Manicardi, L'umano soffrire. Evangelizzare le parole sulla sofferema Th. Matura, Fmncesco, maestro nello Spiri m L. Mirri, La dolcezza nella lotta, donne e ascesi secondo Gim!amo Sorella Maria di Campello, P. Mazzolari, L'ineffabile fmtemit. Carteggio Sorella Maria di Campello, G. M. Vannucci, Il catlto de!!'a!!odo!a. Lettere scelte F. Varillon, L'umi!t2J di Dio
Invieremo gratuitamente il nostm Catalogo generale e i successivi aggonlllmenti a quanti ce ne faranno richiesta. www .qlqajon.it
AUTORE: Maria Ignazia Angelini, badessa di Viboldone TITOLO: Niente senza voce SOTTOTITOLO: lA vita monastica oggi COLLANA: Spiritualit occidentale FORMATO: 20 cm PAGINE: 288 PREFAZIONE Enzo Bianchi, priore di Base IN COPERTINA: M. Pavesi Mazzoni, L'a11ge!o defft~ remnezione, Centro di Etica vivente,
Citt della Pieve, Perugia
2007 EDIZIONI QIQAJON COMUNIT DI BOSE rJ887 MAGNANO (BI) Td. 015.679264 Fax oi5.679290
'
MARIA IGNAZIA ANGELINI BADESSA DI VIBOLDONE
NIENTE E SENZA VOCE
La vita monastica oggi
EDIZIONI QIQAJON COMUNIT DI BOSE
-
PREFAZIONE
Quando Benedetto nella sua Regola per i monaci - che, come ben sappiamo, ha sempre normato e norma anche monasteri di mo-nache chiede che l'abate (la badessa) "sia istruito nella legge di Dio" e dotato di "dottrina di sapienza" (RB 64, 9 2) non mosso dall'auspicio che la comunit sia retta dal pi intellettuale o dal pi erudito dei presenti in monastero, ma indica con chiarezza da dove l'abate debba "attingere il suo insegnamento" (RB 64, 9) per poter "preferire sempre la misericordia alla giustizia" (RB 64, ro). Misericordia per leggere il cuore dei fratelli e delle sorelle, miseri-cordia per aprirsi ai miseri che bussano alle porte del monastero, misericordia per normare le relazioni del monastero con la realt che lo circonda. Una misericordia, appunto, che nasce e s nutre dell'amore per la Parola, che alla Parola riconduce le parole d ogni giorno, che della Parola fa la bussola per affrontare i cambiamenti che s presentano nella quotidianit dell'esistenza e nei caratteri e le sensibilit dei membri della comunit.
questo amore per la Scrittura, fonte di uno sguardo misericor-dioso, che ritroviamo nelle pagine di madre Maria Ignazia Angel-n che abbiamo a lungo desiderato poter raccogliere e offrire a un pubblico pi vasto. Chi ha letto Il monaco e la parabola- l'itine-rario attorno alla lectio divina che madre Maria Ignazia ha rico-struito negli anni precedenti il suo ministero a servizio della comu-nit, prima come maestra delle novizie e poi come badessa non si stupir di trovare come titolo di ogni capitolo un versetto della Scrittura: non si tratta di un artificio stilistico, ma al contrario del-
5
-
la consapevolezza che, come ricorda Benedetto, non c' pagina o parola ispirata della sacra Saittura che non sia norma sicura di con-dotta per la vita monastica e cristiana (cf RB 7},3) e che, specular-mente, non c' sfida o interrogativo posto dagli eventi e dai com-pmtamenti quotidiani che non possa essere letto alla luce della pa-rola di Dio.
Vi costante movimento in questa raccolta di testi, un incessan-te andirivieni dal monastero al mondo, dal corpo comunitario al-l'ospite accolto, dal tempo e lo spazio quotidiano alla lettura dei segni dei tempi e degli spazi ecclesiali e civili d ampio respiro. la voce leggera e insieme ferma che si leva da un monastero ai bordi della citt, addossato a un deserto ideale dal quale si sente pulsare il cuore di una metropoli, lo sguardo d'amore che una comunit ai margini della chiesa - come proprio di ogni presenza "gratuita", non legata a una diaconia specifica - posa sul cuore stesso della compagine ecclesiale, l'appello che invoca e offre misericordia, chiedendo di distogliere lo sguardo da se stessi per fissarlo sulle real-t invisibili di cui Cristo si fatto narrazione.
In questo ministero di solidariet arante, di contemplazione che si sforza di leggere ogni cosa con gli occhi di Dio, il monachesimo femminile ha un dono particolare: privo com' di qualsiasi prospet-tiva clericale o di sbocchi pastorali esterni al monastero, esso ci ri-manda alle motivazioni originarie e fondanti che hanno attratto e ancora oggi possono attrarre donne di ogni condizione sociale e cul-tura a una vita comune nel celibato. Cos~ quello che era chiaro per gli aspiranti monaci dei primi secoli che, cio, si entrava a far parte di una comunit semplicemente per cercare di seguire il Signo-re Ges e il suo evangelo in quella determinata forma vitae, senza minimamente pensare all'eventualit d una successiva ordinazione presbiterale- e che oggi non risulta cos facile spiegare ai pochi gio-vani che ancora si accostano ai monasteri, era e rimane tuttora di evidenza cristallina per le donne.
Non solo, ma questa consapevolezza, !ungi dal costituire un'in-giustizia maschilista, libera le pi autentiche risorse che la vita ma-
6
nastica offre a quanti uomini o donne - vi si accostano ritenen-do/a la loro verit pi intima. Un monachesimo "laico", non cle-ricale, infatti, non solo sgombra gli orizzonti d alcuni quelli che s ritengono o sono i pi dotati dalla agognata o temuta prospetti-va t:pscopale, ma anche facilita la piena comunione tra tutti i mem-bri della comunit, ponendo tutti sullo stesso piano fraterno, in ob-bedienza alla parola del Signore: "Voi siete tutti fratelli" (Mt 2J,8).
Un ambito emblematico di come questo approccio alla vita mo-nastica nella "gratuit" possa aiutare a ritrovare il senso originario di una determinata prassi quello della stabilitas: al momento del-la professione il monaco o la monaca si impegnano a fissare per sempre la propria vita non solo nella condizione del celibato, ma anche in una realt fisica e spirituale ben precisa: quel determinato monastero, con il suo contesto storico e geografico, e quella deter-minata comunit, con le ricchezze e i limiti dei fratelli o delle so-relle passate, presenti e future. Una serie di fattori storici, culturali ed ecclesiali, in massima parte esterni al monachesimo femminile, hanno finito per ridurre questa dimensione cos evangelica della se-quela monastica - il "dimorare" saldamente nel Signore, la perse-veranza nella chiamata ricevuta, la fedelt a Dio attraverso la fe-delt a chi Dio ci ha posto accanto, il non essere uomini o donne "di un momento" - a una questione di mura, grate, divieti, estra-niamento dai fratelli e smelle in umanit. Ma in tal modo le mura dei chiostri rischiano di diventare fredde protezioni da potenziali nemici esterni, e perdono la loro dimensione di abbraccio amoroso che custodisce la carit faticosamente ricercata ogni giorno alloro interno. Su questa dimensione evangelica della stabilitas il pensie-ro di madre Maria Ignazia torna sovente, proprio perch il vissuto - sia storico che attuale della sua comunit a richiamare con estrema semplicit ma anche con chiarezza il dono prezioso, il bo-num dello "stare insieme" come fratelli e sorelle. Non si dimenti-chi che, come ricordava con sapienza il domenicano Timothy Rad-cliffe, i monasteri sono, o dovrebbero essere, "luoghi in cui la glo-Jia di Dio rifulge, troni per il mistero", non per una sorta di diJitto
7
-
divino, n per qualche automatismo nominalistico e nemmeno per la rigida osservanza di regole claustrali, ma proprio a causa di
ci che i monasteri non sono e di ci che non fanno, perch l'invisibile centro della vita monastica si manifesta nel come i monaci vivono. I monaci, in/atti, non fanno nulla di particola-re, non comprendono se stessi n sono compresi come quelli che hanno una particolare missione o funzione nella chiesa: essi so-no l e, felicemente, continuano a essere semplicemente l ... Le loro vite non conoscono carriere e promozioni, non hanno altro traguardo che la venuta del Signore: sono fratelli e sorelle, non possono aspirare a essere nulla di pi, non hanno altra via di progresso che quella dell'humilitas.
Da queste pagine emergono gratuit e fraternit nello stare insie-me, valorizzate nella loro essenzialit dall'assenza di qualsiasi sco-po specifico, fosse anche particolarmente "nobile", come quello di assicurare la cura pastorale di un gruppo di fedeli o di provvedere alle necessit materiali dei pi bisognosi. Anzi, proprio la qualit dello stare insieme unicamente in nome di Ges e della sua Parola diviene essa stessa annuncio e testimonianza dell'evangelo della ca-rit. Il monachesimo cos ricondotto ai suoi due assi portanti e "parlanti": la vita comune e il celibato per il Regno.
Base, 10 febbraio 2007 memoria di santa Scolastica, monaca
8
Enzo Bianchi, priore di Base
PREMESSA
Su proposta e sulla fiducia dei fratelli e delle sorelle della Co-munit di Base, espressemi dal priore Enzo Bianchi, ho accon-sentito a pubblicare presso le loro edizioni alcuni contributi da me stesi in occasioni e per interlocutori diversi, pressappoco nell'arco dell'ultimo decennio. Non che questo consenso non abbia suscitato in me, di contraccolpo, una domanda: ma con tante parole che si scrivono, perch aggiungere carta a carta? La domanda sul perch scrivere, pur nel desiderio fondamenta-le del dialogo e proprio nel rispetto profondo dell'atto della scrittura, mi rimane. Infatti, le pagine qui raccolte, quasi strap-pate, non sono state cos rilette nel cuore da parermi pronte co-me scritto da consegnare. Sono piuttosto testimonianze di oc-casioni dialogiche. Avrebbero richiesto ben altro lavoro di ma-turazione. La paziente opera di redazione dei fratelli e delle sorelle di Base le ha rese meno impresentabili.
L'elemento unificante della raccolta, e anche la ragione per presentarla cos com', il contesto monastico dei destinatari e il carattere di incontri vissuti che ha occasionato questi con-tributi, alcuni dei quali gi parzialmente pubblicati su varie ri-viste. Capitoli generali, convegni di studio, corsi di formazione monastica, seminari monastici del Gruppo Chevetogne. Tutti ambiti di incontro dal vivo, tra monaci, monache e altre perso-ne sensibili alla vita monastica.
Sono tutti stati redatti a partire da un vissuto comunitario, del quale - per me - la mia comunit monastica sostanza e
9
-
banco di prova. Li ho maturati nella frequentazione delle radici della scelta monastica: lectio della Scrittura e dei padri, dialogo fraterno e scambio con gli ospiti del monastero. A tutti costoro, prime tra tutte le mie sorelle, va la riconoscenza per quello che vi si possa trovare di utile e buono.
Sono scritti sparsi sia per data di origine, sia per occasione e contesto; scritti raccolti senza avere il tempo di quella decanta-zione e limatura indispensabili per un testo di una qualche de-finitivit, e perci risentono di una visibile frammentariet e di una certa rudezza di forma. Ne sono consapevole e in anticipo me ne scuso con chi voglia leggerli. Ma non era per me prevedi-bile un tempo pi disteso da dedicare a questa opera, che pa-zientemente i fratelli di Bose mi chiedevano.
Il dialogo monastico da cui queste pagine sono nate, e dalla cui grazia anche la loro pubblicazione resa possibile, anche il senso della decisione di consegnarle cos come sono alla stam-pa. Pagando il tributo all'epoca, in cui sembra potersi coltivare una grande passione solo a partire da frammenti di vita. Purch sia vita vissuta e non rappresentazione di una parte, o immagi-nazione di un soggetto.
"Niente senza voce" (ICor q,IO): questa esperienza di fondo cui la "piccola regola per principianti" di Benedetto da Norcia ci educa, formando monaci all'ascolto, il prezioso fram-mento che vorrei condividere, nel desiderio che possa far rina-scere tra tutti coloro che tra le rughe della storia cercano Dio, il gusto di ascoltare. Caso mai in questo ascolto a tutto campo si assapori il gusto di riconoscere sintonie che aiutano la vita: a stringere legami e a nutrire la speranza.
Maria Ignazia Angelini
Abbazia dei Santi Pietro e Paolo in Viboldone, 10 febbraio 2007 memoria di santa Scolastica, monaca
IO
"Non mi vergogno dell'evangelo" (Rm r,r6)
IL MONACHESIMO E LE SFIDE DEL POSTMODERNO
La crisi del postmoderno e del monachesimo
La questione del postmoderno
di un'importanza fondamentale che le comunit monasti-che si interroghino o, piuttosto, si lascino interrogare dalla sto-ria di oggi e pi profondamente dall'evangelo, che parla anche filtrando attraverso gli avvenimenti e che irrompendo per mez-zo della storia nuovamente chiama e per certi versi ripropone le grandi sfide delle origini e provoca a riappropriarsi in modo evangelico della povert del monaco, la povert vera, non quella ostentata, e della sua marginalit rispetto ai tempi. Io stessa parlo a partire dall'esperienza della comunit monastica nella quale e con la quale, soprattutto in questi ultimi anni, mi trovo a dovermi confrontare con queste domande. Non ho avuto mo-do di approfondire dal punto di vista teorico la questione del postmoderno, il cui orizzonte quanto mai complesso e sfug-gente, al limite dell'evanescenza, ma la vedo via via affiorare praticamente nelle quotidiane vicende della storia vicina a noi, nella relazione del monastero con gli ospiti, nelle sfide che le
II
-
varie letture "laiche" del fatto monastico ci fanno rimbalzare addosso.
Mi pare quindi che "fare come se" non fossimo tutti, prima o dopo, raggiunti dall'onda del postmoderno 1, ci espone al ri-schio di trovarci comunque, magari a nostra insaputa, negativa-mente condizionati da un movimento epocale, che invece per s - come del resto quello della modernit, al di l di ci che ne abbia detto la cultura ecclesiastica di fine xrx e inizio xx seco-lo -ha valenze che, se vengono affrontate in modo consapevole, possono essere rilette e saturate positivamente. Infatti sana umilt la critica che il postmoderno fa delle pretese di una ragio-ne unilateralmente "critica". Se non che il pensiero della post-modernit diventa a sua volta un orizzonte autoreferenziale.
Il postmoderno come incontra la crisi che conosce il mona-chesimo tradizionale?
La questione monastica
per opportuna un'altra premessa. Con quale atteggiamen-to mi pongo di fronte alla questione monastica? Come chi rico-nosce una crisi e cerca rimedi? Come chi ansiosamente smenti-sce voci di crisi per trincerarsi volontaristicamente (cio attra-verso l'appello alla buona volont di ogni monaco e monaca) in uno splendido isolamento, nei nostri recinti garantiti da costi-tuzioni, osservanze, espedienti vari e antiche ricette?
Parlando di monachesimo cristiano, nel quale l'unificazione che definisce per s la ricerca monastica perseguita avendo come riferimento assoluto l'evangelo, dobbiamo guardare bene in faccia le varie risposte che si danno alla questione della crisi,
1 Con questa espressione ormai entrata nell'uso si indica il crollo della cultura mo-derna, che con il suo dinamismo di "emancipazione" dalle schiavit nei diversi campi dell'umano, filosofico, sociale, economico, artistico, politico, eccetera, aveva preteso di adeguare in toto ilmodus dell'umano.
I2
e rifiutare le prospettive di "salvezza" alternative o comunque incompatibili con la qualit fondamentale del monachesimo di semplice rimando all'evangelo, "per ducatum evangelii", "sotto la guida dell'evangelo", come leggiamo nella Regola di Benedetto (Prol. zr). Dobbiamo innanzitutto guardarci da tutte le letture mitiche che si danno del monachesimo. Il monachesimo non una panacea o una sapienza totale per se stessa. Richiede per s relazione ad altri modi dell'umano. Ma quale relazione? questo il punto! Quando cerchiamo di tematizzare in modo espli-cito la comune responsabilit verso l'immagine del nostro mo-nachesimo, dobbiamo guardarci dal teorizzare astrattamente la preziosa realt dell'esperienza della fede invece di discernerla e articolarla in linguaggio.
Nell'odierna situazione di crisi dobbiamo anche vigilare su ogni forma di "ansiet di autodefinizione". tempo di affon-dare le radici ed esporsi nell'avventura ispirata dalla linfa che sale; non ancora, in questa che sembra come l'ora di una nuo-va nascita, il tempo di nominare. Il narcisismo, anche nella sua versione di gruppo, un'antica infermit, un poco adolescen-ziale, anche dei monaci. L'orgoglio della particolarit, esibita a tutti i costi come singolarit, non si addice ai monaci proprio perch in realt nella figura concreta del monaco si tratta di pa-trimonio di "tutti" (l'umano sempre al singolare). E d'altra parte questa ansia non aiuta a imboccare la via della risposta reale alla questione della loro esistenza, che per eccellenza esi-stenza "gratuita", e solo come tale appartiene alla piena espres-sione della chiesa 2
L'epoca attuale induce facilmente a domande pregiudicate ri-volte ai monaci, del tipo: dateci pi religione o pi godimento
2 Cf. Giovanni Paolo II, 01ientale lumen 9-ro; P. A. Sequeri, "Beata solitudo? Mo-nachesimo cristiano e citt postmoderna", in Un mo11astero alle porte della citt. Atti del co11veg1to per i 650 a11ni dell'Abbazia di Viboldo11e, Vita e Pensiero, Milano 1999, pp. 63-75
I3
-
estetico. La religione in questa richiesta viene intesa come una lettura simbolica della realt in senso mitico, senza cio alcun evento di salvezza, e di tale religione il monaco uno dei sim-boli astorici pi suggestivi. Jean-Franois Lyotard ha scritto:
Molti pensano che sia giunto il momento della religione, il momento di ricostruire una narrazione credibile che racconti la ferita di questo secolo e la cicatrizzi. Si mette avanti il fat-to che il mito il genere originario, che in esso il pensiero dell'origine si d nel suo paradosso originale e che occorre rimettere in piedi le rovine cui il pensiero razionale, demito-logizzante e posi ti vista, l 'ha ridotto 3
Un po' come si restaurano i meravigliosi monumenti del pas-sato, capaci di radunare attorno a s i diversi. E ai monaci - si afferma si addice tale ministero.
Si comprende bene come sia un grosso guaio per il monache-simo identificarsi subito come risposta immediata a queste do-mande, indotte da una cultura che considera il "sacro" e, con-seguentemente, il "religioso" come sfera pur sublime ma esote-rica rispetto alla quotidianit di una storia attraversata da molte apparenze minacciose di povert smisurate, di decadenza o di frammentariet priva di senso. Ai filosofi e ai politici del post-moderno l'ambiente dei monasteri sembra particolarmente pro-pizio per elaborazione di percorsi verso l'unit dell'umano e della storia ricostruita nello spazio estetizzante di un sacro sen-za chiesa; e di questa equivoca "salvezza" i monasteri o i vari "padri" e "madri" spirituali vengono spesso chiamati a farsi mediatori. E a chi ha occhi per vedere non sfugge a quale sca-dimento della propria qualit evangelica si esponga quel mona-chesimo che si presti a simile investitura.
'J.-F. Lyotard, LA condizione postmoderna. Rnpp01to rul rapere, Feltrinelli, Milano I990l, p. 39
14
Il compito che ci sta davanti
Va quindi ridefinita in termini teologalmente chiari la porta-ta non convenzionale e critica del monachesimo cristiano pro-prio nell'epoca in cui viviamo e rispetto alla quale non intendia-mo astrarci, ma nemmeno omogeneizzarci. Proprio l'obbedien-za all'evangelo ci chiede di esprimere, di fronte a spinte culturali che si rassegnano alla frammentazione, alla frantumazione irri-mediabile del tessuto del tempo umano (il cosiddetto secolo bre-ve, finito anzitempo con il crollo delle ideologie), il coraggio di abitare nella storia, ma in vista di una storia "nuova". Di questa il monachesimo, con i suoi occhi allenati a scrutare le Scrit-ture nella notte, deve annunciare l'alba 4 In che senso storia "nuova"? Nuova, dal punto di vista evangelico quella espres-sione dell'umano che ha talmente interiorizzato l'annuncio di Ges Cristo crocifisso e risorto da poter esprimere scelte, atteg-giamenti, opere concrete che di tale annuncio sono un' attuazio-ne eloquente: "Se uno in Cristo Ges una creatura nuova" (zCor s,q)5. A questo ci impegna anzitutto il puro evangelo di Ges, "potenza di Dio e sapienza di Dio" e, conseguentemen-te, la pi autentica tradizione monastica cristiana, a stare cio nella concretezza della nostra epoca sotto la potenza dell'evan-gelo e a fare di questa "stabilit" un credibile annuncio, da li-bert a libert. Non con proclami e con spiegamento di ampli-ficatori, ma da bocca a orecchio e con parole umili, tutte intrise di silenzio, come nello stile della comunicazione monastica. Per questa via allora s il monachesimo ha in custodia una paro-la di salvezza, che pu testimoniare forse in maniera meno equi-voca che la parrocchia o la chiesa appoggiata ai media e alle opa-che risorse della p6lis. A grandi linee questa la prospettiva en-tro la quale voglio affrontare la questione.
'1 Cf. M. Zambrano, Dell'aurora, Marietti, Genova zooo, 5 I passi biblici sono citati secondo la traduzione dell'autrice.
15
-
Alcune considerazioni sintetiche sull'epoca contemporanea
Le "regole" della frammentazione dell'umano
La modernit, inaugurata storicamente dall'illuminismo e an-cor prima da Cartesio che pone la questione del soggetto, non tanto un'epoca, quanto un modo del pensiero. Perci, pur es-sendo un fenomeno occidentale non estraneo a nessuna cultu-ra umana. La modernit nasce sotto il segno del disincanto del mondo e dell'idea di emancipazione, anzitutto dal tempo passa-to, verso una libert universale, verso !'"assoluzione" dell'uma-nit intera. Tale emancipazione perseguita dalla modernit at-traverso il principio della soggettivizzazione (il soggetto umano come libert e come creazione) e della razionalizzazione. Que-sti due principi, dei quali non si avverte la nascosta tensione legata alla riduzione del soggetto alla ragione, fino agli anni ses-santa imperversano separatamente in tutti i campi delle scienze umane e tecniche, della vita civile e, in modo un po' a s, nel campo dell'arte e della religione, creando frammentazione sen-za arbitrato alcuno, poich la libert umana viene concepita co-me cominciamento assoluto al vertice del divenire del mondo.
Originariamente la modernit in conflitto con le grandi vi-sioni unitarie, universali dell'umano le "narrazioni", siano es-se filosofiche o religiose denunciandole come favole. Ma per legittimare le sue regole d gioco, la modernit deve comunque costruire un discorso di legittimazione del proprio statuto, un diScorso puramente funzionale, un metadiscorso che chiama fi-losofia, e per far questo inevitabilmente fa ricorso a una meta-narrazione che implica una filosofia della storia (la "narrazione dei Lumi" o le grandi ideologie del xx secolo). Qui ci sarebbe gi da chiarire lo scarto tra illuminismo e ideologie, magari a partire dal significato della figura dell'intellettuale. Ma non questo il luogo.
Nella situazione di modernit, proprio a motivo delle sue in-time contraddizioni, che la storia concreta prima ancora che il pensiero rivela, si introduce un dubbio radicale: a dispetto della sua iconoclastia delle grandi narrazioni del tempo a essa prece-dente la modernit ha prodotto nuove mitologie, ma settoriali. In correlazione con questo la crisi della metafisica e dell'isti-tuzione universitaria. Molto pi di ci che sappiamo accadde con la fine delle ideologie nel 1989. La rottura dell'universalit del sapere con la crisi della cultura occidentale apre la porta al dialogo tra le culture e acuisce la sensibilit e la tolleranza ri-spetto alle differenze, ma non c' pi una misura comune, non arbitraria n basata sull'accordo, di fronte a cui confrontarsi nel dialogo. Rimane aperta la porta a ogni arbitrio. Si dialoga, si apprezza rispettosamente la diversit dell'altro e poi ognuno ri-torna nel suo piccolo mondo con sottile malinconia oppure con miope presunzione e patetico nardsismo.
A causa della mancanza di regole per il dialogo che non sia-no puramente funzionali, la frammentazione, segno tipico delle culture postmoderne, nelle quali il frammento privo di un ri-ferimento simbolico al tutto, la modernit pone comunque del-le regole, parziali, ai vari nuclei umani. Essa dice in sostanza, in maniera insensibile o clamorosa: "Siate operativi, mostrate cio le vostre prestazioni, o sparite". la sublimazione nean-che pi di tanto! del principio economico del profitto, perva-sivo di tutto l'orizzonte della vita. Anche alla religione si chiede di produrre effetti vantaggiosi all'uomo, godimento, serenit, distensione, ma, pi radicalmente, alla religione viene affida-to il ruolo di "ideologia del soggetto". E al monachesimo, di creare - come si sente dire luoghi dello spirito, tradotto spes-so con luoghi di vacanze alternative, con conseguenze disastro-se, se veramente questa diventasse la regola della societ glo-bale. Si tratta di un uso frivolo o - peggio ancora - di un abu-so, a cui non dobbiamo prestarci, anche se venissimo blanditi a produr! o.
-
La religione invisibile: tra gnosi ed estetismo religioso
La fede in Ges di N azaret e la sequela di lui nella via mona-stica rientrano forse nella crisi delle grandi narrazioni ideolo-giche; o sono forse riducibili a regola interna di un sistema re-ligioso particolare, sia pure fascinoso? Qui la sfida del post-moderno che ci investe. Cerchiamo di raccoglierla declinando anzitutto come essa si configuri nella forma della "religione in-visibile".
a livello del mondo cattolico pi attento e in dialogo con la cultura laica che il pensiero postmoderno ha le sue ripercussio-ni. La dinamica pi appariscente che manifesta l' aggiornamen-to cattolico et quidem lo stesso aggiornamento delle forme di quella che convenzionalmente qualificata come vita religiosa, appare quella della secolarizzazione. Il programma che procla-mava la necessaria secolarizzazione del cristianesimo stato espressamente enunciato nella breve stagione tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni settanta. Quella stagione pass in fretta, ma ne rimasero largamente operanti alcuni as-sunti che, quando vengono formalmente dichiarati, appaiono estremamente ingenui, ma che di fatto, non dichiarati, conti-nuano a operare. L'autorizzazione per la verit cristiana nella situazione civile presente cercata attraverso la sua riduzione a verit secolare. Un'illustrazione macroscopica di tale fenome-no la risoluzione dell'evangelo in termini di carit e questa compresa nei termini riduttivi del servizio all'uomo nel biso-gno con la conseguente rimozione delle figure del perdono e del servizio all'amico, che viceversa appaiono essenziali all'im-maginario della carit cristiana.
Maestro riconosciuto del programma secolarizzante apparve allora Dietrich Bonhoeffer. Ma si trattava di una rilettura che fraintendeva Bonhoeffer proprio nel punto nevralgico del suo pensiero: il rapporto fede-storia. In realt, nonostante la sua cri-tica del cristianesimo religioso e devoto potesse prestare il fian-
r8
co a un'interpretazione di tal genere, Bonhoeffer cercava la ra-dicalit della fede in un'epoca in cui le chiese manifestavano il fallimento nella loro missione di interpretare la storia alla luce dell'evangelo. Di Bonhoeffer il secolarismo ha assunto la forma senza averne compreso la fede.
Cos, il rischio proposto dalla secolarizzazione civile non tanto quello della "fine della religione", quanto invece quello di una religione intesa come spazio poetico, nella sua accezione letterale: della poisis del soggetto senza una dimora. Di fatto, la sociologia della religione, dopo la breve stagione in cui pro-clam la tesi radicale della fine della religione, da vent'anni e pi proclama invece un'altra tesi, quella della permanenza della religione nella societ secolare o addirittura del suo ritorno, per altro in forme caratteristiche e problematiche. La formulazione pi chiara e ancora oggi fondamentalmente pertinente quella elaborata da Thomas Luckmann con la figura della "religione invisibile" 6 , una religione cio senza chiesa e organizzata come ideologia del soggetto. Si tratta di un'elaborazione ideale o sim-bolica il cui obiettivo consentire la rappresentazione dell'io in un mondo, l'universo civile, che invece non si mostra pi capa-ce di assegnare all'io un nome e un destino, o una dimora, un thos. Le sue forme sono quelle tipicamente esoteriche, "il bru-sio degli angeli" 7 , quelle cio alimentate dalla risuscitazione di relitti simbolici mutuati alle grandi tradizioni religiose, di fat-to sequestrati rispetto alle forme correnti della comunicazione umana quale si produce nella societ secolare.
In tale quadro si ripropone in forme nuove l'antico rischio di gnosticismo, e in modo particolare nell'ambito monastico. La ca-tegoria andrebbe in tal senso intesa non in riferimento a un ipo-tetico e indebito privilegio della conoscenza o della teoria rispet-
6 Cf. Th. Luckmann, La religione invisibile, Il Mulino, Bologna r976. Cf. P. L. Berger, IL bmsio degli angeli. Ilsczcm nel/
-
to alla prassi, ma in riferimento al tratto "iniziatico" del sapere che salva, nel senso che esso inizierebbe a un sapere arcano sem-plicemente altro rispetto alla rugosa corposit della chiesa reale e a ci di cui questione nelle forme comuni, profane, della vita.
Le forme clamorose di tale interpretazione gnostica della re-ligione sono certo quelle delle nuove religioni, e in specie del-la new age. Dobbiamo peraltro subito precisare che anche in ambito ecclesiale - non dico monastico! - gli stessi simboli (sa-cramenti) cristiani sono di fatto trattati come relitti simbolici, semplicemente sequestrati rispetto alle forme della vita comune secolare. Le interpretazioni che della simbolica cristiana offro-no le aggregazioni carismatiche e "calde", i movimenti, tenden-zialmente separati rispetto all'universo simbolico della societ ambiente, rinforzano tale interpretazione che della simbolica cri-stiana spontaneamente e confusamente d la coscienza del sog-getto individuale, che ha imparato la litania spiritualistica del-l'anticonformismo religioso. Ma anche certi frequentatori di mo-nasteri, se non incontrano un interlocutore chiaro e netto nella proposta del mistero cristiano, dell'incarnazione, della salvezza in Ges Cristo e questi crocifisso, sono nella tentazione di equi-parare il "recinto" monastico e il suo fascino ai linguaggi esote-rici dei movimenti che trasmettono un messaggio emotivo pre-varicante sul semplice evangelo. E la tentazione che l'aura mo-nastica esercita su di loro in tal caso uguale e corrispondente alla tentazione per il monastero di prestarsi a tale gratificante funzione, quella cio di suscitare emozioni forti.
Si potrebbe identificare un'ulteriore provocazione della cul-tura postmoderna con la descrizione dello sfondo antropologico generale, entro il quale prende figura la religione invisibile. Lo sfondo quello dell'esilio a cui il soggetto (o la coscienza) con-dannato da un universo civile organizzato nel segno della razio-nalit scientifica e burocratica, o giuridica. Le questioni di giu-stizia, di fatto tanto dibattute nella stagione successiva alla fine delle "grandi narrazioni" o delle ideologie, sono pregiudizial-
20
mente rappresentate come questioni di equit nello scambio e di soccorso nel bisogno. Egualitarismo e umanitarismo ne sono i due poli. Manca invece il riconoscimento della questione pi seria, quella del difetto di evidenza di un senso o di una promes-sa della vita, il quale consenta la determinazione della libert del singolo, e questo a prezzo della sua stessa identit.
La realizzazione del compito che a ogni essere umano inevi-tabilmente si pone, quello dell'identit del soggetto, viene pre-giudizialmente pensata nella forma estetica, nella forma cio di un "accadere" sorprendente del riconoscimento di s. Come se per riconoscersi nella propria verit originaria fosse necessario prescindere dalla storia, dall'esercizio di una volont istruita dal-l'esperienza, per affidarsi invece a una presunta esperienza "mi-stica" della mano di Dio nella propria vita.
La vocazione storica del monachesimo a questo riguardo - co-me riesco a capire - non certo quella di prestarsi a sfondo di questa ricerca indefinita di sacre emozioni, ma mi pare piutto-sto quella di mostrare nella semplicit di giorni comuni e di ce-lebrazioni piene della sobria ebbrezza della liturgia ecclesiale la possibile armonia di regola di vita e meraviglia della fede, lo splendore dei piccoli e la bellezza degli umili.
Come raccoglie il monachesimo cristiano la sfida di una societ "senza padri"?
La radicalit della crisi non sorprende n seduce. Il monaco addestrato alle crisi ultime e sa del pericolo che si annida nel pretendersi salvatori in tempo di crisi o nell'affidarsi a tali pre-sunte figure. Perci nella generale situazione di crisi il monaco si fa compagno di pellegrinaggio, come colui che ha ricevuto una preziosa eredit, che non per un tesoro geloso.
21
-
Custodire l'inizio e alimentare la speranza
La vera domanda allora di fronte al futuro, che pulsa entro ogni domanda sulla realt di oggi e sul proprio posto in essa non : "Come ottimizzare le nostre prestazioni?", ma: "Come custodire l'Origine e la Speranza affidateci?". In tale situazio-ne critica che tutti ci investe, potremo al limite anche mori-re, non dico solo personalmente ma come monachesimo, che - pur antico - non ha avuto promessa di indefettibilit. Ma, se avremo custodito fedelmente l'Origine e la Speranza, sar anche questo morire un "dare gloria a Dio" (Gv zr,r9). Custo-dire non vuol dire volgerei all'Origine per appropriarci di essa, traendone autorizzazioni al nostro operato, che il grande ri-schio dei "nobili", anche dei nobili ordini monastici. Giocare con le origini per trovarvi le allegorie del breve tratto di strada che stiamo ansiosamente percorrendo pu anche gratificare, ma ci rende evangelicamente irrilevanti. Occorre pensare in grande il senso e l'orizzonte, stando, cio, dinanzi al mistero della no-stra salvezza, fosse anche al buio e privi del conforto di applau-si. Ma non privi della consolazione delle Scritture sante.
L'inevitabile sigillo del "post" coglie tutti gli esiti di un in-discriminato perseguimento dell'emancipazione e chi ne vede la traccia si trova esposto alla tentazione di una sorta di scora-mento, variamente orchestrato. Lo scadimento delle domande originarie, manifestato dalle questioni oggi di moda (pensiero debole, fallimento, frammentazione, depressione), ancora un kair6s da guadagnare (cf. Ef 5,r6) nel senso che fa da richiamo a ritrovare dialetticamente l' arch. Si profilano delle polarit di questo ritrovamento dell'Inizio, che passa per il richiamo che viene come in sordina proprio dali' erramento della cultura per rischiosi sentieri. La moda e il suo fascino fatuo, o per lo me-no ambiguo, richiama a riscoprire lo stile, impareggiabile segno di autenticit di una vita adulta. La merce e il denaro, che con le loro inflessibili leggi pretendono di dominare il mondo, ri-
22
chiamano a riscoprire il cuore. Altrettanto forte il richiamo che spunta dalle contraddizioni della modernit, che spingono a un "oltre" il postmoderno: la contraddizione tra affermazione dell'individualit e svalutazione della persona, tra affermazione della soggettivit e dissociazione completa del mondo tecnico ed economico dal mondo del soggetto, la dissociazione tra siste-ma e attore, tra strumenti e senso, tra economia e cultura.
La custodia del cuore
Il richiamo cui i monaci devono essere sensibili la sollecita-zione a riscoprire e testimoniare con integrit e passione il mi-stero e la potenza umile e grande del cuore umano, che qual-cosa di pi dell'animuccia, pur bella ma senza mondo, di hege-liana memoria. Il cuore infatti, come rivela l'evangelo, il luogo di riannodo dei mondi pi distanti, di tutti i mondi da cui l'uo-mo riguardato.
Su tutto domina il richiamo a "riscattare i giorni cattivi" (Ef s,r6), che viene dalla tragicit della sfida lanciata dalla dilagan-te violenza all'amore incondizionato. L'amore, l'umile amore quotidiano, per il monaco il sapere dei giorni, della sua unifi-cata ricerca di Dio. Al contrario, per il pensiero postmoderno si contrapporrebbe al mondo con un verdetto la cui tragicit pren-de corpo nel clamoroso persistere della violenza tra l'uomo e il suo fratello.
A questo punto le domande scaturiscono a grappolo dalla cul-tura postmoderna fino a rifrangersi sul monachesimo. Le accen-no, in quanto ci faranno da sfondo nella esposizione del pos-sibile percorso di riappropriazione della "preziosa eredit". Il monachesimo: si tratta di un revivallegato alla dissoluzione del-la citt moderna? O monaco dice la semplicit della fede che sfi-da la minaccia di dissoluzione del mondo? Il frantumarsi del reale nella coscienza dell'uomo postmoderno l'orizzonte vero?
23
-
Alla tirannia dei mass media e del denaro occorre realisticamen-te rassegnarsi?
Il monachesimo forse ha in s - non so quanto se ne renda conto e se sapr assumere tale responsabilit - una piccola chia-ve per aprire la via e mettersi umilmente al fianco di altri cerca-tori alla ricerca appassionata di risposta, la chiave che apre il pas-saggio dalla seduzione di Narciso, dall'enfasi dell'io, in tutte le sue forme, alla gioia della quotidianit scoperta con meraviglia come terreno in cui nascosto l'inestimabile tesoro, l'evangelo, e pertanto vero luogo di gestazione del futuro, della unificante salvezza dell'umano. Ritrovare il cuore: questa l'impresa che si propone il monaco, come ha scritto Pier Angelo Sequeri:
L'interesse intramontable della forma monastica, insieme con la sua singolarit cristiana, sta proprio nel fatto che essa ren-de speciale l'essenziale, massimo il minimo, eccezionale d che pi comune 8.
La crisi dell'epoca allora crisi di idee, crisi della cultura oc-cidentale? O alla sua origine non sta piuttosto la frantumazione dell'umano, la separazione troppo netta tra sentimenti e co-scienza, cos che l'una prevarichi sugli altri o viceversa? Questa domanda la sfida che il monachesimo - oggettivamente dico; di fatto poi cosa succeda, da vedersi - lancia alla cultura post-moderna a partire dalla lettura dell'evangelo.
L'antintellettualsmo paralizzante
Nel disegnare il profilo del postmoderno, nei suoi riflessi sul-l'esperienza religiosa, ci si imbatte - e l'impatto rude con
'P. A. Sequeri, "Beata soltudo?", p. 73
l'antintellettualismo. una sorta di veste "agnellina" del post-moderno intessuta - anche nei monasteri! di una rapace au-toreferenzialit che si alimenta a un sentimentalismo retorico. Che si vuol dire? Il sentimento, l'affetto, di certo una dimen-sione originaria dell'esperienza della fede. Ma sentimento in tal senso tutt'altro che sentimentalismo retorico come appare in-vece l'enfasi sentimentale di certi "spirituali": niente di pi che un rigonfiamento di aura emotiva vuota di qualsiasi intenzio-nalit, senz'alcun coinvolgimento della libert, disarticolata da ogni movimento di adesione all'evento dell'evangelo. In man-canza di reale relazione con il darsi della rivelazione di Dio in Ges, ci si consuma e ci si estenua nella ripetizione di fram-mentari impulsi d'anima, di un'anima senza storia. E crescono il risentimento e la delusione, che niente di meglio trova che appigliarsi a chi con modestia e onest cerca di usare l'intellet-to. Con il pretesto di una libert dal vuoto ragionare ci si stacca dal vivo filone della sapienza biblica, autentica forma della vita spirituale cristiana. Certo, i fallimenti della ragione moderna spingono a cercare un approccio diverso per arrivare alla vera intelligenza spirituale della realt. Credo che l'apporto partico-lare del monaco alla ricerca di una nuova intelligenza consista in un sapere che con un approccio esperienziale non esclude ma configura un nuovo esercizio della ratio.
La globalizzazione e la marginalit
L'antica metafora monastica della fuga mundi trova una tra-duzione peculiare nella contemporaneit, che si inserisce a suo modo nella complessa questione della globalizzazione. Accenno soltanto come per richiamare che si tratta di una questione in-clusa nella domanda di come testimoniare l'evangelo oggi e per precisare che, interrogandoci sulla nostra presenza di monaci, diviene indispensabile ricordarci le ragioni evangeliche della se-
-
parazwne, che non sono identiche a quelle del monachesimo come tale.
Oaai assistiamo sin dentro la comunit cristiana, a una radi-oo '
cale messa in dubbio della possibilit di un senso per il mona-chesimo cristiano. Esso sarebbe infatti in questa epoca, diver-samente da un passato dominato dal regime della cristianit, implausibile da un punto di vista cristiano, poich proprio in quanto ricerca di unit sarebbe privo di qualsiasi valenza mis-sionaria, che imprescindibile dall'identit cristiana in base al-l'intima dinamica della vita trinitaria rivelata da e in Ges (cf. Gv 20,21). In un pensiero di questo tipo si manifesta un preci-so modo di intendere il rapporto monachesimo-mondo. A mio parere questa lettura equivale a un completo fraintendimento del fenomeno monastico cristiano, dal momento che lo si inten-de indissolubilmente ed esclusivamente legato alla cultura anti-ca, anzi lo si comprende propriamente come una gnosi. Come se quella dell'unificazione fosse una cultura irreparabilmente estromessa dal circuito del dialogo interculturale, che in questa ipotesi ammette solo interlocutori omogeneizzati sul modello culturale della frammentazione, rimanendo il ruolo dell'unifi-cazione affidato solo all'economia e all'informazione. In realt il monachesimo legato all'animo umano e non a una "cultura dell'unit" di tipo plotiniano, anche se agli inizi pot appro-priarsi di tale infrastruttura di pensiero. Il monachesimo cri-stiano poi, entro il quale i due termini stanno in tensione dina-mica, scaturisce dalla qualit della vita cristiana di estranei-t-appartenenza al mondo.
Per intenderei, un'appartenenza al modo del forestiero. Ge-s sul percorso tra Gerusalemme ed Emmaus ha rivelato co-me possa darsi nella comunicazione interumana originaria una estraneit massimamente relazionata, quando alla provocazione dei due discepoli in fuga mostra di non essere cos forestiero da non sapere le cose accadute, ma di essere cos estraneo da sa-perle in maniera radicalmente innovativa. Credo che la catego-
z6
ria di stranieri residenti (cf. rPt r,q; z,rr), di domestici sen-za citt stabile qui (cf. Eb rr,r3-r6) sia un orizzonte simbolico pieno di verit per comprendere e dire dove e come il monache-simo presente al travaglio dell'epoca attuale.
La categoria tradizionale di xenitefa va perci ,ripresa e attua-lizzata nelle condizioni antropologiche attuali. E infatti un'im-portante luogo di identificazione del monachesimo come, d'al-tra parte, fondamentale per il cristianesimo stesso. Mi pare che per ogni concreta espressione di monachesimo cristiano que-sta operazione spirituale sia decisiva per definire interiormente il gruppo sia di fronte all'evangelo che di fronte al mondo. Co-me tutti i cristiani, nel mondo ma non del mondo.
La coppia eletti-stranieri (dispersi) fu adottata in origine per superare uno scandalo interno al cristianesimo: i cristiani pro-vocati dalla storia di persecuzione e dal fallimento in seno alla cultura ebraica cercavano di darsi una ragione dell'apparente in-significanza. In seconda istanza la coppia di termini antitetici dice il modo positivo della presenza del cristiano nel mondo. Il paradosso della Prima lettera di Pietro pieno di senso: ama-ti, ma senza diritti; uomini comuni, eppure diversi. Sarebbe pieno di significato a mio parere mettere a confronto un testo come la lettera A Diogneto con !"'Excursus sullo straniero" di Georg Simmel:
Se il migrare costituisce, in quanto distacco da ogni punto spaziale dato, l'antitesi concettuale alla fissazione in un ta-le punto, la forma sociologica dello "straniero" rappresenta per in qualche misura l'unit di entrambe le determinazioni ... Qui dunque ... si intende lo straniero ... come colui che oggi viene e domani rimane ... La sua posizione in questo ambito determinata dal fatto che egli non vi appartiene fin dall'inizio, che egli immette in esso qualit che non ne derivano e non possono derivarne. L'unit di vicinanza e di distanza, che ogni rapporto tra uomini comporta, qui per-
-
venuta a una costellazione che si pu formulare nella manie-ra pi breve nei termini seguenti: la distanza nel rapporto si-gnifica che il soggetto vicino lontano, mentre l'essere stra-niero significa che il soggetto lontano vicino ... Lo straniero un elemento del gruppo stesso, non diversamente dai pove-ri e dai molteplici "nemici interni", un elemento la cui posi-zione immanente e di membro implica contemporaneamen-te un di fuori e un di fronte ... Un'altra espressione di que-sta costellazione consiste nell'oggettivit dello straniero ... L'oggettivit non affatto una non-partecipazione ... ma una specie particolare di partecipazione ... L'uomo oggettivo non vincolato da fissazioni di alcun genere che possano pregiudicare la sua recezione, la sua comprensione, la sua ponderazione del dato ... [Lo straniero] il pi libero, prati-camente e teoreticamente, egli abbraccia le situazioni con minori pregiudizi, le commisura a ideali pi generali e pi oggettivi, e non vincolato nella sua azione dall'abitudine, dalla piet, dai precedenti 9
La categoria del liminale intrinseca alla definizione del gruppo umano. Infatti come essere liminale lo straniero ha una sua inconfondibile presenza nella societ, in quanto per la sua distanza (c', ma arriva da altrove e pu da un momento all'al-tro andare altrove) provoca il gruppo a riorganizzare i propri confini operativi e cognitivi.
La liminarit, la marginalit cos espressa dice qualcosa della vita monastica, della vita della comunit monastica ai margini della citt. Ma per riproporre questo messaggio, i monaci devo-no impersonarlo in verit. Occorre dunque ritrovare, senza ti-mori indotti da malintesi presenzialismi, la xeniteia come una tessera dell'eredit di cui rispolverare lo smalto. Sarebbe stolto
9 G. Smmel, Sociologia, Edizioni di Comunit, Milano 1998 1 , pp. 580-582; cf. an-che Vicinam:p e lontanam:a. Modelli e figure dello straniero come categoria mciologica, a cura di S. Tabboni, Franco Angeli, Milano 1986.
28
che la retta intenzione di farci evangelicamente presenti al mon-do, alla citt, d portasse a svuotare questa nota propria e questa estraneit feconda.
In questa dimensione di xeniteia il monachesimo pu creare una parola altra, che non ripeta i luoghi comuni teologici o ecclesiastici; pu divenire spazio di libert e di parrbesia, e perci di incontro e di riconoscimento reciproco tra diversil0
Riappropriarsi "con il cuore" dell'eredit magnifica
Il postmoderno crea una situazione di disorientamento pro-clamando la discontinuit dei tempi; "post" infatti la metafo-ra di un passato di cui la memoria conserva solo il lutto. In que-sta situazione il monachesimo non pu non cantare la sua viva memoria, aprendo cos il sentiero all'irruzione del nuovo. Per trovare la voce a questo canto, credo si debba fare uno sforzo di riappropriazione della propria preziosa e viva eredit. Solo cos, perch sotto la temperie del postmoderno anche noi d sia-mo allontanati come dice il profeta Baruc (cf. 1,15-22), senza ritenerci n avanguardia n laudatores temporis act, possiamo cercare di trasmettere gratuitamente ci che per grazia abbiamo ricevuto, confidando nella forza profetica non degli eroi o dei perfetti, ma dei npioi, "piccoli", e del "piccolo gregge"; senza per questo assomigliare a nessuna conventicola grazie allo slan-cio gratuito di missionariet intessuto nel nostro abito insieme con la trama dell'ascolto. La storia dell'umanit da sempre pas-sa attraverso questi piccoli: cos ci ha rivelato il Signore Ges.
10 L. Manicardi, I c1istimti stranieti e pellegrini, Qiqajon, Base 1997 (Testi di medita-zione 79), p. 14.
-
Parlando di riappropriazione dobbiamo comunque prendere coscienza di una rottura radicale, avvenuta pi o meno sensibil-mente dovunque, paragonabile (ma differente!) a quella avve-nuta nel XIX secolo, quando la vita monastica riprese dopo le soppressioni. In quel tempo si poteva pensare all'ideale della pura restaurazione ed era anch'esso un tentativo di risposta al-l' avvento della modernit; oggi siamo avvertiti dell'illusoriet di questo tentativo. Non c' ritorno alle radici che non sia an-che un'intelligente assunzione dell'aria in cui si vive. Altrimen-ti, il risultato sar da tenere a dovuta distanza dai consumatori, in teche di cristallo, come in un museo, ma non sopporter il corpo a corpo del dialogo tra pellegrini e stranieri, quei cercato-ri di Dio ai quali la nostra stessa regola monastica ci lega con vincoli di sangue.
Ma di che cosa dobbiamo riappropriarci? Della stabifitas foci da intendere in paradossale controtenden-
za rispetto allo spirito di nomadismo della cultura moderna, che trova in Ulisse il suo eroe. La stabiftas una forma di concen-trazione del profilo viceversa essenziale per il quale la libert dell'uomo ha la forma della ripresa di un inizio gi posto, dona-to per grazia. La stabiltas intende rimediare alla libido dell' av-ventura sorprendente. intrinsecamente correlata con il miste-ro dell'incarnazione, secondo il quale Ges visse trent'anni im-merso e nascosto tra gli umani, imparando dalle cose ricevute, prima di annunciare con parole udibili la venuta del regno di Dio. Ebbene, sembra che oggi manchi alla ecclesialit la stabile visibilit, teologica e istituzionale, di una fanna ecclesiae altra dall'appartenenza informe e dall'apostolato organizzato, la qua-le sia capace di dare sostanza di fermento evangelizzatore alle qualit elementari della vita cristiana. Questo modo anomalo di abitare dall'interno la civilt, che prima definivamo con la categoria di liminarit, se si presenta con la semplicit della co-lomba e l'astuzia del serpente, che non si fa catturare e, rifiu-tando ogni esibizione della sua origine assoluta, si affianca con
la sua modestia a ogni uomo e donna comuni, pu dire molto e "altro" alla triste citt postmoderna. Cose che possono essere dette solo nell'umilt di un avvicinamento graduale, nella segre-ta tenacia del legame con il Signore, che sono tutt'altra cosa dalla "religione invisibile". Si tratta di una comunicazione della fede e nella fede, di cui i monasteri devono custodire lo spazio sacro. Tale spazio viva voce di evangelo rivolto allo svilimento burocratico della convivenza nella citt moderna e "post". Sia-mo preceduti: il monaco sa e testimonia questa grazia preve-niente dimorando presso le radici e annunciando di l orizzon-ti di libert. Come potrebbe esistere un accogliente bospitium senza la stabiltas foci, non solo materiale ma anche cordiale?
Della conversi o m o rum. Alla luce di quanto detto sopra vedo un nesso stretto tra conversio e stabifitas. Per trovare me stesso, debbo cercare dove sono; appunto questo il senso della conver-si o. I mores, senza figura e senza rilievo nella cultura estatica (e quindi anche estetica) del nostro tempo, sono raccomandati co-me vera dimora (tbos) dalla tradizione antica della Grecia. Essi sono il terreno sul quale si realizza l'esorcismo dell'assenza di Dio dalle forme della vita comune della societ secolarizzata. E qui si diparte il cammino delle virt di antica memoria ma tutto da riscoprire nella nuova temperie 11 . Non affatto scon-tata tra i monaci e le monache di oggi l'opportunit e la bellezza liberante di un processo di conversione al battesimo, alle virt cristiane, un cammino di pedagogia, di ascesi non pi contrap-posta alla mistica. Tutto questo non affatto scontato! Non lo dico solo per le nuove venute, ma anche per le generazioni adul-te. La vocazione storica del monachesimo nel nostro tempo de-ve andare in tale senso, quello cio di restituire evidenza a quel
11 Su questo argomento rimando a M. L Angelini, "Virtus in in/mitate. VirtLl mona-stiche n un tempo frantumato: prezioso antiquariato o esercizio di conversione all'e-vangelo?", in iHonastica 42 (zoor), fascicolo r, pp. 17-30; fascicolo 2, pp. I93r; fasci-colo 3, pp. r8-3o; fascicolo 4, pp. }044
31
-
tratto morale, non contrapposto a mistico, che costituisce in-dubbiamente un tratto qualificante del cristianesimo. Bastereb-be ripensare alle parenesi di Paolo e delle lettere apostoliche! In questo il monaco pu condividere il prezioso dono della sua tra-dizione, riappropriata, alla civitas e alla sua faticosa ricerca di percorsi educativi.
Anche dell'obbedienza, forse. Essa infatti l'anima profonda del monaco che, attratto dalla singolare bellezza di Cristo, il Fi-glio, si riceve e cerca ovunque con desiderio le tracce della divi-na valuntas, "l'Amor che move il sole e l'altre stelle" 12
Questa riappropriazione avviene secondo tre modelli che pla-smarono gi nei secoli generazioni di monaci: leggere, celebra-re, servire o, meglio, purch sia inteso in senso cristologico, ob-bedire. Sono questi tre modelli che nelle pagine seguenti vorr richiamare ed esplorare a servizio dell'autenticit e verit della parabola monastica per questo nostro tempo.
12 Dante Alighieri, La divina commedia. Paradiso 33, I45.
"Fate attenzione a come ascoltate" (Le 8,r8)
L'ARTE DELLA LETTURA STRADA ALL'ASCOLTO
Il testo lucano che fa da titolo mi apparso quanto mai in-quietante guardando alla nostra storia di oggi. Tanta violenza nel mondo, e tutti, chi per un verso chi per un altro, succubi: non forse perch abbiamo disimparato ad ascoltare? E di que-sta ignoranza epocale il monachesimo non deve forse assumersi le sue pesanti responsabilit riconoscendo che spesso si pre-occupato di dirsi, di autorappresentarsi o al contrario di soprav-vivere, di conquistarsi uno spazio nella scena del mondo pi che di ascoltare in senso teologale? Mi sono domandata se la provocazione evangelica non ci solleciti a rivedere la qualit del nostro ascolto, che pure l'atteggiamento fondamentale ri-chiesto dalla Regola, uscendo da ogni protagonismo o elitarismo spirituale, da ogni allegorismo di "anime belle". Come siamo oggi in ascolto di colui che parla, certo nelle Scritture e nella celebrazione, ma anche e in modo fondamentale nella storia? Domande serie stanno sotto questo abbozzo di discorso.
33
-
"Fate attenzione a come ascoltate" (Le 8,18)
Ascolto come "hypomon"
Il versetto che fa da titolo a questo capitolo, tratto dall'Evan-gelo di Luca, inserito tra la parabola del seminatore e la sua interpretazione (cf. Le 8,1-15), e il detto sulla madre e i fratelli di Ges (cf. Le 8,19-21), cio sulla qualit della relazione di fa-miliarit con Ges e su che cosa la determina. A conclusione della spiegazione della parabola sulla seminagione e la qualit del terreno, l' hypomon era stata identificata come la condizio-ne di terreno che permette al seme della Parola di esprimere la sua massima fecondit (cf. Le 8,15). Esso infatti si consegna alla terra in vista non di una custodia statica, ma di una fecon-dit illimitata, che porta il seme a morire e a farsi "altro", una fecondit non originata da una capacit imprenditoriale, come spesso appare la scienza esegetica, ma dall'atteggiamento emi-nentemente spirituale del "rimanere sotto". Da questo punto di vista mi ha sempre colpito un'immagine: l'uomo-cariatide dell'ambone di Sant'Ambrogio a Milano un simbolo splendi-do di questa pazienza, da non intendere nel senso del "com-plesso di Atlante", ma come espressivo di quell'atteggiamento amoroso che nel salmo 27,14, citato dalla Regola di Benedetto al quarto gradino della scala dell'umilt (cf. 7 >3 7), viene espresso dalla traduzione della Vulgata in maniera splendida: "Confatte-tut cor tuum, et sustine Dominum", "Si rafforzi il tuo cuore e sopporta il Signore". Fatica di un "corpo a corpo" quotidiano massimamente vitale. L'evangelo, da parte sua, prosegue:
34
Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso, o la pone sotto un letto; la pone invece su un lampadario, perch chi entra veda la luce. Non c' nulla di nascosto che non deb-ba essere manifestato, nulla di segreto che non debba essere
conosciuto e venire in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate perch a chi ha sar dato, ma a chi non ha sar tolto anche quello che crede di avere (Le 8,r6-r8).
Il primo senso del come ascoltare dunque definito dalla hy-pomon. Si ha ci che si accolto in quella attiva passivit che la libert che acconsente, nello stare, nel rimanere sotto la Pa-rola per averla in s come energia vitale. La pazienza in questa accezione il primo criterio dell'ascolto adulto e maturo di fe-de. Vedremo che questo atteggiamento "virtuoso" si articola nella forma di un "dimorare" nel testo.
In secondo luogo, dice il prosieguo dell'evangelo, nell'ascolto della fede non si tratta di una rivelazione per pochi eletti desti-nata a singolarizzare dei recettori privilegiati. L'ascolto della Parola evangelica non esperienza esoterica, destinata a rima-nere contenuta in circoli elitari. Se il Battista ha potuto parlare "per categorie" (cf. Le 3,ro-18), Ges parla e non discrimina tra i suoi uditori; solo la libert dell'ascolto che distingue un uditore dall'altro. Ges parla a tutti insieme. L'evangelo per tutti. Anche quando parla ai discepoli, Ges lo fa di fronte alle folle e in funzione di tutti. In corrispondenza potremmo anche tradurre questo tratto in una qualit dell'ascolto: la lectio divina non fatta per rimanere una preziosa esperienza, pur accatti-vante, riservata a pochi. Ogni sorta di ricezione ripiegata sul soggetto sarebbe come un avere che non ha, cio un credere di avere la Parola. C' dunque una frequentazione della Parola fal-lace, illusoria, che viene smascherata inequivocabilmente; men-tre l'assiduit alla Parola che si fa annuncio, che si effonde in frutto, riceve benedizione su benedizione. "A chi ha sar dato", sta scritto.
Il titolo da cui abbiamo preso avvio preannuncia dunque una questione seria. Potremmo enunciarla in questi termini: come mai i monasteri, che pure sono nati come scuola del servizio divino, scrptora in cui coltivato lo studio delle Scritture, ap-
35
-
paiono oggi cos poveri di messaggio evangelico? Come mai si va ai monasteri per acquistare oggetti artistici, liquori o erbe o saponi naturali, o per visitare bellezze antiche pi che per ap-prendere l'arte di ascoltare la Parola? Eppure scriveva non molti anni fa Giovanni Paolo II: "Il monachesimo in modo particola-re rivela che la vita sospesa tra due vertici: la parola di Dio e l'eucaristia" 1! Noi, che cosa riveliamo? La domanda mi pare se-ria. E tutto dipende dall'ascolto, dalla qualit dell'ascolto che a partire dalla lecto divina e dalla celebrazione mettiamo in atto.
Scrittura e liturgia
Non indifferente in riferimento alla nostra questione sul come ascoltare che questo binomio, eppure fondamentale, non opzionale, sia cos disatteso nella comunicazione spirituale cor-rente. Eppure tutto il rinnovamento postconciliare ce lo ha ti-proposto con forza, e soprattutto nella tradizione monastica il cuore dell'esperienza spirituale. Leggere il testo sacro e cele-brare sono due momenti inseparabili, come inseparabili furono nella fede dell'inizio, in quel legame con Dio che d'improvviso apparve cos vitale da far nascere l'imperativo di trasmetterne il dono, di fare memoria nella celebrazione e di consegnare alla Scrittura l'evento di salvezza vissuto e ricordato. Come dice il salmo roz,r9: "Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo nuovo dar lode al Signore".
Il testo scritto, proprio a partire dalla sua proclamazione nel mistero celebrato, sempre di nuovo accade nel tempo della quo-tidianit e lo feconda nutrendolo. L'ambiente pi consono per la lettura spirituale, il suo luogo originario, cos la liturgia. Gi lo spiegava Gregorio Magno commentando il racconto dei due
1 Giovanni Paolo II, Orenttlle lumen ro.
discepoli di Emmaus: "Riconobbero il Signore nel pane spezza-to, essi che non erano riusciti a riconoscerlo nell'esposizione della sante Scritture" 2, come a suggerire che la lettura biblica disancorata dal memoriale di Ges resta indecifrabile e muta.
Inoltre, la liturgia il luogo originario di quel processo di "al-legorizzazione" del testo, in cui consiste la lettura spirituale, intendendo questo termine in senso letterale: dentro la cosa scritta dire altro. Si tratta di cogliere come, nella particolarit del testo biblico, Dio dice oggi ci di cui abbiamo fame per po-ter vivere. La celebrazione dei misteri di Cristo il contesto pi proprio per cogliere non arbitrariamente le vibrazioni moltepli-ci, la polisemia della Parola scritta. Nomino solo questo nodo della spiritualit cristiana antica, come per richiamare l' atten-zione sull'orizzonte della lettura monastica della Bibbia, che pertanto si differenzia sostanzialmente da ogni lettura strumen-tale, tematica o a tesi, del testo biblico. Solo il mistero liturgico e il criterio della lectio continua fanno da chiave per aprire il libro della Scrittura. Nessuna curiosit o spirito di avventura, per spirituale che sia: un monito costante e severo degli anti-chi padri.
"Fate attenzione a come ascoltate", dice l'evangelo, per non isterilirvi, ma crescere nella relazione di fraternit-maternit al-la Parola, come conclude Luca (cf. 8,r9-2I).
La lectio divina, sigillo della spiritualit dei monasteri, pu davvero esprimersi in messaggio di chiesa per la chiesa e l'uma-nit tutta?
La guerra, la violenza, la menzogna che dominano la scena di questo mondo, ci chiamano. Come il nostro un avere che ha, un dire che annuncia, in obbedienza alla Parola, un dire-ascol-tando, perch sia dato in abbondanza?
2 Gregorio Magno, Omelie sugli evangeli 23.
37
-
Ascoltare
La differenza tra ascoltare e sentire
Per trasmettere con fedelt l'arte tutta monastica di leggere necessario prima saper ascoltare e insegnare ad ascoltare. L' at-teggiamento dell'ascolto, inattuale in una cultura autoreferen-ziale, - per usare 1 'espressione di un noto saggista contempo-raneo - una passione mai spenta. Benedetto, scrivendo la sua "piccola regola per principianti" (RB 73,8), lo riconosceva fon-damentale. Alla fine di un'epoca superba, di una cultura do-minatrice, con il forte incipit della Regola: "Obsculta o fili", "Ascolta figlio" (Prol. r), egli intende annunciare uno stile di esistenza pi che regolare un atto particolare. Poich sulla base della rivelazione cristiana, "nihil sine voce", "niente senza vo-ce" (rCor r4,ro), e "tutto stato fatto per mezzo della Parola" (Gv r,3), l'essere umano che si presenta per la conversione della fede deve anzitutto mettersi in atteggiamento di ascolto totale. Innumerevoli linguaggi da decifrare (della creazione, della sto-ria, dei singoli esseri) attendono di trasmettere il messaggio in essi deposto dall'alto, e da ci emerge la figura del credente co-me essere abitato da una grande e totale passione per la Parola. "Trovata la tua parola la divorai", dice Geremia (rs,r6). Questa sorta di voracit, questa fame originaria di vivere incontrando la Parola, ci rende a tal punto vitalmente reciproci del Dio che parla, che l'esperienza corrisponde a un vero e proprio divorare. Il che ben diverso da ogni curiosit vorace e vana dispersione: la passione per la Parola, deposta in ogni vita, si alimenta anzi-tutto di silenzio.
Benedetto vive in un'epoca che conosceva una cultura ormai al suo declino, ma intuisce il nascere di una nuova cultura, ca-ratterizzata dalla capacit di percepire nuovi linguaggi, stolta-mente disattesi o disprezzati, linguaggi "barbari", volgari: una umanit che si cerca ... Un uomo nobile avrebbe anche potuto
ritirarsi a coltivare la memoria di epoche gloriose o a piangere sulla fine di una civilt. Benedetto l'iniziatore di una nuova civilt a partire dalla persuasione d fede che la Parola parla an-cora. "Ascolta!" l'inizio e il caposaldo della sua regola.
Gregorio svilupper questa intuizione di Benedetto nel libro dei Dialoghi 3; poi tutto il medioevo approfondir questa intui-zione della realt come insieme di linguaggi, e anzi l'intuizione si esplicita come percezione dei diversi livelli della realt come "libri da leggere". Il libro diventa cos metafora della realt, profilandosi gi il senso della relazione ascoltare-leggere.
Ugo di San Vittore scriver: "Omnis natura rationem parit et nihil in universitate infecundum est", "Tutta la natura pregna di senso e in tutto l'universo non vi nulla di sterile" 4 Tutto il creato come un libro, un'immagine e uno specchio; il libro prodotto dall'uomo il suo analogo. Per questo lo studium le-gendi una ricerca efficace della sapienza: tutte le cose sono pregne di un senso che attende solo di esser portato all~ lu~e dal lettore. Questi, negli incontri che conosce nel suo V1agg1o da pellegrino, attraverso le pagine del libro ma anche attraverso il reale, al pari di un'ostetrica fa venire fuori, assiste al parto di quel senso di cui ogni cosa impregnata, la parola di Dio 5.
Ci sono tre libri. Il primo il libro che l'uomo fa partendo da qualcosa. Il secondo quello che Dio ha creato dal nulla, il terzo quello che Dio ha generato da se stesso, Dio da Dio. Il primo opera corruttibile dell'uomo, il secondo opera di Dio che mai cessa di esistere, opera visibile in cui scritta visibilmente la sapienza dell'invisibile creatore. Il terzo non
J CL Id., Dialog/;i I, Pro~. Cf. su questo tema B. Ca!ati, "Introduzione", in Gre~orio Magno, Dia!ogbi, a cura di B. Calati, A. Stendardi e delle monache benedettine dell'Isola di San Giulio Citt Nuova, Roma 2000, pp. 8-18.
'1 Ugo di San Vittor;, Didascalicon 6,5. ,significativo il sottotitolo di quest'opera:
De studio legendi, che Etienne Gilson tradurra con: Arte de/leggere. . . ' Cf. L Illich, Nella vigna del testo. Per una etologia della lettura, Cortma, Milano
!994
39
-
opera di Dio ma la Sapienza con la quale Dio ha fatto tutte le sue opere".
Anche noi siamo in una situazione analoga: non una Babele, ma un complesso intreccio di linguaggi da decifrare, una nuo-va epoca che si profila, per intendere la quale mancano ancora le parole. All'inizio solo l'ascoltare in silenzio , in mancanza di un'arte della !ectio, l'atteggiamento proporzionato alla parola in gestazione. Oggi , invece, cos poco normale ascoltare che questo atteggiamento fondamentale dell'essere umano rischia di venire "professionalizzato" in tecnica; si moltiplicano infatti i "centri di ascolto" e i luoghi privati dell'ascolto mediatico o psicologico o sociale. Ma nessuno sembra ascoltare i linguaggi della realt, primo fra tutti il "tu", l'altro. Non l'altro che ci conferma, ci rassicura, ma l'altro in ci per cui si differenzia, addirittura ci contesta, si fa riconoscere nella differenza. Scrive con acutezza in una poesia Fabio Pusteria:
Melassa. A volte sembra melassa questo tempo che riduce ogni cosa a fanghiglia privata. Come ogni cosa ricade e si sfa, come ogni foglia piange sul suo destino, e poi si smorza
e si perde in gioiosa apatia. Ma quante storie s'intrecciano e vana pare ogni nostalgia d'un'altra luce. Speranza? Forse, se resta tempo e forza; soprattutto la pazienza di ascoltare ogni voce 7
6 Ugo d San Vittore, L'arca momle di No 2,12. 7 F. Pusteria, Bozzetti pe scaglio la II, in Parola plurale. Sessanta quattro poeti iMlian
fra due secoli, a cura di G. Alfano, Sossella, Roma zoo5, p. 496.
Ma la cultura contemporanea incapace di nutrire un ascolto totale come espressione del desiderio e della ricerca di cogliere il senso deposto in ogni cosa, ma al tempo stesso soffre di que-sta impotenza. Sente parole, messaggi, notizie, ma non li ascol-ta, disposta pi a un sentire per consumare. Nella comunicazio-ne in genere vige per lo pi un udire che non coinvolge il sog-getto, il quale da parte sua non ha fame di intendere la parola che articola il mistero di ogni cosa, la parola che nutre la ricerca del senso. Questo udire che non comprende (cf. Mc 4,12) non accede alla profondit della fame per cui la persona credente da ogni voce di vita viene posta di fronte al Tu divino.
Mangiare !a Parola o leggere come si mangia
Gi nelle righe precedenti emerso un nesso, quello fra ascol-tare e mangiare, fra ascolto e manducazione, un nesso istruito dalla Scrittura stessa. Il: "Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" (Dt 8,3 LXX) come chiave ermeneutica del cammino dell'esodo, lo ritroviamo sulle labbra di Ges (cf. Mt 4,4): la Parola come pane, il pane della Parola.
Per prendere sul serio questo nesso, forse il caso di mettere in guardia dal pericolo degli slogan, siano essi nell'orizzonte della pastorale, della spiritualit o che altri sia. La Parola pa-ne? S, ma - ci insegna la Scrittura in un modo tutto singola-re, che sottopone a una radicale tensione il senso naturale del pane. Un senso dunque nient'affatto scontato, come gi in prin-cipio si pot intuire nel discorso di Ges a Cafarnao (cf. Gv 6), in cui tutto un rivelarsi di questo pane singolarissimo che in-vece di essere assimilato in carne mortale trasforma radicalmen-te i suoi "divoratori".
Questo pane nutriente, sapido, anzi dai molti sapori in re-lazione vitale con il desiderio di chi lo mangia. La Scrittura non
4I
-
un impersonale serbatoio di verit astratte, ma il pegno di una relazione offerta, da bocca a orecchio, anzi da cuore di Dio che par}a a cuore umano che ascolta. In questo senso pane.
E qui il punto in cui mi pare inserirsi il proprio della tradizio-ne monastica. La portata nutritiva del pane in stretta relazio-ne conl'af/ectus di chi lo mangia:
Offristi un pane gi pronto, senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto ... Esso si adattava al gu-sto di chi l'inghiottiva e si trasformava in ci che ciascuno desiderava (Sap r6,zo-zr).
In stretta corrispondenza alla dinarrca dell'ispirazione sta il dinamismo della lettura come manducazione 8 N o n siamo forse abbastanza consapevoli dell'importanza di questa relazione, co-s poco supportata dall'odierno modo consumista e impersona-le di alimentarsi, relazione intrinseca alla portata nutritiva delle Scritture, al punto che la Parola giace come chicco ibernato, in-terrato e insapore, fino a che un cuore credente non ne dischiu-da la dolcezza masticandola con desiderio vivo, con spirituale affectus, con la libera disponibilit a farsene impregnare.
Ignorare che la Scrittura nutre solo in relazione a un deside-rio vitale che acceso la accoglie, crea spesso oggi una sorta di feticismo della Bibbia, un'idolatria o in senso fondamentalista o anche, al contrario, in senso strumentalizzante, ideologico. Questo accade quando ci si appropria della Parola non per sfa-mare il desiderio sostanziale di vita, ma per svolgere una tesi, per una sorta di protagonismo o moda spirituale. E il pane spi-rituale resiste a queste manducazioni inappropriate, prive di desiderio di relazione viva con il Signore, di disponibilit a farsi incontrare da lui.
' Cf. Concilio Vaticano II, Dei Verbuw 1 z.
Come in principio tutto cambi attraverso un mangiare (cf. Gen 3,6-7), e fino alla fine (cf. A p 2, 7), assimilare la Parola un mangiare che cambia la vita. Mangiare dunque una me-tafora fondamentale nella Bibbia per indicare l'esperienza del-l'incontro con la Parola in una reciprocit singolare, come cifra simbolica di questo particolarissimo leggere-ascoltare. Leggere e nutrirsi nella forma dell'obbedienza: in modo tale per che si viene coinvolti visceralmente nella dinamica del nutrimen-to piuttosto che potersene servire per impinguare il proprio io. Questa una delle prime cose che si imparano in monastero, proprio attraverso la lectio.
La metafora della Parola come pane comporta anche la con-siderazione di tutta una gamma di atti mancati nell'incontro dell'uditore conia Parola, di esperienze traumatiche. Il vissuto monastico, proprio per l'assiduit con la Parola cui ordinato, predispone a sperimentare tutti i passaggi di questa relazione totale, travolgente nell'intimo, di corpo a corpo, di cui testimo-niano i profeti. L'assiduit, quando cade la tensione di fede, pu diventare infatti abitudine, cattiva familiarit, strumenta-lizzazione, sino alla nausea, ultima passione come la designano i padri del monachesimo antico.
Non ogni "addentare" la Parola consente di nutrirsene, nem-meno ogni indiscriminato usa e getta. Qui il termine pane detto in riferimento a una parola-testo scritto, come per esclu-dere ogni accostamento al testo guidato da una volont volut-tuosa di servirsene o da una concezione feticistica della Parola come conclusa in se stessa. Invece l'umilt della fede libera il sensorio pi acuto dell'animo umano e d la capacit di gustare il pane che sazia ogni desiderio (cf. Gv 6,35-48-51). La volont di udire messaggi consolanti senza conversione del cuore viene stigmatizzata cos efficacemente da Ezechiele, pur riferendosi a un altro orizzonte metaforico, quello del canto:
Figlio dell'uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e sulle porte delle case e si dicono l'un l'altro: "An-
43
-
diamo a sentire qual la parola che viene dal Signore". In folla vengono da te, si mettono a sedere davanti a te e ascol-tano le tue parole, ma poi non le mettono in pratica, per-ch si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco, tu sei per loro come una canzone di arno-re: bella la voce e piacevole l'accompagnamento musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica (33.30-32).
Questo brano ci rende vigilanti circa il rischio di finire in pre-da a letture emotive o estetizzanti, alla lettura devota, nel sen-so di autoconsolatoria, intimistica, scorporata dalla storia, nel nostro approccio al testo della rivelazione di Dio. Mai il testo biblico pu essere ridotto a serbatoio di un vissuto costruito autonomamente; mai il senso emerge compiutamente se non si coglie il rimando a quell'altro "coccio" dell'evento simbolico delle sante Scritture: il mistero di Ges, che d la prospettiva dall'interno.
Di fronte a questo pane non scontato sembra inevitabile il passaggio attraverso momenti critici: l'esperienza di non avere "denti", di mancare di un requisito indispensabile per decifrare la scrittura di Dio. La descrive efficacemente il profeta Isaia:
Per voi la rivelazione di tutto ci sar come le parole di un li-bro sigillato: si d a uno che sappia leggere, dicendogli: "Leg-gilo", ma quegli risponde: "Non posso, perch sigillato". Oppure si d il libro a chi non sa leggere dicendogli: "Leggi-lo", ma quegli risponde: "Non so leggere" (z9,ri-r2).
Come potremmo tradurre questa terribile esperienza, un'e-sperienza frequente nella vita del monaco? Forse con il non ave-re desideri, con l'assenza del sensorium del cuore proporzionato alla volont di alleanza, di relazione totale del Dio che parla nel-la Scrittura. Cos gi era accaduto nell'esperienza della nausea per la manna (cf. Nm 11,4-2.3; 20,5; 2r,5).
44
Si pu anche divorare, nell'impeto ingenuo dell'affectus. Ma per una vera manducazione (cio in spirito e verit) necessario anzitutto rispettare il testo, accostarlo nel timor di Dio, come ci insegnano i padri del monachesimo. C' infatti una reticenza particolare nei padri del monachesimo antico all'indiscriminato uso della Parola, che soprattutto agli inizi esige iniziazione e purezza di cuore, virt fondamentale che richiede up lungo ap-prendistato e per la quale la persona che legge completamente decentrata.
L'operazione del mangiare la Parola, in certo modo "trasgres-siva" dei codici naturali del vissuto, non lascia dunque mai in-denni, ma tutti i traumi da lei prodotti sono per la vita. La Pa-rola-pane che nutre anche la Parola che giudica, che converte l'anima, che ferisce e risana, che amareggia il ventre, che ad-dirittura uccide (cf. Os 6,5)! Anche e proprio cos opera effi-cacemente (cf. Eb 4,12) e non ritorna mai senza frutto (cf. Is 55,II). Anche quando indurisce (cf. Rm 9,18; II,8), la sua azione di misericordia. pane sostanziale, pane di lacrime, pane corrispondente al desiderio, pane "leggero" (Nm 21,5) co-me quel "soffio di silenzio" sull'Oreb (1Re 19,21) in cui pure il Signore Dio si fa presente al suo fedele. una Parola che dige-rita non per mai pienamente assaporata.
La ruminatio perci la modalit pi appropriata di frequen-tazione: un'assiduit quasi "animale", come di chi masticando la Parola sa di poter contare su un'energia che supera ogni capa-cit di capire e tanto pi di misurare. Per operare, la Parola ma-sticata richiede solo la semplicit docile dei piccoli, come dice l'autore del salmo 119,1.30: "La tua parola al rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici", e nel contempo la libera disposizio-ne di s il suo normale esito, l'atto conseguente, o deciso o in forma ancora pi piena gratuitamente subito. Di questo tipo , ad esempio, l'effetto dell'operazione di antirrhesis, secondo la quale la Parola viene usata come antidoto ai veleni di pensieri cattivi. Ricordo, a questo proposito, un apoftegma sulla masti-
45
-
cazione della Parola o pi precisamente sulla masticazione del Nome di Ges, inteso come sintesi di tutta la parola di Dio, che nella sua eccentricit mi sembra ricco di simbolo.
Abba Poemen disse: "Ero una volta assiso con dei fratelli presso abba Macario. Gli dissi: 'Padre mio, quale opera Iar l 'uomo per conseguire la vita?'. L'anziano mi rispose: 'Ricor-do che, quando ero bambino, in casa di mio padre, osservavo che le vecchie e le giovani donne tenevano in bocca qualcosa, una sorta di gomma che masticavano per addolcire in gola il gusto della saliva e l'odore del loro fiato. E questa gomma aveva potere rinfrescante per il fegato e i visceri. Se dunque questa cosa materiale procura una tale dolcezza a chi la ma-cera con i denti e la mastica, quanto pi il pane di vita, la dolcezza di tutte le dolcezze, il Signore nostro Ges Cristo, parola di Dio, re dei re e signore dei signori, questa parola benedetta, se la ruminiamo e mastichiamo costantemente, procura una rivelazione all'intelletto, caccia i pensieri malva-gi e rivela le realt celesti"' 9
Mi pare molto efficace questa immagine per esprimere la ca-pacit "medicinale" della Parola-pane, antidoto ai veleni dei pensieri che dividono il cuore ed esalano quella "immondezza" che contamina l'uomo (cf. Mc 7,20-2 3).
C' infine in questa esperienza della Parola come bene "com-mestibile", spazio anche per l'esperienza singolare dell'ecce-denza. Essa corrisponde a quel senso di saziet che deriva dalla viva percezione della sproporzione tra la propria gola e il "pane sostanziale". Efrem il Siro esprime con rara efficacia questa esperienza tipicamente monastica:
Guarda, Signore: le mie braccia sono colme delle briciole cadute dalla tua tavola;
9 Citato in E. Amlineau, Histoire des monastres de fa Basse-Egypte, Leroux, Paris 1894, p. 133
non c' pi posto sul mio labbro. Mentre m'inginocchio davanti a te,
riprenditi il tuo dono, tienilo custodito nei tuoi forzieri per rendercelo in altro tempo opportuno 10
L'asco!to come sacrificio spiritua!e Forse ora richiamata pi al vivo la centralit vissuta dell'a-
scolto. In corrispondenza alla percezione di un dire, che pu es-sere, s, un semplice blaterare o informare, ma pi propriamen-te realizza un meditativo "raccogliere in unit e porgere" (se-condo l'etimologia della parola greca corrispondente, !ghein); in corrispondenza al dire dietro al quale come origine ultima c' solo l'Altro che "disse e tutto avvenne" (Sal33,9), l'ascolta-re autenticamente umano non mero esercizio passivo degli or-gani corporei, ma apertura e uscita verso Altri, e come tale implica la messa in atto della disponibilit attenta, della libert che si mette in relazione; atteggiamento che nella nostra cultura della comunicazione a spot, dove cio "si sente dire" e subito per tutta risposta si "compra", completamente desueto, non va da s.
L'ascoltare per la rivelazione cristiana un atteggiam~nto to-tale (''tutto orecchi"), nel quale ne va tutta una vita. E aper-tura dell'orecchio del cuore, obbedienza sostanziata di carne e sangue. Ascoltare prendere stabile dimora nella parola altrui, uscendo dalla propria terrosit, dall'uomo vecchio, autocentrato o schiavo di idoli.
In ogni umano atto di ascolto, e tanto pi nella !ectio, non si pu dunque adottare la tecnica del "prendi, usa, getta". Non ci
10 Efrem il Siro, Inni su/fil fede ro,22.
47
-
si pu accostare al testo come chi gi sa la Parola, ma ogni volta ci si presenta con mani tremanti e orecchie "forate", stupiti e "stupidi"; sempre prestiamo ascolto da ignoranti, ma responsa-bili! L'ascolto come suggerisce la Lettera di Giacomo (cf. r,zz)- poesia della parola udita. Non si improvvisa, l'ascolto, si matura ai ritmi di una gestazione. Il suo dinamismo analogo a quello del prendere carne di un vivente: non in forme di iso-lamento solipsistico, ma in recettivit interiore, solidale. Non certo un potere, l'ascolto, ma nella sua passivit libera una forza vitale, capace di conferire una certa quale forma corpo-rea alla Parola ascoltata. La resurrezione non forse un atto di ascolto? In figura questo avviene gi a Lazzaro, ma si legga an-che Giovanni 5,25: "In verit, in verit vi dico: venuto il mo-mento, ed questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno".
Oggi siamo soggiogati da una cultura dove domina un dire che definisce o propaganda, senza profondit di rimando all'ol-tre, incapace di superare gli abissi della differenza. L'uditore corrispondente a questo dire quello della diatriba, che sente e obietta, che sente e trasforma in slogan o frase a effetto, che sente e si identifica. Non persuadono neppure, infatti, le ope-razioni di ascolto corrispondenti alla comunicazione informa-tica: "copia e incolla", "salva con nome", messaggi trasmessi senza soggetto. Si addicono a una parola commerciale, sonora-dicalmente inadeguate all'ascolto richiesto da una Parola che dice, che raccoglie in unit il reale porgendo il senso.
Ma quando si d una Parola che dice, che inaugura, che fa sorgere l'aurora del nuovo, allora quali abissi di vasta capacit sono richiesti per ascoltarla! Nella Scrittura sono copiosi gli esempi di un simile ascolto: la percezione della lode di Dio nel balbettio del bambino come nell'armonia dei cieli stellati (cf. Sal 8); la percezione della voce di Dio nella voce di un silenzio sottile (cf. rRe 19,12). Giuseppe Ungaretti cos descrive questo vissuto originario:
Quando trovo in questo mio silenzio una parola scavata nella mia vita come un abisso 11
Divenire "tutto orecchi" suggerisce la trasposizione del sal-mo 40 fatta dall'autore della Lettera agli Ebrei: un corpo fatto orecchio! Mi sembra, infatti, profondamente espressiva l'espe-rienza archetipa dell'ascolto rappresentata nel salmo 40:
Non hai voluto n sacrificio n offerta ma mi hai bucato gli orecchi. Non hai chiesto n olocausto n espiazione. Allora ho detto: "Ecco, io vengo" (vv. 7-8).
GesLl colui che si appropria in maniera originaria di questo salmo, come interpreta la Lettera agli Ebrei ro,yro: "Entran-do nel mondo, Cristo dice: 'Tu non hai voluto n sacrificio, n offerta, un corpo invece mi hai preparato"' (v. 5). Rivela cos che alla relazione giusta con Dio si accede attraverso questo atto unico di Ges che il suo corpo-orecchio. Nel suo vivere da uomo che in ogni cosa si riceve dal Padre, da uomo-figlio, Ge-s impersona l'archetipo della fede, la corporeit come apertu-ra incondizionata a Dio che parla: nell'ascolto l'offerta del corpo. E come tale Ges impersona l'altare che rende santa l'of-ferta, come suggerisce l'espressione della preghiera eucaristica: "Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito". Proprio a questo livello originario di fame della Parola e di interiorizza-zione del detto, l'ascolto si presenta alla sua radice come forma di martirio, cio di adesione alla Parola a prezzo di una vita pro-pria, autoreferenziale.
n G. Ungaretti, Commiato, in Id., Vita d'un uomo. Tutte le poesie, Mondadori, Mi-lano 1997 7 , p. 58.
49
-
La vita comunitaria come "paidefa" all'ascolto
In questa luce la questione appare quella di disporre deci-samente la vita come attenzione alla Parola che ci precede e prepara il nostro venire all'esistenza, il nascere dell'io "figlio". Ascoltando, io nasco dall'alto (cf. Gv 3,7). Anzitutto dobbiamo alimentare in noi stessi e sterrare in altri la fame della Parola. Il monastero deve trovare i modi per riappropriarsi dell'esperien-za del deserto come luogo di questa fame, luogo dove il bisogno fondamentale viene riconosciuto e nominato. A questo riguar-do, Simone Weil ha scritto un testo significativo:
Il desiderio orientato verso Dio la sola forza capace di ele-vare l'anima. Certo, soltanto Dio che discende ad afferrare l'anima ed elevarla, ma soltanto il desiderio costringe Dio a discendere 12 .
Tale desiderio della Parola si intesse e si alimenta attraverso la facolt dell'ascoltare, che per lo pi oggi subisce pesanti ot-tundimenti. Per s, infatti, una facolt "totale" dell'essere umano: la percezione della parola-carne dell'Altro. Nella Regola Benedetto, tra gli strumenti delle buone opere, richiama il mo-naco a "libenter a udire", "ascoltare volentieri" (4,5 s); e il ri-chiamo vale anzitutto per l'abate, che pu essere pi esposto al rischio di anteporre il parlare all'ascoltare.
Mi pare che siamo abituati a pensare che il proprio dell'abate e della badessa sia nel dare risposte. esattamente il contrario: proprio loro devono essere i primi ascoltatori nella comunit, e di un ascolto intelligente. Basilio per descrivere il ministero di chi presiede alla vita comunitaria usa l'immagine dell'occhio; il proest6s l'occhio della comunit:
12 S. Weil, Attesa di Dio, Rusconi, Milano I972 2, p. 75
L'apostolo dice: "Tutto avvenga con decoro e con ordine". Consideriamo dunque decoroso e ordinato quel modo di vi-vere nella comunit dei credenti che consente di salvaguarda-re i principi che regolano il rapporto fra le membra e il corpo. Cos uno ha in qualche modo la funzione dell'occhio: gli vie-ne affidata la cura degli altri, deve valutare ci che stato fatto e prevedere e considerare quel che si dovr fare 0 .
Chi presiede dunque l'organo del corpo comunitario che av-verte i problemi, che coglie le questioni sotto lo scorrere dei giorni e delle attivit; colui che ascolta nei ritmi e nelle pau-se della vita la Parola che parla. I\ elle Regole brevi di Basilio alla domanda: " opportuno imparare a memoria molti passi delle Scritture?", troviamo questa risposta:
Possiamo distinguere, in modo molto generale, due generi di persone: quelli a cui stato affidato il compito d presiedere e quelli a cui richiesta la docilit e l'obbedienza, secondo i diversi carismi. A mio parere, chi ha ricevuto l'incarico di presiedere e di avere cura degli altri deve sapere e imparare quello che riguarda tutti, per poter insegnare a tutti il volere di Dio, mostrando a ciascuno quello che richiesto a lui per-sonalmente14.
un occhio che vede ma pi profondamente e inseparabil-mente un orecchio che ascolta! Non possiede in proprio parole sue; deve come un mendicante attenderle e riceverle da Altri. Le sue risposte sono solo conseguenti a un lungo e personale ascolto.
1l Basilio di Cesarea, Regole di/fuse 24,r. In 35,r chi presiede descritto come "qualcuno in grado di essere l'occhio di molti", e poi si precisa: "Il priore della comu nit sia previdente, capace di parlare, sobrio, misericordioso e ricerchi i giudizi di Dio con cuore perfetto".
H Id., Regole brevi 2 35. Il compito essenziale del priore di essere esegeta delle Scritture per i fratelli a lui affidati e di aiutare ciascuno a dscemere la volont del Si gnore "secondo la sua misura di fede" (Rm 12,3).
)I
-
Ascoltare non ha nulla a che fare con la tendenza a facili con-cordismi, ad assentire immediatamente, a restare soggiogati; tut-ti atteggiamenti che rivelano invece l'assenza di una vera capa-cit di ascolto. Inoltre ci sono anche voci da non ascoltare, ma sol



![Corpus Victorinum Bibliographia generalisStudia 3 Angelini 2004a Giuseppe Angelini: Le virtu` e la fede (Contemplatio 11), Milano 1994, 22004. [Inst 4] Angelini 2004b Giuseppe Angelini:](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f0a4a1c7e708231d42aeddc/corpus-victorinum-bibliographia-generalis-studia-3-angelini-2004a-giuseppe-angelini.jpg)