Urologia Clinica Illustrata · istologia patologica dell’apparato urinario e genitale maschile”...
Transcript of Urologia Clinica Illustrata · istologia patologica dell’apparato urinario e genitale maschile”...


UrologiaClinica
Illustrata
UrologiaClinica
Illustrata
Carlo De DominicisOrdinario di Urologia
Università “La Sapienza”Roma
Text Atlas Series
II Edizione

II
Copyright ©2012 C. De Dominicis
Realizzazione editorialePharma Project GroupViale Rimembranze 43/A - 21047 Saronno -VA-Tel: 02 96720708, Fax: 02 96702677www.ppgedizioni.it
2° Edizione: Settembre 2012
Grafica, impaginazione, illustrazioni: Michela Solbiati, Gustavo Adriàn Gabarrò
Finito di stampare nel mese di Settembre 2012 da Alpha Print, Busto Arsizio
I diritti di traduzione, di riproduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamentototale e parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche)sono riservati per tutti i Paesi.
NOTA:La Medicina è una scienza in continuo divenire. L’Autore e l’Editore di questa operahanno posto ogni cura nel garantire la precisione dei dosaggi riportati, in accordo conle conoscenze scientifiche al momento della pubblicazione. Tuttavia, il medico dovràsempre consultare le informazioni contenute nella scheda tecnica che accompagnaciascun prodotto farmaceutico citato, per assicurarsi che non siano sopraggiunte nuovecontroindicazioni e che i dosaggi raccomandati siano quelli realmente suggeriti dalleAziende produttrici, in modo particolare per i farmaci di recente introduzione o rara-mente utilizzati.
Nessuna responsabilità può essere attribuita all’Editore per le opinioni di natura scien-tifica, clinica o terapeutica espresse dagli Autori. I marchi commerciali citati nel testosono di proprietà dei rispettivi proprietari.
ISBN: 978-88-86758-23-9
E’ obiettivo dell’Editore produrre nel massimo rispetto dell’ambiente. Questo volu-me è stato stampato su carta proveniente da foreste sostenibili e con tecnologieavanzate (CTP) che non necessitano della produzione di pellicole fotografiche.
In copertina:• in alto a sinistra: resezione del giunto pielo-ureterale in laparoscopia• in alto a destra: ureterolitotrissia con sonda laser• in basso a sinistra: biopsia vescicale di lesione piana fluorescente alla fotodinamica• in basso a destra: resezione endoscopica della prostata con ansa bipolare

III
Prefazione alla Seconda Edizione
Non posso nascondere la soddisfazione personale nel presentare la seconda edi-zione del testo di Urologia Clinica Illustrata, pubblicato ormai da cinque annie le cui copie sono andate esaurite. Soddisfazione per l’apprezzamento e i rico-noscimenti venuti dai Colleghi, ma ancor più per il positivo giudizio degli stu-denti e specializzandi urologi cui il libro è inizialmente destinato. So che ne èstata apprezzata la chiarezza espositiva e la ricchezza della documentazionefotografica: erano proprio gli scopi primari che mi ero inizialmente prefisso.Naturalmente il testo non è privo di alcune manchevolezze o inesattezze, eproprio con questa seconda edizione ho cercato per quanto possibile porvi rime-dio con correzioni ed aggiornamenti, nonché con l’ampliamento di un ulteriorecapitolo dedicato alla laparoscopia in urologia. Si è trattato quest’ultimo di unatto doveroso dedicato ad una tecnica che è diventata parte integrante delbagaglio dell’urologo di oggi, così come la endourologia del basso e alto appara-to urinario. Infatti molte patologie sono oggi aggredibili attraverso gli accessi“naturali” o di tipo “mini invasivo” da preferirsi sempre quando possibile, oquanto meno da considerare in prima istanza; non a caso le foto della nuovacopertina evidenziano questo aspetto. Nasce tuttavia l’obbligo, soprattutto perle nuove generazioni, di non tralasciare o sottovalutare l’apprendimento dellachirurgia “open” per avere la necessaria autonomia decisionale ed operativaquando richiesta dagli eventi.Mi auguro che il lavoro così rivisitato possa nuovamente incontrare il favoredel lettore.Desidero in questa occasione ancora una volta ricordare e ringraziare tutticoloro che hanno collaborato con successo alla prima stesura del libro, nonchéalla sua 2a edizione.Infine un ringraziamento particolare all’editore Dott. Paride Iannella e allaDott.ssa Michela Solbiati così fondamentali e preziosi con la loro esperienza,professionalità e particolare cordialità.
Carlo De Dominicis

V
Presentazione alla I Edizione
La medicina è una scienza in continua evoluzione. La ricerca e l’espe-rienza clinica ampliano costantemente le nostre conoscenze soprattuttoin relazione alle modalità diagnostiche e terapeutiche. La crescente com-plessità e la rapidità con cui evolvono tutti i settori della medicina rendo-no necessario disporre di strumenti educativi e formativi comprensibili edaggiornati. Queste caratteristiche sono particolarmente rilevanti per quellespecialità, quali l’Urologia, in cui gli aspetti clinici, biologici e quellichirurgici, hanno avuto e continuano ad avere un progressivo sviluppocon diverse evoluzioni.
Sulla base di queste considerazioni è evidente che chi voglia cimentarsinella stesura di un Testo-Atlante di Urologia ha oggi davanti a sè uncompito complesso e ciò spiega probabilmente ad oggi la carente produzio-ne nazionale in questo settore. Se poi l’Opera viene concepita ed elabora-ta da un solo Autore invece che da una molteplicità di esperti, come spessoavviene nella produzione anglosassone, è evidente come essa costituiscaun significativo, anche se faticoso, lavoro di sintesi delle esperienzeurologiche di tanti anni di attività clinica, che possa essere di stimolo alladiscussione su quanto di attuale viene eseguito e confermato poi dall’espe-rienza.
E’ mia opinione che il volume del Prof. Carlo De Dominicis consentirà amolte categorie di lettori di avere un valido punto di riferimento dovetrovare supporto alla propria attività formativa e di aggiornamento. Lostudente in Medicina, lo specializzando e il medico di medicina di base,ognuno nell’ambito delle proprie competenze e necessità, troveranno inquesto volume, così riccamente illustrato e di facile consultazione, motivoper comprendere ed approfondire le problematiche connesse alla diagnosie alla terapia delle varie patologie urologiche. Questo testo fornisce benela “chiave di lettura” delle varie problematiche urologiche, così da mette-

VI
re in condizione il medico e lo specialista di ascoltare ed interpretare ilmalato e le sue necessità di cura in termini di appropriatezza ed effica-cia.
Sono quindi certo che il Lettore troverà in queste pagine una univocità ditrattazione ed una sua corretta strutturazione dove le diverse patologiesono esposte in modo chiaro, dando rilievo alle novità delle cure medicheed a quelle strumentali più recenti, con particolare attenzione a quelle,come le endoscopiche, che rispondono alle regole della miglioreappropriatezza clinico-organizzativa.
Prof. Luigi FratiPreside della Facoltà di Medicina IUniversità “La Sapienza”, Roma

VII
Prefazione alla I Edizione
E’ con vero piacere che ho accettato l’invito rivoltomi dal Prof. Carlo DeDominicis di presentare il suo testo di Urologia. In primo luogo perché, amio parere, viene a colmare un vuoto che negli ultimi anni si era fattoevidente, quello cioè di un testo aggiornato di urologia dedicato agli stu-denti, in secondo luogo per il titolo stesso pensato per il libro, “UrologiaClinica Illustrata”, che introduce il concetto di una Urologia riccamen-te e razionalmente illustrata ed inserita in un testo che stimola il lettoreal ragionamento clinico, con una esposizione a tutto campo dei vari qua-dri patologici, fino ad arrivare alle nozioni fondamentali di terapia.Nello scorrere le pagine del testo risulta subito evidente l’attualità dellatecnica grafica impiegata, così detta “a tendina” mutuata dalla graficadel personal Computer e particolarmente efficace, da un punto di vistadell’apprendimento mnemonico, per un lettore del mondo moderno sem-pre più abituato a “guardare” e sempre meno a “leggere”.Una sicura valenza didattica hanno inoltre le numerose pagine dedicatealla diagnostica, in particolare per le nozioni che originano dall’ampiouso qui fatto di tecniche di imaging che, nell’ordine degli studi di moltiCorsi di Laurea, sono affrontate dagli studenti successivamente al Corsodi Urologia e Nefrologia, con evidenti difficoltà per il docente Urologoche si trova ad esporre le grandi tematiche della patologia urologica astudenti che non sanno ancora cosa sia una urografia, una TC o unaRM.Nel piano di composizione del testo una specifica efficacia didattica deveessere riconosciuta alla Introduzione che precede ogni capitolo, nella qualesono anticipati gli aspetti più caratterizzanti ed attuali dei quadri pato-logici che saranno trattati nelle pagine successive e come nei confronti ditali quadri è corretto porsi per giungere ad una ragionata ed esattadiagnosi e, quindi, alla scelta terapeutica più appropriata.Una specifica menzione merita il capitolo sulle malformazioni dell’ap-parato genito-urinario che può essere considerato un piccolo ma esau-

VIII
riente compendio di Urologia Pediatrica corredato da note di fisiopatologiadella via escretrice e da una iconografia che illustra chiaramente i diver-si quadri malformativi, correlandoli anche al loro aspetto radiologico conla riproduzione di radiogrammi urografici.Alcuni capitoli trovano un importante completamento ed arricchimentonella esposizione di argomenti di anatomia patologica curati dalla Prof.ssaAnna De Matteis. Docente di chiara fama, ha insegnato “Anatomia eistologia patologica dell’apparato urinario e genitale maschile” presso laScuola di specializzazione in Urologia dell’Università “La Sapienza” diRoma per oltre 30 anni ed è stata responsabile del Servizio di Anatomiae istologia patologica presso il Dipartimento di Urologia U. Bracci, ac-quisendo una indiscutibile esperienza in tale settore. L’esposizioneanatomopatologica è stata volutamente limitata ad alcuni argomenti,privilegiando quanto è stato ritenuto utile per l’urologo, fornendo tutta-via agli studenti e agli specializzandi gli strumenti fondamentali per lacomprensione dell’importanza clinica che i parametri morfologici hannonella scelta della terapia e per un successivo eventuale approfondimento.La trattazione esauriente ed aggiornata dei vari quadri della patologiaurologica, completata da nozioni di terapia e con figure riproducenti letecniche chirurgiche più attuali, estende il target di questo testo di UrologiaClinica Illustrata in quanto, oltre che dagli studenti del Corso di Lau-rea, può essere considerato un valido aiuto anche dagli specializzandi diUrologia, in particolare per quelli all’inizio del Corso che, dalla letturadi questo testo, possono trarre una visione introduttiva a tutto campodella patologia urologica che verrà affrontata ed ampliata poi negli annisuccessivi nei suoi più specifici aspetti diagnostici, clinici e terapeutici.Anche il medico di base, per la chiarezza espositiva e l’ampia documenta-zione, può trarre vantaggi dalla consultazione di questo testo per il suoaggiornamento.A questo libro, nel quale più che trattata è raccontata l’Urologia anchenegli aspetti più attuali, va riconosciuto il merito di appassionare il letto-re, futuro medico di base o futuro specialista urologo, al grande capitolodelle malattie dell’apparato urinario e genitale maschile, che per esserericonosciute e correttamente curate devono essere prima di tutto capitenei loro meccanismi fisiopatologici e più specificatamente clinici.
Prof. Cesare LaurentiOrdinario di Urologia
Università “La Sapienza”, Roma

IX
Ringraziamenti (I edizione)
Quando ci si accinge a compiere un lavoro impegnativo come quello dellastesura di un testo clinico, anche se unico Autore, non posso non riconosce-re che questa “fatica”, che ha richiesto un impegno costante di alcunianni, non è e non può essere a me solamente attribuita. Qualunque tra-guardo piccolo o grande un uomo riesca a raggiungere, non rappresentaaltro che la sintesi delle proprie esperienze personali derivanti dall’am-biente e dalle persone con le quali ha interagito. Non diversa è questamia esperienza.Questo testo, infatti, rappresenta il frutto e la visione di questa Discipli-na maturati in circa trent’anni di esperienza clinica e di insegnamento.Proprio per tale motivo non posso non ricordare con affetto e gratitudineil Prof. Ulrico Bracci, con il quale ho mosso i primi passi in campo urologicoquando ero ancora “tabula rasa” ed ogni cosa nuova che apprendevo sistampava nella mia mente di giovane medico e diventava l’impostazionee la base con la quale fare i confronti con le successive esperienze.E’ anche la summa di anni di attività clinica, di sala operatoria e dididattica svolta e condivisa costantemente a fianco del Prof. CesareLaurenti, cui va profonda stima e riconoscenza per la mia maturazioneclinica, umana e per i traguardi universitari raggiunti.La realizzazione di questo libro non sarebbe stata possibile senza la fattivaed entusiasta partecipazione di stretti e validi collaboratori e di alcunigiovani medici specializzandi dell’Istituto di Urologia “U. Bracci” del-l’Università “La Sapienza” di Roma. Questi ultimi, portatori delle esi-genze del medico in formazione, hanno contribuito alla stesura del testoe alla trattazione dei vari argomenti nel modo più chiaro e adeguatopossibile.Un sentito ringraziamento va alla Prof.ssa Anna De Matteis, che haarricchito il libro con importanti note di anatomia patologica derivantida una non comune personale esperienza in campo urologico.

X
Desidero ringraziare il dott. Paride Iannella per il costante incoraggia-mento a portare a termine il lavoro e la sig.ra Michela Solbiati autricedella moderna e accattivante veste grafica.Infine alla mia famiglia un pensiero grato e affettuoso per il tanto tempoad essa sottratto per la stesura del libro.
Carlo De Dominicis

XI
Collaboratori
Francesco Barrese, MD, PhDSpecialista in Urologia, Università “La Sapienza”, Roma
Stefania Cuzari, MD, PhDSpecialista in Urologia, Università “La Sapienza”, Roma
Paolo De Martino, MDSpecialista in Urologia, Università “La Sapienza”, Roma
Anna De Matteis, MDProfessore Associato di Anatomia Patologica, Università “La Sapienza”, Roma
Cosimo De Nunzio, MD, PhDProfessore a Contratto Università “La Sapienza”, Roma; Dirigente Medico I livelloOspedale Sant’Andrea, Roma,
Emmanuel Elliott De Mayo, MD, PhDSpecialista in Urologia, Università “La Sapienza”, Roma
Alessia Fraioli, MD, PhDSpecialista in Urologia, Università “La Sapienza”, Roma
Costantino Leonardo, MD, PhDRicercatore Università “La Sapienza”, Roma; Dirigente Medico I livello Policlinico“Umberto I”, Roma
Paolo Maria Michetti, MD, PhDRicercatore Università “La Sapienza”, Roma; Dirigente Medico I livello Policlinico“Umberto I”, Roma
Leonardo Misuraca, MDSpecializzando in Urologia, Università “La Sapienza”, Roma
Marco Musy, MD, PhDSpecialista in Urologia, Università “La Sapienza”, Roma
Alberto Pansadoro, MD, PhDDirigente Medico I livello, Ospedale di Terni
Filippo Peris, MD, PhDDirigente Medico I livello, Ospedale “Fatebenefratelli”, Isola Tiberina, Roma
Andrea Tiesi, MDDirigente Medico I livello U.O.C. Urologia Cesena
Manuel Armando Valentini, MDSpecialista in Urologia, Università “La Sapienza”, Roma
Augusto Zani, MDRicercatore Chirurgia Pediatrica, Università “La Sapienza”, Roma

Indice Generale
Sigle ed abbreviazioni .......................................................XVII
1. Lo studio diagnostico in urologia .................................... 1C. De Dominicis, P. De Martino, A. TiesiDiagnostica clinica .................................................................................. 2Diagnostica di laboratorio ................................................................... 15Diagnostica per immagini .................................................................... 24Diagnostica strumentale ...................................................................... 36
2. Infezioni delle vie urinarie ............................................ 49C. De Dominicis, P.M. MichettiAspetti generali delle infezioni urinarie ............................................. 50Infezioni delle alte vie ........................................................................... 55Infezioni delle basse vie ....................................................................... 59Batteriuria asintomatica ....................................................................... 62Tubercolosi urinaria ............................................................................. 63
3. Malformazioni dell’apparato urogenitale ..................... 71C. De Dominicis, A. Zani, A. TiesiMalformazioni del rene......................................................................... 72Malformazioni della via escretrice ...................................................... 86Malformazioni della vescica .............................................................. 116Malformazioni dell’uretra .................................................................. 119
4. La calcolosi urinaria ..................................................... 125C. De Dominicis, F. PerisEpidemiologia ...................................................................................... 126Eziopatogenesi .................................................................................... 127Quadro clinico ..................................................................................... 131Diagnosi ................................................................................................ 132Terapia .................................................................................................. 136
5. La vescica neurologica ................................................. 145C. De Dominicis, S. Cuzari, A. FraioliAspetti anatomo-funzionali del ciclo minzionale ............................ 146Definizione e classificazione .............................................................. 149

XIV
Quadri clinici ....................................................................................... 150Diagnosi ................................................................................................ 151Terapia .................................................................................................. 152
6. Patologie prostatiche ................................................... 155C. De Dominicis, F. Barrese, A. De MatteisAnatomia e fisiologia della prostata ................................................. 155Iperplasia prostatica benigna ............................................................ 160Carcinoma della prostata ................................................................... 172Prostatiti ............................................................................................... 184Stenosi congenita del collo vescicale ............................................... 189
7. Oncologia urologica ..................................................... 195C. De Dominicis, A. De Matteis, P.M. Michetti, S. Cuzari, A. ZaniTumori del rene ................................................................................... 196Tumori della via escretrice e della vescica ..................................... 212Tumori del testicolo ........................................................................... 231Tumori del pene .................................................................................. 247
8. Patologie andrologiche ................................................ 255C. De Dominicis, M. MusyVaricocele ............................................................................................. 256Criptorchidismo .................................................................................. 259Idrocele ................................................................................................. 262Epididimite ........................................................................................... 263Orchite .................................................................................................. 265Cisti dell’epididimo ............................................................................. 265Fimosi ................................................................................................... 266Frenulo breve ....................................................................................... 267Malattia di La Peyronie o Induratio Penis Plastica ......................... 267Incurvamento congenito del pene .................................................... 269Disfunzione erettile ............................................................................. 270Infertilità ............................................................................................... 275
9. Urologia ginecologica .................................................. 281C. De Dominicis, S. Cuzari, A. FraioliAnatomia descrittiva e funzionale del pavimento pelvico ............ 282Incontinenza urinaria e prolasso uro-genitale ................................. 285Malattie dell’uretra femminile ........................................................... 296Fistole dell’apparato uro-genitale ..................................................... 297
10. Le derivazioni urinarie ................................................ 301C. De Dominicis, E.E. De MayoClassificazione ..................................................................................... 302Derivazioni urinarie esterne temporanee ........................................ 302Derivazioni urinarie esterne permanenti ......................................... 305Derivazioni urinarie interne ............................................................... 307

XV
11. Urgenze e traumi urogenitali ...................................... 321C. De Dominicis, M.A. ValentiniUrgenze in urologia ............................................................................. 321Traumi urogenitali .............................................................................. 332
12. Chirurgia laparoscopica .............................................. 351C. De Dominicis, C. Leonardo, C. De Nunzio, L. Misuraca,A. PansadoroCenni storici ......................................................................................... 352Strumentario ........................................................................................ 353Posizione del paziente ........................................................................ 359Posizione delle porte .......................................................................... 359Laparoscopia in urologia ................................................................... 361Controindicazioni ................................................................................ 362Immagini laparoscopiche di alcuni interventi chirurgici ............... 365
13. Miscellanea ................................................................... 369C. De Dominicis, S. CuzariCistite interstiziale .............................................................................. 369Fibrosi retroperitoneale ..................................................................... 372Enuresi .................................................................................................. 375
Indice analitico ............................................................. 379

XVII
Sigle ed abbreviazioni
AAG: Glicoproteine acideAAST: American Association for the Surgery of TraumaADH: Anti Diuretic Hormonα-FP: Alpha Feto ProteinaAI: Anatomic IncontinenceATV: Adenomectomia TransVescicaleBCG: Bacillo di Calmette-GuerinBFB: BiofeedbackbFGF: basic Fibroblast Growth Factorβ-HCG: beta Globulina Corionica UmanaCBG: Corticosteroid Binding GlobulinCG: Gonadotropina CorionicacGMP: Guanosin-Monofosfato ciclicoCh: CharriereCIS: Carcinoma In SituCPSS: Sindrome da Dolore Pelvico CronicoDE: Disfunzione ErettileDHT: Di-idro-testosteroneDMSA: Acido DimercaptosuccinicoDTPA: Acido DietilentriaminopentaceticoDUET: Derivazioni Urinarie Esterne TemporaneeDUEP: Derivazioni Urinarie Esterne PermanentiDUI: Derivazioni Urinarie InterneEMG-P: Elettromiografia del PerineoENS: Enolasi Neurono-SpecificaEGA: EmogasanalisiEGF: Epidermal Growth FactorER: Esplorazione RettaleESF: Elettrostimolazione FunzionaleESWL Extracorporeal Shock Wave LithotripsyF: FrenchFSH: Ormone follicolo-stimolanteGAGS: Glicosaminoglicani vescicaliGCT: Germinal Cell TumorsGUV: Giunzione Uretero-VescicaleHPV: Human Papilloma VirusICS: International Continence SocietyIFN-alfa: Interferone-alfaIGCNU: Intratubular Germ Cell NeoplasiaIGF: Insuline-like Growth FactorIGCCG: International Germ Cell Collaborative GroupIL-2: Interleuchina-2

XVIII
IPB: Iperplasia Prostatica BenignaIPP: Induratio Penis PlasticaIPSS: International Prostatic Symptom ScoreIRC: Insufficienza Renale CronicaISD: Deficienza Sfinterica IntrinsecaISUP: International Society of Urological PathologyKGF: Keratinocyte Growth FactorKT: KinesiterapiaLAK: Limphokine-Activated KillersLDH: Lattico-DeidrogenasiLH: Luteinizing HormoneLRA: Laparoscopia Robot AssistitaLSP: Laparoscopia Single-Portmdc: Mezzo di ContrastoMESA: Micro Epididimal Sperm AspirationNPT: Nocturnal Penile TumescenceOCU: Ostruzione Cervico-UretralePAS: Periodic Acid-SchiffPBG: Progesteron Binding ProteinPEC: Cellula Epitelioide PerivascolarePET: Positron Emission TomographyPIN: Prostatic Intraepithelial NeoplasiaPLAP: Fosfatasi Alcalina PlacentarePNA: Pielonefrite AcutaPNC: Pielonefrite CronicaPNET: Tumore Neuroectodermico PrimitivoPPU: Profilo Pressorio UretralePSA: Antigene Prostatico SpecificoRCC: Renal Cell CarcinomaREM: Rapid Eyes MovementsRMN: Risonanza Magnetica NucleareRPM: Residuo Post MinzionaleRVU: Reflusso Vescico-UreteraleSCF: Stem Cell FactorSCING: Suburetral Collagene InjectionSHBG: Sex Hormon Binding GlobulinSTING: Subureteral poly-Tetrafluoroethylene INJectionT: TestosteroneTC: Tomografia ComputerizzataTESE: Testicular Sperm ExtractionTGF-beta: Transforming Growth Factor betaTIL: Tumor-Infiltrating LimphocytesTOT: Trans Obturator Vaginal TapeTUIP: Trans Urethral Incision of the ProstateTURB: Trans Urethral Resection of the BladderTURP: Trans Urethral Resection of the ProstateTVT: Tension Free Vaginal TapeUCNS: UreterocistoneostomiaUICC: International Union Against CancerVCI: Vena Cava InferioreVFG: Velocità di Filtrazione GlomerulareVIP: Vescica Ileale PadovanaVLPP: Valsava Leak Point PressureWHO: World Health Organization

1
1
LO STUDIO DIAGNOSTICO INUROLOGIALO STUDIO DIAGNOSTICO INUROLOGIA
INTRODUZIONE
L’approccio al paziente rappresenta il primo passo fondamentale per lacomprensione dei problemi che lo hanno condotto al medico e per la lororisoluzione. Particolari qualità vengono richieste al medico in questa primafase molto importante quali soprattutto sensibilità e rispetto per la condizio-ne del malato e comprensione per il suo stato d’animo, non sempre sereno.Con esperienza, abilità ed intuito è possibile interpretare con esattezza ciòche il paziente riferisce con parole sue senza lasciarsi fuorviare dal-l’“interpretazione” dei sintomi, ma cogliendo quanto più possibile gli elementicerti e veramente indicativi ed utili. Non bisogna mai accontentarsi di descri-zioni generiche, ma aiutare il paziente a definire e a quantificare con terminidi paragone certi i propri sintomi ed a cercare un nesso di causalità oggettivaoltre che temporale.
Un ruolo altresì importante è riservato all’esperienza clinica del medicoed alla sua cultura, elementi che devono suggerire le domande da rivolgereal paziente, al fine di confermare o escludere i vari sospetti diagnostici chevengono via via delineandosi durante il colloquio. Il buon medico è colui cheriesce a giungere alla diagnosi con il giusto numero di esami, che devonoessere richiesti in modo mirato e giustificato, badando sempre a cosa si vuo-le sapere e che tipo di risposta ci può fornire l’indagine richiesta. Due cose èbene tenere presente e cioè che la nostra non è una scienza esatta, nono-stante i grandi aiuti forniti dalla tecnologia, e che le risposte che vengonodate ai nostri quesiti non sempre sono necessariamente concordanti. E’ al-tresì importante ricordare che l’efficacia delle indagini diagnostiche comeanche dei risultati terapeutici viene quasi sempre valutata su base statistica,ma a fronte di ciò non dobbiamo mai dimenticare che l’uomo che ci sta di
C. De Dominicis
P. De Martino
A. Tiesi

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
2
fronte vuole una risposta al “suo” problema e la esige quanto più giusta ecerta possibile. Mai essere troppo sicuri, umiltà e prudenza sono elementichiave anche e soprattutto quando tutto sembra chiaro, perché l’errore è sem-pre dietro l’angolo. Non necessariamente si deve assicurare la diagnosi né èsempre il caso di insistere con indagini più complesse o invasive, pur di trova-re una risposta ai propri dubbi, creando peraltro ulteriore ansia al paziente.L’importante è escludere le patologie principali, soprattutto quelle a carattereevolutivo, con sufficiente certezza, e sarà la nostra esperienza e saggezza asuggerirci un prudente “watch and wait”.
DIAGNOSTICA CLINICA
Anamnesi
L’anamnesi si divide in: familiare e personale e quest’ultima, in fisio-logica, patologica remota e patologica prossima.
Familiare
L’anamnesi familiare prevede la raccolta di dati riguardanti condizio-ni patologiche dei familiari che possono avere influito sulla malattia delpaziente stesso. Particolare riguardo perciò va rivolto a quelle malattie acarattere ereditario quali reni policistici e malformazioni, alle malattie acarattere predisponente come la tubercolosi, e quelle a carattere ende-mico, per cui risulta molto importante sapere quali e quanti familiari nesiano o ne siano stati affetti.
Personale
Fisiologica. L’anamnesi fisiologica comprende la raccolta dei dati delpaziente dalla nascita sino al momento attuale, con riferimento allo svi-luppo somatico e psichico, alle abitudini di vita (ad es. alcolici e tabacco)alle condizioni ambientali e lavorative (ad es. professioni che espongonoad un aumentato rischio di sviluppare una neoplasia). Nel bambino èparticolarmente utile raccogliere notizie su eventuali ritardi di crescitasia ponderali che staturali, mentre nel soggetto di sesso maschile vannovalutati i tempi di comparsa dei caratteri sessuali primitivi e secondari ela regolare discesa dei testicoli nella sacca scrotale.
Nella donna hanno invece notevole importanza i disturbi urologici chepossono accompagnarsi alle diverse fasi ormonali della vita sessuale:menarca, mestruazioni, menopausa. Un esempio tipico di queste possi-bili correlazioni è rappresentato dall’insorgere di una sintomatologia ci-stitica prima e dopo il flusso mestruale, che scompare e si attenua note-volmente durante il flusso stesso e nel periodo intermedio tra due flussi.Tale disturbo è riferibile ad una congestione cervico-trigonale da squili-brio endocrino. Tipico è il reperto costante di urine sterili. Altrettanto tipi-ca è la pollachiuria monosintomatica con urine sterili da compressionevescicale da parte dell’utero e degli annessi (fibromi o cisti ovariche vo-luminose).
Le informazioni sull’attività lavorativa possono ricondurre ad un de-terminato sintomo urologico. Ciò vale, ad esempio per i lavoratori dell’in-dustria chimica (coloranti: tumori vescicali), per coloro che sono costret-ti a lungo a una posizione seduta (autotrasportatori, autisti: possibile con-

CAPITOLO 1. LO STUDIO DIAGNOSTICO IN UROLOGIA
3
gestione prostatica) o all’ortostatismo (dolore testicolare, varicocele, do-lore lombare, ptosi renale). E’ necessario ancora, durante la raccolta del-l’anamnesi fisiologica, conoscere le abitudini alimentari (eccessi alcoli-ci) e gli eventuali disturbi dell’alvo.Patologica remota. L’anamnesi patologica remota comprende tutte lenotizie relative agli eventi morbosi che hanno colpito il paziente dallanascita sino all’esordio della malattia attuale. Esempi importanti posso-no essere una precedente tubercolosi polmonare, un’affezione parotiti-ca oppure un contagio venereo. Bisogna tener presente la correlazioneesistente tra il disturbo urologico attuale ed eventuali malattie relative adaltri apparati. L’anamnesi patologica remota è volta anche a ricercare pre-gressi traumi dell’apparato urogenitale e/o eventuali interventi chirurgicisubiti.Patologica prossima. L’anamnesi patologica prossima riguarda le noti-zie relative alla malattia in atto e quindi è rivolta ai sintomi e segni cliniciche hanno costretto il paziente a rivolgersi al medico. Particolare rilievoha la valutazione del fattore tempo, soprattutto quando sono comparsi laprima volta uno o più sintomi componenti il quadro clinico, in che occa-sione e se essi si ripetono in modo costante o occasionale.
Disturbi della minzione
I disturbi della minzione si suddividono in qualitativi e quantitativi. I primisi riferiscono a sintomi di natura funzionale e sono correlati alla percezio-ne soggettiva del paziente. I secondi sono sostanzialmente misurabili edoggettivi.
Qualitativi
Disuria. Difficoltà alla minzione.Stranguria. Minzione dolorosa e difficoltosa.Tenesmo vescicale. Sensazione a fine minzione di voler ancora urinarenonostante la vescica sia vuota, dovuta ad uno spasmo della muscolatu-ra vescicale o ad una irritazione del trigono.Pollachiuria. Aumento della frequenza diurna delle minzioni non in rap-porto alla quantità di urina emessa.
Il paziente “in cornice”...
...“quando mi trovo di fronte un paziente per la prima volta, prima ancora di sapere i mo-tivi “urologici” della sua presenza, sono solito rivolgere tre domande semplici: “Quanti anniha?”, “Ha subito interventi chirurgici?”, “Assume farmaci abitualmente?”. Subito dopo averraccolto questi elementi passo all’anamnesi urologica più specifica. Perché questo? Perchéqualsiasi problema urologico mi accinga a valutare e a cercare di risolvere non può prescinde-re dalle condizioni generali del paziente, che sono rappresentate dalla sua età, soprattuttoquella biologica, dall’aver subito eventuali interventi chirurgici importanti, che possono condi-zionare non solo la spettanza di vita ma anche le eventuali scelte terapeutiche del caso, edinfine dall’assunzione costante di farmaci, che è dimostrativa di patologie mediche di un certorilievo clinico (cardiologiche, respiratorie, vascolari, etc.) e quindi dello stato di salute generaledel paziente. In pratica in questa “cornice” vado ad inserire poi le problematiche urologiche,che necessariamente devono essere valutate e risolte nell’ambito di questo contesto”.

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
4
Nicturia o pollachiuria notturna. Indica la minzione notturna e puòessere messa in relazione ad una patologia ostruttiva cervico-uretrale oad una poliuria, ad una roncopatia, a sonno superficiale.Enuresi. Minzione involontaria durante il sonno. E’ un fenomeno norma-le nei primi 3 anni di vita. Se si prolunga oltre i 5 anni di età può costituireuna condizione patologica (Capitolo 12).Iscuria. Sinonimo di ritenzione cronica di urine, va distinta dall’iscuriaparadossa che indica la fuoriuscita goccia a goccia di urina per rigurgitoda una vescica sovradistesa.Urgenza minzionale. Stimolo alla minzione improvviso e poco control-lato (vescica neurologica, infezioni urinarie, tumore vescicale).Minzione interrotta. Improvvisa interruzione dell’emissione di urinadurante la minzione (calcolo vescicale o corpo estraneo presente in ve-scica che occlude improvvisamente l’uretra).Minzione in più tempi. Atto minzionale ripetuto a breve distanza di tem-po, in genere associato a mitto astenico e ad uso del torchio addominale(diverticolo vescicale ostruzione cervico-uretrale, megauretere).Esitazione minzionale. Ritardo involontario nell’iniziare la minzione(ostruzione cervico-uretrale).Sgocciolamento post-minzionale e sensazione di mancato svuota-mento vescicale. Sono anch’essi tipici segni di ostruzione cervico-ure-trale.
Quantitativi
Comprendono le variazioni della quantità di urina emessa nelle 24ore. Tale valore varia generalmente da 900 a 1.800 ml/24h, poiché nume-rose condizioni fisiologiche o abitudini di vita possono modificare la diu-resi delle 24 ore (abbondante sudorazione, ridotta o esagerata ingestionedi liquidi, vomito o diarrea, etc.). E’ pertanto opportuno tener semprepresente le possibili variabili fisiologiche prima di parlare di un reale di-sturbo quantitativo.Poliuria. Produzione di una quantità di urina nelle 24h superiore ai valorimassimi fisiologici in rapporto all’età del paziente. E’ generalmente espres-sione di uno stato di insufficienza renale, ma può riconoscere altre causequali diabete mellito, diabete insipido, pielonefriti croniche, fasi di ripre-sa dopo nefropatie ostruttive e nefropatie acute anuriche. Si distinguono:poliurie ipotoniche, con elevata emissione di urina, anche 10 litri, e poliu-rie isotoniche, con diuresi da 2 ai 4 litri nelle 24h.Oliguria. Emissione di una quantità di urina nelle 24h inferiore ai valorimassimi fisiologici rapportati all’età del paziente; generalmente è inferio-re a 300-400 ml nelle 24h. Si possono distinguere oligurie con edema(ritenzione idrosalina) e oligurie senza edema (insufficienza renale acu-ta organica e funzionale).Anuria. Arresto della produzione di urina a livello renale, contraddistintadalla mancanza di urina in vescica. Ciò la differenzia dalla ritenzione uri-naria in cui la produzione di urina è normale o rallentata e la vescica èdistesa, ma il paziente è incapace ad espellere l’urina. L’anuria si distin-gue in:Pre-renale: da alterazione della circolazione generale dovuta a grave ipo-tensioni (shock, infarto del miocardio, pancreatite, etc.) o grave perditaematica o di liquidi (emorragie, emolisi , ustioni, peritoniti, vomito, diar-rea, diminuito apporto di liquidi, etc.);

CAPITOLO 1. LO STUDIO DIAGNOSTICO IN UROLOGIA
5
Renale: secondaria a nefropatie, infarto renale, necrosi corticale;Post-renale: secondaria a ostruzione delle vie urinarie per calcoli bilate-rali o in unico rene, neoplasie vescicali o prostatiche, traumi, iperplasiaprostatica, stenosi uretrali, compressione estrinseca di entrambi gli ure-teri per neoplasie o fibrosi retroperitoneale.
Sindromi urologiche
Ritenzione urinaria
Con questo termine si indica solitamente l’impossibilità da parte delpaziente ad emettere in toto o in parte l’urina contenuta in vescica. Sitratta di un quadro urologico frequente le cui cause sono numerose. Lapresenza del “residuo vescicale post-minzionale” è patognomonica del-le affezioni ostruttive acute e croniche delle vie urinarie inferiori o vesci-ca neurologica. Per residuo post-minzionale si intende la quantità di uri-na presente in vescica dopo la minzione: esso viene calcolato dopo averfatto urinare il paziente mediante cateterismo vescicale o con l’ecografiavescicale. Se la ritenzione non viene risolta, è impedito il normale deflus-so in vescica delle urine provenienti dalle alte vie escretrici. Si crea cosìuna dilatazione ureteropielocaliceale e, in casi estremi, uno stato uremi-co per diminuzione della filtrazione renale.
La ritenzione è totale quando non è più possibile alcuna minzione.Può presentarsi sotto forma acuta o cronica. Nel caso di una ritenzioneacuta completa si verifica un blocco urinario con totale impossibilità allaminzione, in un soggetto che fino a quel momento aveva urinato normal-mente senza alcun disturbo o con disturbi di media entità. La vescica èdistesa e si può apprezzare alla palpazione un globo vescicale. Il pazien-te è sofferente e pallido, avverte un forte ed impellente stimolo di urinaresenza tuttavia non riuscirvi. Le cause possono essere molteplici: calcoliuretrali o corpi estranei incuneati a livello cervico-uretrale, traumi uretra-li, adenoma o carcinoma della prostata, prostatiti acute e croniche, bneu-ropatia vescicale, etc.
Tale evenienza richiede un intervento urgente mediante cateterismovescicale o con puntura sovrapubica della vescica (epicistostomia) perimpossibilità di sondare l’uretra. Il drenaggio deve essere lento per evita-re eventuali emorragie ex-vacuo.
La ritenzione cronica completa insorge quando l’incapacità di svuo-tare la vescica viene a complicare una perdurante condizione di minzio-ne incompleta. Anamnesticamente il paziente è disurico da lungo tempoe non distingue più l’incompleto svuotamento vescicale. La ritenzionenon comporta uno stato di sofferenza particolare se non quello indottoda una costante riduzione del filtrato glomerulare (iperazotemia, aumentodella creatininemia) spesso associata a idronefrosi bilaterale.
Ematuria
Per ematuria si intende la presenza di sangue nell’urina le cui causepossono essere di diversa natura (Tabella 1.1). E’ definita macroscopicaquando a seconda della intensità della perdita di sangue, della sede incui questa avviene e del tempo intercorso, è possibile osservare diversecolorazioni dell’urina dal color marsala, al color lavatura di carne e alrosso vivo che solo indicativamente possono essere correlate all’originerispettivamente alta o bassa dell’apparato urinario. Il sintomo è chiara-

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
6
• Renali: glomerulonefriti primitive o secondarie, pielonefriti, nefrolitiasi,neoplasie del rene e della via escretrice, tubercolosi, traumi.
• Ureterali: calcolosi, stenosi, processi flogistici, neoplasie.
• Vescicali: cistite, calcolosi, neoplasie, traumi, corpi estranei.
• Prostatiche: prostatite, congestione del collo vescicale da iperplasiabenigna, neoplasia.
• Extrarenali: malattie emorragiche, flogosi e neoplasie degli organiadiacenti l’apparato urogenitale, farmaci anticoagulanti, fistole daorgani contigui.
mente indice di patologiaurinaria e può presentarsida solo, o associato ad altrasintomatologia (colica, di-sturbi minzionali). Quandosi presenta non accompa-gnato da altra sintomatolo-gia, “a ciel sereno”, devesempre far sospettare in pri-ma istanza una causa neo-plastica, a livello renale o ve-scicale, fin quando questanon venga esclusa.
L’ematuria può essereiniziale, totale o terminale. La prova dei tre bicchieri di Guyon, consisten-te nel far urinare il paziente continuativamente in tre recipienti diversi,aiutava a definire in tal senso l’ematuria ma con le nuove tecniche dia-gnostiche ha perso gran parte della utilità clinica di una volta. In generel’ematuria totale ha origine dall’apparato urinario alto, l’ematuria termi-nale spesso è causata da una patologia vescicale, mentre la cosiddettaematuria iniziale si riscontra per patologie a livello prostatico ed uretrale.E’ chiaro che queste sono solo indicazioni di massima, a volte anchefallaci, che vanno sempre confermate con appropriate indagini di ima-ging (Tabella 1.2) dell’apparato urinario.
L’ematuria microscopica è apprezzabile solo all’esame delle urine edè significativa per valori superiori alle 20-30 emazie per campo nel sedi-mento urinario, soprattutto di fronte alla costanza del dato rilevato piùvolte nell’esame delle urine. Vengono definite ematurie “sine causa” quel-le ematurie macro o microscopiche per le quali dopo un appropriatoscreening diagnostico non è stata riscontrata la causa. Tali pazienti unavolta escluse le patologie più importanti, soprattutto di tipo evolutivo, van-no monitorati nel tempo.
L’uretrorragia va differenziata dall’ematuria perché l’emissione di san-gue ha origine dall’uretra sotto sfinterica, per cui non avviene la commi-stione con le urine se non occasionalmente durante la minzione (ematu-ria iniziale).
L’ematuria va distinta dalla emoglobinuria, termine che indica la pre-senza nelle urine di pigmenti ematici con assenza di globuli rossi. Lecause più frequenti dell’emoglobinuria sono: 1) anemie emolitiche: favi-smo, emolisi trasfusionali; 2) le sindromi emoglobinuriche: emoglobinu-ria parossistica notturna, parossistica a frigore e l’emoglobinuria da mar-cia. L’ematuria non deve essere confusa con l’urina colorata di rosso perl’assunzione occasionale di alimenti ricchi di purine, di vegetali (caroterosse), di farmaci (anti-infiammatori, antiepilettici, antibiotici, lassativi,miorilassanti e tranquillanti). L’urina in questi casi è limpida e non torbi-da come nell’ematuria, presenta un colore rosso bruno e non forma de-positi di sedimento ematico.
Incontinenza urinaria
La continenza urinaria, ossia la capacità di posporre la minzione almomento e nel luogo opportuno, è la risultante di un delicato equilibriotra numerose componenti neurologiche (volontarie ed involontarie) e
Tabella 1.1. Principali cause di ematuria.

CAPITOLO 1. LO STUDIO DIAGNOSTICO IN UROLOGIA
7
anatomiche (integrità anatomica e strutturale della parete vescicale, del-l’uretra, normale posizione uretro-vescicale nel piccolo bacino). La per-dita di questo equilibrio caratterizza l’incontinenza urinaria (IU), ovverola perdita involontaria di urina in tempi e luoghi inappropriati, di gradotale da costituire un problema igienico e sociale. La perdita involontariad’urina può attuarsi “per uretram” o “extra uretram”.
L’incontinenza extra-uretrale configura situazioni in cui vi è la perditad’integrità anatomica delle vie urinarie con una comunicazione anoma-la, congenita o acquisita, tra le vie urinarie e l’esterno vanificando i mec-canismi sfinteriali vescico-uretrali. Esempi classici d’incontinenza extra-uretrale congenita sono l’estrofia vescicale, l’epispadia completa o glisbocchi ureterali ectopici. Esempi d’incontinenza extra-uretrale acquisi-ta sono, invece, le fistole urinarie, per lo più post chirurgiche, come lefistole vescico-vaginali o uretero-vaginali. Secondo l’I.C.S. (InternationalContinence Society) per incontinenza si definisce una perdita involonta-ria di urine che prevede l’integrità anatomica delle vie urinarie. Da un
Misura Diagnostica Tumore Calcolo Flogosi
Anamnesi +++ +++ +++
Esame clinico +++ +++ +++
Esame qualitativo delle urine-sedimento urinario +++-morfologia degli eritrociti +++ +++-citologia urinaria +++ ++
Esame quantitativo delle urine ++
Urinocoltura ++
Esami di laboratorio-VES ++ ++-ematocrito ++ ++ ++-elettroliti sierici ++-acido urico ++
Ecografia +++ +++ ++
Metodiche endoscopiche-uretrocistoscopia Localizz. dell’emorragia Dopo la terapia
+++ antibiotica++
-uretero-pieloscopia (Nel sospetto ditumore ureteraleo del bacinetto)
++
Indagini radiologiche-Rx diretta addome ++-urografia ++ ++ ++-cistouretrografia minzionale ++
Angiografia +
TC +
RMN +
Scintigrafia renale +
Tabella 1.2. Iter diagnostico in presenza di ematuria.

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
8
punto di vista clinico l’incontinenza urinaria denota un sintomo, un se-gno e una condizione. Il sintomo indica la sensazione della perdita d’uri-na da parte del paziente; il segno è l’oggettiva dimostrazione della perdi-ta urinaria; la condizione è il processo fisiopatologico di base come di-mostrato da indagini cliniche e strumentali. Due condizioni generichedeterminano incontinenza urinaria: anormalità vescicali e/o sfinteriche,che modificano i meccanismi d’immagazzinamento d’urina e di svuota-mento vescicale.
Le alterazioni vescicali includono l’iperattività detrusoriale, la bassacompliance e l’ipoattività detrusoriale (di natura neurogena o meno);le anomalie uretro-sfinteriali includono l’insufficienza sfinterica (da iper-mobilità uretrale, deficit sfinterico intrinseco o post chirurgia) e l’ostru-zione cervico-uretrale (anatomica o funzionale). La perdita involontariad’urine può essere classificata in base alle manifestazioni cliniche (Ta-bella 1.3).Incontinenza urinaria da sforzo. Configura la perdita involontaria diurina che si manifesta in occasione di aumenti della pressione addomi-nale conseguenti,ad esempio, a col-pi di tosse, starnu-ti, manovre di Val-salva o ponza-mento, esercizi fisici,etc. All’analisi urodina-mica la perdita si verifi-ca allorquando la pres-sione vescicale superaquella uretrale in assen-za di attività contrattiledel detrusore. Comepatologia spontaneal’incontinenza urinariada sforzo è tipica delsesso femminile (terza-quinta decade di vita), più frequente, anche senon esclusiva nelle pluripare, accompagnata o meno da prolasso geni-tale o, comunque, da disordini della statica pelvica. Dal punto di vistafunzionale la stress incontinence trova origine dall’insufficienza sfinte-ro-uretrale; essa si realizza sia per l’ipermobilità uretrale, con difetto ditrasmissione delle pressioni addominali al distretto cervico-uretrale, perdiscesa e rotazione del collo vescicale e dell’uretra prossimale, sia perdeficienza sfinterica intrinseca (ISD), la quale indica un cattivo funzio-namento intrinseco dello sfintere stesso e che, nella sua forma più estre-ma, è caratterizzata da un collo vescicale beante a riposo e da una bas-sa pressione endovescicale di filtrazione (stress incontinence di tipoIII). Il deficit sfinterico intrinseco riconosce cause neurologiche, postchirurgiche o può essere da invecchiamento o secondario a stati ipoe-strogenici. L’ipermobilità uretrale e l’ISD possono coesistere nella stessapaziente.
Nel sesso maschile l’incontinenza urinaria da sforzo non esiste inquanto patologia primitiva, ma la si può osservare come esito indeside-rato di interventi chirurgici per lesione incompleta dei meccanismi sfin-
• Incontinenza urinaria da sforzo (stress incontinence)
• Incontinenza urinaria da urgenza minzionale (urge incontinence)
• Incontinenza urinaria mista (stress-urge incontinence)
• Incontinenza urinaria da rigurgito (overflow incontinence)
• Incontinenza urinaria continua, “goccia a goccia” (dribbling incontinence)
• Enuresi notturna
• Incontinenza urinaria funzionale
(*)Secondo l’ICS (International Continence Society), per incontinenza urinaria si intendel’incontinenza urinaria per uretram (trans-uretrale), in condizioni in cui sono preservatel’integrità anatomica e l’impermeabilità della vie urinarie.
Tabella 1.3. Tipi di incontinenza urinaria (*).

CAPITOLO 1. LO STUDIO DIAGNOSTICO IN UROLOGIA
9
teriali uretrali (dopo resezione endoscopica o trans-vescicale di adeno-ma prostatico), in seguito a prostatectomia radicale per neoplasia pro-statica o in caso di neovescica ileale ortotopica dopo cistectomia radi-cale.Incontinenza urinaria da urgenza. E’ definita come la perdita involon-taria d’urina associata ad un impellente ed improcrastinabile desiderio diurinare. Spesso tale affezione si presenta con aumento della frequenzaminzionale, diurna e notturna, ed “urgenza minzionale” senza perditad’urina (sindrome urgenza-frequenza). Si può parlare funzionalmented’incontinenza da urgenza di tipo motorio se si rileva, urodinamicamen-te, la concomitanza del fenomeno con una contrazione detrusoriale in-volontaria, oppure d’incontinenza da urgenza di tipo sensitivo, quando laperdita d’urina non si associa a contrazioni non inibite ma ad un’aumen-tata sensibilità percettiva della vescica. Le alterazioni vescicali alla basedell’urge incontinence includono l’iperattività detrusoriale, la bassa com-pliance vescicale e l’ipersensibilità vescicale (vedi paragrafo “urodina-mica”).
L’iperattività detrusoriale è un termine generico per indicare una con-trazione detrusoriale involontaria che deriva da una patologia neurologi-ca (ictus, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, tumore cerebrale, spinabifida, etc.) o è su base non neurogena (idiopatica, ostruzioni, inconti-nenza sfinterica, neoplasie di organi pelvici, cistiti, calcolosi vescicale,etc.). Una bassa compliance vescicale indica un rapporto volume/pres-sione anomalo che porta ad un rapido aumento della pressione detruso-riale durante il riempimento vescicale. Può essere su base neurologica(mielodisplasia, isterectomia radicale, resezione del retto per via addo-mino-perineale) o da stati infiammatori cronici che determinano un au-mento del collagene della parete vescicale (cistiti tubercolari, post attini-che o interstiziale, cateterizzazione cronica, ostruzione prostatica). Nel-l’ipersensibilità vescicale l’aumento degli stimoli percettivi della vescicapuò essere su base neurogena , secondaria a processi irritativi (infettivi,infiammatori, neoplastici, etc.) o idiopatica. L’incontinenza urinaria mi-sta associa nello stesso paziente i sintomi dell’incontinenza da sforzo edell’incontinenza da urgenza.Incontinenza urinaria da rigurgito (iscuria paradossa). E’ una perdi-ta d’urina che si verifica quando la pressione all’interno della vescicasupera la pressione uretrale massima per una sovradistensione del visce-re e senza attività contrattile involontaria del detrusore; è l’espressione diun mancato svuotamento vescicale, quindi di una ritenzione urinaria sub-completa o completa. Si presenta come fuga involontaria d’urine, in par-ticolare la notte, fino ad una situazione di perdita urinaria costante ed inpiccole quantità. Essa può essere causata dall’ipo-areflessia vescicale,dalle ostruzioni cervico-uretrali su base neurologica (lesione midollarecon dissinergia vescico-sfinteriale) o anatomica (iperplasia prostatica,carcinoma prostatico, stenosi uretrale, cistouretrocele, etc.).Incontinenza urinaria continua, “goccia a goccia”. Consiste nella per-dita continua d’urina dall’uretra. Può essere espressione di un deficit sfin-teriale completo, con riduzione marcata o assenza di resistenze uretrali,di bassa compliance vescicale, di ritenzione urinaria cronica completa o,più raramente, di sacche divericolari che non si svuotano durante l’attominzionale (diverticoli dell’uretra).

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
10
Incontinenza urinaria funzionale. Si parla, infine, d’incontinenza uri-naria funzionale quando la perdita involontaria d’urine è causata preva-lentemente da fattori estrinseci alle vie urinarie, come una disabilità cro-nica fisica e/o cognitiva. Caratteristica dell’età avanzata, può trovare gio-vamento dal miglioramento dello stato funzionale generale del paziente,dal trattamento delle patologie mediche associate, dalla revisione dellaterapia farmacologica, da modificazioni dell’idratazione e dalla riduzio-ne delle barriere ambientali.
Enuresi
Per enuresi s’intende una minzione completa ed involontaria che siverifica durante il sonno, essenzialmente notturna, oltre l’età in cui il con-trollo vescicale viene di solito acquisito (3-4 anno d’età). L’enuresi è prin-cipalmente distinta in due forme: a) primaria o idiopatica, in bambiniche non hanno mai raggiunto il controllo vescicale durante il sonno eche, in genere, non è sostenuta da alcuna lesione organica; b) seconda-ria, quando, una volta acquisito il controllo della minzione, si ripresentain concomitanza di stress emozionali durante un periodo vulnerabile dellosviluppo o altro.
Nell’enuresi diurna è compresa anche la cosiddetta “giggle inconti-nence”, ovvero la perdita d’urine che affligge i bambini a seguito di unafranca risata. L’interpretazione fisiopatologica più corrente del fenomenoè che si tratti di una scarica motrice di provenienza limbica, a seguitod’afferenze di tipo emozionale (Capitolo 12).
Il dolore in urologia
E’ un sintomo importante e fondamentalmente soggettivo la cui veraentità e gravità è spesso condizionata dalla soglia del dolore di chi ne èaffetto. Rappresenta spesso il primo segno di molte patologie e, in basealla sede d’insorgenza e alle sue caratteristiche, si distingue in:Dolore renale. Si può presentare secondo due modalità, come gravativoo come colica renale. Il dolore gravativo è spesso in sede lombare e nonpresenta irradiazione; è provocato dalla tensione della capsula renale inseguito a processi flogistici sostenuti da batteri a carico del parenchimadella via escretrice e dei tessuti perirenali (glomerulonefriti acute, pielo-nefriti, etc.).Colica renale. E’ caratterizzata da dolore acuto, intenso e spesso im-provviso con rapida e progressiva esacerbazione, dovuto ad una repenti-na ostruzione, in un qualsiasi tratto della via escretrice, che impedisce iltransito delle urine. Ciò provoca un aumento della pressione a montedella via escretrice ed induce in primo luogo un incremento della produ-zione di prostaglandine renali, responsabili della sintomatologia algica. Aloro volta, le prostaglandine, provocano un ulteriore incremento dellapressione all’interno della via escretrice determinando la caratteristicaesacerbazione del dolore. All’aumentare della pressione endoluminalesi verifica la scomparsa della peristalsi e spesso un temporaneo arrestodella capacità secretoria del rene interessato (rene funzionalmente esclu-so). Tali bruschi aumenti della pressione possono essere anche causa distravasi urinosi attraverso i fornici delle papille renali nel retroperitoneo,che rendono più complesso il quadro clinico. Il paziente appare sudato eagitato, particolarmente sofferente nel tentativo di trovare una posizioneantalgica. Possono associarsi febbre spesso elevata, disturbi neuro-vege-

CAPITOLO 1. LO STUDIO DIAGNOSTICO IN UROLOGIA
11
tativi quali nausea e vomito, o disturbi minzionali (disuria, pollachiuria)ed ematuria (macro- o microscopica). Il dolore non viene avvertito come“profondo”, ma piuttosto lungo la proiezione superficiale cutanea del-l’uretere e con caratteristiche irradiazioni, dipendenti dalla sede dell’ostru-zione, verso l’inguine e lo scroto nell’uomo, verso le grandi labbra nelladonna. La proiezione del dolore si verifica attraverso il plesso nervosolombare (sistema simpatico), dal quale originano fibre ileoipogastriche,ileoinguinali e genitofemorali. Si tratta di nervi misti con componenti so-matomotorie, somatosensitive, ma anche visceromotorie e viscerosensi-tive che interessano i dermatomeri T10-T11-T12 e L1-L2 (Figura 1.1). Lacausa più frequente della colica renale è la calcolosi, ma può essere an-che provocata da distacco di coaguli, di frammenti neoplastici, da ostru-zioni congenite (stenosi del giunto), etc.Dolore vescicale. Spesso dovuto a sovradistensione della vescica perprocessi patologici ostruttivi, a patologie neurologiche o di tipo irritativoper la presenza di una flogosi;può essere accompagnato adisturbi della minzione.Dolore uretrale. Avvertitocome senso di “bruciore” chesi esacerba durante la minzio-ne, può essere secondario aprocessi flogistici (uretriti), acalcoli o a stenosi.Dolore prostatico. Di solitoriferito dal paziente come un“senso di peso” a livello peri-neale a volte mal definito; an-ch’esso si accompagna a di-sturbi minzionali ed è esacer-bato dall’esplorazione rettale.La causa più frequente è laprostatite.Dolore testicolare. Può presentarsi in varie forme: subdola e di lieveintensità, tipico delle neoplasie, quando presente; acuta e continua neiprocessi flogistici a carico dell’epididimo (epididimite) o del didimo (or-chiti); improvvisa e violenta in caso di torsione acuta o subtorsione deltesticolo che spesso appare retratto verso l’alto in posizione anomala.
Disturbi sessuali
I disturbi sessuali negli ultimi anni con il mutare dei costumi e dellasensibilità hanno assunto particolare rilievo sia in assoluto che in correla-zione alle patologie urologiche. Nell’uomo si distinguono in: disturbi del-l’erezione, dell’eiaculazione, del desiderio sessuale.
Per quanto riguarda i disturbi dell’erezione, questi riguardano solita-mente la capacità di raggiungere una buona erezione (deficit di raggiun-gimento) e/o la capacità di mantenerla (deficit di mantenimento). L’ere-zione inoltre può essere dolorosa e/o associata ad incurvamento penie-no, come si riscontra nella induratio penis plastica (IPP). I disturbi del-l’eiaculazione comprendono:Eiaculazione precoce. Sebbene non esista una definizione universalmen-te accettata, con questa espressione si suole indicare un’incapacità del-
Figura 1.1. Colica rena-le. Dolore riflesso renale(area scura) ed ureterale(area grigia).

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
12
l’uomo di ritardare l’eiaculazione al momento della soddisfazione pro-pria e della partner. Nella maggior parte dei casi il problema riconosceuna origine psicogena anziché un’origine organica.Eiaculazione retrograda. Indica l’eiaculazione in senso posteriore, cioèverso la vescica. Può essere la conseguenza di interventi chirurgici sullaprostata o sul collo vescicale per abolizione dello sfintere liscio o la con-seguenza di una neuropatia diabetica.Eiaculazione dolorosa. E’ di solito sintomo di un’infiammazione a livel-lo della prostata, delle vescicole seminali, dell’uretra o di ostruzione deideferenti.Eiaculazione ritardata. Indica l’impossibilità alla eiaculazione duranteil coito e riconosce generalmente una causa funzionale.
Con il termine di emospermia si indica la presenza di sangue nell’eia-culato ed è solitamente una condizione benigna dovuta per lo più a con-gestione prostatica, prostatiti e prostatosi e molto più raramente a cancroprostatico o cancro delle vescicole seminali. L’anorgasmia, cioè l’impos-sibilità a raggiungere l’orgasmo, è una condizione relativamente rara. Sidefinisce primaria quando è di origine psicogena, secondaria quando siverifica in pazienti con lesioni midollari o altre malattie neurologiche.
I disturbi del desiderio sessuale sono rappresentati generalmente dauna diminuzione della libido e possono riconoscere cause organiche (pa-tologie endocrinologiche, diabete, intossicazione da farmaci o droghe) ecause funzionali (problemi relazionali, caratteriali, etc.).
Esame obiettivo
Sebbene negli ultimi anni ci sia la tendenza a sottovalutarlo e ad affi-darsi prevalentemente a test di laboratorio o a metodiche di imaging, èopportuno ricordare che l’esame obiettivo rappresenta un momento ne-cessario e fondamentale nella valutazione del paziente nel suo comples-so, da cui è possibile trarre indicazioni importanti non solo per la succes-siva condotta diagnostica ma anche terapeutica.
Per quanto riguarda l’apparato urinario, formato da organi caratteristi-camente profondi e posti nel retroperitoneo, l’esame obiettivo raramen-te offre elementi indicativi di patologia, ancor più in caso di soggetti obe-si. Solo i genitali esterni consentono un utile esame che poi spesso trovaconferma con le ulteriori indagini di imaging.
Reni
I reni sono organi pari, simmetrici, retroperitoneali, localizzati nellaregione lombare,in corrispondenza di D12 e L2. Il loro apprezzamento ècondizionato dall’età e dalla conformazione fisica del soggetto. Nei bam-bini molto piccoli, infatti, questi sono facilmente palpabili in quanto pococoperti dalle costole, che in quest’età hanno ancora un andamento oriz-zontale. Nei soggetti adulti, invece, con particolare tono muscolare o contessuto adiposo ben rappresentato sono poco apprezzabili, a meno chenon vi sia ptosi o ectopia renale. La palpazione renale viene generalmen-te eseguita secondo il metodo di Guyon: paziente in posizione supinacon esaminatore posto dal lato del rene indagato, che posiziona una manotrasversalmente a livello dell’angolo costo-vertebrale, mentre l’altra è postaanteriormente con l’asse maggiore parallelo all’asse longitudinale delcorpo. Il paziente deve, quindi, compiere respiri profondi, mentre l’esa-

CAPITOLO 1. LO STUDIO DIAGNOSTICO IN UROLOGIA
13
minatore imprime impulsi in corrispondenza della regione lom-bare, così da poter percepire con la mano posta anteriormentela presenza di eventuali masse renali, procedura nota come ma-novra del ballottamento (Figura 1.2).
Altro momento importante importante dell’esame clinico èla palpazione dei punti ureterali: ilpunto ureterale superiore (puntoparaombelicale di Bazin) è situatolungo la linea ombelicale traversaa tre dita dall’ombelico; il punto ure-terale medio (punto di Tourneux)è situato all’incrocio della linea bi-spino-iliaca con la linea verticale in-nalzata dal punto di unione del ter-zo medio con il terzo mediale dellegamento inguinale; il punto ure-terale inferiore, che corrispondeallo sbocco dell’uretere in vescica,è palpabile solo con l’esplorazionevaginale o rettale.
La percussione renale prevede l’esecuzione della manovra di Giorda-no che consiste nel dare piccoli colpi nella regione lombare con il tagliodella mano. In caso di processi patologici renali, infatti, con tale manovraè possibile evocare dolore.
Vescica
La vescica, organo muscolare cavo, impari e mediano, localizzato nellaparte anteriore della piccola pelvi al di dietro della sinfisi pubica, non ègeneralmente apprezzabile se non in soggetti magri e quando risulti es-sere particolarmente distesa. In alcuni casi di ritenzione, l’organo puògiungere fino alla linea ombelicale traversa divenendo facilmente apprez-zabile palpatoriamente. In questi casi la percussione della regione sovra-pubica produce un tono caratteristicamente ottuso che diventa più tim-panico a livello della anse intestinali.
Genitali esterni
Pene. L’ispezione del glande e del solco balanoprepuziale rappresen-tano il primo momento dell’esame obiettivo dei genitali esterni, attraver-so il quale è importante escludere la presenza di processi infettivi o neo-plastici. Eseguendo la retrazione del prepuzio è possibile verificare, qua-lora risulti ostacolata o impossibile, la presenza di una fimosi; la trazionedel glande verso il basso da parte del frenulo, con dolore e talvolta san-guinamento dello stesso nel rapporto sessuale, fa porre diagnosi di fre-nulo breve. La presenza sul glande e/o sulla cute di vescicole superficialiè indicativa di infezione da herpes simplex; le ulcere possono essereespressione di sifilide o anche di carcinoma squamoso; infine è anchenecessario escludere la presenza di condilomi.
Lo sbocco e pervietà del meato uretrale devono essere attentamenteesaminati, dal momento che questo può essere situato ventralmente (ipo-spadia) o dorsalmente (epispadia). Allargando il meato tra pollice e indi-ce si esplora la fossa navicolare per evidenziare eventuali lesioni infiam-matorie o neoplastiche.
Figura 1.2. Palpazione bimanua-le: la mano posizionata sulla schie-na del paziente spinge il rene ver-so l’alto; quella anteriore palpa ilrene, mentre viene eseguita una in-spirazione profonda.

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
14
I corpi cavernosi devono essere palpati per svelare la presenza pato-logica di placche fibrotiche o ispessimenti del setto intercavernoso, le-sioni indicative della malattia di La Peyronie o Induratio Penis Plastica. Laloro eccessiva deviazione a pene flaccido o in erezione, infine, può esse-re segno di recurvatum congenito o secondario alla malattia di La Peyro-nie.Scroto e testicoli. L’ispezione dello scroto deve essere eseguita prima inposizione supina e poi in piedi. Bisogna innanzitutto valutare la presenzadi eventuali patologie dermatologiche. Infatti, essendo tale zona anato-mica ricca di ghiandole sudoripare e apparato pilifero, è spesso sede diinfezioni locali e di cisti sebacee. I follicoli piliferi possono infettarsi, dan-do origine a piccole pustole sulla superficie dello scroto. I testicoli devo-no essere palpati delicatamente con i polpastrelli di entrambe le mani. Sivaluteranno la sede, la consistenza, il volume, la dolorabilità, la superfi-cie e la mobilità. In condizioni normali sono di consistenza teso-elastica.Se sono di dimensioni ridotte, si deve pensare ad un ipogonadismo o aduna endocrinopatia come la sindrome di Klinefelter, ad un pregresso epi-sodio flogistico o traumatico. La presenza di un’area dura all’interno deldidimo deve essere considerata fino a prova contraria, una neoplasiamaligna. In caso di idrocele (raccolta liquida nella cavità vaginale) la luce,con la prova della transilluminazione, è trasmessa attraverso lo scroto,mentre ciò non avviene in presenza di una formazione solida o in caso diversamento ematico (ematocele). Uno o entrambi i testicoli, possononon essere presenti nello scroto; in questo caso, per poter far diagnosi dicriptorchidismo (testicolo ritenuto lungo il canale inguinale), è necessa-rio escludere la presenza di un testicolo retrattile che è facilmente riposi-zionabile nello scroto.
L’epididimo si apprezza come un “cordone” a decorso verticale sullasuperficie posteriore del testicolo. In caso di torsione del testicolo, essoviene invece palpato di solito anteriormente. Un aumento delle dimen-sioni dell’epididimo o la presenza di aree d’indurimento possono esseredovute a esiti di infezioni specifiche o non specifiche oppure essere dellesemplici formazioni cistiche. L’esame del cordone spermatico deve av-venire con il paziente in posizione eretta: la presenza di gavoccioli venosisottocutanei perifunicolari meglio apprezzabili con la palpazione duran-te la manovra di Valsalva (espirazione forzata a glottide chiusa) è caratte-ristica del varicocele, più frequente a sinistra (Capitolo 8). Sempre con ilpaziente in posizione eretta è poi possibile evidenziare la presenza diun’ernia inguinale: il medico deve inserire delicatamente il dito nell’anelloinguinale esterno invitando il paziente ad eseguire la manovra di Valsal-va. L’ernia si apprezza distintamente come un rigonfiamento che discen-de, durante il ponzamento, verso la punta del dito indice posto sull’anel-lo inguinale esterno.Esplorazione rettale. E’ una manovra estremamente utile per la valuta-zione degli organi pelvici. Il paziente è esaminato disteso in posizionesupina sul lettino, con le gambe flesse sull’addome. Può altresì esseremesso in posizione genupettorale o sul fianco o anche prono. Dopo avervalutato la presenza di patologie della mucosa rettale quali emorroidi,ragadi, fistole, tumori o stenosi si procede all’esplorazione con il dito in-dice. E’ importante apprezzare il tono dello sfintere anale: in caso di ipo-tonia o di ipertonia deve essere sospettato un danno neurologico. Ante-

CAPITOLO 1. LO STUDIO DIAGNOSTICO IN UROLOGIA
15
riormente si può palpare la ghiandola pro-statica. Di questa si devono considerare ledimensioni, la consistenza, e la scorrevo-lezza della mucosa rettale su di essa. Nor-malmente la prostata ha le dimensioni ap-prossimative di una castagna con apice ri-volto verso il basso e una consistenza si-mile a quella dell’eminenza tenar del pol-lice in fase di contrazione. Si possono di-stinguere due lobi laterali per la presenzadi un solco verticale mediano. Questo sol-co, in caso di aumento di volume della pro-stata, si appiana fino a scomparire. Non èinfrequente, soprattutto in caso di adeno-mi voluminosi, apprezzare un notevole ag-getto della ghiandola nell’ampolla rettale.La consistenza dell’organo si riduce note-volmente in presenza di processi flogisticiacuti o di congestione, mentre aumentanotevolmente in caso di processi flogisticicronici, fino ad assumere una consisten-za duro lignea in caso di carcinoma pro-statico. La mucosa rettale è scorrevole suipiani sottostanti, ma in caso di carcinomaprostatico infiltrante i tessuti periprostati-ci, appare fissa. Le vescicole seminali disolito non sono palpabili ma, quando in-fiammate o congeste, possono essere ap-prezzate come delle strutture allungate, diconsistenza cistica situate al di sopra della prostata (Tabella 1.4.).
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
Esami ematochimici
I parametri ematochimici sia di carattere generale, sia quelli di parti-colare significato in urologia, devono sempre essere valutati per una cor-retta impostazione diagnostica e terapeutica.
Generali
Emocromo. La poliglobulia è sospetta per la presenza di un tumore re-nale, mentre un’anemia può verificarsi in corso di ematuria cospicua eprolungata o può far parte del quadro clinico dell’insufficienza renale cro-nica (IRC).Glicemia. I pazienti diabetici sono fortemente esposti ad infezioni dellevie urinarie. Frequenti sono le balanopostiti recidivanti, spesso causa difimosi cicatriziale. Non va dimenticato inoltre che il diabete rappresentauna delle cause principali di deficit erettile e di IRC.Azotemia. L’azotemia non è un indice affidabile di funzionalità renale inquanto fortemente influenzata dal contenuto proteico della dieta. Tuttaviaun incremento notevole di tale valore deve sempre far sospettare la pre-
Tabella 1.4. Criteri di valutazione della ghiandola pro-statica all’esplorazione rettale.
MorfologiaForma, posizione e dimensione
• confronto tra i lobi laterali• solco mediano conservato o appiattito• delimitazione dei margini laterali e craniale• ghiandola aggettante nel retto• valutazione delle vescichette seminali
Struttura superficiale• liscia• irregolarità localizzata o diffusa del contorno
dell’organo con delimitazione netta o difficileverso i tessuti circostanti
• scorrevolezza della mucosa rettale
Consistenza• teso-elastica• pastosa, edematosa• morbida, comprimibile, fluttuante• dura
Ulteriori criteri• alterazioni anali (all’ispezione)• sensibilità perianale• tono sfinteriale flaccido, normale o aumentato• dolorabilità locale o diffusa• reperti palpatori sospetti a livello dell’ampolla
rettale• sangue sul guanto esploratore

6
155
PATOLOGIE PROSTATICHEPATOLOGIE PROSTATICHE
INTRODUZIONE
Nei confronti di un paziente con sospetto quadro clinico di origine pro-statica ci si deve sempre porre il problema di una diagnosi differenziale.Questo perché il quadro sintomatologico, escluse le forme acute, è pocoindicativo della patologia; inoltre, non è raro il riscontro di più patologieassociate, quali prostatite cronica ed iperplasia prostatica o iperplasia pro-statica e neoplasia. È evidente come tali eventualità condizionino e deter-minino il definitivo indirizzo terapeutico. E’ da tener presente, poi, che qua-lunque patologia a tale livello incide sulla qualità della minzione e nei casipiù gravi su tutto l’apparato urinario, con quadri clinici vari e complessi. Pertali motivi abbiamo ritenuto opportuno, così come nella pratica clinica, alfine di una più facile comprensione e di un più corretto inquadramento,associare in un unico capitolo le principali patologie prostatiche.
ANATOMIA E FISIOLOGIA DELLA PROSTATA
La prostata è una ghiandola annessa all’apparato genitale maschile,localizzata nella cavità pelvica tra il collo vescicale ed il diaframma uro-genitale, posteriormente alla parte inferiore della sinfisi pubica ed ante-riormente al retto, dal quale è separata dalla sottile fascia di Denonvil-liers. Lateralmente essa è in rapporto con i muscoli elevatori dell’ano,con l’interposizione dei plessi venosi vescico-prostatici e della fascia en-dopelvica. La prostata ha la forma di un piccolo cono rovesciato, conl’apice in corrispondenza del diaframma urogenitale e la base in corri-
C. De Dominicis
F. Barrese
A. De Matteis

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
156
spondenza del collo vescicale ed è attraversa-ta dal primo tratto dell’uretra (uretra prostati-ca) che, a metà del suo decorso, mostra unaimprovvisa angolatura anteriore. Il punto diangolazione segna la divisione dell’uretra pro-statica in un segmento prossimale ed un seg-mento distale. In corrispondenza della parteposteriore della base penetrano nella prostatai dotti eiaculatori, che l’attraversano obliqua-mente in direzione postero-anteriore, dall’altoin basso, per sboccare nel segmento distaledell’uretra prostatica (Figure 6.1 e 6.2).
La prostata, il cui sviluppo embrionale ècondizionato da vari fattori tra i quali l’indispen-sabile presenza di testosterone fetale, subisceuna evoluzione strutturale e ponderale dallanascita all’età adulta per raggiungere un pesodi 20 g all’età di 20-25 anni. Tradizionalmente,si indicano i lati della prostata come lobi, an-che se la prostata è un organo macroscopica-mente unitario, non ripartito, e c’è reale evidenza di una lobaturasoltanto quando l’organo è iperplastico. Attualmente si preferi-sce fare riferimento ad una concezione zonale della prostata,originariamente proposta da McNeal, a sostegno della quale con-vergono osservazioni embriologiche, morfologiche e biologiche. Le zonedella prostata in condizioni normali non sono immediatamente apprez-zabili all’esame macroscopico ma possono essere identificate e studiatein sezioni eseguite secondo piani obliqui coronali. Le zone dell’uretranelle quali sboccano i dotti prostatici sono il principale elemento di rife-rimento per la identificazione dellediverse zone ghiandolari. Secondo ilmodello di McNeal, le zone ghiando-lari della prostata sono tre: 1) la zonacentrale (CZ); 2) la zona di transizio-ne (TZ); 3) la zona periferica (PZ) (Fi-gura 6.3). A queste si devono aggiun-gere poi altre regioni e strutture nonghiandolari.
La CZ, che costituisce circa il 25%della massa prostatica, è quella par-te di prostata che, a forma di cono,con ampia base in corrispondenzadella base della prostata, circonda idotti eiaculatori dalla loro penetrazio-ne nella prostata fino allo sbocconell’uretra. Questo è localizzato sul-la parete posteriore dell’uretra ai latidell’utricolo prostatico o verumonta-num. La rilevatezza oblunga dellaparete posteriore dell’uretra cheprende questo nome e che contiene
Figura 6.1. Veduta sagittale del-la prostata e suoi rapporti con lestrutture circostanti.
Figura 6.2. Visione posteriore della ghiandola prostatica.
Parete fibromuscolaredella vescica
Condotto deferente
Uretere
Ampolla delcondottodeferente
Vescicoleseminali
Muscoloelevatoredell’ano
Utricoloprostatico
Spazioretropubico
Uretra membranosa
Vescica urinaria
Vescicole seminali
Sfintereuretraleinterno
Dottieiaculatori
Capsulaprostatica
Pareterettaleanteriore
Uretraprostatica
Utricoloprostatico
Sfintere uretraleesterno
Ghiandolabulbo laterale
Uretra membranosa
Orifizio ureterico
Trigono vescicale
Parete vescicale
Sinfisipubica
Giunzioneprostato-vescicale
Ghiandolaprostatica
Vena dorsaleprofonda delpene

CAPITOLO 6. PATOLOGIE PROSTATICHE
157
in posizione centrale e profonda l’utricolo pro-statico, è situata nella metà distale dell’uretraprostatica, con il suo apice prossimale in corri-spondenza del punto di angolazione dell’uretrastessa mentre distalmente si assottiglia notevol-mente a formare la cresta uretrale. I dotti pro-statici della CZ provengono dalla base della pro-stata e si aprono sull’utricolo prostatico, circon-dando gli orifizi dei dotti eiaculatori. La TZ costi-tuisce soltanto il 5% della prostata normale ed èformata da due piccoli lobi intraprostatici, cia-scuno a lato dell’uretra prossimale, esternamen-te allo sfintere preprostatico, con estensione an-teriore e verso il collo vescicale. Lo sfintere preprostatico (sfintere liscio)è formato da fibrocellule muscolari lisce che circondano il segmento pros-simale dell’uretra prostatica come una guaina e che normalmente impe-discono, durante l’eiaculazione, il flusso retrogrado di liquido seminaledal tratto distale dell’uretra prostatica. Soltanto una piccola quantità dighiandole della TZ ha sede periuretrale entro i confini dello sfintere pre-prostatico. I dotti della TZ sboccano nella parte postero-laterale dell’ure-tra prostatica subito al di sopra dell’angolazione uretrale, in corrispon-denza del margine distale dello sfintere preprostatico, quindi nel trattoprossimale. La PZ è la più estesa, formando il 70% della massa prostati-ca. Essa comprende un’ampia area periferica, posteriore, postero-latera-le, laterale ed apicale. I suoi dotti si aprono nel segmento distale dell’ure-tra prostatica, con una doppia fila di orifizi che vanno dalla base del col-licolo seminale all’apice prostatico. Da un punto di vista istologico puòessere difficile stabilire quale sia la zona che si sta osservando, sebbenetra di esse esistano differenze morfologiche nella tessitura dello stroma enella configurazione delle strutture epiteliali. Tuttavia, l’importanza diquesto modello è nella correlazione stabilita tra zone della prostata esuscettibilità a specifiche malattie, in presenza delle quali, peraltro, ladifferenza tra le varie zone si accentua. E’ il caso della TZ, esigua in con-dizioni normali, ma che è la sede elettiva della iperplasia nodulare, acausa della quale può assumere un volume prevalente tra le diverse com-ponenti della prostata. La maggior parte dei carcinomi prostatici ha inve-ce origine dalla PZ che è anche la più suscettibile ai processi infiammato-ri. La CZ è la più refrattaria a processi patologici, similmente alle vescico-le seminali con le quali condivide anche l’origine embriologica dal dottodi Wolff.
Nella prostata sono presenti anche regioni o strutture non ghiandola-ri, come lo sfintere preprostatico del quale si è già detto. Oltre questo, sideve ricordare lo sfintere striato, lo stroma fibromuscolare anteriore e lacapsula prostatica. Lo sfintere striato è formato da fibre muscolari striateche avvolgono l’uretra tra l’utricolo prostatico e l’apice prostatico, condistribuzione delle fibre variabile a seconda delle prostate, comunquesempre in maniera incompleta in corrispondenza di alcuni tratti dell’ure-
Figura 6.3. Suddivisione schematicadelle zone prostatiche secondo McNeal.
CZ: zona centraleTZ: zona transizionalePZ: zona periferica
: zona fibromuscolare: regione periuretrale del glande
Dotto eiaculatorio
Uretra prostatica
CZTZ
PZ
CZTZ
PZ

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
158
tra e con non rara intromissione delle fibre striate tra le ghiandole deltessuto prostatico, soprattutto all’apice. Lo stroma fibromuscolare ante-riore costituisce la regione anteriore della prostata e si estende dal collovescicale all’apice, restringendosi ed assottigliandosi verso l’apice. Essoè formato da fibrocellule muscolari lisce e tessuto connettivo fibroso. Lacapsula prostatica non è una reale entità anatomica. Essa è data esclusi-vamente da un addensamento dello stroma fibromuscolare alla periferiadell’organo, e questo delimita i confini entro cui sono contenuti gli acinie i dotti. Tuttavia, la relativa presenza di tessuto connettivo fibroso e mu-scolare liscio e lo spessore della capsula sono molto variabili e, inoltre,non ovunque essa è ben definita, mancando sempre del tutto in alcunisettori dell’apice e della base. La struttura della prostata è quella di unaghiandola tubulo-alveolare composta, con acini e dotti distribuiti in unostroma formato da fibrocellule muscolari lisce e tessuto connettivo fibro-so. Indipendentemente dalle fini differenze istologiche che contraddi-stinguono ciascuna zona, le caratteristiche fondamentali degli acini e deidotti periferici sono le stesse in ogni settore della prostata. Sia gli aciniche i dotti periferici sono rivestiti da un duplice strato di cellule epiteliali,quello delle cellule basali che si distribuiscono lungo la parete dell’acinotra la membrana basale, alla quale aderiscono mediante emidesmoso-mi, e lo strato delle cellule secretorie o luminali. La membrana basale haun’importanza fondamentale per vari motivi, tra cui il mantenimento dellanormale architettura della prostata ed il passaggio di fattori diffusibili dal-lo stroma all’epitelio. Le cellule secretorie da un lato poggiano sulle cel-lule basali e dall’altro aggettano nel lume ghiandolare. Al compartimentobasale si deve la massima parte dell’attività proliferativa mentre alle cel-lule secretorie spetta l’attività secernente. Le cellule basali e quelle se-cretorie hanno differente morfologia e differenti proprietà biologiche. Leprime, infatti, sono attrezzate per proliferare, senza perdere la stabilitàdel genoma, e non hanno recettori androgenici rilevabili con metodicheimmunoistochimiche. Al contrario, le cellule secretorie hanno nulla oscarsissima capacità proliferativa e l’uscita dal ciclo cellulare segna laloro completa differenziazione e prelude alla morte per apoptosi. Esseproducono componenti essenziali del liquido seminale, come enzimi,quali la fosfatasi acida prostatica (PAP) e l’antigene prostatico specifico(PSA). Un terzo tipo cellulare è rappresentato da una piccola quantità dicellule neuroendocrine le quali si localizzano singolarmente tra le cellu-le luminali, talora aprendosi nel lume, talaltra rimanendo indovate tra lecellule vicine. Le cellule neuroendocrine prostatiche non hanno alcunacapacità proliferativa mentre molto probabilmente hanno attività para-crina mitogena. Si ritiene che il compartimento basale sia la sede dellecellule staminali prostatiche. Lo stroma della prostata è molto importan-te per le interazioni con l’epitelio. Le cellule che lo compongono, in par-ticolare fibroblasti, fibrociti, fibrocellule muscolari lisce, sono fornite inmisura variabile di recettori androgenici, estrogenici e progestinici e sonoin grado di produrre numerosi fattori di crescita per i quali le cellule basa-li hanno recettori.
Il trofismo e l’attività secretoria delle cellule epiteliali luminali è sottoil controllo degli ormoni androgeni per i quali queste cellule hanno recet-tori nucleari (AR), facilmente evidenziabili mediante colorazione immu-noistochimica. Il più importante ormone androgeno è il testosterone. La

CAPITOLO 6. PATOLOGIE PROSTATICHE
159
massima parte del testo-sterone circolante è pro-dotto dal testicolo sotto ilcontrollo dell’asse ipotala-mo-ipofisario che produ-ce in modo pulsatile il fattore ri-lasciante decapeptide LH-RH,che a sua volta determina la se-crezione ipofisaria dell’ormonefollicolo-stimolante (FSH) e del-l’ormone luteinizzante (LH). Sot-to l’azione dello LH ed in dipen-denza dall’AMP-ciclico, le cellule di Leydig testicolari sono in grado diprodurre testosterone. Tuttavia, circa il 98% del testosterone circolante èprevalentemente legato alle proteine plasmatiche e quindi non disponi-bile per gli organi bersaglio (Tabella 6.1).
La maggior parte del testosterone è legata alla proteina SHBG (SexHormone Binding Globulin). La pubertà e la somministrazione di andro-geni riducono la produzione di SHBG così che aumenta la quantità ditestosterone in forma libera. La somministrazione di estrogeni determi-na, al contrario, un aumento dei livelli di SHBG in circolo. Le proteineplasmatiche leganti, soprattutto globuline, attuano, pertanto, una regola-zione dell’attività degli androgeni. Nella prostata, tuttavia, l’attività andro-genica non è svolta dal testosterone ma dal di-idro-testosterone (DHT)che risulta dalla riduzione enzimatica del testosterone in DHT ad operadella 5-alfa-reduttasi. Ciò avviene principalmente nello stroma dove sonopiù alte le concentrazione di questo enzima (Figura 6.4). Il DHT è l’ormo-
• Albumina; capace di legare tutti gli steroidi e quindi scarsamentespecifica
• Globulina specifica per gli ormoni sessuali (SHBG - Sex HormonBinding Globulin) dotata di elevata specificità ma con scarsa capacità
• Transcortina o Corticosteroid Binding Globulin (CBG)• Globulina per il progesterone (PBG)• Glicoproteine acide (AAG)
Tabella 6.1. Proteine plasmatiche in grado di legare il testosteronee altri ormoni sessuali.
SHBG T
Cervello
Tessuto adiposo
Muscolo
Metabolismo
EstrogeniEstrogeni
DHT
DHT
FSHLHProlattina
Testicoli
IpofisiGhiandolasurrenale
Fegato
Metabolismo
Sangue
Testosterone (T)
Pelle
Aromatizzazione
Funzionalitàsessuale
5a-riduzione
Feedbacknegativo
AndrosteroneAetiochinolone5a-androstanedione5a-androstanedioloSolfatiGlucuronidi
Figura 6.4. Relazioni endocrine in grado di influenzare la fun-zionalità prostatica.

UROLOGIA CLINICA ILLUSTRATA
160
ne determinante per la crescita prostatica; viene attivato dall’enzima 5-alfa-reduttasi, del quale si conoscono due isoforme, il tipo 1 e il tipo 2.Mentre il tipo 2 è presente essenzialmente a livello prostatico il tipo 1 siriscontra anche nei tessuti extraprostatici.
La vascolarizzazione arteriosa prostatica avviene attraverso le arterievescico-prostatiche che derivano dalle arterie ipogastriche. Le arterievescico-prostatiche si dividono in due rami, le arterie vescicali inferiori ele arterie prostatiche.
Dalle aa. vescicali inferiori e dal tratto prossimale delle aa. prostaticheoriginano dei piccoli rami che, dal collo vescicale decorrono lungo l’ure-tra prostatica per terminare a livello del veru montanum. Le aa. prostati-che decorrono lungo i margini della ghiandola per terminare all’apiceprostatico. Le vene prostatiche all’interno della ghiandola seguono il de-corso delle arterie. Le emergenze avvengono, a livello della base doveconfluiscono con le vene vescicali e vesciculo-deferenziali nella venagenito-vescicale che a sua volta confluisce nella vena ipogastrica e daentrambi i lati della prostata per gettarsi nel plesso venoso del Santorini enelle vene vescicali inferiori. Da qui si evince l’enorme portata venosadel plesso del Santorini e soprattutto l’importanza del suo controllo du-rante l’intervento di prostatectomia radicale, in quanto un’errata mano-vra chirurgica può determinare emorragie importanti. L’innervazione au-tonoma degli organi pelvici e dei genitali esterni deriva dal plesso pelvi-co, che è formato da fibre parasimpatiche che originano dal centro sa-crale S2-S4 e da fibre simpatiche che originano dal centro toraco-lomba-re T11-L2. Il plesso pelvico forma una struttura rettangolare fenestrata ilcui punto centrale si trova nei pressi dell’apice delle vescichette semina-li. Da qui si dipartono rami viscerali che innervano la vescica, l’uretere, levescicole seminali, la prostata, il retto, l’uretra membranosa e i corpi ca-vernosi. Il fascio nervoso per la prostata, per l’uretra membranosa e per icorpi cavernosi che regola rispettivamente il meccanismo eiaculatorio,sfinteriale ed erettivo decorre nella fascia endopelvica tra prostata e rettoe riveste particolare importanza in quanto il suo risparmio durante l’in-tervento di prostatectomia radicale per tumore non compromette l’atti-vità sessuale del paziente.
IPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA
Per iperplasia prostatica benigna (IPB) si intende l’aumento della com-ponente parenchimale e stromale della ghiandola prostatica, cui segueun progressivo incremento del volume; tale evento è legato ai fisiologicimutamenti ormonali che si verificano in tutti gli uomini nel corso deglianni. I primi cambiamenti iniziano precocemente, già durante la 3° e 4°decade di vita. Tuttavia solo il 50% dei pazienti con IPB riferisce una sinto-matologia patologica e ciò è dovuto al fatto che l’aumento volumetricodella ghiandola non necessariamente provoca una ostruzione significati-va del lume uretrale. I primi disturbi si manifestano il più delle volte tra i55 ed i 75 anni d’età. Si è stimato che circa l’85% degli uomini sviluppanel corso della vita tale condizione, e circa il 95% delle prostate esamina-te istologicamente dopo i 50 anni presentano focolai di iperplasia. L’inci-denza autoptica dell’IPB nelle diverse decadi è nulla nei primi 30 anni eraggiunge valori dell’80% in soggetti tra 51 e 90 anni.






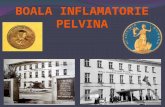

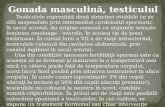








![Atlante Di Istologia [Atlante Istologia]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/553f232a4a7959960d8b471e/atlante-di-istologia-atlante-istologia.jpg)

