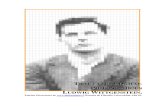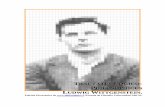tractatus
-
Upload
paolo-rossi -
Category
Documents
-
view
179 -
download
21
description
Transcript of tractatus
Sandro Soleri Note al TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS di Ludwig Wittgenstein con schede di lettura Wittgenstein nello SWIFINTRODUZIONE 1. Le vicende della composizione e della pubblicazione del libro. Il Tractatus logico-philosophicus, insieme ad un libro di testo per le scuole el ementari austriache (1926) e al breve saggio Some remarks on Logical Form (1929) , lunico scritto dato alle stampe in vita da Ludwig Wittgenstein. Lopera ebbe una gestazione piuttosto lunga e travagliata. Il primo progetto di unopera filosofica risale probabilmente al 1911. In quel periodo Wittgenstein si trovava a Manches ter per proseguire i suoi studi di ingegneria aeronautica. La lettura delle oper e di Gottlob Frege e quella dei Principles of Mathematics di Bertrand Russell av evano dischiuso al giovane Ludwig lorizzonte degli studi di logica e filosofia, d istogliendolo progressivamente dai suoi interessi originari. Nellestate del 1911 Wittgenstein si rec a Jena e discusse dei suoi progetti filosofici con Frege, il quale gli sugger di stabilirsi a Cambridge per studiare sotto la guida di Bertran d Russell. Lincontro di Wittgenstein con lautore dei Principia Mathematica avvenne il 18 ottobre di quellanno e fu cos descritto da Russell: Comparve un tedesco affa tto sconosciuto che parlava inglese con difficolt e che tuttavia si rifiutava di esprimersi in lingua tedesca. Alla fine risult uno che aveva studiato ingegneria a Charlottenburg, ma che nel corso di tali studi sera appassionato, in modo del t utto autonomo, alla filosofia della matematica, per cui sarebbe arrivato qui a C ambridge con la ferma intenzione di assistere alle mie lezioni.[1] Wittgenstein n on si limit ad assistere alle lezioni: egli inizi infatti un serrato confronto con Russell discutendone le teorie ed elaborando idee originali che risultavano spe sso in conflitto con quelle del maestro. Il mio tedesco minaccia di trasformarsi in una pestilenza: al termine delle lezioni mi vien dietro e non la smette di ar gomentare fino allora di cena. Ostinato e spietato, non mi sembra per affatto stup ido.[2] Pur dovendo far fronte agli attacchi continui di Wittgenstein (le cui cri tiche si rivolgevano soprattutto alla Teoria dei tipi logici), Russell mostrava di apprezzare le grandi doti intellettuali del suo allievo e col passare del tem po si rese conto che il prossimo contributo di rilievo nel campo della logica ma tematica sarebbe venuto proprio dal suo tedesco. Prima di dedicarsi completamente alle nuove discipline di studio, per, Wittgenstein aveva un disperato bisogno di conferme, come testimonia il seguente episodio: Alla fine del suo primo trimestre a Cambridge, Wittgenstein venne da me e mi chiese: Pu dirmi, per favore, se sono un idiota completo o no?. Gli risposi: Caro amico, non lo so proprio. Ma perch me l o chiede?. E lui: Perch se sono un idiota completo far il pilota daereo, se no far il filosofo. Gli dissi di scrivermi qualcosa, durante le vacanze, su un qualche argo mento filosofico, e poi gli avrei detto se era un idiota completo o no. Segu il m io consiglio e allinizio del trimestre successivo mi port il suo elaborato. Dopo a verne letto una sola frase gli dissi: No, lei non deve fare il pilota daereo .[3] Wi ttgenstein inizi a lavorare ai problemi di logica con incredibile energia. Ha il t emperamento dellartista scriveva di lui Russell in quel periodo- intuitivo e luna tico. Dice che tutte le mattine inizia il lavoro sotto il segno della speranza e tutte le sere lo conclude nella disperazione.[4] Nel febbraio del 1912 Wittgenst ein fu ammesso al Trinity College ed inizi a seguire i corsi di logica. Come gi ac caduto nei suoi incontri con Russell, egli si dimostr un allievo piuttosto diffic ile. Prese a farmi lezione sin dal nostro primo incontro dichiar seccato uno dei su oi professori.[5] Durante il suo soggiorno a Cambridge, negli anni 1912-1913, Wi ttgenstein strinse amicizia con il filosofo G. E. Moore e con leconomista J. M. K eynes. Su richiesta di Russell, nel 1913 egli si decise a mettere un po di ordine nei suoi appunti e a scrivere un resoconto dei progressi fino ad allora compiut i. Wittgenstein era ossessionato dallidea di morire prima di essere riuscito a co mpletare il proprio lavoro. Il suo amico David Pinsent annot nel proprio diario: [ Wittgenstein] ha un terrore morboso di morire prima di mettere a punto quella te oria [ovvero la revisione della Teoria dei tipi, ndr], e prima di aver messo per iscritto tutti gli altri lavori di modo che risultino comprensibili al mondo e di qualche utilit per la scienza logica. Ha gi scritto molto, Russell gli ha perfi no promesso di pubblicare le sue opere caso mai dovesse morire, ma lui convinto che la loro formulazione non sia abbastanza precisa e non rispecchi con la neces saria chiarezza i suoi metodi di pensiero ecc., che ovviamente sono pi preziosi d ei risultati raggiunti. Non fa che dire di essere certo di morire entro quattroanni: oggi erano diventati addirittura due mesi.[6] Forse questo irragionevole ti more fu una delle cause che spinsero Wittgenstein a prendere la penna e a fissar e i punti principali delle proprie scoperte. Nacquero cos le Note sulla logica, c he rappresentano la prima testimonianza scritta del suo pensiero. Di l a poco Wit tgenstein decise inaspettatamente di lasciare Cambridge e di trasferirsi in Norv egia per studiare in solitudine. Russell tent di dissuaderlo, ma fu tutto inutile : Gli dissi che sarebbe stato buio e mi rispose che detesta la luce del sole. Gli dissi che sarebbe stato completamente solo e mi rispose che si prostituiva linte lletto parlando con la gente intelligente. Gli dissi che era pazzo e mi rispose D io mi protegga dalla saggezza. (Esperiamo proprio che Dio lo protegga). [7] Dal 1913 al 1914 Wittgenstein visse a Skjolden, sulla sponda di un fiordo, isolato dal resto del mondo. Il soggiorno n orvegese rappresent per lui un periodo di grande creativit. Allepoca il mio cervello era infuocato! dir anni pi tardi.[8] E scrivendo a Russell: Mi sembra che stia cres cendo dentro di me ogni specie di pianta logica, ma per il momento non sono anco ra in grado di scriverne.[9] Nellaprile del 1914 Wittgenstein invit a Skjolden Geor ge Edward Moore, al quale dett i risultati delle proprie indagini. Nelle note tra scritte da Moore, Wittgenstein delineava quella distinzione tra dire e mostrare che diventer poi uno dei cardini della teoria esposta nel Tractatus consentendo d i sostituire la Teoria dei tipi di Russell con una nuova teoria dei simboli la qu ale mostri che generi differenti di cose sono simbolizzati da generi differenti di simboli che non possono essere sostituiti luno con laltro (LR 244). Al suo ritor no a Cambridge, Moore si inform se il manoscritto (intitolato provvisoriamente: L ogica) potesse garantire a Wittgenstein il diploma di Bachelor of Arts al Trinit y College. La risposta fu negativa: il regolamento del college disciplinava rigi damente la struttura cui doveva uniformarsi un elaborato e lo scritto di Wittgen stein non rientrava nei parametri. Wittgenstein and su tutte le furie e se la pre se col povero Moore: Caro Moore, la sua lettera mi ha molto contrariato. Quando s crissi Logica non mi curai di consultare i Regolamenti, sicch ritengo che sarebbe pi che onesto se mi si desse il mio diploma senza andare tanto a consultarli! () Se non son degno che si faccia uneccezione per me riguardo ad alcuni stupidi dett agli, allora tanto vale mandarmi al diavolo senza tanti ambagi, e se io ne sono degno e lei non lo fa, allora, per Dio!, ci vada lei. Lintera faccenda troppo idi ota e troppo bestiale per continuare a scriverne.[10] Questa vivace reazione dipe se probabilmente dallo stato di esaurimento fisico e nervoso in cui venne a trov arsi Wittgenstein dopo lo sforzo produttivo dei mesi precedenti. Dominato da unes igenza di chiarezza che si traduceva in unesasperante ricerca della perfezione, W ittgenstein incontrava grandi difficolt nel mettere in chiaro i propri pensieri e d era costantemente insoddisfatto dei risultati raggiunti. Nei suoi diari annote r: La mia difficolt solo una enorme difficolt despressione (Q 133). Il fatto che enstein abbia pubblicato cos poco materiale durante la sua vita da ascriversi pro prio a questa ricerca quasi maniacale della forma espressiva perfetta. Ma i prob lemi di Wittgenstein erano anche di natura morale e si collegavano a quellesigenz a di fare i conti con se stesso cui egli accenna in una lettera a Russell: Come p otr mai essere un logico prima di essere un umano?.[11] Fu probabilmente tale nece ssit interiore di mettersi alla prova per scoprire il proprio autentico io che sp inse Wittgenstein, allo scoppio della Prima guerra mondiale, ad arruolarsi come volontario nellesercito austro-ungarico. Wittgenstein riteneva che lesperienza di a ffrontare la morte lo avrebbe in qualche modo arricchito. And in guerra, si potre bbe dire, non per il proprio paese ma per se stesso.[12] La sua prima destinazion e, nel settembre del 1914, fu il fronte orientale, su un battello che pattugliav a il fiume Vistola. In questo periodo Wittgenstein lesse le Spiegazioni dei vang eli di Tolstoj e si accost alla fede cristiana. I suoi compagni lo chiamavano luomo coi vangeli. Nonostante le difficolt connesse al suo nuovo stato, Wittgenstein in izi la stesura del Tractatus annotando le proprie osservazioni su una serie di ta ccuini che portava sempre con s nello zaino militare. Nel dicembre del 1914 venne trasferito in un officina di artiglieria, dove godette di una maggiore tranquil lit per proseguire i suoi studi. Lesse i Saggi di R. W. Emerson, lAnticristo di Ni etzsche e I fratelli Karamazov di Dostoevskij. Nellottobre del 1915 stese una pri ma redazione del Tractatus, andata purtroppo perduta. Dal marzo del 1916 fu tras ferito sulla linea del fuoco, sul fronte russo. Perduti i contatti con Russell e lambiente di Cambridge, Wittgenstein attravers un periodo molto difficile riuscen do tuttavia a portare avanti il proprio lavoro e distinguendosi anche nelle azio ni di guerra per il suo coraggio (acquisito il grado di ufficiale di artiglieria , nel 1917 venne decorato con la medaglia dargento al valore militare). Dal marzo 1918, crollato il fronte russo e firmata la pace di Brest-Litovsk, Wittgenstein fu trasferito sul fronte italiano. Nellagosto dello stesso anno termin la stesura del suo libro e ne invi una copia alleditore Jahoda, che per rifiut di pubblicarlo; fu la prima di una lunga serie di risposte negative, ma Wittgenstein aveva in q uel momento ben altro di cui preoccuparsi: in ottobre cadde infatti prigionierodagli Italiani e fu trasferito in un campo di prigionia prima a Como e poi a Cas sino (dove rimarr dal gennaio allagosto 1919). Riuscito a riprendere il contatto e pistolare con Russell, gli comunic di aver terminato la sua opera, per la quale a veva scelto il titolo di Logisch-Philosophische Abhandlung. Wittgenstein temeva che il libro fosse troppo innovativo per essere compreso, e le sue paure risulta rono purtroppo fondate. Russell e Frege, cui era stata inviata una copia manoscr itta dellopera, manifestarono molte riserve sul contenuto del testo e riconobbero francamente di non aver compreso molto di esso. Ci contribu ad accentuare lo stat o di sconforto in cui versava Wittgenstein per le difficolt di pubblicazione dello pera: nessuno degli editori contattati sembrava infatti disposto a rischiare su unopera cos singolare, e le lettere di rifiuto si susseguivano inesorabili. Ancora nel 1929, quando il Tractatus fu presentato come tesi di laurea al Trinity Coll ege di Cambridge, Wittgenstein era intimamente persuaso che quasi nessuno avesse compreso la lezione del suo libro: al termine dellesame, alzatosi dalla sedia, e gli and a battere sulle spalle di Moore e Russell dicendo: Non preoccupatevi tropp o, tanto lo so bene che non lo capirete mai.[13] Liberato dal campo di prigionia, Wittgenstein torn a Vienna. Era uno degli uomini pi ricchi di tutta lAustria, mail suo primo atto una volta rientrato in patria fu di rinunciare alleredit paterna e di iscriversi ad un corso per diventare maestro elementare. La scelta di abba ndonare gli studi filosofici era in fondo coerente con il giudizio negativo espr esso sulla filosofia nel Tractatus e con la convinzione di aver detto nella sua opera tutto quanto fosse possibile esprimere sensatamente (nella sua Prefazione, Wittgenstein scrive: La verit dei pensieri qui comunicati mi sembra intangibile e definitiva. Sono dunque dellavviso daver definitivamente risolto nellessenziale i problemi). Depresso e in preda alla sindrome del reduce (continuer per anni a indo ssare una logora divisa dellesercito), Wittgenstein medit a pi riprese il suicidio (gi tre dei suoi fratelli si erano tolti la vita). Era comunque convinto che il s uicidio fosse un errore: Sinch una persona vive non del tutto perduta. E invece, c i che spinge una persona al sucidio proprio il timore di essere del tutto perduta. [14] Nonostante le difficolt a trovare un editore per il Tractatus, Wittgenstein rifiutava lidea di pubblicare il libro a proprie spese: Il mio lavoro di modestiss ima mole, circa sessanta pagine. Ma chi scrive sessanta paginette su questioni f ilosofiche? Gli unici sono quegli scribacchini disperati che non possiedono n lo spirito dei grandi n lerudizione dei professori, e, tuttavia, desiderano ad ogni c osto pubblicare qualcosa. Perci tal genere di prodotti viene solitamente pubblica to a spese dellautore. Ma io non posso mescolare tra questi scritti lopera della m ia vita: perch di questo appunto si tratta.[15] Nella speranza di trovare una coll ocazione adeguata per il Tractatus, Wittgenstein decise di contattare Ludwig Von Ficker, editore della rivista letteraria Der Brenner. Wittgenstein scrisse una lettera di presentazione spiegando a Von Ficker il significato dell opera: Il mio lavoro si compone di due parti: ci che ho scritto, pi tutto ci che non ho scritto. E proprio questa seconda parte importante. Grazie al mio libro, letico viene per cos dire delimitato dallinterno; e sono convinto che, in senso stretto, letico sia da delimitarsi solo in questo modo. In breve, credo che: tutto ci su cui molti o ggi parlano a vanvera, io, nel mio libro, lho definito semplicemente tacendone. P erci, a meno che non mi sbagli del tutto, questo libro dir molte cose che anche le i vuol dire, magari senza nemmeno accorgersi che vi vengono dette. Nel frattempo , vorrei raccomandarle la lettura della prefazione e delle conclusioni, perch esp rimono le cose nella maniera pi immediata.[16] Von Ficker si riserv di decidere dop o aver consultato un professore di filosofia, ma Wittgenstein si mostr tuttaltro c he favorevole allidea: se nemmeno Frege e Russell avevano compreso la lezione del Tractatus non vera speranza che qualcun altro riuscisse nellimpresa. Sottoporre un lavoro di filosofia a un professore di filosofia come gettare perle ai porci. () Del resto non ne capir una parola.[17] Anche questo tentativo si risolse cos in un fallimento. Le cose cambiarono dopo che Russell, con il quale Wittgenstein avev a discusso il libro parola per parola durante un incontro in Olanda, accett di sc rivere una introduzione al Tractatus. Il fatto che un autore affermato e conosci uto internazionalmente quale era Russell si facesse garante del valore dellopera riusc in effetti a convincere gli editori ad interessarsi al lavoro di Wittgenste in. Il Tractatus (ancora intitolato Logisch-Philosophische Abhandlung) venne cos pubblicato nel 1921 su una rivista tedesca, Annalen der Naturphilosophie, dirett a da W. Ostwald. Ledizione era zeppa di errori tipografici e a Wittgenstein non f u data nemmeno la possibilit di correggere le bozze. Linsoddisfazione di Wittgenst ein crebbe ulteriormente per il fatto che lintroduzione scritta da Russell conten eva gravi fraintendimenti della dottrina esposta nellopera. Finalmente nel 1922 f u pubblicata ledizione inglese, nella traduzione di Frank Ramsey. Il titolo Logis ch-Philosophische Abhandlung fu cambiato in Tractatus logicophilosophicus su pro posta di G. E. Moore, ispiratosi al famoso Tractatus theologico-politicus di Spi noza. Wittgenstein aveva a quel punto gi intrapreso la carriera di maestro elemen tare e continu a tenersi lontano dagli studi logici e filosofici fino alla fine d egli anni Venti (abbandonato linsegnamento egli aveva lavorato come giardiniere i n un convento e successivamente come architetto insieme allamico Paul Engelmann). Egli ritorn a Cambridge solo nel 1929, scoprendo che il Tractatus logico-philoso phicus lo aveva gi da tempo consacrato come uno dei massimi pensatori della scena mondiale. 2. La struttura del libro.Il Tractatus logico-philosophicus si compone di sette proposizioni principali e dei corollari a queste proposizioni, ordinati secondo un sistema di numerazione decimale che serve a mettere in rilievo limportanza di ogni singolo enunciato. Ad esempio, la proposizione 1 pi importante della 1.1 (il cui contenuto presuppone quanto viene affermato nella 1), la quale a sua volta pi importante della 1.11, e tc.. In realt Wittgenstein non rispetta sempre tale criterio e capita pertanto di trovare in posizione subordinata osservazioni degne di maggiore rilievo. Le set te proposizioni fondamentali costituiscono la struttura portante di tutta lopera e la loro sequenza descrive sinteticamente limpianto teorico del Tractatus: 1. Il mondo tutto ci che accade. 2. Ci che accade, il fatto, il sussistere di stati di cose.3. 4. 5. 6. 7. Limmagine logica dei fatti il pensiero. Il pensiero la proposizione munita di sen so. La proposizione una funzione di verit delle proposizioni elementari. La forma generale della funzione di verit : [ , , N( ) ]. Su ci, di cui non si pu parlare, s i deve tacere. Il numero di enunciati subordinati a queste proposizioni di base variabile: la n umero 1 consta ad esempio soltanto di sei corollari, mentre la 5 e la 6 ne conta no diverse decine e la proposizione numero 7 viene presentata senza alcun commen to. Lopera caratterizzata da unarchitettura severa che richiede al lettore un impe gno ed unadesione costanti: Wittgenstein presenta ogni pensiero nella forma di una sserzione che non ammette repliche (Bertrand Russell paragon le proposizioni del Tractatus agli ordini dello Zar) e non si cura molto di argomentare le proprie c onclusioni. Chi sappia collegare le fredde e laconiche osservazioni di Wittgenst ein nel disegno generale dellopera, per, non potr non apprezzare la bellezza essenz iale e priva di fronzoli del Tractatus. La ricerca della chiarezza espressiva se nza alcuna concessione al dettaglio ornamentale e alla decorazione accomunava Wi ttgenstein agli esponenti della nuova architettura viennese come Adolf Loos, sos tenitore di una forma stilistica rigorosa e lineare. Da questo punto di vista, i l Tractatus pu essere considerato come il risultato di un faticoso lavoro di dist illazione del materiale preparatorio mirante a concentrare fino alla sua essenza pi pura il nucleo delle tesi originarie. Preparando la stesura definitiva del li bro per ledizione inglese, Wittgenstein aveva scritto una serie di aggiunte che ( a parte una) non furono poi inserite nella redazione finale. Leditore inglese chi ese a Wittgenstein se fosse possibile inserire tali aggiunte per ampliare (e ren dere pi comprensibile) lopera. Ricevette questa risposta: Le aggiunte sono esattame nte ci che non deve pubblicarsi. E a parte il fatto che non contengono alcuna del ucidazione di sorta, sono ancor meno chiare delle restanti proposizioni. Per qua nto poi riguarda la brevit del libro ne sono veramente costernato: ma cosa posso farci? Se lei mi spremesse come un limone non ne caverebbe nemmeno una goccia. L asciarle stampare le aggiunte sarebbe una cosa irrimediabile. Sarebbe esattament e come se lei andasse da un falegname a ordinare un tavolo e quello glielo faces se troppo corto e allora volesse venderle i trucioli, la segatura e tutti gli al tri scarti unitamente al tavolo per rimediare al fatto che corto. (Piuttosto che pubblicare le aggiunte per ingrassare il libro, si lascino una dozzina di fogli bianchi a disposizione del lettore per riempirli di imprecazioni quando dopo av er comprato il libro non ci capisce nulla.). Questo episodio e molti altri testim oniano il fatto che Wittgenstein considerava la forma del Tractatus, per quanto ardua per il lettore, impossibile da modificare senza stravolgere il messaggio s tesso dellopera. Forma e contenuto del Tractatus devono quindi considerarsi ununit inscindibile: gli insegnamenti che Wittgenstein intendeva comunicare potevano es sere veicolati soltanto nella forma espressiva scelta dallautore. Al di l dellordin e di successione imposto ai singoli enunciati, nella trama del Tractatus si assi ste al costante e regolare riemergere delle idee fondamentali e al loro inquadra mento prospettico secondo una molteplicit di punti di vista differenti. La strutt ura dellopera stata in questo senso paragonata felicemente ad una composizione mu sicale i cui leitmotiv ricompaiono di continuo in sottili modulazioni.[18] Il lett ore si trova cos ripetutamente posto di fronte alle verit essenziali del messaggio r endendosi conto che ogni sentiero del percorso suggerito da Wittgenstein, per qu anto in apparenza tortuoso e divergente dalla strada principale, lo riconduce in fine sempre ad uno stesso scenario di fondo. Lidea di un percorso filosofico che conduca il lettore a vedere la verit del messaggio, un percorso insomma che si limi ti a mostrare e a dischiudere lorizzonte del visibile, era del resto profondamente coerente con lidea che Wittgenstein aveva maturato a proposito del sapere filosof ico: Wittgenstein pensava (ed unidea a cui sarebbe rimasto sempre fedele) che esse ndo la filosofia puramente descrittiva essa non contenga deduzioni. (...) Conforme mente a questa convinzione, il Tractatus non organizzato (almeno in superficie) come una successione di argomentazioni, ma come una sequenza di osservazioni. Lor dine delle osservazioni, e il loro ruolo gerarchico, indicato (almeno in teoria)dal numero scritto a sinistra di ciascuna osservazione, dovrebbe guidare il let tore non lungo un percorso argomentativo, ma piuttosto a vedere come stanno le cos e; cos come si potrebbe pensare di guidare qualcuno a osservare un paesaggio atti rando la sua attenzione prima sui tratti pi salienti, poi sui dettagli (prima su una catena di montagne, poi su ciascuna montagna, poi sui villaggi ai piedi di c iascuna montagna, e cos via). [19] La metafora pi efficace per descrivere il Tracta tus logico-philosophicus forse quella della scala, cui Wittgensteinaccenna nella proposizione 6.54 del testo. I singoli enunciati del Tractatus son o i come i gradini di una scala che il lettore sale fino a raggiungere un punto di vista che gli consente di vedere quanto prima si celava al suo sguardo. Arriv ati al vertice della struttura (cio una volta giunti alla proposizione finale del lopera e assimilata la lezione del libro), ognuno di noi vede rettamente il mondo ( 6.54) ed in grado di agire in esso senza pi il rischio di cadere negli equivoci e negli errori prospettici tramandati dalla tradizione filosofica. Questo modo di considerare il testo ci suggerisce anche quale valore debba essere attribuito a l Tractatus una volta che esso abbia svolto la sua funzione. Nel momento stesso in cui abbiamo raggiunto il livello prospettico adeguato, ci dice Wittgenstein, la scala che ci ha reso possibile lascesa non serve pi a nulla e bisogna perci disf arsene senza rimpianti. Perch il Tractatus logico-philosophicus servito a mostrar ci e indicarci la strada da percorrere ed esaurisce il suo compito una volta che noi, i lettori, ci siamo incamminati nella direzione giusta. Continuare a fissa re i nostri sguardi sul libro equivarrebbe ripetere lerrore di quello sciocco cui veniva indicata la luna e che invece di guardare in direzione del cielo concent rava la sua attenzione sul dito teso del suo interlocutore. 3. Note alla presente edizione. Per il Tractatus logico-philosophicus, i Quaderni 1914-1916 e le Note sulla logi ca e ci siamo rifatti alla traduzione di Amedeo G. Conte (Einaudi editore, 1987, terza ristampa; il testo contiene anche alcuni Estratti da lettere a B. Russell ). Il testo che presentiamo si articola in due sezioni alternate luna allaltra: le Note al Tractatus (numerate secondo lordine progressivo delle proposizioni origi nali di Wittgenstein), indicate da un quadratino blu, e le Schede di commento, i ndicate da un quadratino rosso. Riguardo alle Note al Tractatus, va segnalato ch e la divisione del testo in capitoli e i titoli di questi dipendono da una scelt a arbitraria dellautore e rispondono unicamente allesigenza di fornire un percorso di lettura dellopera di Wittgenstein quanto pi schematico e chiaro possibile. Ogn i nota presentata in questa sezione un commento alla corrispondente proposizione del Tractatus, con rimandi ad altri luoghi dellopera di Wittgenstein o a interve nti di altri autori. Non vengono commentate tutte le proposizioni originali del Tractatus, ma soltanto quelle che lautore del presente libro ha ritenuto funziona li allo sviluppo del proprio percorso di lettura, n vengono segnalati i tagli app ortati al testo originale di Wittgenstein (alcune delle proposizioni omesse poss ono tuttavia essere citate in altre Note di commento o nelle Schede di lettura). Lestensione relativa delle varie note dipende unicamente dalle scelte espositive del commentatore e non deve pertanto esser considerata proporzionale allimportan za delle corrispondenti proposizioni del Tractatus. Per semplificare il sistema delle citazioni, i testi vengono indicati con il nome dellautore seguito dal nume ro della pagina o, nel caso della maggior parte delle opere di Wittgenstein, da una sigla seguita dal numero della pagina (le proposizioni del Tractatus sono in dicate semplicemente dal loro numero). Si rimanda alla nota bibliografica per ma ggiori dettagli. Le Schede di lettura hanno lo scopo di presentare in forma unit aria i temi fondamentali che emergono di volta in volta dal testo del Tractatus. Per consentire uno sviluppo progressivo del percorso di studio sono stati limit ati al massimo, ove possibile, i rimandi in avanti, ovvero si cercato di impostare ogni Scheda come un riassunto schematico ed un approfondimento dei problemi gi a nalizzati nella sezione delle Note al Tractatus. Il lettore si accorger che alcun i temi e problemi tornano a presentarsi in forma pi o meno modificata in diversi luoghi delle Schede e delle Note: ci inevitabile dato che il testo originale di W ittgenstein, come s detto, caratterizzato dal continuo riaffiorare dei medesimi ar gomenti e dalla loro discussione alla luce dei risultati via via raggiunti. Per facilitare la lettura abbiamo limitato al massimo luso dei simboli logici, sostit uendoli ove possibile con espressioni della lingua naturale e fornendo comunque la traduzione di ogni espressione simbolica introdotta nel testo. [1] In: Monk 45. [2] In: Monk 46. [3] In: Kenny 14. [4] In: Monk 50. [5] In: Mon k 49. [6] Pinsent, 107. [7] In: Monk 98. [8] In: Monk 101. [9] Ibidem. [10] In: Monk 108-109. [11] In: Monk 103.[12] Monk 118. [13] Monk 269. [14] In: Monk 190. [15] In: Monk 182. [16] In: Mon k 182-183. [17] In. Monk 183. [18] Black 12. Wittgenstein era dotato di grande s ensibilit per la musica. Nella casa dei Wittgenstein a Vienna erano spesso ospita ti compositori di fama come Mendellshon e Brahms. C persino una somiglianza di fami glia tra le strutture logiche, i motivi e le intenzioni del Tractatus e quelli d ella teoria musicale di Schnberg: perch anche Schnberg guidato dalla convinzione ch e il linguaggio attraverso cui egli si esprime, la musica, deve essere innalzato a d un grado di necessit logica tale che eliminerebbe tutti gli incidenti soggettiv i (E. Heller in: Bouveresse 21). [19] Marconi 1997, 18 n. 9.Scheda 1: La Prefazione di Wittgenstein Le finalit del Tractatus. Se gli avessero chiesto in qualunque momento, mentre compilava trattati di geomet ria o di logica matematica, oppure di scienze naturali, quale scopo egli si prop onesse, avrebbe risposto che un solo problema valeva veramente la pena di essere meditato, e cio quello del vivere giusto. (R. Musil, Luomo senza qualit, p. 246) Ne lla Prefazione al Tractatus, Wittgenstein espone per sommi capi le finalit dellope ra. Innanzitutto, il libro intende chiarire in modo esaustivo (la teoria esposta infatti definita intangibile e definitiva) che i problemi filosofici nascono da u n uso errato del linguaggio: la definizione esatta delle regole logiche che gove rnano gli enunciati della lingua servir pertanto a stabilire quale sia luso sensat o delle nostre proposizioni e, nel contempo, quale sia il limite invalicabile de l linguaggio (al di l di questo limite tutto sar nonsenso). Wittgenstein, pur dich iarando di non essere interessato al fatto che altri filosofi possano aver gi dis cusso tesi comprese nel Tractatus, si riconosce debitore nei confronti di Frege e di Russell per i loro studi innovatori nel campo della logica. Questo non vuol dire che il pensiero di Wittgenstein non sia stato influenzato, come mostreremo di volta in volta, da altri pensatori; comunque un dato di fatto che Wittgenste in non ebbe una vera e propria formazione filosofica (studi infatti ingegneria e si accost relativamente tardi alla filosofia) e che al tempo della stesura del Tr actatus egli considerava la logica come lunica chiave per risolvere i problemi fi losofici. Il senso generale del Tractatus, secondo lautore, sintetizzabile in que sta breve affermazione: Quanto pu dirsi, si pu dir chiaro; e su ci, di cui non si pu parlare, si deve tacere. Visto che questo pensiero sar ribadito nella proposizione finale (la numero 7), si pu dire che Wittgenstein saldi ad anello linizio e la co nclusione del Tractatus per far meglio risaltare linsegnamento fondamentale dellop era. Indagata la natura e le condizioni del linguaggio, Wittgenstein mostrer che lunico uso sensato delle nostre proposizioni quello descrittivo: gli enunciati de lla lingua sono raffigurazioni di fatti e finch si user il linguaggio per comunica re contenuti rappresentativi sar possibile esprimersi in modo corretto. Lambito di quel che si pu dir chiaro, dunque, corrisponde senza riserve allambito della descri zione di fatti: ne consegue che solo le proposizioni della scienza naturale rien trano a pieno diritto nella sfera delle proposizioni dotate di senso (cfr. 6.53) . I problemi di cui si occupa la filosofia non possono invece essere formulati i n proposizioni sensate perch tendono a proiettare il soggetto conoscitivo oltre l a sfera dei fatti. Cos, quando la metafisica si interroga sui fondamenti del mond o fenomenico chiamando in causa concetti quali Essere, Anima, Essenza, etc., assistiam o alla pretesa di usare il linguaggio in senso non naturale (cio non descrittivo) con lunica conseguenza di creare fraintendimenti e nonsensi; e lo stesso accade quando in campo morale si pretende di indagare questioni come il Valore o il sig nificato dellesistenza. Questordine di problemi, facendo riferimento ad un livello di realt sganciato dallambito dei fatti, non pu essere contenuto in parole signifi canti e va perci consegnato al silenzio (su ci di cui non si pu parlare si deve app unto tacere). Wittgenstein giunge a questa radicale conclusione al termine di uni ndagine volta a stabilire le condizioni ed i limiti di quanto pensabile ed espri mibile. Questa impostazione stata spesso accostata al problema critico affrontat o da Kant nella Critica della ragion pura. Vi sono in effetti molte analogie tra lindagine di Kant e quella di Wittgenstein (ad esempio, entrambi sottolineano il valore dellesperienza ed escludono che la metafisica possieda lo status di scien za); tuttavia, nella Prefazione al Tractatus contenuta una precisazione polemica che colpisce un aspetto essenziale della concezione di kantiana. Kant aveva dis tinto tra lambito del fenomeno (inteso come il risultato del mio modo a priori di conoscere) e quello del noumeno (o cosa in s, esistente fuori di noi ma inconosc ibile). La cosa in s era considerata da Kant come un pensiero vuoto (nel senso che non poteva esserle fatta corrispondere unintuizione sensibile), ma la sua esisten za doveva tuttavia essere correlata a quella del fenomeno al fine di stabilire i l principio dellindipendenza della realt in s dal pensiero ed evitare cos il rischio d i scivolare in una posizione compiutamente idealista. Il noumeno, ponendosi al d i fuori del raggio della nostra conoscenza, chiamava cos in causa il limite della facolt conoscitiva. Dato che la conoscenza umana pu applicarsi soltanto al campo dei fenomeni, Kant, nella Dialettica trascendentale, sottoponeva ad una criticaserrata ogni tentativo di estendere la nostra conoscenza oltre i suoi limiti nat urali allo scopo di illuminare il livello noumenico della realt. Wittgenstein acc etta la tesi secondo la quale impossibile conoscere quanto si trova oltre il lim ite della conoscenza, ma ritiene che la posizione kantiana contenga una contradd izione. Quando Kant si esprime riguardo alla pensabilit del noumeno, infatti, avv iene proprio quello sconfinamento in direzione dellimpensabile che avevamo dichia rato illecito. Il limite un concetto di natura spaziale ed inevitabilmente legat o alla distinzione tra un luogo interno ed un luogo esterno: ogni volta che delimiti amo uno spazio per mezzo di un linea, in altri termini, quel che otteniamo una s eparazione tra ci che allinterno del limite e ci che si trova fuori di esso. Spinoz a spiegava a questo proposito che nessuno pu concepire i limiti di una qualche est ensione o spazio senza concepire oltre essi altri spazi che lo seguano immediata mente.[1] Se lidea di limite chiama in causa automaticamente lidea di un luogo ester no, ne consegue che non possibiletracciare un limite al pensiero: infatti, questa pretesa metterebbe subito capo alla situazione assurda di concepire quel che per definizione dovrebbe porsi al di fuori di ogni possibile pensiero (ne appunto un esempio il noumeno kantiano, come gi prima di Wittgenstein avevano rilevato i filosofi idealisti). Per tracciar e al pensiero un limite osserva Wittgenstein nella Prefazione al Tractatus- dovr emmo poter pensare ambo i lati di questo limite (dovremmo dunque poter pensare q uel che pensare non si pu). Per superare questa contraddizione, Wittgenstein si pr opone di tracciare un limite non al pensiero bens allespressione dei pensieri, rei mpostando cos il problema kantiano da un punto di vista strettamente linguistico (di qui la distinzione tra ci che pu essere espresso in modo sensato e ci che non p u trovare posto nel linguaggio). Quel confine che Kant aveva stabilito in rapport o ad un elemento (il noumeno) esterno alla facolt conoscitiva deve dunque essere cercato procedendo dallinterno del linguaggio, tentando di delimitare limpensabile dal di dentro attraverso il pensabile (4.114). Il limite del linguaggio non pu ess ere concretizzato al modo di un confine spaziale perch cos facendo evocheremmo imm ediatamente anche ci che si trova oltre esso (e ci troveremmo, come Kant, a parla re di quanto non possibile esprimere). Ci comporta in un certo senso lo sparire del limite, cio la sua trascendenza rispetto al campo prospettico della conoscenza u mana. Il campo visivo dellocchio risulta di fatto senza limiti perch locchio non pu coglierne il margine estremo (cfr. 6.4311); allo stesso modo, i limiti del lingu aggio non possono essere descritti allinterno del linguaggio stesso e finiscono p erci per assomigliare ad un orizzonte irraggiungibile ed invalicabile. Tutto ci ch e dobbiamo e possiamo fare, al fine di chiarire i limiti dellespressione sensata, si riduce perci a rappresentare chiaramente il dicibile (4.115). Luomo, per cos di re, si muove sempre nel linguaggio senza possibilit di trascenderlo in direzione di un impensabile al di fuori: quel che non si pu dire deve rimanere assolutamente inesprimibile, e non c modo di aggirare il divieto (di qui la costante preoccupazi one, da parte di Wittgenstein, di escludere ogni prospettiva che possa generare lillusione di poter trascendere il linguaggio). Se il tentativo di Wittgenstein p ossa dirsi riuscito e se la delimitazione dallinterno sia esente dalle contraddizio ni che si intendeva scansare sono questioni che prematuro sollevare. Per valutar e la complessit della posizione di Wittgenstein basta pensare che egli sottoline s pesso limportanza fondamentale proprio di quanto risulta indicibile. Parlando del T ractatus, ad esempio, Wittgenstein scrisse: Il mio lavoro si compone di due parti : ci che ho scritto; pi tutto ci che non ho scritto. E proprio questa seconda parte importante (in: Monk, 182). Quel che nel Tractatus chiamato il mistico o letico, p quanto inesprimibile, ci che pi stava a cuore al filosofo viennese perch a tale liv ello trascendente legata la possibilit di comprendere il mistero dellesistenza. E proprio in ci risiede la differenza tra Wittgenstein ed i filosofi del Circolo di Vienna, i quali si richiamarono spesso alla lezione del Tractatus. Paul Engelma nn osserv a questo riguardo: Il Positivismo sostiene, e questa la sua essenza, che ci che conta nella vita ci di cui possiamo parlare, mentre Wittgenstein crede app assionatamente che ci che conta veramente nella vita umana proprio quello di cui, dal suo punto di vista, si deve tacere. Quando, con immensi sforzi, [Wittgenste in] delimita ci che non importante (e cio gli scopi e i limiti del linguaggio ordi nario), non sta misurando le coste dellisola che esplora con tanta meticolosit, ma i confini delloceano (in: Janik/Toulmin, 193). Il rigore dellanalisi di Wittgenste in, insomma, si accompagna alla continua tensione verso ci che per natura si sott rae alle capacit definitorie ed espressive del linguaggio. In questa associazione di volont di chiarezza e di aspirazione al trascendente, Wittgenstein rivela una s tretta affinit con le idee dello scrittore viennese Robert Musil, autore de Luomo senza qualit. Sia Wittgenstein che Musil sono dominati (come notava Cesare Cases) dallesigenza di servirsi del lavoro analitico della ragione e di spingerlo fino a l punto in cui appaiono i contorni del paese della trascendenza (Introduzione a Lu omo senza qualit, XXI). Ulrich, il protagonista del romanzo di Musil, oscilla di continuo tra due differenti impulsi: il primo rivolto allesattezza, alla precisio ne, allanalisi rigorosa della realt secondo schemi logico-matematici ed alla verif ica empirica propria delle scienze fisiche; il secondo impulso mira invece alle verit superiori, non traducibili in parole, determinando una continua tensione a scavalcare il livello empirico dei fatti al fine di cogliere il senso profondo che si cela dietro lapparenza fenomenica. Come per Ulrich, cos anche in Wittgenstei n convivono due pulsioni apparentemente incompatibili verso la logica e verso il misticismo; e lesigenza dellordine e dellesattezza, anzich annullare la tensione mi stica, finisce proprio per evocarla come suo naturale complemento. Certo, il lin guaggio non consente di penetrare nella regione del trascendente, ovvero, ripren dendo lesempio di Engelmann, il filosofo non pu abbandonare lisola di cui prigionie ro (leggi: lambito delle proposizioni dotate di senso) per intraprendere lesploraz ione delloceano (leggi: lambito del valore, inesprimibile). Se si comprende ci, si sono risolti dun colpo i problemi filosofici semplicemente annullandoli come prob lemi (cfr. 6.52 e 6.521). Allo stesso tempo, per, nota Wittgenstein nelle ultime righe della sua Prefazione, manifesto quanto poco sia fatto dallesser questi probl emi risolti, ovvero: quanto rimanga da fare sul piano etico per diventare persone degne una volta riconosciuto che certe risposte fondamentali non possono essere trovate allinterno del linguaggio e per mezzo di esso. Nella proposizione 6.52 l eggiamo: Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scienti fiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppur tocc ati. Vestendo i panni del logico, Wittgenstein pu affermare di aver guadagnato la via duscita per sottrarsi a problemi che per loro natura sono insolubili. Ma per luomo Wittgenstein, per il filosofo, lincapacit di impostare una soluzione sensata dei problemi fondamentali dellesistenza suona come uno scacco e rivela il dramma di un pensatore che continuava a ritenere quei problemi come gli unici ad avere realmente valore.[1] B. Spinoza, Principi della filosofia cartesiana, Torino, p. 164.Note al Tractatus IL MONDO (1 1.21) 1. Il Mondo (o realt, 2.063) costituito da tutto ci che accade. Dato che ci he accade sono i fatti (2), il mondo costituito dalla totalit dei fatti (1.1). 1.1 . Il mondo non si compone di cose ma di fatti. Un fatto, ovvero ci che accade, il su ssistere di stati di cose (2). Lo stato di cose poi definito come un nesso di ogge tti (Enti, cose) (2.01). Il mondo dunque costituito di oggetti combinati tra loro e non di oggetti isolati. Loggetto unentit semplice, mentre un fatto unentit comple sa. E opportuno rilevare fin dora che mentre i fatti sono indipendenti luno dallaltr o (1.21, 2.061, e 5.135), gli oggetti risultano sempre combinati con altri ogget ti (2.011). 1.11. Il mondo come aggregato di fatti lorizzonte che racchiude tutto ci che accade e perci non ammesso alcun altro livello di realt oltre a questo: non vi sono fatti extra-empirici. Il mondo costituito da tutti i fatti, ma non c un su per-fatto (o fatto di ordine superiore) per cui non ci sono pi fatti (Black 44). 1 .12. Linsieme dei fatti di cui si compone il mondo costituisce la totalit di ci che esiste (accade) e, allo stesso tempo, determina anche tutto quel che non accade nel mondo. Pi avanti Wittgenstein ribadir che il mondo la totalit degli stati di c ose sussistenti (2.04) e che questa totalit determina anche quali stati di cose n on sussistono (2.05). Se so ci che sussiste nel mondo, ad esempio il fatto che il libro sul tavolo, allora io so anche quel che nel mondo non sussiste (ovvero so che il libro non si trova sul pavimento, oppure sul divano etc.). Tali possibil it non sussistenti saranno definite da Wittgenstein fatti negativi 1.13. Lo spazio logico contiene tutti i fatti possibili (cos come lo spazio fisico contiene virtualm ente tutti gli oggetti spaziali). Affermare che il mondo costituito dai fatti nel lo spazio logico significa dunque che per mondo si pu intendere sia linsieme dei fat ti esistenti in atto, sia linsieme di tutti i fatti possibili. Nel mondo, conside rato identico allo spazio logico, troviamo dunque sia i fatti esistenti (i fatti positivi) che i fatti non esistenti (i fatti negativi). Sulla duplicit di signif icato del termine mondo, v. nota alla 2.06. 1.21. Cfr. 2.062: Dal sussistere o non sussistere di uno stato di cose non pu concludersi al sussistere o non sussistere dun altro. Wittgenstein sostiene lindipendenza reciproca degli stati di cose (o fa tti elementari): Gli stati di cose sono indipendenti luno dallaltro (2.061). Pertant o, dallaccadere di un certo stato di cose non pu inferirsi che un altro stato di c ose si verifichi o meno. Su queste basi, Wittgenstein rifiuter di attribuire un f ondamento al nesso causale (il quale presuppone appunto un legame necessario tra due accadimenti, cfr. 6.37). I fatti di cui si compone il mondo sono tutti cont ingenti: non sussistono tra essi relazioni necessarie. Lunica necessit ammessa da Wittgenstein quella logica (6.37), mentre tutto ci che vediamo e che possiamo des crivere potrebbe essere altrimenti (5.634).Note al Tractatus OGGETTI, STATI DI COSE E FATTI (2 2.062) 2. Il mondo si compone di fatti e ogni fatto (in tedesco: Tatsache) si compone di stati cose. Stato di cose corrisponde al termine tedesco Sachverhalt, che pu essere anche tradotto con lespressione fatto atomico o fatto elementare. Lo sta to di cose lunit complessa minima di cui si compone il mondo. Gli stati di cose so no prodotti dalla combinazione di oggetti (2.01). Pi stati di cose si possono com binare dando origine ad un Tatsache, che potremmo pertanto anche tradurre con les pressione fatto complesso. Ad esempio, dalla combinazione degli oggetti: penna, tavol o, si produce lo stato di cose: La penna sul tavolo; dalla combinazione di due stat i di cose si produce poi un fatto (ad esempio: La penna sul tavolo e il libro sul tappeto). Lontologia del Tractatus si pu riassumere schematicamente cos: oggetti = entit semplici; una combinazione di oggetti = uno stato di cose; una combinazione di pi stati di cose = un fatto; la totalit dei fatti = la totalit di ci che accade = il mondo. 2.01. Lo stato di cose una configurazione o connessione di oggetti. Sappiamo che il mondo costituito di fatti, e non di cose (1.1). Le cose (oggetti ) non esistono isolatamente le une dalle altre ma si combinano insieme formando gli stati di cose. Nello stato di cose gli oggetti sono in relazione reciproca ( 2.031) come le maglie di una catena (2.03). 2.011. Un oggetto , essenzialmente, un possibile costituente di uno stato di cose (Kenny, 92). Mentre i fatti sono reci procamente indipendenti, gli oggetti, il cui nesso d origine allo stato di cose, sono sempre inseriti in un contesto (ovvero sono sempre legati luno allaltro nella struttura del fatto elementare). La possibilit di occorrere in stati di cose con tenuta nelloggetto cos come un elemento chimico contiene virtualmente tutte le sue possibili combinazioni con altri elementi, e non possiamo concepire alcun ogget to fuori della sua possibilit di essere collegato ad altri oggetti (2.0121). Ques ta tesi pu essere considerata affine a quella di Leibniz secondo cui la cosa, il s oggetto deve contenere tutti i suoi possibili predicati (Vanni Rovighi, 541). La propriet di combinarsi reciprocamente per costituire un complesso propria anche d ei nomi, i quali hanno la funzione di indicare gli oggetti (3.3). 2.012. La logi ca lambito delle verit necessarie e fuori della logica tutto accidente (6.3). La pos sibilit di entrare in connessione con altri oggetti una propriet logica (essenziale) delloggetto e come tale necessariamente connessa al suo esistere. 2.0121. Cfr. 2 .013: Ogni cosa in un uno spazio di possibili stati di cose. Dato che un oggetto d eve necessariamente entrare in combinazione con altri (2.011), e dato che ci dipe nde dalle propriet logiche delloggetto, posso dire che con gli oggetti dato linsiem e di tutte le loro possibili relazioni: questa rete di relazioni virtuali la chi amer spazio logico. Cos come un oggetto spaziale non pu essere concepito fuori dello spazio, e un oggetto temporale fuori del tempo, allo stesso modo nessun oggetto pu concepirsi fuori dello spazio logico, vale a dire indipendentemente dalla poss ibilit di un nesso con altri oggetti. Quella che abbiamo appena enunciato una ver it logica, e dunque necessaria a priori. Non invece una questione logica, ma rien tra nel campo delle verit contingenti, indicare quali combinazioni di oggetti sus sistano effettivamente nella realt (cos come una questione empirica sapere quale p orzione dello spazio fisico un oggetto spaziale occupi effettivamente). Alla log ica compete la descrizione di tutte le possibilit di combinazione, le quali sono determinabili a priori e valgono indipendentemente dalle configurazioni empirich e sussistenti di fatto nel mondo. 2.0122. Solo astrattamente si pu considerare un oggetto separato dal suo nesso con gli altri: anche se un oggetto pu non trovars i inserito in un particolare nesso empirico (in questo senso si manifesta la sua indipendenza), tuttavia impensabile che esso sia sganciato da ogni contesto pos sibile (e qui viene in luce il suo essere dipendente). Allo stesso modo, un nome (la cui funzione indicare un oggetto) devessere sempre inserito nel contesto del la proposizione: il nome pu occorrere in diverse proposizioni, ma da solo non pu s tare. Cfr: 3.3: Solo la proposizione ha senso; solo nella connessione della propo sizione un nome ha significato. 2.01231. Le propriet interne delloggetto corrispond ono alle possibilit logiche delloggetto di combinarsi conaltri per formare uno stato di cose (cfr. 2.011); le propriet esterne delloggetto corrispondono invece alle sue relazioni con altri in un singolo stato di cose es istente. Stabilendo unanalogia con il gioco degli scacchi, che una torre possa mu oversi in orizzontale e verticale dipende dalle propriet interne di quel pezzo; c he una certa torre si trovi sulla casella a2, e dunque sia in una determinata re lazione con i pezzi circostanti, invece una propriet esterna di quel pezzo. Si pu dire che in base alle propriet interne delloggetto posso fare affermazioni necessa rie a priori, mentre le propriet esterne sono contingenti e determinabili solo em piricamente. Conoscere un oggetto significa conoscerne le propriet interne, ovver o le propriet essenziali: ad esempio, conoscere una torre significa sapere quali sono le sue possibilit logiche (cio come essa pu muoversi sulla scacchiera, il che ci consente di prevedere in quali combinazioni essa pu trovarsi). Viene cos confer mato che conoscere un oggetto vuol dire conoscere tutte le possibilit del suo occo rrere in stati di cose ( 2.0123). 2.0124. Dato che ogni oggetto contiene in s tutt e le sue possibili combinazioni con altri oggetti (ovvero, ogni oggetto contiene la possibilit di tutti gli stati di cose in cui pu occorrere), allora se sono dat i tutti gli oggetti sono con ci dati anche tutti i possibili stati di cose. 2.013 . Cfr. 2.0121. Come una macchia non pu non avere un colore ed un suono non pu non essere caratterizzato da unaltezza (2.0131), cos loggetto in generale non pu non tro varsi in combinazione con altri. Un oggetto dunque idealmente inserito in uno sp azio di relazioni possibili e se da una parte posso concepire tale spazio come v uoto, dallaltra non posso pensare un oggetto fuori dello spazio. Largomentazione d i Wittgenstein ricorda un passaggio della Critica della ragion pura kantiana: Noi non possiamo mai rappresentarci lassenza dello spazio, bench possiamo benissimo p ensarlo vuoto degli oggetti (Estetica Trasc., I, 2). 2.0131. S detto che risulta in concepibile che un oggetto spaziale non occupi una porzione di spazio: v pertanto una somiglianza tra il luogo spaziale e la x che compare in una funzione, la quale rappresenta un luogo in cui pu trovar posto un argomento. E ugualmente inconcepibil e, aggiunge Wittgenstein, che un oggetto cromatico non abbia un colore, o che un suono non possieda unaltezza, etc.. Loggetto in generale deve perci essere inserit o in un reticolo di combinazioni possibili con altri oggetti. 2.0141. Riassumend o le indicazioni fin qui fornite da Wittgenstein, si pu affermare che la possibil it delloggetto di entrare in relazione con gli altri oggetti rappresenta la sua es senza (2.011) o natura (2.0123), le sue propriet interne (2.01231) e la sua forma (2.0141). Wittgenstein assume pertanto questi termini come equivalenti: essenza = natura = propriet interne = forma. E chiaro che egli considera la forma logica d i un oggetto alla stregua della capacit o facolt di combinarsi con altri oggetti i n fatti atomici: gli oggetti hanno forme logiche diverse quando hanno diverse po ssibilit di associazione (Black, 62). 2.02. Cfr. 2.021: dato che gli oggetti sono la sostanza del mondo, essi devono essere semplici. La posizione di Wittgenstein pu essere confrontata con lanaloga tesi di Leibniz sulla semplicit della monade: La monade di cui parleremo qui non altro che una sostanza semplice, che entra nei composti; semplice, cio senza parti. E bisogna che vi siano sostanze semplici, da to che ci sono composti; poich il composto non altro che un ammasso o aggregato d i semplici (Leibniz, Monadologia, 1, 2 ). Gli oggetti sono le entit semplici la cui aggregazione d vita agli stati di cose. Cfr. Kant (Critica della ragion pura, Di al. Trasc., Secondo conflitto delle idee t.): Se si ammettesse che le sostanze co mposte non constino di parti semplici, sopprimendo nel pensiero ogni composizion e, non resterebbe nessuna parte composta, e (non essendoci parti semplici) nessu na parte semplice, quindi assolutamente niente, e per conseguenza nessuna sostan za sarebbe data. 2.0201. La relazione di isomorfismo sussistente tra struttura de lla realt e struttura della lingua consente a Wittgenstein di deviare bruscamente il discorso dal piano ontologico a quello linguistico. Ogni complesso pu essere scomposto finch non siano raggiunti i suoi elementi costitutivi semplici. Ci vale, livello ontologico, riguardo agli stati di cose (entit complesse costituite di c ose) e, a livello linguistico, riguardo alle proposizioni elementari (entit compl esse costituite di nomi). Wittgenstein presenta per la prima volta lidea di analis i della proposizione quale strumento per svelare la struttura degli enunciati (cf r. 3.201 e 3.25). Tale idea rivela uninfluenza di Bertrand Russell, al quale Witt genstein fa esplicito riferimento nella 4.0031. 2.021. Gli oggetti sono la sostanza del mondo: in quanto tali essi devono risultare semplici, cio non scomponibil i in parti minori, ed immutabili. La nozione classica di sostanza presuppone appun to la stabilit e la permanenza (cfr. 2.023 e 2.026: gli oggetti sono la forma fiss a del mondo). Ci che nel mondo muta sono le configurazioni degli oggetti, ovvero l e loro diverse combinazioni, ma gli oggetti sono entit fisse e sussistenti [per s] (2. 027,2.0271). Cfr. 2.024: La sostanza ci che sussiste indipendemente da ci che accade. 2. 0211. Cfr. quanto discusso pi avanti nella Scheda 2. Se, per assurdo, il mondo no n avesse sostanza, allora ad un nome corrisponderebbe non un oggetto semplice, m a una molteplicit infinita di parti. Il senso della proposizione Lorologio nel cass etto dipenderebbe allora dal fatto che abbiamo stabilito la verit di una serie di altri enunciati che asseriscono lesistenza di ogni componente dellorologio. Dato c he la serie dei costituenti di ogni oggetto fisico verosimilmente infinita, sare bbe evidentemente impossibile progettare unimmagine (vera o falsa) del mondo (2.0 212), cio sarebbe impossibile asserire alcunch riguardo al mondo. 2.023. Ogni mond o possibile (anche qualora volessimo immaginarlo differente dal mondo della nost ra esperienza) deve avere una sostanza: questa rappresentata dagli oggetti. Gli oggetti costituiscono la forma fissa del mondo, ovvero una caratteristica immutabi le della realt stessa. In altri termini, gli oggetti come sostanza o forma della re alt sono le condizioni di pensabilit del mondo. Cfr. Kenny 93: Gli oggetti non sono generabili e sono indistruttibili: ogni possibile mondo, infatti, deve contener e gli stessi oggetti di questo. 2.0231. Per propriet materiali si devono intendere l e caratteristiche empiriche degli stati di cose esistenti. Esse sono contingenti e mutevoli (non necessarie), e pertanto vanno intese in opposizione alle propri et interne o formali (necessarie a priori). La sostanza del mondo (gli oggetti) deter mina necessariamente soltanto la forma della realt (ovvero linsieme delle relazion i possibili, che vale necessariamente a priori e dipende dalle propriet interne d egli oggetti) ma non determina quali stati di cose sussistono poi effettivamente in atto (il che costituisce una questione empirica). Le propriet materiali, ovvero gli stati di cose esistenti, sono descritti dalle proposizioni del linguaggio. 2.0232. Gli oggetti sono incolori, cio: ogni propriet [materiale, esterna], ogni col ore attribuito agli oggetti dalla proposizione, dal trovarsi gli oggetti in uno s tato di cose (Vanni Rovighi, 541). 2.024. Wittgenstein accetta la classica defini zione della sostanza come fondamento immutabile della realt. Quel che muta nella realt sono le caratteristiche accidentali, mentre lessenza permane sempre uguale a se stessa. Gli oggetti, quali sostanza del mondo, sussistono indipendentemente da ci che accade, indipendentemente cio dalle loro configurazioni empiriche (stati di cose e fatti), le quali costituiscono lelemento accidentale della realt. Cfr. 2.0271: loggetto ci che sussiste come fisso, mentre la configurazione variabile e incostante. 2.025. Riassumendo quanto viene detto nelle proposizioni precedenti: gli oggetti rappresentano la sostanza (2.021), la forma fissa e immutabile (2.0 23) e il contenuto (2.025) del mondo. Considerati come i fattori determinanti dei fatti atomici in cui possono presentarsi, gli oggetti hanno ciascuno la sua pro pria forma e tutti insieme costituiscono sotto questo rispetto la forma del mond o. Ma gli oggetti sono anche il materiale che costituisce i fatti (Black, 70). Pe rci gli oggetti sono sia forma che contenuto del mondo. 2.0272. Lo stato di cose o fatto atomico (elementare) unentit complessa formata da una combinazione di ogge tti. Cfr. 2.01: Lo stato di cose un nesso doggetti (Enti, cose). 2.03. Nello stato di cose gli oggetti sono connessi secondo un ordine logico: in questo senso, uno stato di cose non un miscuglio di oggetti (cfr. 3.141), ma una relazione determin ata da regole. Una catena non pu essere costruita senza tener conto dellordine che deve sussistere tra i suoi elementi costitutivi. 2.032. La struttura di uno sta to di cose il modo in cui gli oggetti sono connessi luno con laltro. Cfr. 2.15: la struttura di unentit complessa (stato di cose o immagine) il modo della connessio ne dei suoi elementi costitutivi. 2.033. La forma delloggetto la sua possibilit di occorrere in stati di cose (2.0141). La forma di un oggetto pertanto ci che rende possibile lesistere di una struttura: , appunto, la possibilit della struttura. 2.034 . Cfr. 2: un fatto (Tatsache) il sussistere di stati cose (Sachverhalte). Ogni f atto unentit complessa costituita di stati di cose (che a loro volta sono entit com plesse costituite di oggetti). La struttura di un fatto dunque determinata dalle strutture degli stati di cose che lo compongono. 2.04. Wittgenstein riprende or a lanalisi del concetto di mondo. Se Il mondo tutto ci che accade (1) e ciche accade, il fatto, il sussistere di stati di cose(2), allora il mondo linsieme di tutti gli stati di cose sussistenti. 2.05. Ma linsieme dei fatti sussistenti d etermina anche linsieme dei fatti che non sussistono. Cfr. 1.12: Ch la totalit dei f atti determina ci che accade, ed anche tutto ci che non accade. Sapendo tutto ci che esiste come fatto nel mondo sono in grado di dire anche tutto quanto non esiste n el mondo. I fatti che non sussistono sono definiti fatti negativi (2.06). 2.06. Da to che realt equivale a mondo (2.063), il mondo si compone sia di fatti positivi (cio di stati di cose sussistenti) che di fatti negativi (cio di stati cose non sussis tenti). Questa affermazione di Wittgenstein contrasta con la 2.04, secondo la qu ale il mondo la totalit degli stati di cose sussistenti. Probabilmente Wittgenstein intende qui per mondo linsieme di tutti i fatti possibili, sia quelli esistenti in atto nella realt empirica (i fatti positivi) sia quelli che non si sono realizza ti (i fatti negativi). Nella 1.13 Wittgenstein aveva appunto identificato il mon do con lo spazio logico. Nello spazio logico compreso ogni fatto che ha possibil it di realizzarsi. E in questo senso che il mondo si compone di fatti positivi e d i fatti negativi. Il termine mondo, dunque, ha due valenze: da un lato, esso la to talit dei fatti sussistenti (1 + 2 + 2.04), e quando parliamo del mondo in questo senso ci riferiamo quindi allinsieme dei fatti positivi riscontrabili empiricame nte; in un senso pi ampio, il mondo anche lorizzonte di tutte le possibilit (1.13 + 2 .06): quando parliamo del mondo in questa accezione ci riferiamo alla totalit deg li stati di cose possibili, e in esso troviamo sia fatti positivi che fatti nega tivi. 2.061. Gli stati di cose sono caratterizzati dalla reciproca indipendenza. Cfr. 1.21: Una cosa pu accadere o non accadere e tutto laltro restare eguale. Dallac cadere di un determinato stato di cose non pu essere inferito laccadere o non acca dere di uno stato di cose diverso (2.062). Non sussistendo relazioni necessarie tra gli accadimenti, il livello dei fatti caratterizzato da unassoluta contingenz a. 2.062. Non vi sono, tra due stati di cose, relazioni di tipo logico che conse ntano di derivare luno dallaltro. Cfr. 5.135: In nessun modo pu concludersi dal suss istere duna qualsiasi situazione al sussistere duna situazione affatto diversa da essa.Scheda 2: Gli oggetti semplici. Il limite la legge del mondo manifestato Simone Weil, Quaderni, I, p. 322. Dopo aver affermato che il mondo un aggregato di fatti, che i fatti sono costitu iti dal sussistere di stati di cose e che gli stati di cose sono combinazioni di oggetti, Wittgenstein postula come necessaria la semplicit degli oggetti (2.02). Nella 2.021 egli afferma che gli oggetti sono la sostanza del mondo e che per que sto motivo essi non sono concepibili come aggregati di parti. Wittgenstein non e sita dunque a servirsi della nozione metafisica di sostanza come fondamento ultimo , limite che non possibile oltrepassare e che perci rappresenta il livello di rea lt cui ogni divisione deve infine metter capo. Lanalisi della posizione di Wittgen stein complicata dal fatto che egli non forn mai esempi di oggetti semplici, n rit enne che ci costituisse un limite della sua teoria. Vi sono anzi nellimpianto teor ico del Tractatus precise regole restrittive che impediscono di formulare esempi concreti di oggetti semplici (cfr. 3.221, 4.1272); una proposizione che asseris se: Questo un oggetto dovrebbe essere respinta come del tutto priva di senso perch si esprimerebbe intorno alle propriet logiche dei simboli, mentre una propriet log ica non pu mai essere oggetto di descrizione. Si potrebbe quindi dire che Wittgen stein non poteva fornire esempi concreti di oggetti semplici. Nei Quaderni (Q. 1 57-158) viene affermato esplicitamente che lesistenza del semplice una necessit di tipo logico: lidea del semplice [] gi contenuta in quella del complesso e nellidea d ellanalisi, e in modo tale che noi (prescindendo completamente da qualsiasi esemp io doggetti semplici o da proposizioni ove si parli di tali oggetti) perveniamo a questa idea ed intuiamo lesistenza degli oggetti semplici come una necessit logic a a priori. Wittgenstein, insomma, procede nella sua indagine ontologica partendo da presupposti logici, domandandosi quali caratteristiche debbano attribuirsi a lla realt se devono esistere proposizioni dotate di senso. La mancanza di esempi, nota Kenny, non dunque casuale. Infatti, Wittgenstein credeva nellesistenza di og getti semplici e di stati di cose atomici non perch pensava di poterne fornire de gli esempi, ma perch riteneva che essi dovessero esistere quali correlati, nel mo ndo, dei nomi e delle proposizioni elementari di un linguaggio completamente ana lizzato (Kenny, 94). Pertanto luniverso, quale lo concepisce Wittgenstein, una proi ezione dei caratteri chegli rileva nel linguaggio (Black, 34). Per comprendere il tema della semplicit degli oggetti dunque necessario anticipare alcuni elementi d ella teoria raffigurativa del linguaggio sostenuta da Wittgenstein. Il Tractatus considera le proposizioni come immagini della realt (4.01). Ogni enunciato in gr ado di raffigurare un determinato stato di cose in virt della sua interna comples sit (4.032): le relazioni che sussistono tra le parti della proposizione (i nomi) corrispondono alle relazioni che sussistono tra gli oggetti che costituiscono l o stato di cose raffigurato. Cos, la proposizione: Lorologio nel cassetto mette in r elazione dei nomi (orologio, cassetto) in modo da raffigurare un determinato nesso d i oggetti (lorologio e il casetto) esistenti nella realt. Analizzare una proposizi one significa scomporla nelle sue parti costitutive fino a raggiungere le unit mi nime di cui costituita: queste ultime sono rappresentate appunto dai nomi, segni semplici che significano gli oggetti (3.202, 3.203). La tesi di Wittgenstein ch e se i nomi non si riferissero ad entit semplici, allora nessuna proposizione pot rebbe avere un senso compiuto. Poniamo infatti che orologio sia unentit complessa. I n questo caso, un enunciato che parli di tale entit risulterebbe incomprensibile a meno di presupporre un elenco completo delle sue parti (cio una serie di altri en unciati descriventi gli elementi del composto). Cos, se con il termine orologio int endo un complesso di ingranaggi, viti, rotelle, etc., io non potrei essere sicur o che la proposizione Lorologio nel cassetto si riferisca proprio a quel determinat o oggetto a meno che io non sia preliminarmente informato del fatto che tutti i suoi componenti sono effettivamente presenti in esso (se allorologio mancasse un ingranaggio, la parola orologio non indicherebbe loggetto in modo determinato). Ma una volta individuati i costituenti dellorologio mi troverei di fronte alla medes ima difficolt perch ogni oggetto fisico , almento in linea di principio, infinitame nte divisibile: neanche la proposizione lingranaggio x si trova nellorologio potrebb e quindi essere compresa se non presupponendo una serie di altri enunciati che a sseriscono che ogni singola parte dellingranaggio effettivamente presente in esso. E a questo punto non mi sarebbe lecito nominare alcuna cosa con la speranza di essere compreso, n sarebbe possibile costruire alcun enunciato dotato di senso c ompiuto. E per un fatto evidente che chiunque in grado di comprendere la proposizi one Lorologio nel cassetto, e da ci Wittgenstein deduce che i nomi devono effettivam ente possedere la capacit di indicare unit semplici, cio entit formalmente compiute. Nei Quaderni leggiamo conseguentemente che Lesigenza delle cose semplici lesigenza della determinatezza del senso (Q. 162, cfr. 3.23). In altre parole, se ammettia mo che le proposizioni del linguaggio debbano avere un senso determinato, allora dobbiamo anche ammettere lesistenza di oggetti semplici quali correlato ontologi co dei segni semplici contenuti nelle proposizioni. Nei Quaderni si trovano lung he e complicate riflessioni che mostrano quanta importanza Wittgenstein annettes se al problema degli oggetti semplici e quali difficolt egli incontrasse nella de finizione di una chiave risolutoria. Wittgenstein ritiene indispensabile lesisten za del semplice per evitare che venga annullata la possibilit di parlare in modo sensato delle cose. Tuttavia, questa esigenza si scontra con lindefinita divisibi lit degli enti fisici e non facile indicare in che misura la complessit di un oggetto debba essere tenuta in conto per ottenere proposizioni nelle quali un oggetto possa comparire come unit in s compiuta. Se io dico che lorologio nel cassetto, scrive Wittgenstein, sto for se implicitamente affermando che anche una rotella dellingranaggio nel cassetto? Forse io non sapevo affatto che quella rotella si trovava nellorologio e quindi, con lespressione questo orologio io non intendevo descrivere un complesso ove la rot ella occorre (Q. 163). Tuttavia, quando parlo dellorologio in questione (il quale, almeno in teoria, si compone di infinite parti) vengo facilmente compreso dai m iei interlocutori: lespressione: Lorologio nel cassetto ha infatti un senso compiuto indipendentemente dalla possibile complessit infinita delloggetto e ne prova il f atto che ciascuno di noi comprende perfettamente tale enunciato. Wittgenstein pu allora affermare che la complessit di un oggetto, se determinante per il senso del la proposizione, devessere raffigurata nella proposizione nella misura in cui det ermina il senso della proposizione. E, nella misura nella quale la composizione non determinante per questo senso, in questa misura gli oggetti di questa propos izione sono semplici. Essi non possono essere scomposti ulteriormente (Q. 162). G li oggetti il cui nome compare in un enunciato devono dunque essere considerati, se lenunciato ha senso, come unit formalmente compiute, cio semplici. Se di un ogg etto (ad esempio, lorologio) si intende mettere in rilievo la complessit, la propo sizione illustrer in modo definito e compiuto le parti di cui esso si compone, ma anche in questo caso le parti compariranno nellenunciato come semplici (cos, in una proposizione ove interessa illustrare che lorologio contiene ingranaggi, la sing ola rotella sar considerata un oggetto semplice non ulteriormente decomponibile). Il fatto che ogni oggetto fisico sia scomponibile, insomma, non pregiudica seco ndo Wittgenstein la possibilit di costruire enunciati dal senso perfettamente def inito perch ogni volta che un oggetto viene nominato nella proposizione costituis ce ununit esistente in atto e la sua potenziale infinit pu venir trascurata come non essenziale per il senso della proposizione. Se una proposizione ci dice qualcosa essa devessere, cos com, unimmagine e completa- della realt. (Q.159). Le indicazion el Tractatus, insomma, non valgono ad individuare entit fisiche ultime (sul model lo degli atomi della tradizione democritea) ed quindi inutile cercare nella real t fisica un corrispettivo dei semplici logici. Da alcune affermazioni di Wittgenste in risulta poi evidente che tutta la questione pu essere trattata senza essere co stretti a determinare preliminarmente se la realt fisica sia o non sia infinitame nte scomponibile in parti: Anche se il mondo infinitamente complesso recita la pro posizione 4.211 del Tractatus, cos che ogni fatto consta dinfiniti stati di cose ed ogni stato di cose composto dinfiniti oggetti, anche allora vi devono essere ogg etti e stati di cose. Paolo Zellini, nel libro Breve storia dellinfinito, inserisc e queste tesi del Tractatus nel quadro della classica contrapposizione tra princ ipio dellinfinito e principio del limite. Gi Aristotele (Phys. III, 204 a 21) avev a negato che potesse esistere un oggetto infinito in atto perch tutto quel che es iste definito dal principio limitante della forma: ogni entit corporea deve dunqu e essere intesa come una forma compiuta, un tutto irripetibile eretto dal princip io formale, limitante, sul substrato dellinfinita potenzialit, racchiusa negli inf initesimi che lo compongono (Zellini, 17). Secondo questa linea di pensiero, si p u comprendere e definire soltanto ci che limitato: la radice del termine definire ap punto finis, cio confine, limite, mentre non v logos riguardo allinfinito (in greco n, letteralmente: ci che privo di limite). La stessa esistenza delle cose sembra inconcepibile se prescindiamo dal principio del limite: Dopo tutto scrive Musil ne Luomo senza qualit, un oggetto esiste solo merc i suoi limiti. Il pitagorico Filolao , in questo senso, affermava che per concepire la realt necessario postulare un p rincipio formale limitante perch soltanto cose illimitate non potrebbero esistere ( fr. 2). Dal punto di vista gnoseologico, osserva Zellini, lattualit e il limite for nirono in ogni tempo il presupposto irrinunciabile di ogni teoria della conoscen za, la stessa essenza discriminante del pensiero, lirrinunciabile criterio di ogn i ordinamento concettuale e attivit dastrazione (...). Gli oggetti semplici di Wittg enstein rispondono anchessi alla esigenza della priorit dellattuale: essi sono dell e entit primarie non scomponibili se non al prezzo di una insensata frantumazione d el senso della proposizione in cui compaiono (Zellini, 48, 52).Scheda 3: Lesempio della scacchiera. In un indovinello sulla scacchiera, qual lunica parola proibita? J.L.Borges, Finzio ni Anthony J. P. Kenny, uno studioso di Wittgenstein, ha illustrato le prime pro posizioni del Tractatus (quelle che si occupano della struttura della realt) serv endosi di unefficace metafora: il gioco degli scacchi. Molte delle tesi fin qui c onsiderate possono essere esemplificate in modo chiaro se immaginiamo che il mon do sia rappresentato dai pezzi degli scacchi e dai quadrati della scacchiera. Un oggetto sar rappresentato da un singolo pezzo (pedone, torre, alfiere, etc.); da to che Wittgenstein ritiene che gli oggetti costituiscano la sostanza inalterabi le del mondo, sar necessario modificare le regole del gioco in modo che non sia p ossibile mangiare, ovvero eliminare pezzi dal nostro mondo (la scacchiera). Uno st ato di cose corrisponder ad una determinata posizione dei pezzi sui quadrati bian chi e neri della scacchiera (ad es., il re si trova in a4). Un fatto, ovvero il sussistere di stati di cose, consister nella congiunzione di differenti combinazi oni di pezzi (ad es., il re si trova in a4 e lalfiere si trova in d5). La realt o mondo, ovvero tutto ci che accade, corrisponder alla posizione della totalit dei pe zzi sulla scacchiera in un dato momento. Partendo di qui, consideriamo le principali tesi del Tractatus. Il mondo sar la to talit dei fatti, non delle cose (non soltanto la scacchiera pi i pezzi, bens la pos izione di questi su quella). Lo spazio logico sar linsieme delle possibilit ammesse dalle regole degli scacchi, cio quello che potremmo chiamare lo spazio scacchist ico (1.13). Caratteristica essenziale dei pezzi che possano occupare posizioni s ulla scacchiera, e dei quadrati che siano delle possibili posizioni per i pezzi. Solo in questo consiste la loro essenza [2.011, 2.013]. Nelle regole non c niente di accidentale: se un pezzo pu occorrere in uno stato di cose (per esempio, se u n alfiere pu occupare una casella nera) perch questo gi contenuto nelle regole per il suo uso (2.012). Le regole per la disposizione dei pezzi costituiscono la lor o forma logica; i pezzi possono differire per la forma logica (come un cavallo d a una torre) o per il semplice fatto di essere numericamente diversi (come due p edoni fra loro). Le propriet interne dei pezzi (ad esempio, che lalfiere possa muo versi in diagonale) possono essere confrontate con quelle esterne (ad esempio, c on il fatto che un certo alfiere sia ora in h4). Separato dalla scacchiera e dag li altri pezzi un re inconcepibile: non si possono pensare i pezzi degli scacchi separatamente dalle regole e dal gioco (2.0121). I pezzi, inoltre, sono oggetti semplici [2.02]; ovviamente, quelli con cui effettivamente si gioca sono fatti di legno o di avorio e hanno forme e parti, ma per quanto stabiliscono le regole la loro composizione del tutto trascurabile, e degli atomi solidi andrebbero ug ualmente bene (Kenny, 95). Lanalogia con il gioco degli scacchi pu essere utilizzat a anche per comprendere un tema di fondamentale importanza nella teoria del Trac tatus: limpossibilit di immaginare un punto esterno al mondo ed al linguaggio. Nel la Prefazione, Wittgenstein ha rifiutato lidea di un luogo esterno al pensiero e, d i conseguenza, ha impostato la ricerca dei limiti del linguaggio procedendo dallin terno di esso. Il Tractatus definisce insensata la pretesa di esprimere ci che si trova oltre il linguaggio, il pensiero ed il mondo (linguaggio, pensiero e mondo si identificano nel senso che ci che pensiamo coincide con quanto esprimibile da l linguaggio, e ci che viene espresso dal linguaggio sono i fatti, ovvero il mond o). La 1.11 ha del resto gi suggerito lidea che non esistono fatti che trascendono il mondo. Queste affermazioni risultano pi chiare se proviamo ad assumere il pun to di vista dei pezzi che si trovano sulla scacchiera. Per un pedone, il mondo c oincide con la scacchiera e non v modo di fare esperienza di ci che trascende le ca selle bianche e nere (con i relativi pezzi che le occupano). Parlare di quanto s i trova oltre il mondo sarebbe un puro nonsenso perch lorizzonte dei pezzi solo e semplicemente la scacchiera. Considerando lesempio proposto da Kenny siamo portat i naturalmente ad immaginare la scacchiera inserita in un contesto (essa poggia su un tavolo, il tavolo si trova al centro di una stanza, etc.). Siamo pertanto soggetti a fraintendere le possibilit conoscitive del nostro pedone perch il nostr o punto di vista ci consente di considerare, a un tempo, quel che si trova sullascacchiera e quel che esterno ad essa (lambito spaziale che la circonda). Condizi onati dalla nostra percezione del contesto, potremmo chiedere ad un pezzo di pro seguire il suo movimento oltre lultima casella della scacchiera fino a cadere sul pavimento: in tal modo non avremmo forse provato che possibile esperire ci che e sterno al mondo-scacchiera? Ma questo modo di procedere non corrisponde alle rea li possibilit di un pezzo situato sulla scacchiera. Se ci sforziamo (con un po di immaginazione) di collocarci a nostra volta su una delle caselle prendendo il po sto del pedone citato, ci accorgeremo che la nostra prospettiva muter considerevo lmente. Nel nostro nuovo mondo esisteremo soltanto noi, gli altri 31 pezzi e le 64 caselle bianche nere. Ogni pezzo si muove in un certo modo: lalfiere in diagon ale, la torre in verticale o in orizzontale, e via di seguito. Le regole che det erminano il movimento dei pezzi sono le uniche regole esistenti in quel mondo e la posizione dei pezzi in qualsiasi momento avviene conformemente alle regole de l gioco. Immaginiamo adesso che ci venga impartito lordine che avevamo in mente d i rivolgere ad un pezzo quando ci trovavamo fuori del mondo-scacchiera (prosegui re oltre lultima casella fino a cadere sul pavimento). Evidentemente, tale ordine non potrebbe essere compreso da noi n da alcun altro pezzo. Pavimento, infatti, no n significa nulla perch con tale parola non si descrive alcun elemento del mondos cacchiera; e lintero enunciato un perfetto nonsenso perch il movimento in question e non corrisponde ad alcuna regola ammessa dal gioco degli scacchi. Lespressione da noi usata per tentare di guidare lesperienza del pedone in direzione di ci che trascende il suo mondo era dunque formata in modo scorretto. Se smettiamo di con siderare il problema dallesterno, ci renderemo facilmente conto del fatto che ci c he viola le regole logiche inesprimibile ed impensabile ( questo uno degli insegn amenti fondamentali del Tractatus). Al di l della scacchiera , dal punto di vista di chi appartiene al mondo-scacchiera, unespressione vuota, un gioco di parole inco mprensibile (in generale, ci si pu chiedere cosa si trovi al di l di un oggetto co llocato nel mondo, ma non cosa si trovi al di l del mondo). Uno degli obiettivi d el Tractatus consiste proprio nel mostrare che impossibile raggiungere un punto di vista che autorizzi la visione del mondo dallesterno. Tale tentativo, secondo Wi ttgenstein, caratterizza intimamente tutta la tradizione filosofica: lessenza del la metafisica consiste appunto nel proiettare il soggetto conoscitivo oltre la s fera dellesperienza fino a considerare il mondo come un tutto (6.45). E da questa er rata prospettiva che sorgono, secondo Wittgenstein, tutti gli pseudo-problemi ti pici della tradizione filosofica (ad esempio potrebbe sorgere il problema dellart efice di questa totalit, ovvero il problema di un Dio creatore). Di qui la condan na espressa da Wittgenstein nei confronti delle teorie metafisiche, considerate come insiemi di enunciati privi di senso (ovvero, insiemi di proposizioni simili allordine che poco fa tentammo di impartire al pedone). Tutte le volte che usiam o la parola mondo, a ben vedere, rischiamo di scivolare inconsapevolmente in una p osizione di tipo metafisico. Per rendercene conto, proviamo a rispondere al ques ito che il lettore ha trovato in epigrafe alla presente scheda. Stephen Albert, il protagonista del racconto di J. L. Borges intitolato Il giardino dei sentieri che si biforcano, pone il seguente quesito: In un indovinello sulla scacchiera, qual lunica parola proibita?. Linterlocutore di Albert risponde immediatamente che la parola proibita scacchiera, ed Albert acconsente. Questa risposta pu forse appar ire banale, ma contiene unindicazione importante. Un indovinello sulla scacchiera (ovvero un problema scacchistico del genere di quelli che si trovano sulle rivi ste di enigmistica) ha per oggetto una certa configurazione di pezzi sulla scacc hiera. E facile notare che in nessun caso, in problemi di questo tipo, si fa menz ione della scacchiera o delle regole del gioco: questi sono semmai i presupposti dellindovinello (se non vi fossero la scacchiera e le regole non sarebbe nemmeno concepibile un problema scacchistico). Ma perch dovremmo considerare scacchiera un a parola proibita? Si potrebbe ad esempio dire: Il gioco degli scacchi presuppone una scacchiera, dei pezzi chiamati pedoni, torri, etc.. Per quale motivo dovremmo co nsiderare scorretto un enunciato di questo tipo? La ragione che menzionando la s cacchiera noi ci troviamo a parlare del gioco degli scacchi e quindi ci stiamo e sprimendo da un punto di vista metascacchistico: ovvero noi non ci troviamo pi allin terno del gioco, ma ci poniamo esternamente ad esso. Dallinterno del gioco, che v i siano una scacchiera e dei pezzi non un evento problematizzabile: gli unici eventi descrivibili sono i singoli fatti che si svolgono nel mondo-scacchiera, e d unque la successione delle mosse tutto ci di cui si pu parlare (non si parla dunqu e della scacchiera n si dice che essa esiste, o che fatta in un certo modo, o che il gioco si svolge secondo certe regole, etc.). Come si diceva in precedenza, p er ogni elemento appartenente al mondo-scacchiera vale questa condizione restrit tiva: Non si pu assumere un punto di vista esterno alla scacchiera. Il punto di vis ta metascacchistico (che ammette la possibilit di parlare della scacchiera e dell e regole del gioco) quindi irraggiungibile dai pezzi. Il termine scacchiera divent a a questo punto una parola sempre proibita (dato che non indica alcun oggetto) e non potr mai occorrere in enunciati dotati di senso. La stessa considerazione v ale per linsieme delle regole che governano il gioco: per enunciarle, infatti, do bbiamo presupporre la possibilit di parlare di qualcosa che nulla ha a che fare c on le posizioni assunte dai pezzi, ovvero di qualcosa che non costituisce un fat to situabile allinterno del mondoscacchiera. Il compito che Wittgenstein si assum e nel Tractatus precisamente quello di riportare il nostro punto di vista allinte rno del mondo in modo da evitare pericolose tendenze a sconfinare oltre esso. La teoria raffigurativa del linguaggio, come vedremo, ci obbliga a parlare esclusi vamente dei fatti che accadono nel mondo sbarrando la strada ad ogni tentativo d i formulare asserzioni sul mondo come un tutto e sulla logica che lo governa. Per comprendere appieno il senso di questa operazione sar per necessario progredire ul teriormente in quella delimitazione dallinterno cui Wittgenstein faceva cenno nella Prefazione.Note al Tractatus IMMAGINE E RAFFIGURAZIONE. (2.1 2.17) 2.1. Definita la struttura del mondo, lindagine si sposta adesso sulle modalit della sua rappresentazione da parte del soggetto. Wittgenstein assume co me punto di partenza il fatto che noi raffiguriamo gli eventi per mezzo di immag ini. Successivamente, passa a chiarire in che modo funziona unimmagine, ovvero qual i rapporti sussistono tra una raffigurazione e levento da essa rappresentato. Dat o che per Wittgenstein le proposizioni sono nientaltro che raffigurazioni di fatt i, le analisi riguardanti la natura delle immagini preparano i successivi approf ondimenti sulla natura della proposizione. Comprendere lessenza dellimmagine e del rapporto raffigurativo significa compiere un passo decisivo per chiarire le mod alit di funzionamento del nostro linguaggio. 2.11. Unimmagine raffigura sempre una situazione possibile (lo spazio logico contiene infatti tutte le possibilit). Vi s ono dunque immagini raffiguranti fatti positivi (il sussistere di stati di cose) e altre raffiguranti fatti negativi (il non sussistere di stati di cose). In al tri termini, posso costruire immagini sia di ci che esiste sia di ci che non esist e nel mondo empirico: ad esempio, posso raffigurare una combinazione di pezzi ch e di fatto non si realizza sulla scacchiera. Limmagine non deve dunque essere int esa come una semplice copia visiva di quanto esiste, ma come un modello (2.12) che deve essere messo a confronto con la realt. 2.12. Cfr. 4.01: La proposizione unimm agine della realt. La proposizione un modello della realt quale noi la pensiamo. La nozione di modello derivata dalla fisica. Un modello non una semplice copia di qu anto viene rappresentato, ma consiste in una costruzione (operata dal soggetto s econdo regole logiche) il cui scopo la spiegazione di una certa classe di fenome ni e la cui validit dipende sempre dal confronto con la realt (un modello pu dunque rivelarsi inadeguato, cos come unimmagine pu risultare falsa una volta accertato c he le cose non stanno cos come essa le raffigura). Quando si studia un fenomeno f isico per mezzo di un modello si isolano alcune caratteristiche essenziali del f enomeno in modo da ottenere una rappresentazione semplificata di esso (tra il mode llo e ci che esso raffigura sussiste pertanto solo una somiglianza di struttura, e non una corrispondenza assoluta). Tali osservazioni valgono anche per limmagine quale intesa da Wittgenstein. Unimmagine ha in comune con il raffigurato solo qu ella conformit strutturale che nella 2.18 definita forma logica. Sulla nozione di mo dello, v. nota alla 4.01 e Scheda 4. 2.13, 2.131. La raffigurazione fondata e res a possibile dalla corrispondenza tra gli elementi dellimmagine e quelli del fatto raffigurato in essa. In uno spartito musicale deve sussistere una relazione tra i segni sul pentagramma ed i suoni, altrimenti non vi sarebbe alcun nesso tra s partito e melodia. In generale, qualsiasi linguaggio segnico caratterizzato da u na corrispondenza di uno ad uno tra elementi simbolici ed elementi della realt. 2.1 4. Ad ogni elemento dellimmagine deve corrispondere un elemento del fatto raffigu rato (2.13), ma ci non sufficiente a realizzare il rapporto raffigurativo: infatt i una raffigurazione riuscita solo se il nesso che lega gli elementi dellimmagine corrisponde al nesso che lega gli elementi del fatto cui limmagine si riferisce. Per raffigurare su uno spartito la Quinta sinfonia di Beethoven non basta che v i sia una corrispondenza tra il numero delle note ed il numero dei segni sul pen tagramma: bisogna soprattutto che sia rispettato lordine di successione tra i suo ni (cio la struttura, la forma della melodia). Unimmagine sempre caratterizzata da l fatto di possedere una forma. In questo senso, essa non un semplice miscuglio di elementi (cfr. 2.03, 2.031, 3.14, 3.141). 2.141. Ogni immagine, riproducendo nella propria struttura la complessit del fatto rappresentato, essa stessa un fat to. Cfr. 3.14 e relativa nota. 2.15. Cfr. 2.032 e 2.033. La struttura dellimmagin e consiste nella connessione esistente tra i suoi elementi. Tale connessione mos tra come stanno le cose nella realt (cio quale relazione sussista tra gli elementi del fatto raffigurato). Ogni immagine deve dunque essere articolata, cio deve po ssedere la medesima molteplicit logica della situazione che rappresenta (cfr. 4.032 , 4.04). Perch ci si realizzi bisogna che immagine e fatto abbiano qualcosa in com une (2.16): immagine e fatto devono essere isomorfi, cio devono condividere una s tessa forma. Ad esempio, in un ritratto noi constatiamo che gli elementi dellimma gine sono disposti in modo conforme alle relazioni sussistenti tra le diverse pa rti del volto raffigurato: immagine e raffigurato devono dunque possederequalcosa di comune. Se immagine e fatto fossero del tutto eterogenei, ovviamente , non vi sarebbe relazione raffigurativa; tuttavia immagine e fatto sono due ent it materialmente distinte, e quindi lelemento comune deve avere una natura puramente formale. Wittgenstein chiama forma di raffigurazione lelemento comune a immagine e realt dal quale dipende la possibilit del loro reciproco corrispondersi (cfr. 2 .151). Solo se sussiste la forma di raffigurazione possibile una somiglianza di struttura tra immagine e fatto: la forma di raffigurazione pu essere pertanto def inita la possibilit della struttura. 2.1515. La coordinazione tra gli elementi delli mmagine e gli elementi del fatto paragonata da Wittgenstein al rapporto sussiste nte tra una figura geometrica e la sua proiezione. Cos come, in una proiezione or togonale, si ottiene unimmagine conforme di una data figura proiettando su un pia no le sue perpendicolari, cos ogni immagine pu intendersi come il risultato di un collegamento uno a uno dei suoi elementi costitutivi con quelli del fatto raffigur ato. Immagine e fatto sono idealmente collegati per mezzo di linee di proiezione (le antenne). Cfr. 3.1. 2.161. Limmagine e ci che da essa viene raffigurato devono ovviamente avere qualcosa in comune, altrimenti non sussisterebbe nemmeno la rel azione raffigurativa. Quel che identico la forma di raffigurazione. Se vogliamo ra ppresentare su una tela un determinato soggetto (ad es., una tavola su cui si tr ovano piatti e bicchieri), dovremo fare in modo che tra le immagini dipinte suss istano le medesime relazioni sussistenti tra gli oggetti reali (se i bicchieri s ono a destra dei piatti, ci dovr valere anche per le immagini dipinte sulla tela, etc.). La relazione di raffigurazione consiste appunto nella coordinazione degli elementi dellimmagine e gli elementi del fatto (2.1514). Ma questa coordinazione concepibile solo se immagine e realt sono omogenee dal punto di vista formale. 2 .17. Dato che unimmagine pu raffigurare sia situazioni esistenti che situazioni no n esistenti (2.11), essa pu risultare vera o falsa una volta confrontata con la r ealt. Se ad esempio raffiguro in unimmagine un gatto su un tappeto e poi mi accert o del fatto che il gatto non si trova sul tappeto, la raffigurazione in questio