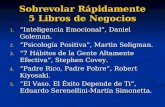Seligman
-
Upload
armando-editore -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
description
Transcript of Seligman
Adam B. Seligman - Robert P. WellerMichael J. Puett - Bennett Simon
RITO E MODERNITÀ
I limiti della sincerità
Traduzione diMatteo Bortolini
ARMANDOEDITORE
SOMMARIO
Prefazione 9
Introduzione 13
Capitolo primo: Rito e soggiuntivo 31Il rito e il soggiuntivo 36L’opera del rito 45Rito e tragico 47Rito e mondo fratturato 49Rito e autonomia 52Il rito e i suoi rischi 60Conseguenze teoriche 62
Capitolo secondo: Ambiguità, ambivalenza e confini 65Sull’ambiguità 67Il rito e lo sviluppo del fanciullo 70Rito e ripetizione 77Il rito nella psicopatologia: la scissione dell’Ionel processo di difesa 80Un rito feticistico 82Un rito pubblico: la performance della tragedia greca 88Inganno e menzogna 90Riti privati, personali e pubblici 92Senso e signifi cato 95
Capitolo terzo: Rito, gioco e confini 97Gioco e rito comparati 98Tipi di rito, tipi di gioco 106Cornici e confi ni 116Membrane cellulari e muri di mattoni 127Non giocare 133
Capitolo quarto: Rito e sincerità 139I termini della sincerità 140I confi ni totalizzanti e il loro superamento 145I limiti dell’incertezza 150Rito e preghiera sincera 154Ripetizione e rito: al di là del politico 159Sincerità, fondamentalismo e modernità 162Conclusione 170
Capitolo quinto: Movimenti tra rito e sincerità 173Rito, sincerità e Il mercante di Venezia 181
Il mercante e l’ebreo 183Rito, sincerità e arte ornamentale 194Sulla musica 214
L’orecchio assoluto in un mondo frammentato 215Ripetizione e ornamento 218Harmonia Mundi 222Musica e sincerità 224
Commiato 231
Bibliografia 235
Indice analitico 253
Nota sugli Autori 267
9
PREFAZIONE
Come tutti i riti riusciti – e le ricerche scientifi che riuscite – questo libro è il risultato di uno sforzo collettivo. Scriverlo in quattro ha ri-chiesto molto tempo e molte conversazioni, studi condivisi, un bel po’ di frustrazioni e parecchie risate. “La scienza”, ha scritto Werner Hei-senberg nel suo Physics and Beyond: Encounters and Conversations, “si fonda sulla conversazione”1. Così come la scienza è una conver-sazione condivisa (di un certo tipo), il rito è una pratica condivisa (di un certo tipo). Un libro sul rito è un mondo sociale condiviso che sta più o meno a metà tra le due – è qualcosa di più di una conversazione e forse qualcosa di meno di una pratica condivisa.
Questo libro è il frutto dell’allargamento progressivo di una conver-sazione che ha coinvolto autori vivi e morti. Siamo partiti da un esercizio di comparazione tra alcuni prontuari popolari confuciani ed ebraici da parte di Rob e Adam. Dalla parte ebraica abbiamo letto il Kitzur Shul-chan Aruch, un diffusissimo manuale ottocentesco che spiega come con-durre la vita di tutti i giorni in maniera ritualmente corretta – la copia che abbiamo usato era appartenuta alla nonna di Adam ed era stata pubbli-cata a Duane Street, New York, nel 1900. Abbiamo confrontato questo testo con la traduzione di Patricia Ebrey di un testo dell’eminente fi lo-sofo confuciano Zhu Xi, Family Rituals, pubblicato originariamente nel Dodicesimo secolo ma largamente utilizzato anche nella Cina di oggi.
L’esercizio è stato tanto affascinante da spingerci immediatamente ad allargare la conversazione. Era evidente che quanto riguardava i precetti sulla preparazione dei morti (e dei vivi) per la sepoltura e ciò che seguiva quest’ultima era molto diverso da quello a cui eravamo stati preparati da decenni di teoria e ricerca antropologica. Non trova-vamo solo funzione e signifi cati, non solo pratica e performance, ma un approccio specifi co alla performance che incornicia azione e atteg-
1 W. Heisenberg, Physics and Beyond: Encounters and Conversations, New York, Harper & Row, 1971, p. vii.
10
giamenti in maniera unica, un approccio che la letteratura sul rito non sempre è stata in grado di cogliere. Per dare un senso a tutto ciò ci sia-mo trovati ad approfondire, leggendoli più e più volte, testi piuttosto lontani dall’attuale letteratura sul rito: Verso un’ecologia della mente di Gregory Bateson e Homo Ludens di Johan Huizinga, I giochi e gli uomini di Roger Caillois e Verità e metodo di Hans-Georg Gadamer. Siamo stati inoltre infl uenzati profondamente da Rito e religione nella costruzione dell’umanità di Roy Rappaport.
Ci siamo convinti sempre più decisamente che il rito non è soltanto un ambito dell’azione e dell’interazione tra gli uomini, distinto e sepa-rato da altre forme di azione umana. Abbiamo cominciato a conside-rarlo come un modo di approcciare il mondo, una forma che nel mon-do contemporaneo (nella cultura accademica come in quella popolare) viene troppo rapidamente liquidata. A quel punto abbiamo capito che dovevamo allargare ulteriormente la conversazione. Abbiamo allora invitato per qualche giorno un gruppo di persone che praticano l’azio-ne rituale e ci rifl ettono sopra. Nell’ambito di un piccolo seminario abbiamo incontrato rabbini, imam, antropologi, psicoanalisti, giuristi, agopuntori, studiosi confuciani, esperti dei classici e altri per discutere testi e pratiche. Il risultato di questo primo incontro è stato così posi-tivo da spingerci a intraprendere un percorso annuale di seminari sul rito in cui molti dei partecipanti originari hanno presentato e discusso dei testi. Siamo grati alla Humanities Foundation della Boston Uni-versity per averci aiutato a realizzare il programma.
Il gruppo di discussione ha poi dato origine alla decisione di scri-vere il libro che avete tra le mani. Il libro è stato letteralmente scritto insieme da tutti e quattro gli autori. Ogni parte del processo è stata del tutto condivisa: abbiamo buttato giù un indice provvisorio a cui ogni autore ha rivolto critiche e osservazioni fi no a quando ognuno ha concretamente contribuito a tratteggiare la forma e i contenuti di ogni capitolo. Ogni autore ha scritto la prima versione di un capitolo, che è stata poi distribuita agli altri per critiche e osservazioni. Alcuni ca-pitoli sono stati rivisti collettivamente quattro o cinque volte. Quando abbiamo ritenuto che i capitoli fossero pronti li abbiamo fatti girare e ognuno ha aggiunto, modifi cato e limato il testo che si è trovato tra le mani prima di passarlo all’autore successivo.
Scrivere insieme non è banale. Non è solo il prodotto secondario di una organizzazione del lavoro un po’ originale ma è, molto specifi ca-mente, una parte integrante dell’argomento che proponiamo in questo
11
libro. La pratica del rito non è diversa da quella della conversazione (almeno per come la vedevano gli antichi e i medievali). Entrambe necessitano di coordinamento, vicinanza, fi ducia, limitazione della volontà; necessitano della capacità di restarsene in silenzio e di am-mettere che in un progetto collettivo la chiarezza delle proprie espres-sioni non è l’unico “bene”. Rito e conversazione necessitano entrambi di apertura verso l’altro, entrambi affermano che la verità non sta nelle mani (o nel cuore) di nessuno, ma che deve essere prodotta insieme mediante uno sforzo comune. Uno sforzo che, tra l’altro, ha qualcosa in comune anche con la danza – la necessità di coordinamento, atten-zione, precisione, pratica e grande attenzione a ciò che si sta facendo. Si tratta di competenze che oggi sembrano un po’ in disuso, ma ciò non è che un particolare delle nostre disgrazie.
Non abbiamo alcuna intenzione di introdurre il lettore all’enorme biblioteca di opere che riguardano il rito. I due recenti volumi di Ca-therine Bell hanno svolto impeccabilmente l’importante ruolo di rias-sumere i molti studi sui riti umani permettendoci di fare passi avanti nella loro comprensione. L’opera di Bell segna il punto a cui è giunto lo studio del rito alla fi ne del Ventesimo secolo. Il nostro obiettivo è diverso: speriamo di aprire una conversazione sul rito come moda-lità specifi ca di approccio al mondo che va ben oltre quelle che co-munemente vengono individuate come attività rituali. In questo libro concettualizziamo il rito come modalità specifi ca di acconciarsi alla natura fratturata e spesso ambivalente del nostro mondo. Il rito è una risorsa di cui possiamo privarci solo a nostro rischio e pericolo.
Prima di continuare vorremmo ringraziare una serie di persone che hanno contribuito alle nostre conversazioni, durante e dopo i nostri primi seminari: Paula Fredrikson, Bruce Kapferer, Ted Kaptchuk, Barry Mensch, Arnold Modell, Khaleed Muhammad, Steve Scully, Suzanne Last Stone, Brackette Williams, Rahel Wasserfall, Shlomo Fischer e Nehemia Polen, che vogliamo ringraziare per le due citazio-ni dai libri dell’Esodo e della Epistola agli Ebrei con cui apriamo il volume. Vogliamo ringraziare anche Nelia Ponte, David Montgomery e Christal Whelan. Solitamente i ringraziamenti sollevano anche le persone a cui si è grati da ogni responsabilità per il risultato fi nale. Noi non intendiamo assolvere nessuno. Questo libro è il risultato di un lungo sforzo collettivo che va molto al di là dei quattro autori. Come avviene in ogni gruppo, non tutti sono d’accordo su tutto, ma troviamo comunque un modo per vivere insieme.
13
INTRODUZIONE
Uno dei fenomeni più interessanti dell’inizio del Ventunesimo se-colo è il riemergere, del tutto controintuitivo, del rito proprio in quei settori della società che se ne erano allontanati. I leader dell’ebraismo riformato, per esempio, sono tornati sui loro passi e hanno riammesso i riti nelle pratiche religiose per venire incontro alle richieste dei mem-bri delle loro congregazioni1. Assistiamo inoltre all’affermarsi di or-todossie basate, seppur parzialmente, sull’azione rituale (tanto che sa-rebbe meglio chiamarle ortoprassie). Si pensi alla diffusione mondiale delle identità islamiche, alla crescita dell’ortodossia ebraica e anche al successo che negli Stati Uniti hanno il neo-paganesimo, le pratiche wiccan e i centri per lo yoga2. L’interesse di un numero crescente di chiese protestanti per la teologia pratica è un altro indicatore della medesima tendenza3. Allo stesso modo, l’interesse degli intellettuali cinesi per varie forme di neo-confucianesimo comprende una chiara attenzione per il concetto di li – un concetto che include le forme ritua-li di devozione e i riti interpersonali di tatto e cortesia4.
1 D. Freedlander, R. Hirsch, S. Seltzer, Emerging Worship and Music Trends in UAHC Congregations, New York, Union of American Hebrew Congregations, 1994.
2 Sul ritorno dell’ortodossia ebraica si veda M.H. Danzger, Returning to Tradi-tion: The Contemporary Revival of Orthodox Judaism, New Haven, Yale University Press, 1989.
3 D. Browning, A Fundamental Practical Theology: Descriptive and Strategic Proposals, Minneapolis, Augsburg Fortress, 1996; M. Volf, D.C. Bass (eds.), Prac-ticing Theology: Beliefs and Practices in Christian Life, Grand Rapids, Eerdmans, 2002.
4 R. Weller, Divided Market Culture in China, in R. Hefner (ed.), Market Culture: Society and Morality in the New Asian Capitalism, Boulder, Westview Press, 1998, pp. 78-103; W.-M. Tu, The Search for Roots in Industrial East Asia: The Case for Revival, in M.E. Marty, R.S. Appleby (eds.), Fundamentalism Observed, Chicago, University of Chicago Press, 1991, pp. 740-781.
14
L’emergere globale di identità parzialmente defi nite da riti si ac-compagna, non sorprendentemente, a un rinnovato interesse per il rito da parte di alcuni settori delle scienze sociali. Nell’ultimo secolo sono molti gli studiosi che si sono occupati di riti, a partire dai primi ten-tativi di sistematizzazione teorica compiuti da Émile Durkheim nelle Forme elementari della vita religiosa5. Come accade per ogni impresa intellettuale, le ricerche sul rito si dividono in correnti assai diverse; evitando qualunque tentativo di sistematizzazione, ci limiteremo a po-sizionare la nostra proposta all’interno del più ampio campo degli studi sul rito6. La corrente principale, in antropologia come negli studi sulla religione, ha cercato di interpretare il signifi cato dei riti e di indicare i sistemi culturali di tipo discorsivo codifi cati ed evocati dai loro sim-boli.
Dal nostro punto di vista questo approccio rischia di rimanere pri-gioniero dei propri assunti, fortemente infl uenzati da quella che può forse essere defi nita una concezione post-protestante o post-illumini-stica, secondo la quale il rito è il referente di un signifi cato la cui autentica essenza sta al di là del rito stesso. Espressa parecchi secoli prima della Riforma, la celebre concezione agostiniana dell’Eucari-stia come “segno visibile di una grazia invisibile” è oggi la principale chiave per l’interpretazione dei riti: la “cosa in sé” sta sempre oltre il rito, così che l’atto rituale non è che lo strumento di qualcos’altro. Nonostante le interessanti interpretazioni dei simbolismi rituali che ha stimolato, questa visione ha concentrato la sua attenzione su stati interiori come la sincerità o le credenze la cui rilevanza per i contesti sociali e cognitivi dell’azione rituale non è sempre scontata.
In generale, questa concezione presta un’eccessiva attenzione alle interpretazioni individualistiche e soggettivistiche dei signifi cati e del-le interazioni. Lo spazio “essenziale” o costitutivo dell’azione (spesso sussunto nella categoria dell’intenzionalità) si trova all’interno degli attori sociali, mentre il rito esterno e formale viene concepito come mero indicatore dei processi interiori7. In questo lavoro utilizzeremo
5 E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Roma, Meltemi, 2005.6 Le migliori rassegne della letteratura continuano a essere i due libri di Catherine
Bell: Ritual Theory, Ritual Practice (New York, Oxford University Press, 1992) e Ritual: Perspectives and Dimensions (New York, Oxford University Press, 1997).
7 Le più importanti eccezioni appartengono a una corrente di pensiero antropolo-gico ispirata al rapporto reciproco tra rito e società in Durkheim, al potere delle parole rituali sul mondo in Malinowski e alla relazione tra rito e confini in Douglas.
15
il termine “sincerità” per indicare questa concezione del sé e del mon-do.
Noi cerchiamo, da molti punti di vista, di nuotare contro questa corrente. È indubbio che le persone saturino i riti di signifi cati e che possano, in molti casi, proporci spiegazioni assai elaborate. E tuttavia, un rito può avere luogo senza che sussista alcun interesse per i signi-fi cati (almeno nel senso in cui il termine viene utilizzato discorsiva-mente) e in molti casi gli informatori si rifi utano di indicarne il senso – rispondono semplicemente che i riti si eseguono in un certo modo perché è “la tradizione”. La maggior parte dei signifi cati, dopotutto, viene imposta al rito dall’esterno. Dal nostro punto di vista, il rito riguarda più il fare che il dire.
Non siamo i soli a nuotare controcorrente. Secondo Catherine Bell, per esempio, una delle caratteristiche principali della ritualizzazione è “il semplice imperativo a fare qualcosa in modo che il fare (doing) stesso attribuisca all’atto uno status speciale o privilegiato”8. Il carat-tere performativo e tradizionalizzante del rito, afferma Bell, fa sì che il suo “fare” sembri naturale e defi nito dall’esterno. Nel loro studio sui rituali giainisti, Caroline Humprey e James Laidlaw sostengono che la “ritualizzazione, presentando all’esperienza un’azione che è già-costi-tuita e dunque immediatamente coglibile, permette a un’ampia varietà di azioni concrete di essere giudicate chiaramente come performance ben riuscite, indipendentemente dall’attribuzione di signifi cati propo-sizionali particolari agli atti stessi”9. Come noi, questi autori conside-rano il rito come una specifi ca forma di orientamento all’azione, una cornice che ci dice cosa signifi cano atti come accendere una candela o sedere tranquillamente su una sedia10. Ne deriva che l’ambito che so-litamente chiamiamo “religioso” non esaurisce gli atti rituali. In altre parole, il rito offre un orientamento all’azione e dunque una cornice per l’azione che è rilevante per la comprensione delle attività umane al
8 C. Bell, Ritual, cit., p. 168. 9 C. Humprey, J. Laidlaw, The Archetypal Actions of Ritual: A Theory of Ritual
Illustrated by the Jain Rite of Worship, New York, Oxford University Press, 1994, p. 88.
10 Autori che abbracciano più o meno la medesima concezione, e su cui torne-remo più avanti sono M. Douglas, Purezza e pericolo, Bologna, il Mulino, 1975; S. Tambiah, Rituali e cultura, Bologna, il Mulino, 2002; M. Bloch, From Blessing to Violence, Cambridge, Cambridge University Press, 1986; T. Asad, Genealogies of Religion, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993; R. Rappaport, Rito e religione nella costruzione dell’umanità, Padova, Edizioni Messaggero, 2002.
16
di là di ciò che si fa nei templi, nelle chiese o nelle moschee – o nelle aule dei parlamenti11.
Si tratta di un argomento che ha suscitato un ampio dibattito. Jack Goody e John Skorupski sono due degli autori entrati nel dibattito utilizzando i medesimi termini per indicare atti come “portare un cane a fare una passeggiata, guardare la tv, andare al cinema, ascoltare un disco, far visita ai parenti, le procedure sul posto di lavoro, cantare sul posto di lavoro, i giochi di strada dei bambini, andare a caccia e così via”12. Come molti sostengono, una categoria troppo ampia diventa inutile. Noi pensiamo, tuttavia, che molte diverse forme di comporta-mento e azione possano essere utilmente comprese come ritualistiche proprio perché il termine “rito” inquadra l’azione in maniera molto precisa. È la categorizzazione che rende l’azione rituale, non l’azione stessa: fare la comunione e stringersi la mano possono essere compre-se come azioni rituali o meno, almeno ai margini.
Le discussioni sui movimenti delle mani e le posizioni degli offi -cianti nel corso dell’amministrazione dell’Eucaristia riguardano pre-cisamente i confi ni della ritualità nella gestione del rito sacro13. La Riforma protestante del Sedicesimo secolo eliminò l’Eucaristia come rito amministrato a favore dell’intera congregazione da un sacerdote dotato di paramenti sacri di fronte a un altare circondato da una balau-stra. Nel New England dell’epoca coloniale, per esempio, la “Eucari-stia” assumeva la forma di Cena del Signore amministrata da un mi-nistro modesto per eloquio e abbigliamento di fronte a un tavolaccio pieghevole e solo per i membri della congregazione, la cui salvezza era stata in qualche modo certifi cata14. La differenza tra le due attività
11 Usiamo il concetto di “cornice” (frame) secondo una concezione introdotta da Gregory Bateson: la cornice è un principio organizzatore e intersoggettivamente costituito che ordina l’esperienza (Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1984). Si tratta di un concetto simile a quello di “cornici primarie” (primary frames) sviluppato poi da Erving Goffman in Frame Analysis, Roma, Armando, 2001.
12 J. Goody, Against “Ritual”: Loosely Structured Thoughts on a Loosely Defined Topic, in S.F. Moore, B.G. Myergoff (eds.), Secular Ritual, Amsterdam, Van Gorcum, 1977, p. 27; J. Skorupski, Symbol and Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1976.
13 Sulle sponde opposte di questo dibattito si vedano D. Grey, Hand ans Hocus Pocus: The Manual Acts in the Eucharistic Prayer, in «Worship», 69, 1995, pp. 306-313; R. Guardini, Paylfulness of the Liturgy, in D. Vogel (ed.), Primary Sources of Liturgical Theology, Collegeville, Liturgical Press, 2000.
14 E. Winslow, Meetinghouse Hill, 1630-1783, New York, Norton, 1972, p. 52 e p. 56.
17
riguarda appunto la deritualizzazione dell’Eucaristia e il suo incor-niciamento entro un diverso insieme di categorie e desiderata. Allo stesso modo, possiamo stringere la mano “ritualisticamente” a tutti gli sconosciuti che incontriamo nel foyer del Teatro comunale, ma pos-siamo anche stringere la mano a un vecchio amico che abbiamo perso di vista, nel caso che il tempo, l’età e le decisioni che abbiamo preso dall’ultima volta che ci siamo visti ci impediscano un caldo abbraccio, anche se i sentimenti di amicizia e vicinanza non sono affatto scom-parsi. Dal punto di vista materiale la stretta di mano è esattamente la medesima. La cornice dell’atto è però molto diversa. Dal nostro punto di vista la differenza riguarda la forte ritualizzazione dell’Eucaristia pre-Riforma e della normale stretta di mano, rispetto all’orientamento relativamente non ritualizzato della seconda. L’Eucaristia protestante e la stretta di mano “sentita” sono incorniciate nei termini della “sin-cerità”. Dedicheremo a quest’ultima una parte non piccola del nostro ragionamento.
Il libro parte da qui per andare oltre il contributo controcorrente di quegli autori che hanno considerato il rito come un possibile orienta-mento all’azione, invece che come un insieme di signifi cati. L’identifi -cazione della sincerità come importante orientamento alternativo non solo ci ha permesso di studiare l’interazione tra le due modalità, ma ci ha anche spinto a esaminare le relazioni tra i due orientamenti e i pro-blemi generati dall’ambiguità sociale e psicologica. Come vedremo, rito e sincerità creano confi ni individuali e di gruppo da cui dipendono modalità assai diverse di empatia e interazione. Non intendiamo so-stenere che non esistano altre modalità di orientamento all’azione; si tratta però di due orientamenti che ci dicono molto del nostro mondo.
La nostra concezione del rito è ampia ma non indiscriminata. Il suo valore esplicativo non viene compromesso dalla sua inclusività. Se la pensiamo come specifi ca modalità di incorniciamento dell’azio-ne, possiamo utilizzare la nostra concezione del rito per comprendere fenomeni sociali diversi ed elaborare nuove spiegazioni su aspetti fi -nora inesplorati del mondo sociale condiviso. Ampliando il concetto in modo da poter discutere di architettura, musica e gioco, oltre che di liturgia, non vogliamo sminuirne l’importanza nell’ambito in cui uomini e donne si avvicinano al sacro. Il rito può, ovviamente, essere un orientamento al sacro, ma non è l’unico orientamento possibile – la sincerità è un orientamento alternativo che ha la stessa importanza e conseguenze molto differenti.
18
Portando il rito fuori dall’ambito della religione non intendiamo affatto concentrarci su quello che Moore e Myerhoff hanno chiama-to “rito secolare”15. La maggior parte degli studi da essi raccolti era più interessata a eventi secolari di carattere cerimoniale che non al rito come orientamento all’azione. Moore e Myerhoff intendono il rito nella sua connotazione religiosa, mentre le attività che avvengono in altre sfere sociali vengono considerate come equivalenti funzionali.
Dal nostro punto di vista, invece, il rito non è essenzialmente un fenomeno di tipo religioso. In effetti, l’unica ragione per cui la mag-gior parte di noi tende a considerarlo tale è la consueta separazione tra ambito religioso e ambito secolare tipica del protestantesimo e del cri-stianesimo in generale. Noi defi niremo invece il rito come una moda-lità fondamentale di incorniciamento dell’attività umana. Come tale, essa è una modalità tra le altre. Sosterremo che le scelte individuali e sociali tra l’orientamento rituale e quello della sincerità (le due moda-lità che ci interessano) hanno conseguenze sociali rilevanti.
Almeno a partire da Durkheim, la maggior parte degli autori ha identifi cato le azioni ritualizzate con ciò che la società ritiene sacro, cioè con ciò che possiamo ragionevolmente chiamare “religioso”. Se è vero, come ha scritto Jonathan Z. Smith, che “il rito è, soprattutto, l’affermazione di una differenza”, allora il sacro, nella classica for-mulazione durkheimiana, è ciò che è “più diverso”, ciò che è comple-tamente separato e disgiunto dal profano16. Non intendiamo mettere in discussione questa defi nizione del sacro e il ruolo che essa assegna al rito. Vogliamo però mettere in guardia il lettore contro la tendenza a a considerare questo particolare effetto del rito – l’affermazione delle differenze – come qualcosa che sta al di fuori della vita quotidiana. Si tratta di una tendenza che ci impedisce di comprendere come incorni-ciamo, potremmo incorniciare, o qualche volta abbiamo incorniciato le azioni secondo una modalità ritualistica. Sono i nostri pregiudizi, la nostra incapacità di vedere l’ubiquità delle differenze nella vita – differenze che vengono continuamente mediate dai riti – che ci por-tano a ridurre il rito a una rappresentazione del sacro (ci torneremo nel primo capitolo). È nostra opinione che la sincerità – come forma di orientamento all’azione e ai signifi cati – ci porta a comprendere l’azione rituale mediante gli strumenti che le sono propri, cioè in ter-
15 S.F. Moore, B.G. Myerhoff (eds.), op. cit., pp. 3-4.16 J.Z. Smith, To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago, University of
Chicago Press, 1987, p. 109.
19
mini separati da, e non più legati alla mediazione de, la vita di tutti i giorni.
Affronteremo dunque rito e sincerità come due modalità “ideal-tipiche”, presenti in ogni società e in continua tensione reciproca, di attribuzione di senso all’esperienza, al sapere e all’azione. Sosterremo inoltre che l’importanza che attribuiamo irrifl essivamente alla sinceri-tà rende diffi cile comprendere le modalità esistenziali di tipo ritualisti-co in disgiunzione dal sacro. “Il rito”, come ha sostenuto Smith, “ren-de più chiare le ambiguità, senza però risolverle né allentarle”17. Ciò dipende dal fatto che il rito cerca di mediare le differenze e di defi nire i confi ni senza cercare, come invece avviene nel caso della sincerità, di eliminarli o di superarli. Nel prosieguo di questo lavoro cercheremo di delineare alcune di queste ambiguità individuali e sociali, mostran-do che il rito ci insegna a vivere all’interno dei confi ni, o tra di essi, senza cercare di assolutizzarli – come invece fanno le interpretazioni de-ritualizzate dei saperi e dell’azione.
I capitoli che seguono sono dedicati allo sviluppo di quattro punti. In primo luogo, sosteniamo che il rito crea un universo soggiuntivo (subjunctive)18 fatto di “come se” o “potrebbe essere”, da cui emerge il mondo sociale condiviso. La creazione di un soggiuntivo condiviso identifi ca e sancisce l’intrinseca ambiguità della vita sociale e delle sue relazioni – comprese quelle tra esseri umani e mondo naturale. La for-malità, la reiterazione e i vincoli tipici del rito sono elementi necessari di tale creazione condivisa. Il rito, inoltre, garantisce ampio spazio alla realizzazione e al perfezionamento degli esseri umani, troppo spesso mortifi cati dalle versioni liberali e autonome dell’universo delle scelte individuali e dall’ideale di autonomia del tutto distaccata da qualsivo-glia riferimento alle tradizioni. Ciò che qui defi niamo “soggiuntivo”
17 J.Z. Smith, op. cit., p. 110.18 Preferisco utilizzare la parola “soggiuntivo” per tradurre subjunctive al posto
del più consueto “congiuntivo” per varie ragioni. In primo luogo, l’uso di “soggiun-tivo” richiama a uno dei principali concetti del volume – la parola “congiuntivo”, solitamente utilizzata per designare un modo verbale, poteva forse distrarre il lettore. In secondo luogo, la parola “soggiuntivo” – più vicina all’originale subjunctive – ri-flette in maniera più chiara il carattere “aggiuntivo”, appunto, e cumulativo dei mondi “come se” di cui parlano gli autori. Ciò è chiaro dall’etimologia delle due parole, italiana e inglese: “soggiuntivo” deriva dal latino subiûngere (attaccare, unire) com-posto a sua volta da sûb, so-, e iûngere, congiungere o giungere (Dizionario etimo-logico della lingua italiana, a cura di M. Cortellazzo e P. Zolli, Bologna, Zanichelli, 1999). N.d.T.
20
ha dei paralleli nella letteratura sul rito: come vedremo nel primo ca-pitolo, Jonathan Z. Smith si riferisce a qualcosa di simile quando parla della natura “immaginaria” del rito19.
In secondo luogo, affermiamo che il “come se” condiviso creato dal rito è presente in molti ambiti della vita umana. Il rito non sus-siste soltanto nell’ambito che noi moderni chiamiamo “religioso” o nei cosiddetti “rituali secolari”. I riti e il comportamento rituale non sono eventi; sono una modalità di negoziare la nostra esistenza nel mondo. Con ciò, non intendiamo negare che i riti avvengano anche nelle chiese, nelle moschee o nelle sinagoghe. Ma possiamo trovarli anche nelle esibizioni pubbliche, nei concerti, nei teatri e, ancora più importante, nel quotidiano esercizio della buona educazione tra estra-nei, conoscenti e amici. Quando usiamo le espressioni “per favore” e “grazie”, quando chiediamo a un conoscente “come stai?”, sapendo entrambi che non ci attendiamo davvero una risposta sincera (che po-trebbe essere disastrosa), stiamo mettendo in atto un rito necessario all’esistenza del mondo sociale condiviso. Questo tipo di comporta-mento rituale (studiato in alcune delle sue forme da Goffman) non è diverso dai comportamenti considerati come “ritualistici” e dalle loro regole – entrambi creano universi soggiuntivi, entrambi garantiscono l’esistenza di un mondo sociale condiviso, entrambi mantengono gli uomini all’interno di un universo che, senza atti performativi, sempli-cemente non esisterebbe20. Il comportamento rituale, dunque, avviene negli ambiti pubblici tanto quanto in quelli privati, in una miriade di forme, nei normali atti quotidiani così come nelle patologie psichi-che e sociali. Lo troviamo nell’arte e nell’architettura, nella musica e nella poesia, nei giochi dei bambini e nel tennis professionistico. Per comprendere pienamente il rito, per abituarci alla sua presenza, dobbiamo capire che non si tratta di assistere a un evento (una messa in una chiesa, un sacrifi cio animale, l’alzabandiera in una base mi-litare e così via) quanto piuttosto di partecipare a un concerto, i cui ritmi e cadenze lasciano immaginare modi di vivere nel mondo che noi moderni tendiamo a soffocare con il discorso e la narrazione della “sincerità”21.
19 J.Z. Smith, Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago, Univer-sity of Chicago Press, 1982, pp. 53-65.
20 Per Goffman si vedano Il rituale dell’interazione (Bologna, il Mulino, 1988) e La vita quotidiana come rappresentazione (Bologna, il Mulino, 1995).
21 Anche il recente saggio di Robert Bellah intitolato The History of Habit (in
21
Il nostro terzo punto è che possiamo utilmente contrapporre ai comportamenti di tipo rituale quelle che defi niamo modalità “sincere” di rapportarsi al mondo. Le concezioni basate sulla sincerità non si dedicano alla creazione di un “come se” o di un universo soggiuntivo condiviso, ma proiettano una visione “come se” di quella che spesso diventa una visione della realtà “come veramente è” totalistica e priva di ambiguità. I nostri mondi personali e sociali traboccano di metafore della sincerità: nell’arroganza delle cosiddette credenze religiose fon-damentalistiche, nella nostra ossessione per l’“autenticità” e la scelta individuale, nella convinzione che se solo potessimo raggiungere il cuore, l’origine, il nucleo inalterabile e inimitabile di ciò che sentia-mo o pensiamo “veramente” allora tutto sarebbe perfetto – se non per tutti, almeno per noi stessi. Si tratta dell’atteggiamento che Christian Smith, sociologo all’università di Notre Dame, attribuisce ai giovani cristiani evangelici americani: “Se non l’hai scelto tu, non è autenti-co per te”22. Ne consegue ovviamente che ciò che non è “autentico” perde qualsivoglia valore e signifi cato. È lo stesso atteggiamento da cui è nato il business delle Bibbie “di nicchia” alla metà degli anni Sessanta. Come ha detto Phyllis Tickle, autrice di un popolare libro di preghiere, “invece di chiedere al credente, al lettore, al cercatore di uscire dalla propria cultura e diventare più cristiano, noi stiamo dicendo: ‘rimani pure nella tua cultura, veniamo noi’”23. Questi esem-pi illustrano l’essenza stessa del fenomeno che defi niamo “sincerità”, che noi distinguiamo dal formalismo, dalla reiterazione e dai vincoli esternamente defi niti del rito.
La tensione tra rito e sincerità non è un fenomeno moderno. Le diverse culture la affrontano in modo diverso, elaborano un equilibrio diverso e attribuiscono un diverso valore all’uno o all’altro orienta-mento. Si tratta di differenze che si ritrovano nella politica, nell’arte, nella musica, nell’architettura, e anche nel signifi cato che le persone attribuiscono alle proprie tradizioni sacre. Ciò detto, la nostra tesi è che il tempo in cui viviamo si caratterizza per una spropositata con-
R.N. Bellah, S.M. Tipton (eds.), The Robert Bellah Reader, Durham, Duke Univer-sity Press, 2006, pp. 203-220) afferma che le abitudini – in tutte le loro forme, rito compreso – sono fondamentali per la creazione della comunità e che la bassa stima che è stata attribuita loro nel Ventesimo secolo è un problema sociale.
22 N. Banerjee, Going Church to Church to Find a Faith That Fits, in «New York Times», December 30, 2005, p. A18.
23 Citato in D. Radosh, The Good Book Business, in «The New Yorker», Decem-ber 18, 2006, p. 59.
22
siderazione per la sincerità a spese del rito. Ciò dipende, in gran par-te, dal ruolo del protestantesimo nella genesi della modernità e della cultura contemporanea (sebbene questo mondo sia ora condiviso da ebrei, confuciani, hindu, musulmani, sikh e così via). La centralità della sincerità nel protestantesimo è in un certo senso un luogo comu-ne, come testimoniano gli scritti di Lionel Trilling, William Haller e molti altri. Anche altre culture, naturalmente, hanno attribuito grande importanza alla sincerità: pensiamo ai chassidici, ai buddisti zen, o ai mohisti cinesi di duemila anni fa. Henri Peyre ne ha ricostruito il ruolo nella letteratura francese dal Rinascimento a oggi24. L’articolazione che ne ha dato il protestantesimo, tuttavia, è quella che ha più infl uito sulla cultura contemporanea.
Riteniamo che ciò sia di cruciale importanza per comprendere i cosiddetti movimenti fondamentalisti contemporanei. Se analizziamo questo fenomeno (evitando di usare “fondamentalista” solo per indi-care credenze o gruppi religiosi che troviamo offensivi), è chiaro che le manifestazioni attuali del radicalismo religioso – siano esse cristia-ne, ebraiche, islamiche o hindu – presentano una forte componente di “sincerità”. Ciò dipende in gran parte dal romantico, quasi herderiano espressivismo di tali movimenti25, che considera l’atto religioso – e, fi n troppo spesso, l’atto religioso in politica – come veicolo di espres-sione e realizzazione di sé: non la realizzazione di un atto di Dio nel mondo, ma la proiezione del proprio sé. È una delle conseguenze più perniciose della tendenza odierna a privilegiare autenticità e libera scelta come fondanti dell’azione religiosa. Sosterremo che molte delle azioni che vengono acriticamente attribuite a un impulso religioso di tipo ritualistico dipendono invece da un orientamento fortemente sin-cero che non ha alcuna relazione intrinseca con l’impulso religioso o le tradizioni sacre.
Nel mondo contemporaneo il rito non gode di una buona reputa-zione: è stato considerato una forma di devianza dallo struttural-fun-zionalismo americano della metà del Novecento, disprezzato come un involucro vuoto ed esterno, privo di signifi cati spirituali profondi o, ancora, condannato in quanto forma di autoritarismo. Siamo troppo occupati a esplorare le forme di espressione del sé e dell’autentici-tà individuale per apprezzare e comprendere la struttura ritmica del
24 H. Peyre, Literature and Sincerity, New Haven, Yale University Press, 1963.25 S. Fischer, Self-Expression and Democracy in Radical Religious Zionist Ideo-
logy, Ph.D. dissertation, Jerusalem, Hebrew University, 2007.
23
soggiuntivo condiviso su cui poggiano i riti. L’immagine del mondo come mercato affollato di utilizzatori e agenti razionali impegnati, per la maggior parte del tempo, in scambi reciprocamente vantaggiosi di beni privati ci ha resi sordi alle cadenze del rito, al suo funzionamento, agli spazi della sua presenza e al prezzo della sua assenza.
Il nostro quarto e ultimo punto è che l’accenno normativo pre-sente nel titolo del nostro libro non è casuale26. Solo attraverso una riconsiderazione del rito come elemento costitutivo della condizione umana possiamo negoziare le realtà del secolo che è appena iniziato. La reazione alle forze economiche e culturali della globalizzazione, il riemergere della religione e delle identità etniche e l’opposizione tra “Occidente e resto del mondo” dimostrano che le risorse culturali a nostra disposizione non sono in grado di affrontare le ambiguità, le ambivalenze e l’intrecciarsi di confi ni che vanno a un tempo posti e trascesi. Troppo spesso, invece, la modernità ha assolutizzato i confi ni. Ciò è avvenuto mediante la costruzione di identità schermate (come le identità razziali, etniche, quelle cosiddette “religiose” o l’idea della cittadinanza nazionale) ovvero con la distruzione dei particolarismi e la negazione di tutte le differenze costitutive tra i popoli e le comuni-tà. La negazione dei confi ni è l’obiettivo di diverse agende politiche liberali, tra cui l’universalizzazione dei diritti umani. Le conseguenze tragiche della negazione dei confi ni si sono dispiegate in maniera fi n troppo chiara nel corso del Novecento, cominciato e fi nito a Saraje-vo, e nelle sue guerre etniche e nazionalistiche. L’insuffi cienza di tale approccio è fi n troppo chiara nella sfi da dei particolarismi che rifi uta-no l’assimilazione della cultura globale – e i particolarismi europei e americani non fanno eccezione.
Nessuno di questi approcci tiene conto della profonda necessità umana di avere dei confi ni e della loro natura di entità negoziabili, più simili alla membrana di una cellula vivente che alle mura di una for-tezza impenetrabile. Gli uomini si costituiscono grazie ai loro confi ni – si costituiscono cioè su un piano di cui non hanno pieno controllo, un piano che è sempre aperto all’altro, allo straniero, a ciò che è diverso e sconosciuto e che non può essere raggiunto dal potere del centro. È per questo che i confi ni sono pericolosi. Invece di tentare di eliminare i confi ni o di renderli impenetrabili, il rito li rinegozia continuamente, accettandone l’instabilità e la labilità. Solo prestando la dovuta atten-
26 In inglese: Ritual and its consequences. An essay on the limits of sincerity.
24
zione al funzionamento del rito – anche quando i suoi elementi e ritmi formali subordinano a sé i contenuti – possiamo negoziare le pretese emergenti del mondo contemporaneo.
Il primo capitolo prende le mosse da alcune delle proprietà formali del rito, concentrandosi su ciò che il rito fa e non, come spesso fanno le scienze sociali, su cosa esso sta a signifi care. Abbiamo trovato la defi nizione del rito di Roy Rappaport particolarmente utile: dal suo punto di vista il rito è “la performance di sequenze di atti ed enunciati formali più o meno invarianti e non interamente codifi cati da chi li esegue o li pronuncia”27. Il rito crea e ricrea un mondo sociale con-venzionale e dotato di autorità indipendente dalla volontà interiore di qualsivoglia individuo. Affronteremo il punto analizzando alcune tra-dizioni, come l’ebraismo e il confucianesimo, che attribuiscono al rito un’importanza centrale. Tali tradizioni vedono il mondo come intrin-secamente fratturato e discontinuo; il rito consente di viverci dentro mediante la creazione di un mondo performativo e soggiuntivo che a sua volta garantisce l’esistenza temporanea dell’ordine. Ogni rito ricostruisce il mondo “come se” fosse davvero così, come un mondo tra i tanti possibili.
Possiamo vedere un chiaro esempio di quanto appena detto nel-le elezioni presidenziali nello Stato in cui viviamo, il Massachusetts. Sono passati decenni da quando il voto di questo Stato ha davvero infl uito sulla elezione di un presidente: il risultato è talmente scontato che i candidati non vengono neanche a fare campagna elettorale. Ul-timamente, un economista si è chiesto perché la gente vada a votare, visto che le probabilità di infl uire sul risultato sono minime mentre la perdita di tempo ed energia è reale28. Gli autori di questo libro e milioni di loro concittadini vanno comunque a votare. Per quanto sia privo di valore pratico, il voto è un rito molto importante, in quanto permette di ricreare un immaginario sociale, un mondo in cui il popolo controlla il governo. In casi come questi votiamo meno per scegliere il presidente che per ricreare la nostra democrazia ogni quattro anni. La ragione per cui andiamo a votare è, almeno in parte, simile alla ragione per cui rispettiamo le regole della buona educazione nella vita quotidiana – si tratta di riti che permettono ai soggiuntivi sociali di non collassare in un mondo di interessi personali e coercizione.
27 R. Rappaport, op. cit., p. 64.28 S.J. Dubner, S.D. Levitt, Why Vote?, in «New York Times Magazine», Novem-
ber 6, 2005.
25
L’aspetto performativo è cruciale perché con esso il rito affronta gli aspetti relazionali dei ruoli, del sé e dell’altro. Il rito segna i confi ni e allo stesso tempo permette di attraversarli. Riconoscendo i limiti, il rito si offre anche come strumento per trascenderli. All’inizio della preghiera quotidiana, per esempio, l’ebreo proclama: “Cosa siamo? Cos’è la nostra vita? Dov’è il nostro bene? Dov’è la nostra giustizia? A cosa serviamo? Dov’è la nostra forza? Dov’è il nostro coraggio? […] Davvero gli eroi sono niente di fronte a Te, davvero è come se gli uomini illustri non fossero mai esistiti”. Ma subito dopo dichiara anche: “E tuttavia, noi siamo il Tuo popolo, il Tuo popolo del patto, i fi gli di Abramo, il Tuo amico a cui Tu hai fatto una promessa sul mon-te Moria”29. Il primo insieme di frasi circoscrive l’esistenza e il suo signifi cato, il secondo insieme li apre.
Verso la fi ne delle preghiere quotidiane, e con un tono diverso, con la preghiera di Aleynu l’ebreo devoto ringrazia il Signore “che non ci ha fatti come le nazioni del mondo e non ci ha fatti come le famiglie della terra; che non ha voluto che il nostro destino fosse come il loro”30. Ma ecco che l’ultima frase della preghiera punta al supera-mento di tali differenze: “in quel giorno [in cui] il Signore sarà Uno e il Suo nome sarà Uno”31. Entrambi i segmenti, provenienti da una liturgia, esemplifi cano il modo in cui il rito sancisce sia l’esistenza dei limiti sia il loro superamento o trascendimento. I capitoli secondo e terzo affrontano in dettaglio questa importante caratteristica del rito andando oltre gli esempi liturgici.
Diversamente da molte analisi del rito, il secondo capitolo mette in relazione la funzione sociale del rito e la psicologia individuale. Ana-lizzeremo lo sviluppo dei mondi soggiuntivi e dei comportamenti ri-tuali nei bambini, dai riti della buonanotte allo sviluppo delle capacità di fantasticare, inventare e mentire. Ci concentreremo poi su temi più strani ed esotici come il feticismo e la menzogna estrema. Le due linee di ricerca convergeranno sul tema dell’ambiguità a partire dal concet-to psicoanalitico di scissione dell’Io. Il capitolo si concentra sia sulla capacità umana di tollerare l’ambiguità, sia sull’abilità di generarla creativamente al fi ne di affrontare le contraddizioni dell’esistenza nel mondo. Ambiguità e ambivalenza non sono solo esperienze passive. Tutti noi, almeno in alcuni periodi della vita, abbiamo creato ambiguità
29 P. Birbaum, Daily Prayer Book: Ha-Siddur Ha Shalem, cit., p. 24.30 Ivi, p. 136.31 Ivi, p. 138.
26
e ambivalenza per adattarci alle richieste e agli impulsi contraddittori delle nostre vite individuali e sociali. Sosterremo che tale capacità di-pende non poco da comportamenti ritualistici di carattere psicologico e sociologico. Insieme, essi contribuiscono alla creazione di universi soggiuntivi “come se” che pongono confi ni tra entità discrete nello stesso momento in cui li confondono e, a volte, li trascendono.
Facendo seguito all’analisi della capacità umana di tenere insieme versioni o visioni della realtà diverse, o addirittura contraddittorie, il terzo capitolo affronta il “come se” del gioco. La prima metà del ca-pitolo utilizza la letteratura sul gioco per mettere in luce importanti differenze presenti all’interno del mondo del rito e le relazioni tra rito, sé e ruolo. La seconda metà del capitolo approfondisce la discussione sui confi ni affrontando i temi del framing nel gioco e nel rito, due attività necessariamente dotate di confi ni e quindi di meccanismi per attraversarli. Ci concentreremo sulla capacità di giocare con i confi ni come una caratteristica fondamentale della visione rituale del mondo che è andata perduta in un mondo fondato sulla sincerità pura.
Grazie alla capacità di giocare con i confi ni – di vedere la doppia natura dei confi ni come qualcosa che allo stesso tempo separa e met-te in contatto – l’azione rituale si contrappone alle forme moderne dell’organizzazione sociale, che assolutizzano i confi ni cercando di eliminarli del tutto ovvero di esaltarli come entità indiscutibili e invio-labili. Nel quarto capitolo sosterremo dunque che l’organizzazione so-ciale – e personale – liberale punta a garantire interazione e solidarietà mediante l’eliminazione dei confi ni. Gli unici confi ni che resistono all’attacco del liberalismo sono quelli che derivano da distinzioni stru-mentali, vale a dire dalle necessità della divisione del lavoro.
Si tratta, da molti punti di vista, del nucleo stesso del progetto della modernità per come si presenta nel primo articolo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789: “Tutti gli uo-mini nascono e rimangono liberi e uguali nei loro diritti: le distinzioni sociali si fondano esclusivamente sull’utilità comune”. Le distinzioni sociali tra gli uomini e le donne, dunque, si basano esclusivamente sulla posizione che essi occupano nella divisione del lavoro, in sostan-za sulla loro utilità per il funzionamento del tutto sociale. Nella con-cezione modernista – socialista o liberale – le divisioni e le distinzioni tra individui e gruppi sono dunque strumentali, non costitutive. Ma la negazione dei confi ni costitutivi non funziona – non funzionava allora e non funziona adesso. Una delle conseguenze della globalizzazione
27
(il più grande esperimento di decostruzione dei confi ni mai provato) è il riemergere di confi ni e di identità schermate, spesso in senso for-temente xenofobico: confl itti religiosi in Africa, attacchi contro gli immigrati in Europa occidentale, confl itti religiosi e nazionalistici nel subcontinente indiano, e così via. Il rito è interessante proprio perché la sua capacità di riconoscere l’esistenza dei confi ni può forse permet-tere di negoziarli con il minimo ricorso alla violenza.
Possiamo aggiungere incidentalmente che dopo la Rivoluzione francese e per tutto l’Ottocento la negazione dei confi ni e delle iden-tità costitutive ha rappresentato il processo chiave dell’integrazione (e dell’assimilazione) degli ebrei nell’ordine politico europeo. Tale posizione è stata espressa classicamente nel 1789 dal conte Stanislas de Clermont-Tonnerre: “Dobbiamo negare tutto agli ebrei come na-zione e concedere tutto all’ebreo come individuo”32. Nel tempo que-sta espressione dell’atteggiamento verso l’altro ha assunto uno status paradigmatico. Come sappiamo, questa forma di integrazione è fi nita con la tragedia del genocidio degli ebrei europei durante la Seconda guerra mondiale. Vista la considerazione che gli europei, in Francia come in Bosnia, hanno oggi dei musulmani e visto il persistere del ri-fi uto popolare dell’inclusione della Turchia nell’Unione Europea, non è il momento sbagliato per dubitare seriamente del nostro paradigma e per cercare di articolare, o almeno creare, lo spazio per un modello alternativo.
Il mondo moderno e quello postmoderno hanno ignorato le forme di vita e i comportamenti di tipo rituale. Davanti alle fi glie delle élite turche secolarizzate che si riappropriano volontariamente del velo e i fi gli degli ebrei liberali di New York che si assoggettano a regole ali-mentari più restrittive, comprendiamo che le scienze sociali non han-no idea del legame tra ruolo, rito e identità personale. È possibile che sia la forza indicativa del rito, più che il suo potenziale proposiziona-le, a esprimere aspetti delle relazioni umane, e forse della condizione umana, che non sono facilmente ignorabili, a prescindere da ciò che pensano i moderni.
Il quarto capitolo affronta direttamente la tensione intrinseca tra rito e sincerità. Spesso la sincerità nasce come reazione all’apparente ipocrisia del soggiuntivo creato dai riti. Col tempo, però, tali reazio-ni tendono esse stesse a ritualizzarsi. La sincerità immagina un solo
32 Citato in M. Shurkin, Decolonization and the Renewal of French Judaism, in «Jewish Social Studies», 6, 2, 2000, pp. 156-176.
28
mondo “così com’è” invece dei molteplici mondi “come se” del rito. Si concentra sui signifi cati discorsivi e sulle personalità uniche invece che su atti ripetuti e realtà frammentate. Una delle conseguenze più rilevanti dell’affermarsi della sincerità negli ultimi secoli è il generale dissolversi, di principio, di confi ni sociali, che di fatto vengono conti-nuamente riaffermati. Il rito mantiene infatti tutta la sua importanza in questo mondo come in ogni altro – e gran parte della teoria sociale e politica non l’ha compreso.
Il quinto capitolo allarga l’orizzonte del rapporto tra sincerità e rito concentrandosi sulle riforme che richiedono l’affermarsi dell’una o dell’altro. Diversamente dai precedenti, il quinto capitolo introduce poche novità concettuali per dedicarsi ai diversi ambiti (spesso al di là della religione) in cui la tensione si fa evidente. Discuteremo dapprima l’intreccio di legge e amore, ebraismo e cristianesimo, rito e sincerità nel Mercante di Venezia di Shakespeare. Passeremo poi alla storia del-la decorazione architettonica, che condivide con il rito non solo ritmo e ripetizione ma anche l’attenzione per confi ni e cornici. In questo caso la tensione tra rito e sincerità si declina nel confl itto tra ornamento e pedagogia attraverso l’arte rappresentativa o l’affermazione del testo a scapito delle immagini – l’iconoclastia è uno dei temi principali di questa parte del libro. Ci concentreremo infi ne sulla musica, che con-divide molte caratteristiche del rito e spesso lo accompagna. Come il rito, la musica permette di tracciare e attraversare confi ni e di fare ordine in un mondo caotico. Ciò è visibile nell’intonazione, nel ritmo e negli abbellimenti. La tensione tra rito e sincerità emerge nei lunghi dibattiti sulle armonie o gli abbellimenti troppo complessi, considerati come distrazioni dal testo cantato, e ha il suo culmine nel tentativo novecentesco di superare del tutto le convenzioni tonali.
Sebbene la maggior parte della letteratura sul rito si sia concentrata sui signifi cati, noi sosterremo che il modo migliore per avvicinarsi al rito è attraverso ciò che esso fa, e non attraverso ciò che esso sta a signifi care. Benché i loro risultati siano assai importanti, questi studi tendono a celare alcuni degli elementi cruciali del rito, che invece pos-siamo cogliere spostando l’attenzione dai signifi cati al fare.
Il rito riconosce l’esistenza delle relazioni di autorità e dei loro effetti sull’esistenza umana ponendo relazioni esistenti tra entità costi-tuite – e non funzionando come un codice informativo strumentale che trasmette messaggi di tipo descrittivo. Il rito si basa sulle convenzioni sociali condivise e allo stesso tempo le riproduce. Le convenzioni in-
29
cludono le distinzioni di ruolo e di autorità ma anche l’idea stessa di un sé costituito. Queste proprietà fanno sì che il rito non sia riducibile agli assunti moderni sull’autonomia degli individui; è importante studiarle proprio per via dell’importanza che i confi ni hanno per l’esistenza dei sé sociali e del mondo sociale che essi condividono.
Non intendiamo proporre l’intreccio delle visioni del mondo del rito e della sincerità come una teoria esauriente dell’esperienza reli-giosa o anche solo di quella rituale. La nostra proposta è più mode-sta: esaminando questa particolare dinamica possiamo giungere a una comprensione più ricca del funzionamento del rito e della sua persi-stente importanza. Ciò rimane vero anche in un mondo moderno che si è fi nora concentrato quasi esclusivamente sulla sincerità – e forse so-prattutto in questo mondo, i cui limiti ci paiono ora fi n troppo chiari.