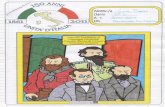Sardegna (Guide d'Italia), Milano 2001
description
Transcript of Sardegna (Guide d'Italia), Milano 2001

Guide d’Italia
Touring Club Italiano
SardegnaCagliari e il golfo degli Angelile coste della GalluraBarbagie e Gennargentu
Edizione 2001
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Touring Club ItalianoPresidente: Roberto RuoziDirettore generale: Guido Venturini
Touring EditoreAmministratore delegato: Alfieri LorenzonDirettore editoriale: Michele D’Innella
Editor: Anna Ferrari-BravoCoordinamento redazionale: Gino CerviRedazione e realizzazione: Cinzia Rando e Luciana Senna con la collaborazione di GuglielmoMartinello per la selezione di alberghi e ristoranti Segreteria di redazione: Laura GueriniCoordinamento tecnico: Vittorio SironiCartografia: Servizio cartografico del Touring Club ItalianoImpaginazione di copertina: Mara Rold
Testi di: Manlio Brigaglia (Gli ambienti e i paesaggi; Sardegna: una storia che viene da lonta-no; tutti i box tranne quello di pag. 24; itinerari tematici: La grande stagione del romanico,Costumi e manifestazioni tradizionali, Un'isola di specialità enogastronomiche); Antonio Arca(Alghero, revisione di Aldo Sari); Mimma Brigaglia (Gli altri luoghi eccetto alberghi e ristoran-ti, di Il territorio di Cagliari e del Capitolo 4) Gino Camboni (Il territorio di Cagliari; Capitolo4); Gino Cervi (box di pag. 24); Barbara Fenu (Introduzione a La Nurra e il Paese di Villanova;Dal golfo dell'Asinara ad Alghero; Il Paese di Villanova e Bosa) Roberto Coroneo (Il percorsostorico e artistico e relativo box); Franco Fresi (Introduzione a La Gallura; Verso TempioPausania; La Costa Smeralda e il Nord); Attilio Mastino (Testo di Bosa); Antonello Mattone(Capitolo 9); Geltrude Piquereddu (Capitolo 7); Salvatore Pirisinu (Capitolo 8); LudovicaRomagnino (Introduzione a Cagliari e il suo territorio; Cagliari: Castello; La città bassa);Antonio Sanciu (Capitolo 6; Porto Torres); Eugenia Tognotti (Introduzione a Olbia e il suogolfo; L'Arcipelago della Maddalena; Tempio Pausania); Salvatore Tola ( Sardegna: come visi-tarla; Capitoli 3 e 11; itinerari tematici La Sardegna delle spiagge e La Sardegna delle monta-gne); Luisanna Usai (Capitolo 2); Raimondo Zucca (Capitolo 5).
Hanno contribuito inoltre:Il decumano, per la revisione redazionaleStudio Tragni, per l'impaginazioneRossella Barresi / Realy Easy Star, per la ricerca iconograficaGiorgio Pomella, per la tavola alle pagine 106-107
Fotografia di copertina: Isola dell’Asinara, cala d’Arena (Egidio Trainito)
Grande cura e massima attenzione sono state poste, nel redigere questa guida, per garantirel'attendibilità e l'accuratezza delle informazioni. Non possiamo tuttavia assumerci la respon-sabilità di cambiamenti d'orario, numeri telefonici, indirizzi, condizioni di accessibilità oaltro sopraggiunti, né per i danni o gli inconvenienti da chiunque subiti in conseguenza diinformazioni contenute nella guida.
Direttore della pubblicità: Claudio BettinelliUfficio pubblicità: Angela RossoConcessionaria della pubblicità: Progetto Milano, piazza Fidia 1, t. 0269007848, fax 0269009334Trento, via Grazioli 67, t. 0461231056, fax 0461231984; Roma, viale del Monte Oppio 30, t. 064875522, fax [email protected]
Prestampa: Emmegi Multimedia, MilanoStampa e legatura: G. Canale & C., Borgaro Torinese (Torino)Stampa copertina: Publinova Italiana, Rozzano (Milano)
Touring Club Italiano - corso Italia 10, 20122 Milanowww.touringclub.it© 2001 Touring Editore s.r.l. - MilanoCodice L17ISBN 88-365-2163-0
4a ristampa - maggio 2005
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

L’immagine della diversità della Sardegna entrò nella letteratura di viaggio ottant’anni fa,quando David Herbert Lawrence ne diede la famosa definizione di terra "che non assomigliaad alcun luogo". È un’immagine per molti aspetti ancora attuale, che neppure il flusso delturismo – che si è riversato sull’isola, a ritmo crescente, dagli anni sessanta in poi – è riuscitosostanzialmente a intaccare.È un’immagine che, tuttavia, non è di segno negativo. I visitatori mostrano di gradirla, stimo-lati a una curiosità di sapere e di scoprire che è tra gli aspetti più qualificanti del turismo nel-l’isola. I sardi, alla loro diversità, sono affezionati e in questo atteggiamento affiorano, talvol-ta, punte di orgoglio. Ne contrastano la matrice più insidiosa, quella che viene da una plurise-colare storia di isolamento, ma nel confrontarsi coi ritmi veloci della necessaria trasforma-zione non rinunciano all’attenta difesa della propria identità.Anche nella rappresentazione della Sardegna proposta dalla guida, il tema della diversità haun adeguato rilievo. Senza indulgere a facili mitizzazioni, si è cercato di non lasciare in ombranessun aspetto della sua eterogenea realtà, sottolineando che qui natura e storia, cultura esocietà hanno concorso a creare una eccezionale concentrazione di beni e richiami tra i piùamati dai visitatori.C’è la Sardegna solatia del mare e delle spiagge, di celeberrima notorietà e affollata frequen-tazione, tanto che ad essa la guida dedica un apposito e particolareggiato itinerario tematico.Ma c’è anche la Sardegna delle montagne, non solo delle Barbàgie, che si ammantano di unfascino diverso ma non meno convincente di quello costiero. Anche alla severa bellezza dellemontagne sarde la guida riserva un itinerario tematico, altrettanto particolareggiato e riccodi efficaci indicazioni.Se la fascia litoranea e i rilievi costituiscono gli elementi più rappresentativi della natura edel paesaggio con cui la grande isola è identificata, non minore significato vi rivestono altriaspetti più legati alla storia, alla cultura e all’evoluzione sociale. Tre di essi, non a caso svi-luppati a fondo nella sezione tematica, meritano qui di essere citati. Sono le manifestazionidel costume e del folclore, che in Sardegna vantano una spettacolarità e una autenticità note-voli, le specialità enogastronomiche, per le quali la regione va egualmente famosa, e natural-mente "la grande stagione del romanico", le cui espressioni potrebbero valere da sole unviaggio nell’isola. È quella, infatti, una stagione che rimanda a una delle due epoche storicheche i sardi amano ricordare con particolare fierezza: quella giudicale, in cui dall’inizio dell'XIsecolo all’inizio del XIV lo spirito di indipendenza si contrappose validamente a una lungavicenda di dominazioni. L'altra, misteriosa e remota, è "la bella età dei nuraghi", che per unmillennio e mezzo disseminò dalla Gallura all’Iglesiente migliaia di testimonianze di una cul-tura tra le più emozionanti della protostoria europea.Una delle caratteristiche precipue delle Guide verdi d’Italia è che, alla doverosa attenzionenei confronti delle tendenze del turismo maggiormente consolidate, si intreccia sempre quel-la funzione di stimolo alla conoscenza di aspetti meno noti che favorisce un costume turisti-co civile e avanzato. Su questa regola si basa anche la nuova guida che racconta e descrive laSardegna, curata nei dettagli sia per quanto riguarda i volti dell’isola più rinomati sia perquelli che, solitamente trascurati, possono riservare invece momenti di sereno appagamen-to. I piccoli paesi dell’interno, per esempio, e i musei di esigua dimensione, numerosi e sem-pre ben tenuti. Anche attraverso queste testimonianze, che esprimono il rispetto per il pro-prio passato, si riesce a conoscere e capire un territorio così denso di valori e di storia.
Roberto RuoziPresidente del Touring Club Italiano
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

4
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Sommario
8 Quadro d’unione degli itinerari di visita e indice delle carte e delle piante
10 Come consultare la guida
14 Gli ambienti e i paesaggi18 Sardegna: una storia che viene da lontano24 Box: Lingua e dialetti27 Dalla preistoria alla Sardegna contemporanea:
il percorso storico-artistico31 Box: Lo sfavillio dei retabli33 Sardegna: come visitarla36 Box: La musica tradizionale
Carta: Parchi naturali e aree protette, pag. 16
1 Cagliari e il suo territorio
38 Profilo della città39 Cagliari: Castello44 Cagliari: la città bassa49 Il territorio di Cagliari50 Box: Sa genti arrubia52 Box: Le saline di Molentàrgius
Pianta urbana di Cagliari, pagg. 40-41
2 Il Sulcis e l’Iglesiente: mare e miniere
53 Profilo dell‘area54 Da Cagliari a Sant‘Antìoco59 Le isole sulcitane
Itinerari di visitaLe descrizioni dettagliate dei luoghi di interesse turistico
IntroduzioniQuadro ambientale, storico, culturale e turistico della regione

63 Box: La Madonna dello Schiavo64 L’Iglesiente66 Box: Memoria delle miniere
Pianta urbana di Iglesias, pag. 68.Piante archeologiche: Scavi di Nora, pag. 55, e Fortezza di Monti Sirai, pag. 70; Carta delle isole di Sant’Antìoco e San Pietro, pag. 60;
3 Il Sàrrabus e il Gerrei: la montagna meridionale
72 Profilo dell’area72 Il Sàrrabus76 Il Gerrei
4 Trexenta, Marmilla e Sarcidano: la Sardegna delle colline
80 Profilo dell’area81 La Trexenta e la Marmilla84 Le Giare e il Sarcidano86 Box: I cavallini della Giara87 Intorno al monte Arci
Pianta archeologica di Su Nuraxi di Barùmini, pag. 85
5 Oristano e il Sinis
90 Profilo della città92 Oristano92 Box: La Sartiglia94 Il Campidano
di Oristano96 Box: Gli stagni
di OristanoPianta urbana di Oristano,pag. 93 Pianta archeologica di Tharros, pag. 97
6 Nelle terred’Arborèa
102 Profilo dell’area103 Da Oristano al lago Omodeo103 Box: Lussorio e i suoi fratelli108 Il Montiferru
Tavola del nuraghe Losa di Abbasanta, pagg. 106-107
7 Nùoro
112 Profilo della città113 La città e il monte Ortobene115 Box: Il parco letterario Grazia Deledda
Pianta urbana di Nùoro, pag. 114
5
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

6
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
116 Profilo dell‘area117 Da Nùoro all’Ogliastra122 L’Ogliastra e le Barbàgie126 Tra Nùoro e il Gennargentu127 Box: I murales di Orgòsolo128 Box: Il Carnevale132 La costiera orientale e il monte Albo
9 Sassari
135 Profilo della città136 I quartieri storici e la città ottocentesca141 Box: La Cavalcata sarda
Pianta urbana di Sassari, pag. 137
10 La Nurra e il Paese di Villanova
143 Profilo dell’area144 Al golfo dell’Asinara e ad Alghero149 Alghero152 Box: Il corallo di Alghero153 Box: Il Paese di Villanova e Bosa
Piante urbane di Alghero, pag. 150, e di Bosa, pag. 155
11 L’Anglona e il Logudoro
157 Profilo dell’area157 Da Sassari a Castelsardo161 I colli dell’Anglona164 Il Lugodoro: Montacuto, Gocèano e Meilogu167 Box: L’intramontabile sughero
12 La Gallura: il granito nel vento
170 Profilo dell’area171 Olbia e il suo golfo174 Verso Tempio Pausania176 Box: Le tombe di giganti178 La Costa Smeralda e l’estremo Nord

7
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
182 L’Arcipelago della Maddalena
185 Box: Garibaldi e CapreraPianta urbana di Olbia, pag. 171; Carte della Baia di Porto Cervo, pag. 180, e dell’Arcipelago dellaMaddalena, pag. 183
Itinerari tematici
187 La Sardegna delle spiagge, carta a pag. 189193 La Sardegna delle montagne, carta a pag. 189198 La grande stagione del romanico, carta a pag. 199201 Costumi e manifestazioni tradizionali, carta a pag. 202204 Un’isola di specialità enogastronomiche
208 Gli altri luoghi: alberghi, ristoranti, curiosità. Orari e indirizziIl compendio delle notizie utili e di carattere pratico
236 Indice dei nomiI principali personaggi storici e gli autori di opere d’arte citati nella guida
238 Indice dei luoghi e delle cosePer la rapida individuazione delle località e dei monumenti
Referenze iconograficheArchivi Alinari/Archivio Seat: pag. 31, 61, 134, 138, 142; R. Brotzu: pag. 35, 36, 66, 91, 104, 105,116, 118, 126, 127, 128, 154, 156, 168, 200, 203 in basso, 206 in alto e in basso; M. Lanfranchi:pag. 59, 62, 64, 121, 122, 147, 181, 182, 184, 186 in alto, 187; Realy Easy Star: 166 in alto, M.Bruzzo: pag. 34, X. Carreras: 149, G. Corte: 176, Di Paolo: 20, 22, P. Ferrer:152 in alto e in bas-so, G. Iacono: 92, A. Maisto: 6, 7, 77, 96, 113, 135, 139, 140, 141, 144, 158, 161, 162, 164, 173in alto, 177, M. Marchetti: 18, 96, A. Picone: 15, 33, V. Rossato: 86, L. Sechi: 148, 151, 160, 167,186 in basso, 205, T. Spagone: 21, 23, 25, 54, 76, 82, 115 in basso, 120, 157, 179, 201, 204, C.A.Zabert, 185; D. Ruiu: pag. 26, 53, 72, 88, 100, 112, 124, 130, 131, 132, 174, 194, 196, 197; A. Sa-ba: pag. 43, 44, 46, 48, 67, 69, 75, 79, 94, 99, 101, 103, 198; P. Sanna: pag. 14, 19, 27, 28, 42, 51,56, 65, 71, 80, 85, 90, 115 in alto, 143, 163, 165, 166, 170, 190, 203 in alto; E. Trainito: 172, 173in basso, 192, 207.
Informazioni turistiche e indici

8
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Quadro d’unione degli itinerari di visita in Sardegna
Il quadro d’unione indica, schematicamente, le aree territoriali e le tavole cartograficherelative agli itinerari di visita in Sardegna.Nell’elenco numerato sono riportati il titolo e il numero di pagina di ciascuna tavola. Le città sottolineate in rosso sono dotate di pianta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il territorio di Cagliari, pag. 49
Da Cagliari a Sant’Antìoco per la Costa del Sud, pag. 57L’ Iglesiente, pag. 57
Il Sàrrabus, pag. 73Il Gerrei, pag. 73
La Trexenta e la Marmilla, pag. 81Le Giare e il Sarcidano, pag. 81Intorno al monte Arci, pag. 81
Il Campidano di Oristano, pag. 95
Da Oristano al lago Omodeo, pag. 102Il Montiferru, pag. 102
Da Nùoro a Dorgali e ad Àrbatax, pag. 119L’Ogliastra e le Barbàgie, pag. 119Tra Nùoro e il Gennargentu, pag. 119La costiera orientale e il monte Albo, pag. 119
Da Sassari al golfo dell’Asinara e ad Alghero, pag. 145Da Alghero a Bosa per Villanova Monteleone, pag. 145
Da Sassari a Castelsardo, pag. 158I colli dell’Anglona, pag. 158Il Logudoro: Montacuto, Gocèano e Meilogu, pag. 158
Il territorio di Olbia, pag. 175La Gallura tra Olbia e Tempio Pausania, pag. 175La Costa Smeralda e l’estremo Nord, pag. 175
Carte territorialiSardegna (1: 900 000), nel risguardo
anterioreLe isole sulcitane (1: 270 000), pag. 60L’Arcipelago della Maddalena
(1: 150 000), pag. 183
Carte tematicheDa non mancare: i tesori scelti
dal TCI, nel retro del risguardo anteriore
Parchi naturali e aree protette, pag. 16La Sardegna delle spiagge e delle mon-
tagne, pag. 189La grande stagione del romanico, pag.
199
Le manifestazioni tradizionali, pag. 202
I luoghi dell’archeologia, nel risguardoposteriore
Piante di cittàAlghero (1: 9500), pag. 150Bosa (1: 10 000), pag. 155Cagliari (1: 13 000), pagg. 40-41Iglesias (1: 11 000), pag. 68Nùoro (1: 16 000), pag. 114Olbia (1: 20 000), pag. 171Oristano (1: 13 000), pag. 93Porto Cervo (Baia di; 1: 20 000), pag.
180Sassari (1: 15 000), pag. 137

9
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
e indice delle carte e delle piante
Piante di aree archeologicheFortezza di Monte Sirai, pag. 70Nora, pag. 55
Su Nuraxi di Barùmini, pag. 85
Tharros, pag. 97

10
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Come consultare la guida
GèsturiDa Barùmini si prosegue verso Gèsturi(m 310, ab. 1445), il paese che possiede lapiù ampia porzione della Giara. Seguendo la via principale, dopo la bian-ca facciata della chiesetta di S. Maria Egi-ziaca (XVI sec.), si incontra il cartello gial-lo per la Giara di Gèsturi**. La strada asfaltata per il pianoro s’inerpicatortuosa sino al ciglio basaltico dove pren-
La riconoscibilità dei monumenti è facilitata dalla seguente gerarchia di valori:
Il carattere corsivo indica glialtri monumenti e opered’arte degni di segnalazione.
La guida si apre con alcuni capitoli introduttivi che delineano le caratteristicheambientali, storiche, culturali e turistiche della Sardegna, a cui seguono i capitoli de-scrittivi della regione organizzati per itinerari di visita. Chiude il volume un esaurien-te compendio di indirizzi e informazioni utili.
Molto importanti sono i riquadri, definiti da lettere e da numeri, in cui le piante risultanosuddivise, perché è a essiche si riferiscono le indicazioni poste accantoa monumenti, musei ecc. Es. S. Francesco (B1).
Il colore azzurro indica:negli itinerari di città, i monumenti, i musei, le viee le piazze di maggiorerilievo turistico; negliitinerari territoriali, i centri ai quali si suggeriscedi dedicare una sosta.
Delle località citate nel corsodegli itinerari vengonoindicati l’altimetria (m sta per metri) e, per i comuni, il numerodegli abitanti (abbreviati ab.),desunti dalle più aggiornatefonti ISTAT disponibili al momento della redazionedel volume.
Il carattere nero segnala i monumenti d’arte e i luoghi che, anche se noncontrassegnati dal coloreazzurro, risultanoturisticamente importanti.
L’asterisco singolo (*)o doppio (**) richiamal’attenzione sui luoghi e le cose che presentano, nel loro genere,rispettivamente speciale o eccezionale interesse.
L’abbreviazione f.p. dopo ilriferimento indica che il monumento si trova fuoripianta, in corrispondenza del riquadro segnalato.
L’elenco completo dei simboli contenuti nelle piante è a pag. 12.
monumenti molto interessanti(in nero)
monumentiinteressanti(in bistro scuro)
tutti gli altri (in bistrochiaro)

11
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Il corredo fotografico,selezionato tra i migliorifotografi, completa anchevisivamente le descrizionicontenute nei testi e illustra iluoghi più belli, i monumentipiù significativi e le situazionipiù tipiche dell’area.
Nei box, collocati qua e là tra gli itineraridi visita, notiziecuriose, aneddoti e altro rappresentanopiacevoli approfondimentidella visita stessa.
Nelle carte territoriali, cheaccompagnano ciascunitinerario, il percorso daseguire è indicato daltracciato in colore, lungo il quale sono segnalati i singoli luoghi dove sostareper la visita. La partenza e l’arrivo sonoevidenziati con unabandierina. L’elenco completo deisimboli contenuti in questepiante e carte è a pag. 12.
Le grandi tavole illustrative (in questa guida alle pagg. 106-107), appositamenteeseguite da un artistadisegnatore, costituiscono unostrumento per agevolare lacomprensione e la visita deicomplessi monumentali.
3.1 Il Sárrabus 3.2 Il Gerrei

12
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Informazioni turistiche
Legenda piante di città
Legenda itinerari
Alle In aggiunta alle modalità e agli orari di visita indicati, si segnala che generalmente i musei, i monumenti,le aree archeologichepossono osservare i seguenti giorni di chiusura totale: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1°maggio, la prima domenica di giugno, 15 agosto, 25 dicembre. Si tenga inoltre presente che gli orari delle chie-se non sono indicati quando non si discostano dai consueti orari d’apertura (indicativamente 8-12 e 16-19).
Sant’Antìoco K 09017Pagina 59L Pro Loco , piazza Repubblica 41, t.
078182031, 0781840592.
moAlberghi, ristoranti, campeggi e villaggiV L’Eden. Piazza Parrocchia 15, t.
0781840768, fax 0781840769. Camere 26.Aria condizionata, parcheggio. Centrale,nei pressi della Basilica, recentementeampliato e di sobria eleganza.
I Musei e istituzioni culturaliTophet. Via Tanit, t. 078183590. Visite: esti-vo (aprile-settembre) 9-13 e 15,30-19,30;invernale (ottobre-marzo) 9-13 e 15,30-18.
g Botteghe, arti e mestieriCooperativa tessitrici Sant’AntiocoMartire. Centro pilota dell’Isola, Istituto
Per i musei e le istituzioni culturalisi riportano modalità di visita, orari,giorni di chiusura in vigore al momentodella redazione dei testi e suscettibili,pertanto, di variazioni.
Come consultare la guida
Per gli altri indirizzi, cioè servizituristici, luoghi di spettacolo e di ricreazione, feste, botteghe diprodotti tipici distribuiti uniformementein tutta la regione, si riportanosoprattutto elementi di caratterizzazionee informazioni utili al loro reperimento.
Per gli alberghi è riportata la classificazione ufficiale dell’esercizioespressa nel numero di stelle. I ristoranti sono preceduti dalletradizionali ‘forchette’ (da una a cinque)che ne indicano la qualità.
Monumento molto interessante
Altro monumento interessante
Chiesa
Ufficio di informazione turistica
Parcheggio
Giardino/Ospedale
Itinerario e direzione seguita
Partenza itinerario
Arrivo itinerario
Località principale dell’itinerario
Località nei dintorni
Area urbana
Parco, riserva, area protetta
Autostrada
Strada principale
Altre strade
Chiesa/Villa
Castello/Torre
Nuraghe/Rovine, resti archeologici
Grotta/Curiosità naturali
Grande arteria di attraversamento
Via principale
Altre vie
Rampa pedonale
Ferrovia e stazione ferroviaria
Altimetria con curve di livello e quote

Introduzioni
Quadro ambientale, storico,culturale e turistico del territorio
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Se isola vuol dire non solo una terra tutta circondata dal mare, ma anche una ‘zattera’di terra sufficientemente lontana dalla terraferma, la Sardegna è, fra quelle maggiori, l’u-nica vera isola italiana. Le sue coste distano 180 km dall’Africa, 190 dall’Argentario, 230da Civitavecchia, 280 dalla Sicilia, 330 dalle Baleari, 375 da Marsiglia, 395 da Genova.Collocata fra il 41° e il 38° parallelo, è divisa quasi per metà dal 40° parallelo, che pas-sa anche (tanto per avere un’idea) a Toledo e Minorca a occidente, a Lecce, il monte Olim-po e Ankara a oriente. Delle sue due città principali, Cagliari è alla stessa latitudine diCosenza, Sassari di Salerno e Napoli.
Un’isola anticaII geologo vi dirà che la Sardegna ingloba, nel sottosuolo del Sulcis-Iglesiente (il rettangolosud-occidentale dell’isola), la zolla più antica del territorio italiano: nata qui nel Cam-briano, da 600 a 500 milioni di anni fa.Ma tutta la Sardegna è poi emersa dal mare e si è venuta plasmando in una serie di con-vulsioni vulcaniche, di sprofondamenti e di corrugazioni che l’hanno rapidamente (sifa per dire, perché sono processi che durano nell’ordine delle decine di milioni di an-ni) lavorata, limata e ‘invecchiata’. La montagna più alta dell’isola, la punta La Marmoranel massiccio centro-orientale del Gennargentu, supera di poco i 1800 metri (la vicinaCorsica ne ha di oltre 3000, con nevi quasi eterne). A un viaggiatore dell’Ottocento, l’i-sola si presentò all’orizzonte «come un vasto altopiano azzurro posato sul mare». Pae-se di molte colline e di brevi pianure (salvo la grande piana alluvionale del Campida-no, un tempo granaio dell’isola), la Sardegna ha poche montagne: e, come abbiamo det-to, di moderata altitudine.Strana contraddizione con l’impressione che invece più frequentemente il visitatore ri-ceve e gli stessi sardi amano comunicare della loro terra: un’isola-montagna, abitatada un popolo fatto quasi tutto di pastori (e pastori, in Sardegna, vuol dire ancora mon-tagna – come qua si chiama anche l’alta collina). Il fatto, spiegano i geografi (di quelliche hanno studiato la Sardegna almeno uno ne andrà evocato per nome: Maurice LeLannou, uno dei più grandi geografi francesi del XX secolo, che negli anni trenta presela Sardegna come oggetto delle sue ricerche, lasciandoci un libro indimenticabile e fon-damentale, tradotto col titolo Pastori e contadini di Sardegna), è che la montagna sar-da è tutta ‘spaccata’, fessurata, divisa da grandi gole, un tempo pressoché invalicabi-li. «La Sardegna – ha scritto Le Lannou – è come un grande mosaico di terra, le cui tes-sere siano state furiosamente scompigliate». Una montagna difficile, aspra, severa: unamontagna ‘vera’.Questa durezza della tettonica sarda ha anche avuto due conseguenze storiche, che han-
14
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Gli ambienti e i paesaggi

no operato direttamente sulle vicende e i caratteri dei sardi: ha isolato i villaggi l’unodall’altro, alimentando nei secoli la disunione e l’estraneità fra gruppi pure contigui (dun-que, impedendo la nascita di una più vasta unità nazional-regionale), e ha isolato la mon-tagna dal resto dell’isola, rendendone difficili gli accessi e spesso negando alla monta-gna più frequenti contatti con le pianure ‘civilizzate’. I romani conquistarono tutta la Sar-degna, ma per piegare i popoli della montagna impiegarono più d’un secolo: e neppu-re alla fine si sentivano del tutto sicuri diaverli addomesticati. Un grande storicofrancese parla della montagna sarda comedel «luogo della libertà, delle libere re-pubbliche pastorali». E un grandissimocome Fernand Braudel ha notato che del-l’isolamento della Sardegna – altro con-notato portante della sua storia millenaria– la montagna è responsabile nella stessamisura del mare, e forse anche di più.
I caratteri dell’insediamentoLa Sardegna ha oggi circa 1 milione 650mila abitanti. Distribuiti su una superficiedi 24 mila chilometri quadrati, fanno unadensità di 70 abitanti per chilometro qua-drato, quasi un terzo di quella italiana. Do-po la Valle d’Aosta, la provincia di Nùoro èla meno popolata d’Italia (39 abitanti perkm2). Caratteristica dell’insediamento deisardi nel territorio è, quasi dappertutto, laconcentrazione degli abitanti in grossi bor-ghi, circondati da una campagna pressochéradicalmente deserta. Solo due regioni dell’isola, la Gallura nell’estremità nord-orienta-le e il Sulcis nell’estremità sud-occidentale, conoscono quello che i geografi chiamano l’ha-bitat disperso, cioè la presenza, nelle campagne, di piccole aziende agro-pastorali costituitecome unità produttive (un tempo quasi) autosufficienti: si chiamano medàus o furria-dròxius nel Sulcis, stazzi (dal latino statio, ‘luogo dove ci si ferma, dove si sta’) nella Gal-lura. Punteggiano le campagne o svettano sulle colline con le loro bianche facciate, il gro-viglio dei recinti per il bestiame, i piccoli pezzi verdi di orto e di vigna. Negli ultimi cinquant’anni la Sardegna ha conosciuto due fenomeni importanti (il chenon vuol dire immediatamente anche positivi): il primo è stato un imponente inurba-mento, che ha visto le città e i centri maggiori crescere a ritmo sostenuto, con tutti i pro-blemi di infrastrutture civili e di qualità della vita che questa corsa alla città porta sem-pre con sé; il secondo è stata la nascita del turismo, come conseguenza della eradica-zione della malaria (terribile male endemico che ha angustiato i sardi per quasi tre mil-lenni), e l’intensificarsi delle abitazioni (più seccamente: del cemento) sulle coste un tem-po pressoché inabitabili.Cagliari ha oggi, all’anno 2000, 168 000 abitanti: ne ha avuto anche più di 200 000, ma dalcorpo centrale si sono staccati molti sobborghi, diventati comuni autonomi; e anzi si cal-cola che la conurbazione cagliaritana superi oggi i 400 000 abitanti. Quartu, così conti-gua a Cagliari che è ormai impossibile distinguere i confini fra i due centri, è con i suoiquasi 70 000 abitanti la terza città dell’isola. Sassari ne ha 130 000, gli altri due capoluoghidi provincia, insieme, altri 70 000 (38 000 Nùoro, 33 000 Oristano). Olbia, spinta dallo svi-luppo del turismo, me ha 44 000, Alghero 40 000.Quasi un terzo della popolazione vive raccolta negli agglomerati urbani: la campagna,che già colpiva i visitatori del passato per i suoi grandi silenzi, è ancora più deserta. Esiccome in questi stessi ultimi cinquant’anni due sardi su cinque hanno abbandonatoi paesi dove erano nate e vissute le generazioni dei padri e dei nonni, i piccoli comunisono diventati anche più piccoli e hanno visto moltiplicarsi i problemi dei servizi es-senziali (tre per tutti: la scuola, l’assistenza medica, il sistema dei trasporti). Gran parte di loro hanno reagito rivalutando orgogliosamente le radici della propria iden-tità particolare: quasi tutti i paesi della Sardegna hanno oggi piccoli (e spesso intelligenti)musei archeologici o etnografici, della vita contadina o dell’abbigliamento tradizionale.
15
Gli ambienti e i paesaggi
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

16
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Gli ambienti e i paesaggi
17
Queste cifre e queste considerazioni per introdurre il lettore ai grandi spazi che carat-terizzano il paesaggio sardo: tanto sulle coste, con le loro frastagliate sequenze di spiag-ge e di rocce, quanto nell’interno, dove dalle pianure litoranee si sale rapidamente ver-so la collina o, nella Sardegna centro-orientale, verso la montagna.La geografia, e con essa la storia, hanno lavorato a dividere l’isola in zone fortementecaratterizzate, ciascuna con la sua vicenda passata, la sua economia presente, diverseperfino nelle varianti della lingua regionale e diverse, sino a qualche decennio fa, nellostesso modo di vestire nella quotidianità e più nelle feste (le grandi sagre-rassegne incui i sardi indossano i loro costumi ne sono la testimonianza visiva più efficace).Ognuna di queste sub-regioni ha una sua specificità: del paesaggio e della gente. Sicché,talvolta, parlare di Sardegna come di un tutt’uno, di una entità indistinta, se non è pro-prio una comoda astrazione certo presuppone una sintesi di impressioni, di tratti, di sug-gestioni che sono di singoli “segmenti” dell’isola. Negli ultimi anni cinquanta un libro for-tunato, che fece un po’ da incunabolo non soltanto a tutta la letteratura turistica sull’isolama anche allo stesso avvio di una qualche attività nel settore, era intitolato Sardegna qua-si un continente. Il titolo rende bene questa immagine di una terra mossa, dove la suc-cessione dei paesaggi e la differenza fra area e area sono recuperate da alcuni tratti fon-damentali: il silenzio, gli spazi, il verde della campagna e della montagna, il senso di unavita naturale e umana semplice e a tratti anche severa.
Le regioni nella regioneAl viaggiatore che arriva in Sardegna dal nord (dove sono i grandi porti di Olbia, GolfoAranci e Porto Torres, e gli aeroporti di Olbia-Costa Smeralda e Alghero-Fertilia) è so-prattutto la Gallura a dare l’impressione di questa vastità e diversità insieme. Dai pri-mi anni sessanta, quando sui bordi del mare gallurese nacque la Costa Smeralda – de-stinata a diventare in breve il punto di attrazione di un turismo d’élite, ma anche l’im-magine-copertina di un’intera isola di vacanze – le rocce e il mare della Gallura sono en-trati a far parte dell’immaginario collettivo del turista, italiano o straniero che fosse. Ipossenti contrafforti di granito, che arrivano sino al bordo del mare, modellati in mil-le forme dalla forza erosiva del vento, delle onde e della pioggia, appartengono in realtàquasi soltanto a questa cuspide nord-orientale dell’isola: anche se una catena di mon-tagne granitiche si svolge lungo tutta la costa tirrenica. Il Logudoro, a nord-ovest, è in-vece regione di brevi pianure e dolci colline. Il suo nome (logu de oro, il ‘luogo dorato’)gli sarebbe venuto dal biondo delle messi, quando un po’ dappertutto, nell’isola, si col-tivava il grano: è una delle regioni più “storiche”, protesa dal mare settentrionale sin ver-so il centro dell’isola. I suoi abitanti si vantano (non correttamente, secondo i filologi)di parlare il ‘vero’ sardo. Il Gocèano è la zona di transizione verso la montagna centra-le: e intanto si affaccia sulla valle del Tirso (il padre dei fiumi sardi, ma i fiumi in Sardegnasono sempre assediati dalla siccità) dall’erta costa del suo Màrghine, dove i piccoli cen-tri stanno arroccati verso le foreste delle cime. A occidente la Planargia (terra d’altopiano)scende da Macomèr verso il mare di Bosa. Il centro della Sardegna è, paradossalmen-te, spostato a oriente: è il grande acrocoro del Gennargentu, il cuore di pietra dell’iso-la, regno dell’economia e della vita pastorali, che i sardi sentono come un nucleo, un no-do saldo di patria all’interno della più grande patria regionale. Dopo l’altopiano di Ab-basanta e le creste vulcaniche del Montiferru, nella Sardegna meridionale si apre il gran-de corridoio del Campidano, orlato a oriente dalla catena del monte Arci e a occiden-te, man mano che si scende verso il mare di Cagliari, dalle montagne dell’Arburese, del-l’Iglesiente e del Sulcis, sacre alle memorie del lavoro minerario. Il Campidano fu per se-coli destinato alla cerealicoltura, granaio dei conquistatori di turno; oggi ha saputo con-vertirsi all’agricoltura intensiva e ha già al suo attivo numerose esperienze nel campodelle colture biologiche. Dal Campidano si può risalire, volgendo a ovest, la valle del Cixer-ri, che porta all’Iglesiente e al Sulcis (con i loro ricordi di Cartagine, di Roma e del me-dioevo, ma anche con litorali fra i meno toccati dell’isola), oppure, prendendo a est, ar-rivare alla imponente costa dell’Ogliastra attraverso i paesaggi contadini della Marmillae della Trexenta o la “piccola Svizzera” delle groppe montane del Gerrei.Abbiamo fatto una corsa a perdifiato dal nord al sud dell’isola: una sintesi troppo veloce,ma i singoli quadri regionali che formano il corpo di questa guida daranno meglio ragionedi tutte le specificità che, messe e ‘godute’ insieme, fanno della Sardegna un’isola diversa,che si vanta di questa sua diversità.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Più ancora della geografia, sono state le lunghe vicende della storia a conferire alla Sar-degna i tratti essenziali della sua identità. Della storia e anche della preistoria.La preistoria sarda comincia intorno al 14 000 avanti Cristo: nel senso che è a quella da-ta che si collocano i primi avanzi di qualcosa di ‘umano’, ritrovati in una grotta del Nuo-rese (famosa perché si dice che lì avesse eletto il suo temuto rispettatissimo rifugio unasorta di ‘patriarca’ del banditismo sardo di fine Ottocento: in Sardegna tutta la storia sem-bra svolgersi in un’infinita linea di continuità, l’archeologia finisce alle soglie della sto-ria contemporanea). In realtà, non è da molti anni che gli studiosi dell’antichità sardahanno indicato in alcune pietre d’un greto di torrente presso Pèrfugas (nella Sardegnasettentrionale, ai bordi della Gallura), scheggiate al modo clactoniano (come lo chiamanogli specialisti, dal nome della località inglese in cui per la prima volta ne furono trova-te e individuate di simili), le tracce dell’uomo sardo del Paleolitico inferiore, un’età cheva da 200 a 150 000 anni fa.
La bella età dei nuraghiMa la preistoria vera, quella più gremita di frequenze e di presenze umane, si fa inizia-re intorno a 6-5000 anni prima di Cristo, e la si segue nel suo svolgimento lungo tutto ilNeolitico sino al 1500 quando inizia quella che Giovanni Lilliu – il maestro degli archeologisardi – chiama «la bella età dei nuraghi». In quei tre-quattro millenni che dura il Neoli-tico, gli studiosi individuano, nell’isola, il susseguirsi di una serie di culture ognuna del-le quali prende nome, in genere, dalla località in cui per la prima volta sono state trovate
le testimonianze che piùoriginalmente la connota-no: così, una dopo l’altra, lacultura di S. Michele (è ilnome di una grotta di Ozie-ri: ma monumenti e restidi quella ‘cultura’ si trova-no in tutta l’isola), quella diAbealzu-Filigosa, quella diMonte Claro e di Bonnàna-ro (in mezzo, anche la cul-tura detta del Vaso campa-niforme). Quando, a parti-re dalla prima metà del se-condo millennio a. C., scop-pia l’età nuragica, i suoimonumenti coprono, sipuò dire, l’intero territorioisolano. Sono 7 mila torri,
in pietra scura di trachite o basalto, che dominano – allineate nella gran parte sui cri-nali delle colline – l’intero paesaggio sardo. In alcune aree se ne contano più di uno perkm2. Costruiti con grandi massi sovrapposti in file circolari tenute insieme dalla sola for-za di gravità, alti spesso sino a 20 metri, non sono soltanto una sorta di monumento-mar-chio della Sardegna. Sono anche l’emozionante testimonianza di una vicenda che,svolgendosi per quasi un millennio, ha lasciato un patrimonio sterminato di monumentie di memorie: dalle sepolture dette tombe di giganti (tanto grandi e forti si pensava chene fossero i costruttori) ad alcune centinaia di piccole statue in bronzo, in cui il popo-lo nuragico è ritratto con i suoi capitribù, i guerrieri, gli arcieri, i sacerdoti, i pastori, glianimali. Eppure queste manifestazioni di vita associata, di senso religioso, di modi di la-vorare, di conoscenze tecnologiche, di articolati assetti sociali, di fantasia architetto-nica e plastica – che ben meritano, tutte insieme, il nome di civiltà – non sono arrivatea costruire una nazione: e meno ancora uno Stato. La civiltà dei sardi nuragici fu emi-nentemente ‘cantonale’, cioè frammentata in tante piccole comunità (clan, tribù), se-parate anche dalla tormentata orografia dell’isola. Ne è derivata, sin dalle origini, come
18
Sardegna: una storia che viene da lontano
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

una debolezza (politica, civica) che sembra aver poifunzionato come una costante di tutta la storia isolana. Grotticelle, Tombe di giganti, nuraghi (e, prima di loro,ancora dolmen e menhir), l’intero patrimonio dellamonumentalità preistorica è ‘in campagna’. Un altro de-ficit della civiltà nuragica – e di tutte le culture che l’han-no preceduta – è che essa non arrivò mai a creare lacittà: il massimo dell’insediamento si espresse in villaggidi cento-duecento capanne al massimo, spesso raccolteai piedi d’un nuraghe. Questa ruralità della preistoriasarda fa sembrare il paesaggio dell’isola ancora più an-tico. È un effetto curioso, ma esiste. E permane comeuna sensazione profonda nel visitatore. Isolamento, in-sularità, antichità della terra, ruralità della preistoria,severità del paesaggio e del carattere: sono già alcunelinee di rotta per capire meglio la Sardegna e le direttricistesse della sua storia. Che è, dopo il periodo felice del-l’indipendenza nuragica, quasi tutta storia di domina-zioni e invasioni
Le prime invasioniComincia con i fenici, intrepidi viaggiatori di tutto il Me-diterraneo. Collocata al centro del bacino occidentale,non troppo lontana dalle altre terre abitate, la Sardegnaera un’isola-scalo ma anche, a quei tempi, un’isola ric-ca di risorse. La prima materia sarda a essere esportatafu l’ossidiana: una pasta vulcanica, nera dura e vetro-sa, atta a cento usi (primo fra tutti, a farne punte di freccia). Ne ha vasti giacimenti il mon-te Arci, che domina a oriente la pianura del Campidano, seguendo con le sue creste ar-rotondate il lento svolgersi della piana subito dopo Oristano. Partendo dall’isola, quel-la ossidiana circolò praticamente per tutto il mondo occidentale allora conosciuto: gliarcheologi l’hanno chiamata, con efficace immagine, l’«oro nero dell’antichità». Ma i fe-nici venivano a cercare anche altre cose: come le cercavano in tutto il Mediterraneo, fre-neticamente scambiando tutto quello che c’era da maneggiare e scambiare. Arrivaro-no nell’isola intorno al 1000 avanti Cristo: i loro insediamenti si fecero sempre più sta-bili e costruiti, rispetto ai primi scali, sicché quando Cartagine e poi Roma s’acquar-tierarono nell’isola, le loro città andarono a posarsi sui resti e le strutture delle primi-tive città fenicie.Ai cartaginesi questa successione dovette riuscire più facile: i cartaginesi erano infat-ti i fenici d’Occidente: la parola romana punici viene, come si sa, dalla stessa parola phói-nix (nome greco della conchiglia da cui si tingeva la porpora) che è anche alla radice del-la parola fenici. I cartaginesi arrivarono in Sardegna intorno al 550 a.C. Il loro insedia-mento fu molto più stabile ed esteso. Nacquero così le prime città della storia sarda, qua-si tutte disposte lungo il sud-ovest isolano, quasi in linea (di mare) con Cartagine: da Ca-gliari (forse Kàrales, roccia, collina) sino a Tharros, passando per Nora, Bithia, Sulci. Fat-ta eccezione per Bithia, di tutte le altre città esistono ancora ruderi imponenti, sebbe-ne nascosti dalle sovrapposte architetture d’età romana. La dominazione cartaginese– che peraltro non fu così pervasiva e totalizzante come sarebbe stata quella romana –durò solo due secoli: eppure la storia sarda ne fu così segnata che ancora oggi s’accendeogni tanto una polemica sulla quantità di debiti che il carattere dei sardi ha verso queilontani antenati. Perfino l’idea fondamentale della vita e della morte verrebbe, ai sardi,più dai culti di Tanìt e di Ashtart, divinità dell’Olimpo fenicio-punico, che dalla filosofiaromana o dalla stessa religione cristiana.
Mille anni di RomaI romani arrivarono in Sardegna nel 238 a.C., nell’intervallo fra la prima e la seconda guer-ra punica, col pretesto dell’inosservanza d’una clausola del trattato di pace. Roma ri-mase in Sardegna non solo sino al 476, anno canonico della caduta dell’Impero d’Occi-dente, ma anche ben oltre, attraverso l’appartenenza dell’isola – per il tramite della pro-vincia d’Africa, di cui fece parte – all’Impero romano d’Oriente. Qualcosa come quasi mil-
19
Dall’età nuragica alle prime invasioni
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

le anni di romanizzazione: le cui tracce sono profondamente incise soprattutto nella lin-gua sarda, la più latina delle lingue neolatine. Roma, che pure in città come Cagliari ave-va lasciato sopravvivere religione e perfino magistrati punici, estese in ogni angolo del-l’isola la sua presenza attraverso insediamenti di guarnigioni militari e una straordina-ria rete di grandi strade che mise in collegamento le città del Sud – e in particolare Ca-gliari, che proprio sotto Roma venne assumendo quel ruolo di città-leader che avreb-be poi conservato (e rafforzato) nei secoli – con le nuove realtà del Nord, dove eranonate città come Olbia e Turris Libisonis (l’attuale Porto Torres), abitata da famiglie dicoloni e magistrati romani. C’era solo la zona della montagna a opporre una lunga re-sistenza: non per niente i romani indicavano quelle terre come popolate dalle civitatesBarbariae, dove il termine Barbària, da cui deriva alla regione intorno al Gennargentuil nome attuale di Barbàgia, segnala il difficile rapporto fra i conquistatori e le genti del-la montagna sarda.Per Roma la Sardegna era importante, e per molti motivi. La sua collocazione geogra-fica ne faceva l’ideale testa di ponte verso l’Africa e perfino verso la Spagna. Le montagnedel Sulcis-Iglesiente erano già famose dai tempi dei fenici per i loro giacimenti di piom-bo e d’argento: spesso Roma mandava ad metalla i ‘devianti’ dell’Urbe. E soprattutto c’e-ra il Campidano, una pianura lunga cento chilometri e larga venticinque, dove già i car-taginesi avevano proibito, pena la morte, che si piantassero alberi per lasciare tutto lospazio e tutto il sole alla coltivazione del grano. Con la Sicilia e l’Africa, la Sardegna era,come diceva Cicerone, uno dei tria granaria Reipublicae subsidia firmissima, solidissimogranaio della Repubblica. Anche da Bisanzio vennero alla Sardegna pezzi importanti del-
la sua civiltà: l’esperienza del monachesimo e della re-ligiosità orientali, nuove magistrature e una diversa or-ganizzazione dell’amministrazione statale, colture nuo-ve (per esempio, si dice, il fico), architetture chiesa-stiche, l’uso (presto dimenticato) della lingua greca,perfino l’onomastica bizantina: i sardi arrivarono a
eleggere santo, a furor di popolo, l’imperatore Co-stantino, al quale è dedicato il più famoso santuario sar-
do e in onore del quale si celebra ogni luglio la più dram-matica e animata delle feste equestri isolane.
Dall’alto medioevo ai giudicatiMa c’è, nella storia della Sardegna, un ‘bu-co nero’ di quasi mezzo millennio, che vadal 500 d.C. (in questo periodo si collocauna passeggera, ma anche crudele domi-nazione vandalica) sin verso il Mille. La fu-ria predatoria delle flotte arabe radica-lizzò l’isolamento di una terra già isolatadalla sua stessa geografia. Quando co-minciano a riaffiorare i primi documentiscritti, la Sardegna ci appare già divisa inquattro territori sostanzialmente sepa-rati uno dall’altro e praticamente ormai in-
dipendenti dalla lontana, irraggiungibile Bisanzio. Si chiamano giudicati, e giudici, ju-dikes, i loro signori e alla memoria di questi piccoli e automi Stati i sardi affidano vo-lentieri anche oggi (come all’altro periodo eroico, quello nuragico) i titoli del propriospirito regionale (e regionalistico).I giudicati si chiamano, dai loro territori o dalle città principali, di Logudoro (o Torres)e di Gallura a nord, di Arborèa (con capitale a Oristano) e di Cagliari a sud. Sulla loro ori-gine si sa ancora poco. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di una divisione del ter-ritorio operata per motivi di controllo amministrativo e politico (e di difesa), in cui quel-la che potrebbe essere stata un’unica potente famiglia patrizia di Cagliari (i de Làcon,forse) avrebbe distribuito fra i propri componenti le diverse ‘province’ di quello che era,all’inizio, un unico possedimento. Ma la caratteristica più interessante di questi nuoviStati è appunto la loro novità: pur riecheggiando modelli di statualità e di organizzazionesociale presenti nell’Europa loro contemporanea, i giudicati se ne discostano per dareluogo a una società in parte anche democratica (le coronas de logu, cioè le assemblee
20
Sardegna: una storia che viene da lontano
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

dei maggiorenti del territorio, coadiuvano il signore nel governo del rennu, del regno),ma in parte anche più arretrata di quella europea: non esiste il feudalesimo, ma la mag-gioranza della popolazione è di servi, tenuti alle più diverse specie di tributi e di servizi.Rapidamente i giudici entrano nel mirino di altre potenze continentali. Nel 1016 una sor-ta di grande crociata navale bandita dal pontefice per liberare la Sardegna dalle incur-sioni dei mori, sempre più frequenti negli ultimi tre secoli, vede Pisa e Genova prima scon-figgere il potente emiro Mugiahid al-Amiri poi invadere l’isola con i loro mercanti e le lo-ro famiglie patrizie, che si legano ai signori sardi in una fitta rete di alleanze politiche,commerciali e matrimoniali. Arrivano in Sardegna, in questo stesso periodo, anche gliordini monastici, chiamati dai giudici a coltivare la terra e a insegnare la fede di Romaa popolazioni che hanno conosciuto, semmai (e in tempi di scisma), l’osservanza del-la Chiesa orientale. Energici lavoratori, bonificatori indefessi, educatori del popolo, i mo-naci creano nell’isola potenti centri di riferimento, il cui nucleo è costituito spesso danuove, grandi chiese, figlie del romanico, che essi innalzano coraggiosamente nella stes-sa campagna in cui si sono insediati.
Genova, Pisa, Aragona e SpagnaDei giudicati, tre scompaiono prima della fine del Duecento: Gallura e Cagliari divisi pereredità fra potenti signori d’oltre Tirreno (gli ultimi signori di Gallura sono i Visconti pi-sani, come quell’Ugolino-Nino che Dante ricorda nel suo Purgatorio, quello di Logudo-ro frantumato dal rapido svilupparsi di una nuova città presto eretta a libero Comune,Sassari, formatasi alle immediate spalle del porto di Torres, in una zona più sicura, me-no malarica e più ricca di acque e di terreni fertili. Un Comune libero in libertà ‘condi-zionata’: prima sotto la protezione di Pisa, che vi manda i suoi podestà, poi sotto Genova(ma alcune grandi famiglie liguri hanno già stabilito forti teste di ponte nel nord dell’i-sola, dove i Doria hanno fondato Castelgenovese – oggi Castelsardo – e la città-fortez-za di Alghero, e i Malaspina controllano centri importanti come Òsilo e Bosa).L’unico giudicato che sopravviva è quello di Arborèa. Gli abitanti di Tharros si sono tra-sferiti a Oristano portandosi appresso, si dice, non solo l’arcivescovo ma anche le pie-tre della città romana. I signori si sono imparentati con la potente famiglia catalana deiBas-Serra, e molti dei loro figli sono educati alla corte di Barcellona.Nel 1297, per dipanare l’aggrovigliata matassa di problemi internazionali creati dallaguerra dei Vespri, papa Bonifacio VIII cede la Sardegna in feudo a Giacomo II d’Arago-na. Così nel 1323 il principe ereditario Alfonso sbarca in Sardegna con una potente ar-mata e nel giro di pochi mesi s’impadronisce dell’isola. Padrone, o quasi: perché il giu-dice di Arborèa, che era stato suo alleato al momento dell’invasione, diventa quasi im-
21
L’età giudicale
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

provvisamente il principalenemico degli aragonesi sino acapeggiare una lunga solleva-zione, praticamente estesa atutte le zone della Sardegna. Èquella che alcuni storici sardichiamano, magari con unapunta di esagerazione, una‘guerra di liberazione nazio-nale’. Dietro il vessillo d’Ar-borèa (che ha al centro l’al-bero sradicato che diventeràquasi il simbolo della resi-stenza sarda) comunità, tribù,piccoli eserciti si organizzanoper opporsi al conquistatore:che intanto, come premio del-la conquista, ha spartito i tre-
cento villaggi dell’isola fra i nobili catalani che lo hanno accompagnato nell’impresa.Così la Sardegna conosce ora quel feudalesimo che è scomparso da qualche secolo inquasi tutto il resto d’Europa.La resistenza arborense dura sino al 1409, anno della battaglia di Sanluri. Arborèa diventaun marchesato, finisce la stirpe dei suoi giudici: eppure ancora nel 1478 un loro lonta-no discendente rialzerà la bandiera della rivolta. Occorrerà batterlo in campo aperto,a Macomèr, per poter considerare definitivamente domata la Sardegna, proprio negli stes-si anni in cui, per il matrimonio fra Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, cominciaquella che si chiama l’età della Sardegna ‘spagnola’.Resta, del periodo giudicale, il ricordo sempre affascinante di una libertà e di un’auto-nomia che saranno vagheggiate nei secoli avvenire come un diritto inestinguibile dei sar-di. E resta la memoria della grande Eleonora che, giudicessa d’Arborèa durante la pri-gionia del marito, non solo continuò a guidare imperterrita la guerra ‘nazionale’, maemanò anche, intorno al 1392, un codice di leggi conosciuto come Carta de logu (il ‘co-dice del territorio’ arborense). Aragona lo estenderà di lì a qualche anno a tutta la Sar-degna rurale e durerà in vigore sin quasi il 1830. Si dice che perfino Caterina di Russiainvidiasse, a distanza di secoli, quella donna sarda così guerriera e così saggia.Il periodo spagnolo è considerato, dai sardi, quello in cui l’isola conosce – sotto il go-verno dei viceré che seggono a Cagliari (la Sardegna è un regno per decreto pontificio)– il suo periodo più infelice: pesti, carestie, spopolamento, povertà; nelle città l’arroganzadei funzionari spagnoli, nei paesi l’inesausto bisogno di denaro dei feudatari (gran par-te dei quali abitano in Spagna) e dei loro ufficiali. Il dominio spagnolo dura sin verso il1720, quando, a conclusione di una serie di guerre (prima fra tutte la guerra di succes-sione spagnola), l’isola passa – dopo una breve parentesi di presenza asburgica – nel-le mani dei Savoia, costretti dalla pace dell’Aja a cedere la ricca Sicilia (da cui hanno ot-tenuto il titolo di re) in cambio della povera Sardegna. Finiscono così quattro secoli incui i sardi sono vissuti nell’orbita non solo d’un potere iberico ma anche della culturae della civiltà di Spagna: i rapporti con l’Italia non si sono mai interrotti (sebbene qual-che legge li vietasse espressamente), ma le istituzioni, la lingua, la letteratura, la religiosità,le tendenze dell’arte e perfino alcuni elementi ‘archetipici’ del carattere spagnolo la-sceranno tracce profonde nella civiltà della Sardegna. Il bilancio ha anche qualche vo-ce attiva, come la fondazione delle due Università di Sassari e Cagliari tra fine Cinque-cento e inizi del Seicento, l’affascinante produzione dei retabli, e come la stessa esistenza(secondo le usanze prima di Aragona e poi di Spagna) di un Parlamento che esercita unaqualche funzione ‘nazionale’ di rappresentanza del popolo sardo (o, se si vuole, dellesue classi dominanti).Ma il lascito più originale e fascinoso dei quattro secoli catalano-spagnoli è un’intera città.Ancora oggi Alghero, pure fondata dai Doria a immagine di una città fortificata di tipogenovese, è chiamata Barceloneta, la piccola Barcellona. Carlo V, che fu qui di passag-gio nel 1541, la trovò «bonita y bien asentada», graziosa e felicemente collocata. Alghe-ro lo è ancora oggi che è diventata, come diceva uno slogan degli anni pionieristici, «laporta d’oro del turismo sardo».
22
Sardegna: una storia che viene da lontano
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

La Sardegna piemonteseLa Sardegna fu piemontese per quasi centocinquant’anni, sino all’Unità. In realtà si po-trebbe dire che fu il Piemonte a essere sardo, visto che dalla Sardegna prendeva nomeil nuovo regno. Ma piemontesi erano i monarchi, i viceré, gli alti magistrati, i grandi fun-zionari: il destino della Sardegna veniva deciso, un giorno dopo l’altro, più a Torino chea Cagliari. E perché non ci fossero equivoci, i Savoia non convocarono più il Parlamen-to che pure, al momento dell’acquisto dalla Spagna, si erano impegnati a convocare ognidieci anni, come si era fatto nel passato.All’inizio, in realtà, i Savoia non volevano tenersi quell’isola lontana, spopolata e malarica,praticamente priva di risorse, più bisognosa d’aiuto che capace di contribuire al redditodello Stato. Poi, a partire dal 1743, il conte Gian Lorenzo Bogino, ministro di Carlo Ema-nuele III, cominciò a introdurre elementi d’un cauto ma sapiente riformismo: furono ria-perte le Università, travolte nel Seicento dalla crisi dello smisurato impero spagnolo; fu-rono riformati e rafforzati i consigli ‘comunitativi’, antenati delle moderne assemblee ci-viche; furono creati i Monti frumentari, per incrementare l’agricoltura con prestiti in gra-no e attrezzi, e i Monti nummari per far girare un po’ di denaro fra i contadini.Ma, morto il re, il figlio Vittorio Amedeo III, nel momento stesso in cui gli succedeva, li-cenziò il Bogino. La Sardegna era ancora nelle mani di un centinaio di feudatari: solo lecittà maggiori (esse stesse ‘baronesse’ della campagna circostante) ne erano esenti, ealcune di loro profittavano di questa condizione per crescere con istituzioni scolastichee iniziative commerciali. Tempio diventa sempre più importante in Gallura, mentre la re-gione tutta intorno si va popolando di coloni, molti dei quali provenienti dalla Corsica:il dialetto gallurese nasce così, come il corso, su radici toscane; viene fondata Carloforte(1738), popolandola con coloni d’origine ligure che ancora oggi conservano parlata ecostumi d’un tempo, e viene occupato l’arcipelago di La Maddalena (1767), dove cresceràpresto una robusta piazzaforte militare marittima; Bosa schiera sui bordi del fiume Te-mo le sue attive concerie; Nùoro e Ozieri si sviluppano da grossi borghi a piccole città(e tali lo stesso Carlo Alberto le consacrerà nel 1836).Il secolo dei Lumi finisce in Sardegna, come nel resto d’Europa, fra le fiamme della ri-voluzione. Anzi, di quella che si chiamò “la sarda rivoluzione”, un vasto moto antifeu-dale, animato da intellettuali borghesi di città, da pastori e contadini di paese, da co-raggiosi parroci di villaggio: ma il suo capo, Giommaria Angioy, giudice della massimamagistratura isolana, sconfitto, fu costretto all’esilio (morì aParigi nel 1808, dopo aver inutilmente cercato di.convincere igoverni francesi a ‘liberare’ la Sardegna).
Il difficile OttocentoGli anni-chiave dell’Ottocento sono i decenni centrali del se-colo: nel 1839 prende concretamente corpo un editto, giàemesso nel 1820, che permette a chi possiede la terra dichiuderla con muri, siepi o fossati (di qui il nome di edit-to “delle chiudende”), nella speranza di attivare laformazione di una piccola borghesia agrariaimprenditrice; nel 1836-39 viene abolito ilfeudalesimo; fra il 1859 e il 1865 vengonoaboliti gli ‘ademprivi’, cioè i diritti che le co-munità avevano sulle terre feudali e demaniali.Sono tre grandi serie di provvedimenti legislativi,volti (come altre misure coeve) ad allineare il più ra-pidamente possibile la Sardegna al resto d’Europa o,come minimo, al resto (continentale) del Regno diSardegna. Ma sono leggi che sconvolgono, nell’isola, as-setti plurisecolari: con esiti, nella gran parte dei casi, chevanno nella direzione opposta a quella per la quale era-no stati pensati. L’abolizione del ‘comunismo’ agrario noncrea la borghesia imprenditrice, solo consegna ai possi-denti di paese la possibilità di far pagare più cari i fitti deipascoli: nasce una nuova classe, ma parassitaria e as-senteista, s’invelenisce l’antico antagonismo fra pa-stori e contadini, molti terreni sono più usurpati
23
Dal governo spagnolo a quello piemontese
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Sardegna: una storia che viene da lontano
24
Tra gli idiomi che hanno avuto originedal latino, il sardo è quello che ha mag-giormente conservato tratti della linguamadre. Lo storico isolamento della re-gione - diverso peraltro a seconda delle treprincipali varietà dialettali: il campida-nese, al sud, e il gallurese-sassarese alnord, più permeabili all’influenza toscana;il logudorese, al centro e nelle zone mon-tuose dell’interno, assai più resistente earcaico - ha preservato il sardo da feno-meni evolutivi che hanno determinato in-vece le sorti linguistiche di altre aree ro-manze: quasi assente, ad esempio, l’in-flusso delle lingue germaniche, come pu-re solo superficiali i contatti con greco oarabo. Per limitarci soltanto all’ambitolessicale, numerosi sono i vocaboli di di-retta derivazione latina sopravvissuti nelsardo fino ai giorni nostri: mannu da ma-gnus, invece dell’italiano “grande”; domuda domus, al posto dell’italiano “casa”;janna (“porta”) da janua, solo per citarnealcuni tra i più comuni.Sempre riconducibili alle stesse cause di
isolamento, sono le sopravvivenze di for-me prelatine, forse riferibili a ceppi lin-guistici iberi, berberi o punici. I toponimirecano spesso i segni più evidenti di que-sti “fossili” linguistici: la parola nurra,esclusiva dell’area sarda col significato di“voragine, crepaccio nel terreno”, ma an-che, antiteticamente, di “cumulo di terra,di sassi” - da cui ha origine nuraghe - si ri-trova in Nuràminis, Nurallào, Nurachi,Nuragus, oltre che nel coronimo Nurra, lasubregione nord-occidentale dell’isola.Altra origine prelatina è da attribuire allabase gon(n)- , correlata al significato di “al-tura, monte”: Goni, Gonnesa, Gonnosco-dina, Gonnosfanàdiga, Gonnosnò, Gon-nostramatza (in quest’ultimo caso, il temasi unisce con la parola sarda tramattsu, “ta-merice”). Interessanti “isole” linguistiche all’internodel panorama sardo sono quelle del ca-talano ad Alghero e di un antico dialettoligure che caratterizza la parlata delle cit-tadine di Carloforte e Calasetta sull’isoladi San Pietro.
Lingua e dialetti
che chiusi. L’abolizione del feudalesimo avviene attraverso il riscatto dei feudi: in pra-tica, lo Stato paga ai feudatari le rendite dei loro privilegi, ma ne carica l’obbligo del rim-borso sui Comuni, che cominciano la loro nuova vita già oberati di debiti. La cancella-zione degli ademprivi, cioé dei diritti dei poveri di andare a far legna, a cogliere ghian-de e funghi, allevare maiali nei boschi demaniali priva i pastori senza gregge e i conta-dini senza terra dei mezzi elementari della sussistenza. Questi decenni (e queste leggi)gettano un seme di violenza che germoglierà nel banditismo rurale di fine secolo.Ma l’anno dei portenti, in Sardegna, è il 1847. Tra ottobre e novembre un moto di bor-ghesie urbane, intellettuali e commerciali, chiede e ottiene la “fusione perfetta” fra Sar-degna e Stati di Terraferma: è la fine dell’autonomia del Regnum Sardiniae, la rinunciaai (pochi) privilegi d’origine spagnola, l’inizio di un’integrazione diseguale nel resto del-lo Stato, un processo non ancora compiuto e ancora drammaticamente in discussione.La stessa unificazione della Penisola avvia in Sardegna, di fronte ai problemi che crescono,un ripensamento di quel moto con cui i sardi, in fondo, avevano anticipato gli unitari-smi del risorgimento. «Fu una follia collettiva», dirà, a qualche anno dall’evento, uno deicapi delle ‘radiose giornate’ del 1847. La Sardegna sperimenterà così, con quasi quin-dici anni d’anticipo, il difficile rapporto Nord-Sud.Il secolo finisce con una crisi epocale: chiusi gli sbocchi commerciali con la Francia dal-la “guerra delle tariffe”, crollano una dietro l’altra le banche, falliscono le industrie agri-cole, il banditismo nel Nuorese scoppia così violento che Pelloux ordina, nel 1899, unavera e propria spedizione militare. Resiste la pastorizia (industriali del Lazio comincia-no a produrre in Sardegna quel “pecorino romano” che ora si fa quasi soltanto nell’iso-la); resiste, anzi cresce, l’industria mineraria che ha la sua area privilegiata nel Sulcis-Igle-siente, dove si sviluppa una classe operaia insieme disperata e combattiva (oggi che leminiere sono arrivate al loro anno zero, le nere architetture minerarie sono uno dei piùemozionanti spettacoli dell’archeologia industriale italiana). Le due città maggiori, sul-la spinta di attive borghesie commerciali o delle professioni, aprono nuovi, eleganti quar-tieri: a Cagliari il nuovo palazzo del Municipio s’affaccia dritto sul porto, quasi a consa-crazione del destino mediterraneo della città (1899), a Sassari sull’umbertina piazza d’I-talia si dispiega la vasta fronte classicheggiante del palazzo della Provincia (1873-80).L’età giolittiana, in cui l’Italia passa da paese contadino a potenza industriale, è segna-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

ta in Sardegna dallo straripare della pastorizia (oggi l’isola con i suoi 3 milioni di peco-re possiede più d’un quarto dell’intero patrimonio ovino nazionale) e da sanguinosi scon-tri nelle miniere (l’eccidio di Buggerru, settembre 1904) e nelle città (i moti per il caro-vita, maggio 1906): anche i sardi cominciano a emigrare.
La Grande Guerra e il fascismoQuesta “appendice incerta” dell’Italia entra prepotentemente nell’immaginario nazio-nale quando, nel novembre del 1915, il bollettino del Comando Supremo cita «gli intre-pidi Sardi della Brigata Sassari», conquistatori di una «munitissima posizione nemica».C’è un sussulto d’orgoglio anche in Sardegna: dopo il Piave il presidente Orlando diràalla Camera: «Quando ho visto i soldati della Brigata Sassari ho sentito l’impulso di in-ginocchiarmi davanti a loro». La media regionale dei caduti in guerra è per l’isola unadelle più alte d’Italia.Il dopoguerra dovrebbe essere il momento in cui lo Stato paga i suoi debiti. Nasce nel-l’isola il più forte movimento regionale di ex combattenti, che chiede nuova attenzionedai governanti e l’autonomia politico-amministrativa. È la matrice non soltanto di un’o-riginale formazione politica, il Partito sardo d’Azione, ma anche d’un vasto moto di ri-vendicazionismo regionalista che, covando durante il fascismo «come il fuoco sotto lacenere» (l’immagine è di uno dei più prestigiosi ‘capitribù’ della Sardegna moderna, Emi-lio Lussu), avrà una sanzione costituzionale nel 1948 con lo Statuto regionale di auto-nomia speciale.Il fascismo non è neppure in Sardegna una ‘parentesi’. Nell’isola il governo conduce ilsuo più vasto esperimento di bonifica agraria ‘integrale’ (e nascono così le ‘città nuo-ve’ di Mussolinia, oggi Arborèa, presso Oristano, e Fertilia, sul golfo di Alghero), attivanelle miniere le produzioni più funzionali alla politica autarchica (nel 1938 viene fondataCarbonia), finanzia con ‘la legge del miliardo’ (1924) un vasto programma di opere pub-bliche, prova a combattere il più antico dei mali dell’isola, la malaria.Al censimento ‘imperiale’ del 1936 i sardi superano il milione di unità e Cagliari i centomila
abitanti. Ma il mondo della campagna – questa vasta, imprendibile, inabitata campagnasarda – resta sostanzialmente intatto. Non solo: alla fine del ventennio più di quattro quin-ti dei paesi sardi non avranno ancora acqua, luce, fognature, scuole, in qualche caso nep-pure cimitero. E il mondo delle miniere – la struttura industriale più importante dell’i-sola, autentica risorsa strategica del Paese – s’arrenderà in pochi anni alla concorren-za internazionale.Nel 1962 il primo Piano di rinascita lancia un imponente programma per la moderniz-zazione della Sardegna: basato sulla creazione di alcuni robusti poli industriali (Sassa-ri, Porto Torres, Cagliari, Olbia, Àrbatax e poi ancora Oristano, Macomèr, Ottana), si fer-ma però alla creazione di una massiccia industria petrolchimica di base, esposta ai ca-
25
Ottocento e Novecento
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

pricci e agli intrighi del mercato mondiale del petrolio. Nel 1974 la prima crisi del Golfotravolge il fragile impero e avvia una fase di forte recessione da cui la Sardegna non èancora uscita: numerose manifestazioni di malessere isolano (anche la più clamorosa,quella del banditismo delle zone interne, che si esprime soprattutto nell’‘industria’ delsequestro di persona) sono da ricondurre, in parte, a queste nuove, difficili condizio-ni di vita e di lavoro. La Sardegna è oggi un mondo straordinariamente antico e insiemecuriosamente moderno.La grande svolta si colloca nel 1950. In quell’anno nessun sardo s’ammala di malaria. Ungrandioso esperimento igienico-sanitario, condotto da tecnici italiani, finanziato e direttoda americani, ha portato in meno di quattro anni all’eradicazione dell’Anopheles ma-culipennis, la zanzara portatrice di questa millenaria piaga delle coste mediterranee. Lascomparsa della malaria sgombra da un pericolo micidiale ogni insediamento nel ter-ritorio: da quello dell’industria a quello nelle stesse campagne e, soprattutto, nelle zo-ne costiere. Il turismo sardo è figlio, quasi tutto, del ‘miracolo’ del DDT: il famoso di-sinfestante è da tempo nell’occhio del ciclone ecologista, ma i sardi conservano anco-ra, e con qualche gratitudine, i ‘marchi’ del passaggio dell’operaio-disinfestatore segnatisullo stipite delle porte di centinaia di villaggi.
Non solo mareÈ stata la scomparsa della malaria a dettare le direzioni dello sviluppo dell’isola negliultimi cinquant’anni, che hanno visto l’impetuoso sviluppo del turismo. La Sardegna staora nel Gotha internazionale delle vacanze.Del resto, l’isola ha qualcosa come 1897 chilometri di coste, un quarto esatto dell’in-tero perimetro litoraneo d’Italia. È giusto, dunque, che quando si dice Sardegna si di-ca (specie se lo dice chi ci viene in vacanza) mare, sole, silenzio. Ma c’è anche altro so-le e altro silenzio, e un verde non molto diverso da quello del mare, nella Sardegna in-terna. Intanto, dal mare, in Sardegna, non ci si allontana mai troppo: nessun punto del-l’isola è distante più di 50 chilometri dal mare. In ogni luogo dell’isola il mare, se nonsi vede, si sente.Salendo verso gli altipiani e le montagne centrali, fra piccole chiese campestri, quasimimetizzate nella macchia (ce ne sono, in Sardegna, più di seicento: e spesso sono l’u-nico segno d’una presenza umana recente) e foreste di sughere, lecci, querce, boschettidi olivastri e i grandi viluppi della macchia mediterranea con i suoi cento colori e i suoicento profumi, si va verso il cuore stesso non di un’isola ma di una storia. La storia delpopolo sardo, la sua più intrinseca civiltà.
26
Sardegna: una storia che viene da lontano
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Le culture preistoriche e l’età nuragicaAlcuni sporadici reperti attestano la presenza dell’uomo in Sardegna fin da tempi anteriorial Neolitico antico. Le prime tracce sono relative all’insediamento in grotta di piccolecomunità dedite alle attività di caccia e di raccolta con occasionali esperienze agrico-le, localizzate sulle coste. L’industria litica è ben rappresentata dall’ossidiana del mon-te Arci, che costituisce anche merce d’esportazione.Nella prima metà del IV millennio a.C. si colloca la cultura di Bonuighinu, già del Neoliti-co medio, documentata sia in caverne sia in villaggi all’aperto, soprattutto grazie a re-perti ceramici con eleganti decorazioni incise. Attorno al 3000 a.C. le subentra la cultu-ra di Ozieri, riferibile al Neolitico recente e al primo Calcolitico, nel cui ambito si ma-nifestano relazioni culturali più strette con il Mediterraneo orientale, soprattutto nel-l’importante santuario megalitico di Monte d’Accoddi presso Sassari. A partire daquest’epoca si diffondono i culti funerari, documentati specialmente dalla presenza digrotticelle artificiali, dette domus de janas (si segnalano quelle di Anghelu Ruju pressoAlghero), talvolta decorate con simboli elementari o anche dipinte. Dal 2000 a.C. fannola loro comparsa figurette in pietra riferibili alla Dea Madre il cui culto è diffuso nell’interobacino mediterraneo e in Medio Oriente. A queste si affiancano le stele-menhir con at-tributi femminili; in un secondo momento compaiono anche statue-menhir con attributimaschili (sono notevoli quelle di Pranu Mutteddu presso Goni). Queste ultime segna-no un’epoca di transizione, nella quale la diffusione della metallurgia è sintomo di unapratica della guerra, apparentemente sconosciuta fino ad allora in Sardegna. Il quadrodi riferimento è quello della cultura dolmenica, che segnala relazioni con il continenteitalico ed europeo, esplicitate dalle culture del Vaso campaniforme, di Monte Claro e diAbealzu-Filigosa. Verso il 2000 a.C. la Sardegna rielabora in modo originale le due componenti culturali co-stitutive delle origini, quella orientale e quella occidentale, soprattutto con la creazionedelle forme iniziali di nuraghe a pianta circolare o allungata. Intorno al 1500 la cultura diBonnànaro produce le prime forme di nuraghe complesso, particolarmente apprezzabilinelle fasi evolutive del grandioso complesso di Su Nuraxi a Barùmi-ni, nel quale al mastio centrale si aggiunge una cinta di torri,con sviluppo del villaggio circostante. Tra il XVI e il IV se-colo a.C., la cultura nuragica rappresenta l’elemento dicontinuità locale nell’isola interessata via via dal-la frequentazione dei mercanti micenei (sino al1200 a.C.) e fenici (sino al VII sec. a.C.), quindi dal-la conquista militare a opera dei cartaginesi edei romani (238 a.C.). Oltre che con il suo monu-mento più caratteristico, che è il nuraghe (Santu An-tine a Torralba, Serra Òrrios a Dorgali, Losa ad Ab-basanta, Arrubiu a Orroli), essa si esprime consantuari (Santa Vittoria a Serri), pozzi sacri (SuTempiesu a Orune, Santa Cristina a Paulilàtino), se-polture dette tombe di giganti e, dal punto di vista pla-stico, non solo con le piccole sculture in bronzo di guer-rieri, navicelle, figure femminili di dea madre o di sacerdo-tessa (oggi soprattutto a Cagliari nel Museo archeologiconazionale), ma anche – ed è una scoperta recente –con la statuaria monumentale in pietra, documentatadai frammenti di monte Prama nell’Oristanese.
La colonizzazione fenicio-punica e l’età romana (VII secolo a.C.-IV d.C.)Il primo momento della frequentazione fenicia della Sardegna corrisponde alla fase pre-coloniale (XI-IX sec. a.C.), cui subentra, tra l’VIII e il VII secolo, la fondazione di colonie lun-go la costa sud-occidentale, fra le quali assumono speciale rilevanza Nora (che ha re-
27
Dalla preistoria alla Sardegna contemporanea:il percorso storico-artistico
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

stituito la più antica iscrizione semitica nell’isola), Bithia (attuale Chia), Sulci (attualeSant’Antìoco), Tharros (Cabras) e Càrales o Kàrales (Cagliari). Per garantire la sicurezza delle proprie colonie i fenici intraprendono la costruzione del-le prime fortezze nell’entroterra (Monte Sirai presso Carbonia), potenziate dai cartaginesinel momento in cui, a partire dal VI sec. a.C., la città africana assume un ruolo egemo-ne fra le colonie d’Occidente. Il controllo cartaginese della Sardegna, fino alla cessione
ai romani all’indomani della seconda guerra punica, si limita preva-lentemente alle coste e alle vie di comunicazione, lungo le quali tran-
sitano le merci oggetto di scambio con le non sottomesse popo-lazioni barbaricine dell’interno. Fuori dalle città, configurate co-
me porto-mercato attorniato da un tessuto non regolare di ca-se, botteghe, officine e santuari urbani, si collocano le necropolie i tophet, luoghi deputati alla sepoltura e al sacrificio di fanciullie di piccoli animali. Nelle botteghe transitano i manufatti d’im-portazione, sia italica sia orientale; nelle officine si produco-no vetri, oggetti d’oreficeria, terrecotte (di particolare interessele maschere votive nel Museo archeologico di Cagliari), scul-
ture in metallo e in pietra, fra le quali spiccano le stele aniconicheo antropomorfe dei tophet. I siti, le produzioni e la stessa vita quotidiana delle città puniche nonsubiscono sostanziali variazioni nel passaggio della Sardegna da Car-tagine a Roma, dopo il 238 a.C. La continuità devozionale è docu-
mentata nel santuario di Àntas (Fluminimaggiore), già dedi-cato alla suprema divinità paleosarda, poi al dio semiti-co Sid-Addir, quindi al Sardus Pater ricordato nelle fonticlassiche. Nei primi secoli della romanizzazione la cittàegemone è Nora, fra le cui rovine si conservano ambien-ti termali, pavimenti musivi di ville e il teatro; dal I secoloa.C. emergono Càrales, dove si segnala soprattutto l’an-fiteatro, e Turris Libisonis (Porto Torres), colonia di fon-dazione augustea, della quale restano ruderi dell’ac-quedotto e le strutture termali del cosiddetto palazzodi Re Barbaro. I manufatti della Sardegna romana,sia quelli d’importazione (notevole la serie marmorea
di ritratti imperiali giulio-claudi recuperata a Sulci), sia quelli di produzione locale, ri-velano l’adeguamento alle mode extraisolane, in tutto simili agli analoghi reperti del con-tinente italico e dell’Africa, dai cui centri proviene la ceramica sigillata, esportata finoall’alto medioevo (VI-VII secolo).
L’età tardoantica e bizantina (V-X secolo)Bisogna arrivare alla fine del III-inizi del IV secolo per trovare il più antico frammento disarcofago marmoreo di soggetto cristiano, rinvenuto a Olbia e oggi nel Museo nazionaledi Cagliari. La cristianizzazione dell’isola, iniziata fin dai primi secoli, non conosce in-terruzioni nemmeno nell’epoca della dominazione vandalica, fra il 455 e il 534. In que-st’anno le truppe di Giustiniano, nel quadro della campagna africana, riconquistano laSardegna, che rientra a far parte dei territori dell’impero romano e fra il VI e il X secolovive un corso storico differente rispetto a quello dei territori italici e dell’Occidente ingenere: non viene occupata da popolazioni germaniche, non entra a far parte dei dominicarolingi, mantiene un’ininterrotta dipendenza politico-amministrativa da Costantino-poli, dunque dall’impero che si suole definire bizantino. Nella produzione artistica i riflessi sono immediati: alle importazioni di manufatti da Ro-ma si affiancano quelle dall’Oriente. È databile alla prima metà del VI secolo un notevolecapitello marmoreo del Museo archeologico di Cagliari, lavorato nelle botteghe pressoCostantinopoli e quindi esportato in Sardegna. Altre sculture, come i capitelli con co-lombe riutilizzati nella basilica romanica di S. Gavino a Porto Torres, documentano l’a-dattamento locale dei modelli di provenienza orientale. Anche le architetture superstitimostrano di risentire dei modi bizantini, ma restano fedeli al prototipo tardoantico delmartyrium a pianta cruciforme con cupola all’incrocio dei bracci voltati a botte. Tale do-veva essere l’originale configurazione strutturale di tre grandi chiese, erette fra il V e ilVII secolo: S. Saturno di Cagliari (ristrutturata in forme romaniche dopo la donazione ai
28
Dalla preistoria alla Sardegna contemporanea: il percorso storico-artistico
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

monaci Vittorini nel1089), S. Antioco del cen-tro omonimo e S. Gio-vanni di Sinis (Cabras).Esiste poi un gruppo dichiese cruciformi cupo-late, di minori dimensio-ni, delle quali è difficilestabilire l’esatta cronolo-gia: il santuario di Bonàr-cado, S. Teodoro di SanVero Congius (Ollastra Si-maxis), S. Elia di Nuxis,S. Salvatore di Iglesias, S.Maria di Cossoìne, S. Cro-ce di Ittireddu. È possibile che siano state costruite fra il IX e i primi decenni dell’XI se-colo, quando la Sardegna bizantina evolveva nella Sardegna giudicale.In questi secoli i locali rappresentanti dell’autorità imperiale di Costantinopoli si tro-vano ad agire praticamente in autonomia da Bisanzio ed elevano se stessi al rango di ‘giu-dici’, di fatto autorità supreme nelle quattro città più importanti dell’isola: Cagliari, Ori-stano, Porto Torres e Olbia. Si costituiscono così i quattro giudicati, o regni, nei qualila Sardegna risulta divisa a partire dalla metà dell’XI secolo. Nella sua fase formativa, l’i-stituzione, la cultura e l’arte giudicale avvertono il bisogno di legittimare la propria realtàstorica attraverso il riferimento a Bisanzio, mediante la lingua greca delle iscrizioni e illinguaggio bizantino delle sculture marmoree. Queste ultime, giunte a noi frammenta-rie, rivelano forti relazioni con la costa campana, sede di ducati di cultura bizantina. Sitrattava di pilastrini e plutei di recinzione presbiteriale, fra i quali riveste uno specialeinteresse la lastra con grifo e pegaso, ritrovata in mare presso l’isola di San Macario (Pu-la) e custodita nel Museo di Cagliari.
La Sardegna giudicale (XI-XIII secolo)Attorno alla metà dell’XI secolo la Sardegna si presenta divisa in quattro giudicati (Ca-gliari, Arborèa, Torres, Gallura), ognuno delimitato da confini, entro i quali l’autorità su-prema era esercitata da un ‘giudice’, o re. Nel giudicato di Torres, il giudice Gonnario-Comita si fa promotore della grandiosa ricostruzione romanica della basilica di S. Ga-vino, caratterizzata dalla pianta a due absidi, che si aprono nei lati brevi del corpo tri-navato. Nei setti divisori si utilizzano colonne e capitelli di spoglio; la muratura è di ti-po lombardo, con paramenti scanditi da lesene e conclusi in alto da archetti.Nella seconda metà del Mille si assiste all’avvio di un’intensa attività edilizia, che nelsecolo successivo dà origine a un panorama architettonico fra i più intatti e significa-tivi del romanico europeo, destinato a caratterizzare il paesaggio storico dell’isola. Il cre-scente controllo che le repubbliche marinare di Pisa e Genova esercitano sulla vita po-litico-sociale dei giudicati determina la diffusa presenza di maestranze di provenienzatoscana e ligure, che si radicano in Sardegna e sviluppano modi locali. La scala dimen-sionale si rapporta alla funzione delle chiese: è infatti massima nella cappella palatinadi S. Maria del Regno ad Àrdara; in cattedrali come S. Simplicio di Olbia, S. Pietro di Bo-sa, S. Antioco di Bisarcio (Ozieri), S. Pietro di Sorres (Borutta), S. Nicola di Ottana (con-sacrata nel 1160), S. Giusta nel centro omonimo; in chiese monastiche benedettine cas-sinesi come S. Maria di Tergu, S. Nicola di Silànis (Sèdini), S. Pietro del Crocifisso di Bul-zi, camaldolesi come la SS. Trinità di Saccargia (Codrongiànos) e S. Maria di Bonàrca-do (consacrata nel 1146), cistercensi come S. Maria di Corte (Sindìa), vittorine come S.Efisio di Nora (Pula). Variano dalla media alla minima scala dimensionale le altre chie-se, anch’esse monastiche o parrocchiali; meritano una menzione S. Maria di Sibiola, S.Platano di Villa Speciosa e S. Maria di Uta. La caduta del giudicato di Cagliari in mano pisana, nel 1258, è la premessa storica perla costruzione nella città della cattedrale di S. Maria e della cinta muraria del quartie-re di Castello, che si conclude nel 1305-07 con le torri di S. Pancrazio e dell’Elefante, pro-gettate da Giovanni Càpula e tuttora superstiti. Nella seconda metà del XIII secolo si am-plia S. Maria di Bonàrcado e si costruisce la cattedrale di S. Pantaleo di Dolianova, nelcui cantiere si formano le maestranze che erigono numerose chiese minori del territo-
29
L’età tardoantica e bizantina
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

rio; nel 1293 l’architetto Anselmo da Como dirige la fabbrica del S. Pietro di Zuri (Ghi-larza), che denota analoghe forme di transizione dal romanico al gotico.Tutte queste chiese romaniche sono caratterizzate da un esuberante apparato di de-corazione architettonica, che si esplica nei peducci delle archeggiature esterne e talvoltanell’uso di colonne e capitelli di spoglio. Sono invece poche le sculture capaci di svin-colarsi da uno stretto rapporto con la struttura architettonica. Gli esempi più significativisono costituiti per il XII secolo dai due plutei marmorei del Duomo di Oristano (uno dei
quali con Daniele nella fossa dei leoni),per il Duecento dalla coppia di picchiottibronzei per la stessa cattedrale (con ladata 1228, la firma di Piacentino e la men-zione del giudice arborense e dell’arcive-scovo committente) e dal pregevole grup-po di statue lignee che compongono laDeposizione dalla croce, già nella chiesa diS. Pietro del Crocifisso e oggi nella par-rocchiale di Bulzi. Ugualmente rarefatta èla documentazione per quanto attiene al-la pittura parietale romanica, che anno-vera soprattutto gli affreschi della SS. Tri-nità di Saccargia, del S. Nicola di Trullas(Semèstene), del S. Pietro di Galtellì.
L’età aragonese e spagnola (XIV-XVII secolo)Fin dalla metà del Duecento la presenza deiFrancescani determina l’introduzione inSardegna di tipologie architettoniche e de-corative legate ai modi gotici italiani, in ba-se ai quali viene intrapreso l’ampliamentodella cattedrale cagliaritana di S. Maria diCastello. Nel 1323 Alfonso d’Aragona sbar-ca nell’isola e nel 1326 conquista il Castel-lo pisano di Cagliari. Negli anni dell’assedio
della città gli aragonesi costruiscono il santuario della Madonna di Bonaria, primo edi-ficio gotico-catalano in Sardegna, e dopo il 1326, nella Cattedrale, alla cappella “pisana”a destra del presbiterio si affiancherà, a sinistra, quella “aragonese”, simbolo visivo del-la presa di possesso da parte dei nuovi dominatori. Inizia il lento processo di catala-nizzazione dell’isola, che si svolge lungo l’arco di un secolo. Per tutto il corso del Tre-cento si verifica la sostanziale continuità dei rapporti artistici con il continente italicoe la Toscana in particolare, documentata da opere come gli affreschi della cappella delcastello di Serravalle a Bosa, la pala di Ottana (commissionata fra il 1339-43 dal vesco-vo Silvestro e da Mariano IV, futuro giudice d’Arborèa) e la statua marmorea del santovescovo nel S. Francesco di Oristano (firmata da Nino Pisano attorno al 1360). Fin dagli inizi del Quattrocento si assiste invece a un mutamento delle rotte commercialie culturali, che non fanno più capo a Pisa bensì a Barcellona e a Napoli. Nell’arredo li-turgico delle chiese si impone il retablo, la grande pala lignea d’altare, decorata e dipinta,di tipologia e provenienza catalano-valenzana; il primo esemplare giunto fino a noi, perquanto incompleto, è il retablo dell’Annunciazione, del 1406-09 circa, attribuito al pit-tore catalano Joan Mates. Attorno alla metà del secolo la committenza isolana non si li-mita a importare retabli dalla Catalogna, ma richiede il trasferimento degli artisti nel-l’isola: nel 1455-56 due pittori iberici, Rafael Tomás e Joan Figuera, dipingono a Caglia-ri il retablo di S. Bernardino. La personalità più rappresentativa della pittura sardo-ca-talana quattrocentesca rimane ancora oggi anonima: si tratta del Maestro di Castelsar-do, cui si attribuisce un corpus di opere a Barcellona, in Corsica e in Sardegna, delle qua-li l’unica sicuramente datata è il retablo di Tuili, che gli fu pagato nell’anno 1500.Il nuovo secolo segna l’ingresso del reame di Sardegna nei domini della corona di Spa-gna. Esso vede da un lato l’ultimazione delle parrocchiali campidanesi esemplate sul S.Giacomo di Cagliari (S. Pietro di Assèmini, S. Giorgio di Sestu, S. Pietro di Settimo SanPietro), dall’altro l’elaborazione di un analogo modello, applicato alla fabbrica di quel-
30
Dalla preistoria alla Sardegna contemporanea: il percorso storico-artistico
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

le della Sardegna set-tentrionale (S. Giorgiodi Pèrfugas, S. Giulia diPàdria, S. Maria di Cos-soìne, S. Vittoria diThiesi, S. Giorgio diPozzomaggiore). Il pre-sbiterio di queste chie-se, di tipologia gotico-catalana, rappresenta lospazio ideale per l’in-serimento dei reta-bli, che talvolta do-minano anche all’in-terno di edifici romanici: è il caso del retablo di S. Maria del Regno di Àrdara, datato al1515, il più grande nell’isola. A Cagliari, fin dal secondo decennio del Cinquecento la sce-na pittorica è dominata dalla scuola di Stampace (così detta dal quartiere in cui si tro-vava la bottega) e dalla personalità di Pietro Càvaro, che nel 1518 firma il retablo di Vil-lamar. Nella seconda metà del secolo saranno il figlio Michele e Antioco Mainas ad as-sumere le commissioni sempre più numerose che giungevano alle botteghe di Stampace.In ambito sardo settentrionale si segnala l’attività di un altro anonimo, il Maestro di Ozie-ri, nella cui pittura è constatabile un adeguamento ai canoni manieristi, analogo aquello apprezzabile nell’opera matura di Pietro Càvaro e dei suoi epigoni. Nei decennifinali del secolo l’orientamento classicista impresso all’ambito cagliaritano dalla poli-tica culturale di Filippo II ha riflessi non solo nelle imprese architettoniche, con la co-struzione della chiesa di S. Agostino Nuovo (1577-80), ma anche nella committenza, chespezza il monopolio delle botteghe locali e si rivolge nuovamente a quelle extraisolane.
31
L’età aragonese e spagnola
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Retablo (in catalano retaule) è parola ca-stigliana che deriverebbe dal latino re-trotabula altaris, e indica le grandi paled’altare dipinte su legno che costitui-scono la manifestazione più interessan-te della pittura sarda fra la metà del Tre-cento e i primi anni dei Seicento. Com-posti di due parti principali, in bassouna predella orizzontale, in alto una va-sta composizione verticale articolata suscomparti dipinti, piccole sculture e unafitta serie di cornici, i retabli vennerointrodotti in Sardegna dalla Catalognasubito dopo la conquista dell’isola. Al-l’inizio venivano direttamente da Bar-cellona, poi gli stessi artisti catalani si tra-sferivano in Sardegna per realizzarli, in-fine furono maestri sardi (in particolarela cosiddetta scuola di Stampace, dalnome di un quartiere cagliaritano) ariprodurli. Il retablo, che all’inizio ri-prende la lezione della pittura goticacatalana e poi subiscesempre più l’influssodella cultura italiana,è un trionfo della figu-razione e dei colori:l’uso dei fondi oro dàa questi dipinti uno
splendore inusitato. Gran parte dei re-tabli sardi (o, talvolta, delle tavole che neavanzano) è conservato presso la Pina-coteca nazionale di Cagliari. Ma molti sitrovano ancora nelle chiese dei villaggi edei centri per le quali furono realizzati:Oristano e Sassari, ma anche, nel NordSardegna, la basilica di Saccargia, Àrda-ra (forse il più grande e il più bello, da-tato 1515), Castelsardo, Ozieri e Bene-tutti, dove si trovano le opere di artisticonosciuti solo col nome Maestro diOzieri; nel Centro Bortigali, Nùoro e Ol-zai; al Sud Villamar (nella foto quello diPietro Càvaro, del 1518) e Milis. Al Me-tropolitan Museum di New York sonoconservati i disegni preparatori di unretablo del sardo Francesco Pinna.
Lo sfavillio dei retabli

Questa tendenza si registra anche per l’intero corso del Seicento, quando giungono nel-l’isola numerosi dipinti di scuola genovese, romana, napoletana; della stessa provenienzasono anche le sculture lignee che si inseriscono nelle nicchie di retabli di tipologia ba-rocca, che vanno a sostituire quelli tardogotici già innalzati nel presbiterio delle chie-se. L’interazione fra l’opera dei costruttori e degli scalpellini locali e quella dei maestriche giungevano dal continente italico si constata soprattutto nella fabbrica sassaresedella chiesa gesuitica di S. Caterina (1579-1609), nella ristrutturazione della Cattedraledi Cagliari (iniziata nel 1615 con il santuario dei Martiri e conclusa nel 1703 con la fac-ciata barocca) e nella costruzione dell’imponente portico della cattedrale di S. Nicoladi Sassari, datata 1714 e caratterizzata da un esuberante apparato decorativo barocco.
La Sardegna sabauda e post-unitaria (XVIII-XX secolo)Il definitivo passaggio della Sardegna ai Savoia nel 1720 non segna un’interruzione del-le fabbriche in corso, contrassegnate dall’adesione al linguaggio tardobarocco, destinatoa perdurare sino alla fine del secolo. Tra il 1674 e il 1712 viene costruito il complesso ge-suitico di S. Michele a Cagliari, decorato ad affresco da Giacomo Altomonte. Nel 1722 An-tonio Felice De Vincenti esegue i disegni per la nuova basilica di Bonaria a Cagliari, se-condo i modi di Guarino Guarini e Filippo Juvarra. Dallo schema di questa facciata, mairealizzata, deriveranno quelli di altre chiese sarde, fra cui la parrocchiale di Nostra Signoradelle Grazie a Sanluri, eretta fra il 1781 e il 1786 su progetto di Carlo Maino e Antonio Igna-zio Carta. Il linguaggio tardobarocco si esplica soprattutto nel complesso (chiesa e mo-nastero) del Carmine di Oristano, progettato nel 1776 dal piemontese Giuseppe Viana.L’allineamento alle mode degli ambienti artistici italiani si intensifica nell’Ottocento conl’opera di alcuni architetti nativi dell’isola ma formatisi a Torino, al corrente delle for-me neoclassiche che andavano diffondendosi in Europa. Giuseppe Cominotti progettail cappellone di S. Luigi Gonzaga nella Cattedrale di Oristano (1829-37), dove si collo-cheranno sculture neoclassiche del sassarese Andrea Galassi (1793-1845). Antonio Ca-no dirige la ristrutturazione della chiesa francescana di S. Maria di Betlem a Sassari (1829-34) e la costruzione della cattedrale di S. Maria della Neve a Nùoro (1835-40). Ma il pro-tagonista del secolo XIX in Sardegna è l’architetto cagliaritano Gaetano Cima, cui si de-vono la chiesa di S. Maria Assunta a Guasila (1839-52) e l’ospedale di S. Giovanni di Dioa Cagliari (1844-48), che pone il Cima al passo con il funzionalismo in campo interna-zionale. Alla metà del secolo il pittore più rappresentativo è Giovanni Marghinotti(1798-1865), che nel 1830 dipinge la grande tela con Carlo Felice munifico protettore del-le Belle Arti in Sardegna, oggi nella sala del sindaco nel Palazzo civico di Cagliari, e la-vora poi per il Palazzo reale di Torino.L’ultimo quarto del secolo è segnato sia dagli sforzi artistici volti alla costruzione di un’I-talia sabauda anche culturalmente unitaria, sia dalla valorizzazione delle specificità sto-riche dell’isola. A Oristano si innalza il monumento di Eleonora d’Arborea, realizzato nel1875-77 da Ulisse Cambi e Mariano Falcini; a Sassari e a Cagliari si eseguono grandi ci-cli decorativi, a celebrazione di casa Savoia. Gli affreschi delle sale consiliari del Palazzoprovinciale di Sassari sono affidati al catanese Giuseppe Sciuti (1878-82), quelli del Pa-lazzo di Cagliari al perugino Domenico Bruschi (1893-96).La lenta e difficile integrazione nell’Italia delle nazioni ha come contropartita, nel primotrentennio del Novecento, l’invenzione di un’identità artistica sarda, perseguita dallo scul-tore Francesco Ciusa (1883-1949), dai pittori Giuseppe Biasi (1885-1945), Filippo Figari(1885-1974) e Mario Delitala (1887-1990), e dalla poliedrica attività, fra arte, artigiana-to e design, dei fratelli Melkiorre e Federico Melis. Il processo di costruzione di un’ar-te connotata da caratteri regionali sardi si arresta nel ventennio fascista, quando in cam-po architettonico si assiste a una decisa accelerazione verso la modernità, secondo i ca-noni funzionalisti perseguiti dagli architetti di regime.Il dopoguerra vedrà da un lato la stanca ripetizione di quelle formule folcloriche inaugurateda Biasi, Figari e Delitala, dall’altro l’adeguamento agli stimoli che provenivano dalla con-temporaneità internazionale, soprattutto nell’opera di Eugenio Tavolara (1901-63) eMauro Manca (1913-69). Negli ultimi decenni del XX secolo la Sardegna è inserita piena-mente nella globalizzazione che interessa ormai l’intero ambito della cultura non solo oc-cidentale. A distinguersi sono soprattutto le sculture di Costantino Nivola (1911-89), nel-le quali l’esperienza maturata negli Stati Uniti si coniuga a un’originale riscoperta delleradici classiche e mediterranee del linguaggio artistico-artigianale del popolo sardo.
Dalla preistoria alla Sardegna contemporanea: il percorso storico-artistico
32
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

«La Sardegna, che non assomiglia ad alcun luogo. La Sardegna che non ha storia, né età,né razza, nulla da offrire. Vada per la Sardegna. Dicono che né romani né fenici né gre-ci né arabi la conquistarono mai. E c’è ancora una Sardegna non conquistata. È dentrola rete della civiltà europea, ma non è stata ancora tirata in secco».Chi verrebbe oggi in Sardegna con idee come queste, già un po’ stravaganti, forse, quan-do David Herbert Lawrence le scriveva all’inizio degli anni venti? Comunque, in Sarde-gna ci venne: una rapida corsa di un paio di settimane da Cagliari a Terranova Pausa-nia (come si chiamava allora Olbia) attraverso le montagne del versante orientale, sutrenini periclitanti ai bordi di piccoli abissi e autobus zeppi di quella umanità aspra eselvaggia, così primitiva, anzi primigenia, che all’autore di L’amante di Lady Chatterleypiaceva moltissimo. Su quel viaggio Lawrence scrisse un libro famoso, Mare e Sardegna. Anche oggi per ituristi standard la Sardegna è soprattutto mare, centinaia forse migliaia di spiagge. Mac’è anche una Sardegna interna, con le sue regioni montane di cui è re il massiccio delGennargentu. È l’“altra Sardegna”: visitata e, soprattutto, capìta è capace di raccontare,dai maestosi nuraghi sino al più raffinato gioiello dell’artigianato, una civiltà origina-ria e originale.
Quando andareOgni stagione è buona per vedere la Sardegna. La scelta è tutta affidata alle preferen-ze personali del visitatore: se si amano (o si debbono scegliere) le stagioni sacre al tu-rismo, che in Sardegna è soprattutto turismo marino, allora bisogna andarci in luglioo in agosto. Siccome i giorni del “pieno” cadono tra la fine di luglio e il 20 agosto e letemperature medie sono già alte in giugno e si prolungano fino a settembre (nella fa-scia costiera stanno tra i 26 e i 30° C), sono i due mesi estremi dell’estate che andreb-bero consigliati per un più rilassante soggiorno: il mare di settembre in Sardegna nonteme confronti. Ma anche il mite autunno, l’inverno mai troppo freddo e la splenden-te primavera hanno il loro fascino.
Come andarePer andare in Sardegna, come in ogni altra isola, bisogna prenotarsi per tempo. Per ma-re si può arrivare da Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli o Palermo con traghetti del-la Tirrenia, delle Ferrovie dello Stato o di diverse compagnie private. Il viaggio verso iporti sardi (i più serviti sono Porto Torres, Golfo Aranci e Olbia nella Sardegna setten-trionale, Àrbatax e soprattutto Cagliari in quella meridionale) ha una durata variabile,da un massimo di 13 ore a un minimo di 7 nella tratta più breve, quella fra Civitavecchia
33
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Sardegna: come visitarla

e Olbia o Golfo Aranci; su questa – ma anche sulle Fiumicino-Golfo Aranci, La Spezia-Ol-bia e Genova-Porto Torres - operano in alta stagione anche le “navi veloci” che arriva-no a dimezzare il tempo.La Sardegna è collegata da una rete di servizi aerei che fa capo agli aeroporti di Alghe-ro-Fertilia (tel. 079935039 o 079935194; Alitalia 079935033 o 079935037; Ryanair e Vola-re Airlines 079935282) e Olbia-Costa Smeralda (informazioni: tel. 078952634, bigliette-ria 0789922637; Meridiana 199111333 o www.meridiana.it) nella Sardegna settentrionale;
Cagliari-Elmas (tel. 070241014, Alitalia147865643, Meridiana 070240169 o 070669161;Volare Airlines, Air Dolomiti e Alpi Eagles0702128263) e Tortolì-Àrbatax (tel. 0782624300)in quella meridionale.L’Esit (Ente Sardo Industrie Turistiche), l’entepreposto al turismo isolano (Cagliari, via Mameli97, tel. 07060231; www.esit.net.it), ha un effi-ciente servizio di informazioni (tel. 800013153)e dispone di molto materiale informativo. La crescita del turismo è stata accompagnata nel-l’isola da un notevole sviluppo delle agenzie diviaggio (con i servizi connessi, dal reperimentodegli alloggi al servizio rent-a-car): tutti i centrid’un qualche rilievo ne posseggono più d’una.Informazioni si possono chiedere anche agliEnti provinciali per il turismo:Cagliari, piazzaDeffenu 9, tel. 070604241, www.regionesarde-gna\eptca.it, con uffici informazioni alla sta-zione marittima, tel. 070668352, e all’aeroportodi Cagliari Elmas, tel. 070240200; Oristano, via
Cagliari 278, tel. 078373191; [email protected]; Nùoro, piazza d’Italia 19,tel. 078430083; Sassari, viale Caprera 36, tel. 079299546; ufficio informazioni all’aeroportodi Alghero-Fertilia, tel. 079935124.I centri di maggiore importanza hanno anche Aziende di Soggiorno e Turismo, gran-dissima parte dei paesi hanno attive Associazioni Pro Loco (per le Aziende e le Pro Lo-co v. la sezione Gli altri luoghi).Avvertenza non inutile: la cosiddetta “tradizionale ospitalità sarda” non è, nella gran par-te dei casi, mera propaganda turistica; in ogni centro la gente vi sarà prodiga di detta-gliate informazioni e notizie.
I trasporti interniLa rete ferroviaria lascia parecchio a desiderare per durata del viaggio e comfort dei tre-ni: la rete principale è una sorta di Y che collega Olbia e Golfo Aranci (Sardegna di nord-est), Porto Torres e Sassari (Sardegna di nord-ovest) con Cagliari. I centri maggiori so-no collegati con linee automobilistiche (fra Cagliari, Sassari e Porto Torres e Nùoro esi-ste anche un servizio non stop: durata del viaggio da Cagliari a Sassari, 210 km, 3 ore 15’).Le linee ferroviarie minori sono ridotte a pochi tronchi, ma conservano la caratteristi-ca di viaggiare in paesaggi fortemente suggestivi: restano in funzione, ormai più con tre-nini verdi a carattere turistico che con servizi di linea, le tratte da Cagliari a Mandas, daMandas a Sòrgono e da Mandas ad Àrbatax, da Sassari a Tempio e Palau, da Macomèra Nùoro e da Macomèr a Bosa Marina. L’ufficio informazioni è a Monserrato, vicino a Ca-gliari, via Pompeo, tel. 070580246.Le strade sarde sono in genere strette e ricche di curve, ma quasi tutte asfaltate e ben te-nute. Tra Porto Torres-Sassari e Cagliari esiste una superstrada a quattro corsie (la sta-tale 131 Carlo Felice) di 228 km. Tratti di superstrada esistono anche sulla Cagliari-Iglesiase Olbia-Siniscola-Nùoro-Abbasanta; “direttissime” fra Sassari e Olbia, Sassari e Tempio.
OspitalitàLa Sardegna ha ormai un’attrezzatura ricettiva adeguata alla domanda: soltanto nei gior-ni ‘caldissimi’ intorno a Ferragosto può essere difficile trovare posto, soprattutto nel-le località balneari.Lo sviluppo del turismo ha favorito in questi anni la crescita dell’attività agrituristica
34
Sardegna: come visitarla
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

che è, più ancora dell’accoglienza ‘moderna’ in ristoranti e alberghi, estensione natu-rale dell’ospitalità tradizionale. Il fenomeno ha preso piede dapprima nell’Oristanese,è stato adottato poi nelle zone del maggiore sviluppo turistico, la Nurra di Alghero e laGallura, e si è esteso infine a quasi tutte le altre aree dell’isola.Le aziende sono circa 300, segno che la crescita è stata agevolata dall’apprezzamento deiclienti. La loro frequentazione si è rivelata infatti come uno dei modi più efficaci per ve-nire a contatto con una civiltà così distante da quella delle città di terraferma e del mon-do industrializzato: in queste case – per lo più in campagna, ma a volte nelle periferie deipiccoli centri – ci si trova di fronte a modi di produrre e di vivere (e quindi anche, ov-viamente, di mangiare) che altrove sono sconosciuti o appartengono al passato. Sono ca-se e fattorie, per fare qualche esempio, nelle quali si alleva e si cucina il ricercatissimo“porcetto”, si coltiva la vite e si fa il vino, si tengono le api e si ricava il miele. Non solo:nelle sale da pranzo sono organizzate spesso esposizioni di antichi strumenti e oggettidella civiltà contadina, e nei dintorni si può trovare la sorgente cristallina, il nuraghe, l’a-rea naturalistica. Assaggiare i cibi e partecipare ai momenti della convivialità diventanocosì parte di una più profonda presa di contatto con la realtà isolana.Gran parte delle aziende fanno capo ad associazioni con sede nei capoluoghi provinciali,alle quali ci si può rivolgere per le informazioni: Agriturist Sardegna, via Bottego 7, 09125Cagliari, tel. 070303486; Terranostra, viale Trieste 124, 09123 Cagliari, tel. 070280537; Tu-rismo Verde, sede regionale: via Libeccio 31, 09126 Cagliari, tel. 070373733, 070373966,070372628. Sedi provinciali: viale Carlo Felice 18, 09124 Cagliari, tel. 070651992; via Al-ghero 3, 08100 Nùoro, tel. 078435963; via Diego Contini 40, 09170 Oristano, tel. 078372896;emiciclo Garibaldi 16, 07100 Sassari, tel. 079235516; Consorzio Agriturismo di Sardegna,piazza Duomo 17, 09170 Oristano, tel. 078373954;Cooperativa Turistica Dulcamara,07040 Alghero-Santa Maria La Palma, tel. 079999197.
Gli sport Le caratteristiche del paesaggio isolano e le specificità del turismo sardo hanno fattocrescere in molti centri strutture per lo sport e il tempo libero direttamente legate al-l’industria delle vacanze. La stessa dotazione di porti e approdi turistici è nata come con-seguenza di una domanda eminentemente estiva.Alcuni comprensori turistici hanno anche strutture di rilievo come campi dagolf: sul golfo di Cagliari a Santa Margherita di Pula (Is Molas Golf Hotel,tel. 0709241006; www.ismolas.com); sulla Costa Smeralda (PeveroGolf Club, Cala di Volpe, tel. 0789958000); nella penisola del Sinis (IsArenas Golf, località Is Arenas, tel. 078352235).Altre due attività sportive connesse alla natura della Sardegna so-no il windsurf (praticato un po’ dappertutto lungo le coste, conpreferenza per i riparati, ma insieme ventilati, golfi della costa set-tentrionale) e l’equitazione in tutte le sue forme (maneggi esi-stono presso molti degli alberghi della costa, mentre l’interno of-fre straordinarie manifestazioni dell’antica pratica equestre deisardi), con particolare riguardo per il trekking a cavallo (in Sar-degna esiste un rinomato Istituto per l’Incremento Ippico dellaSardegna, ‘genitore’ del cavallo anglo-arabo-sardo: Ozieri, piaz-za Borgia 4, tel. 079787852).La frequenza di scogliere a picco sul mare (soprattutto sulla costaorientale) ha imprevedibilmente sviluppato anche attività di free-climbing di grande attrattiva per gli amanti di questa difficile arte.Allo stesso modo, la frequenza di grotte marine e terrestri, soprattut-to nella massa calcarea che corre dal Nuorese verso l’Iglesiente,ha dato vita a numerosi club speleologici (tra i più attivi quelli chehanno recapito a Cagliari e a Nùoro).
L’artigianatoAnche in Sardegna l’artigianato è nato dal breve circuito della vita rurale: dalle materieofferte dal mondo (vegetale e animale) che circonda il villaggio, con le quali pastori econtadini – ma soprattutto le loro donne – inventavano gli oggetti essenziali della vitaquotidiana, abbellendoli sulla base di un gusto quasi istintivo.Le materie prime sono il legno, le piante (l’asfodelo, il giunco, la palma, il grano, il lino),
35
Sardegna: come visitarla
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

l’osso, il cuoio, l’argilla, la lana. Le erbe for-niscono i coloranti. La lavorazione del fer-ro, ma anche dei metalli preziosi, e la pescalocale del corallo aggiungono altri settori‘merceologici’ alla inesauribile vena delletessitrici, le filatrici, le cestinaie che lavo-rano accanto ai vasai, i conciatori, i cuoiai,i falegnami, i fabbri, i gioiellieri della fili-grana d’oro e d’argento, i coltellinai. L’inventario degli oggetti prodotti un tem-
po per le necessità quotidiane èentrato oggi nei cataloghi dell’Iso-la (Istituto Sardo per l’Organizza-zione del Lavoro Artigiano), creatodalla Regione sarda (via Bacaredda184, 09127 Cagliari, tel. 070400707,[email protected]; negozi a Cagliari,Sassari, Nùoro, Oristano e, stagio-nale, a Porto Cervo nella CostaSmeralda). Sassari ospita, nel Pa-diglione dell’Artigianato, apertotutti i giorni feriali, una grande ras-segna biennale (tel. 079230101).Nel corso della visita è bene sape-re quali sono i principali centri di
produzione, in modo da poter vedere gli ar-tigiani all’opera ed eventualmente acqui-stare i prodotti direttamente da loro. In un ideale viaggio a volo d’uccello danord verso sud (durante il quale bisogneràvincere a più riprese l’imbarazzo dellascelta) si segnala in primo luogo Castel-sardo, per l’intreccio e la produzione deicestini, documentati anche in un museoospitato nel castello; sulla costa occiden-tale Alghero e Bosa propongono i monili ot-tenuti dal corallo; all’interno della provin-cia sassarese Pattada vanta l’antica tradi-zione dei coltelli a serramanico (sa patta-desa: “la pattadese”), cui si sono aggiuntidi recente apprezzati violini e altri stru-menti a corda. A poca distanza Nule, cele-bre per i tappeti dai vistosi disegni “a fiam-ma”. Per i tappeti e gli arazzi si distinguo-no ancora Sarule, non lontano da Nùoro, e
in provincia di Oristano, Samughèo e soprattutto Mògoro, che, come Aritzo (Nùoro), van-ta anche l’intaglio del legno. I coltelli a serramanico si lavorano anche a Santu Lussur-giu (Oristano; insieme ai finimenti in ferro e pelle per cavalli) e ad Àrbus (Cagliari), do-ve un produttore ha aperto, adiacente alla sua officina, un piccolo interessante museo.In provincia di Nùoro si distingue Dorgali, dove si lavorano la pelle, l’argento e l’oro esi perpetua una scuola della ceramica. Ancora più a sud abbiamo una rinomata scuoladi ceramica ad Assèmini; la lavorazione di cestini con vivaci inserti di stoffa a Sìnnai; unascuola di argentieri a Iglesias.
Sardegna: come visitarla
36
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
La forma più antica della musica sarda èquella delle launeddas (nella foto, un ar-tigiano intento alla costruzione di unesemplare), lo strumento a tre canneche gli esecutori riescono a suonare incontinuazione, usando le gote come“sacca di compensazione” del respiro.Vengono impiegate per accompagnare lecerimonie religio-se e soprattuttoper dare il tempoal “ballo tondo” ealle altre forme delballo locale, ese-guito da uomini edonne che indos-sano i variopinticostumi della fe-sta. Il ballo venivae viene guidato an-che con il cantodel “coro a teno-re”, la cui originerisale ugualmente ai primordi della ci-viltà sarda: è costituito da quattro vocimaschili che eseguono – nel caso delballo – brevi testi poetici di natura amo-rosa e spesso erotica, ma anche altri divari argomenti. Nel corso di alcune festereligiose si tramanda la consuetudinedei gosos, lodi dei santi di lontana origi-ne iberica.A queste, che sono le forme-base dellamusica sarda, altre se ne sono venuteaggiungendo nel tempo: il ballo, adesempio, viene condotto dal suono del-l’organetto diatonico, che ha nell’isoladegli ottimi esecutori; e alcuni “cori a te-nore”, come a Bitti, hanno sperimenta-to la collaborazione con esecutori dimusica moderna, rock in particolare.
La musica tradizionale

Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Itinerari di visita
Le descrizioni dettagliatedei luoghi di interesse turistico

Profilo della cittàUn panorama di pietra e di mare, di stagni e di sole. Questaè Cagliari* (m 6, ab. 167 490): con le sue case a picco sui pre-cipizi, i bastioni inondati di luce dorata, lo specchio lucidodelle saline appena dietro la spiaggia. Un gioiello d’ambra, chefiorisce improvviso nell’insenatura della costa, come la videlo scrittore inglese David Herbert Lawrence negli anni venti, o la città sbocciata da unpaesaggio lunare descritta da Guido Piovene in una delle sue pagine di viaggio. Raccoltatra le rocce di calcare bianco e l’azzurro del mare, Cagliari tiene unite le molte anime chela compongono: l’antico approdo dei navigatori fenici è rimasto in parte arroccato e dif-fidente, come all’epoca di Pisa, ma ha saputo votarsi ai traffici e ai commerci, seguen-do la vocazione già coltivata dai mercanti di Roma. Chiese e palazzi rievocano i sovra-ni di Spagna, ma è del governo sabaudo l’impronta di moderna città italiana.La storia della capitale sarda è dunque la chiave per entrare nelle sue vie e nei suoi quar-tieri. Una storia che è già tutta contenuta nel nome: pietraia nuda e solitaria nel signi-ficato dell’antico toponimo Càralis (o Kàralis), trasformato poi nella forma plurale Ca-
rales, a indicare probabil-mente un abitato che siestendeva e suddividevain rioni autonomi. Nel me-dioevo fu Calaris e Calares,ma con i pisani divenneCallari, nome che i succes-sivi dominatori spagnolipronunciavano col suonoattuale. Riassunta in questibattesimi ripetuti, la lungavicenda di Cagliari parteda lontano. I primi insedia-menti risalgono a epochepreistoriche, come atte-stano i ritrovamenti, riferi-bili al Neolitico, di BorgoS. Elia e S. Bartolomeo,Monte Urpinu e Monte Cla-ro. Attratti dalla posizionecostiera, i fenici fondano i
loro empori (circa sec. VIII a.C.) nel promontorio di S. Elia e nella laguna di S. Gilla. I car-taginesi realizzano poi la prima forma di tessuto urbano, con strutture commerciali e luo-ghi di culto (necropoli di Tuvixeddu, tophet di S. Paolo, ai margini di S. Gilla, dove so-no comparsi numerosi reperti votivi, i templi di via Malta e delle colline di Bonaria e diS. Elia). Il dominio romano (dal 238 a.C.) porta significativi cambiamenti nell’assetto ur-bano. Cagliari viene dotata di vie e piazze, case di prestigio, magazzini, nuove necropoli.Nel 46 a.C. Cesare la dichiara municipium. Il declino arriva con la decadenza dell’imperoromano. Nel 455 la conquistano i vandali, a cui succedono nel 534 i bizantini. Agli inizidell’XI secolo le ripetute scorrerie arabe provocano l’intiepidimento dell’interesse bi-zantino alle sorti dell’isola. Le istituzioni passano ai ‘giudici’ locali, giuridicamente e for-malmente autonomi. La decadenza del centro urbano si aggrava quando il giudicato diCagliari, per ragioni di sicurezza, sceglie come sede di governo la periferica S. Igia, nel-la laguna di S. Gilla. Nel 1258 Pisa vittoriosa nella lunga guerra con Genova per il pre-dominio sulla città, le dà una nuova legislazione amministrativa e giudiziaria: il colle diCastello diventa la rocca fortificata sede degli uffici pubblici, si incrementano le attivitàmercantili. Nel 1323 gli aragonesi sbarcano nell’isola, assumendo negli anni successivila guida della città e del suo giudicato. Gradualmente viene introdotto un ordinamen-to che esclude i sardi dalla vita pubblica e li fa oggetto di pesanti prevaricazioni da par-
1 Cagliari e il suo territorio
38
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

te dei nuovi dominatori. È uno dei periodi più oscuri per Cagliari e la Sardegna che si pro-lunga, sotto la Spagna, sino al 1720 (con un breve intervallo austriaco, 1708-17). Il trat-tato di Londra (1718) consegna però la Sardegna a Vittorio Amedeo II di Savoia. Con l’ar-rivo dei piemontesi Cagliari si avvia verso una lenta ma sostanziale trasformazione. LaCittadella, sulla punta nord di Castello, è l’ultima importante opera militare in una cittàche si sviluppa in altre direzioni. Progressivamente l’assetto feudale perde definizioneed emerge, seppure a fatica, la classe borghese. Avvenimenti di grande rilievo politicoagitano la società sarda sul finire del Settecento. È del 1793 il bombardamento della cittàda parte di una flotta francese. L’anno successivo una sollevazione antisabauda culminanella temporanea cacciata dei piemontesi. Dopo la restaurazione, il governo torinese pun-ta alla trasformazione urbana: illuminazione pubblica, collegamento stradale con Sas-sari, servizio postale, edifici civili e chiese. Nel 1847 la “fusione perfetta” con gli stati diterraferma segna la fine del regime doganale separato, l’estensione alla Sardegna dei co-dici civili e penali del Piemonte, la soppressione della carica di viceré. Con l’attuazio-ne del piano regolatore di Gaetano Cima comincia il lento abbattimento delle mura (inCastello, dove la configurazione del quartiere le lascia sostanzialmente intatte, perdo-no il carattere difensivo). Con l’Unità, Cagliari rafforza la sua posizione di preminenzanell’economia isolana, anche per merito di una classe politica matura. Nel periodo fa-scista, evita almeno le devastazioni del ‘piccone risanatore’.Il dopoguerra – medicate le tremende ferite dei bombardamenti del febbraio e maggio1943 – è stato per Cagliari una corsa verso le campagne del Campidano, gli stagni, il ma-re; con l’abitato che si è velocemente esteso sino a sfiorare i comuni più vicini.
Profilo della città
39
Il colle di Castello, con la cinta bastiona-ta e le torri come sentinelle, sembra qua-si una corona assisa sulla sommità dellacittà alta e ripida.È la rocca antica e panoramica, meta pri-vilegiata della visita a Cagliari. Proprioqui, in “su Casteddu”, i sardi identificanol’intera città. La sua storia inizia ufficial-mente nel 1217, quando la giudicessa diCagliari, Benedetta, cedette ai pisani ilKastrum Kàralis. I toscani innalzaronomura difensive e torri, rafforzarono lacinta bastionata gli spagnoli prima e poii piemontesi, che vi costruirono anchel’arsenale e i terrapieni. La struttura delquartiere, bloccata sin dalle origini dallaforma del colle, allungata e in forte pen-denza, è rimasta pressoché immutata an-che dopo l’abbattimento ottocentesco diparte delle mura. I bastioni meridionali fu-rono trasformati in belvedere dal gover-no piemontese, che si preoccupò anche diabbellire le porte, attenuando così lachiusura nei confronti dei sottostanti rio-ni di Marina, Villanova e Stampace. Con ilprogressivo spostamento della sede delpotere politico, Castello fu fatalmente av-viato al degrado, abbandonato anche daisuoi abitanti tradizionali, i nobili e i fun-zionari pubblici. I bombardamenti del1943 hanno danneggiato ulteriormentele abitazioni, che in gran parte attendonoancora convenienti restauri.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Il percorso a piedi, effettuabile in un paiod’ore (escluso il tempo occorrente per le vi-site ai musei), si svolge nella fitta rete distrade di segno spagnolo, aperte a im-provvise vedute sulla città, con i prospet-ti dei palazzi nobiliari affiancati da umili abi-tazioni, le tante botteghe artigiane e anti-quarie impegnate nella rivitalizzazione diCastello. Diverse le vie d’accesso; prefe-rendo l’ingresso dalla centrale piazza Mar-
1.1 Cagliari: CastelloItinerario pedonale nel centro antico (pianta alle pagg.40-41)

40
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

41
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

tiri si potrà salire dal bastione di SaintRemy per via Fossario, in direzione dellaCattedrale, oppure entrare da porta delLeone dopo aver percorso via Mazzini. Inquesto secondo caso il cammino che por-ta al Duomo sarà più lungo e tortuoso, mapermetterà di conoscere chiese e palazzi.Alla rocca si sale anche, più velocemente,per mezzo di due ascensori, collocati l’u-no a lato del bastione di Saint-Remy, l’altroa metà del viale Regina Elena.
Bastione di Saint Remy (D3). Fu edificatofra il 1899 e il 1902 sistemando gli antichibastioni spagnoli dello Sperone e dellaZecca, nell’estremità meridionale del quar-tiere. Lo compongono due terrazze: quel-la più grande, intitolata a Umberto I, e l’al-tra, più piccola e sovrastante, dedicata aS. Caterina. Elemento di raccordo fra Ca-stello e Villanova, il bastione nacque comepasseggiata e belvedere panoramico, fun-zione rimarcata dallo scenografico pro-spetto neoclassico in granito e calcare,con arco trionfale e lunga gradinata in di-rezione di piazza Costituzione.Dal lato destro della scalinata parte laPasseggiata coperta. Gravemente dan-neggiato dai bombardamenti, il bastione èstato fedelmente ricostruito. Oggi, in di-suso come luogo di passeggio, è sede di unmercatino domenicale dell’usato.
In via Università, a sinistra l’ex Se-minario tridentino e l’Università(C3), costruiti nel ’700 sulbastione del Balice da Sa-verio Belgrano di Famo-lasco; a destra, accantoai ruderi del Teatro ci-vico impiantato anco-ra da Belgrano e ri-strutturato nel secolosuccessivo dal caglia-ritano Gaetano Cima,l’ottocentesco palazzoBoyl in via Mario De Can-dia. Superata la torre del-l’Elefante (v. sotto) si trovanole chiese di S. Giuseppe (1641),di S. Croce (1661, difronte al panorami-cissimo bastione del-lo stesso nome) e di S. Maria del Sacro Monte diPietà, eretta nel 1591 secondo un impianto tar-doaragonese. Aggrappato sulle mura di cinta delbastione di S. Croce si trova un complesso di co-struzioni indicate come Ghetto degli Ebrei. Inrealtà il quartiere dove la comunità ebraicaabitò sino al 1492, quando ne fu decretata la cac-ciata da tutti i territori, si estendeva nelle vici-nanze. La caserma militare S. Carlo, costruita nel1738 per disposizione delle autorità piemonte-
1 Cagliari e il suo territorio
42
si, è stata recentemente restaurata per farne unasede di eventi ed esposizioni.
Le torri di S. Pancrazio e dell’Elefante.Presenze caratteristiche nella scenografiacagliaritana, le due torri gemelle in concidi calcare furono costruite rispettivamentenel 1305 e nel 1307 su progetto dell’archi-tetto sardo Giovanni Capula. La torre di S.Pancrazio (B3), posta sul lato settentrio-nale di Castello, nel punto più alto dellarocca, permetteva il controllo di tutto ilterritorio intorno alla città: dal ’600 fino al-la fine dell’800 fu adibita a carcere. La tor-re dell’Elefante (C3), che segnava l’in-gresso alla parte più bassa del quartiere,è contraddistinta da un elefantino scolpi-to nella pietra, eletto a simbolo della città.
Cattedrale di S. Maria* (C3). Di impiantopisano, domina piazza Carlo Alberto, l’an-tica plazuela degli spagnoli, che si trova aun livello sottostante rispetto al pianostradale di piazza Palazzo. Dell’edificiooriginario la chiesa conserva all’esternola torre campanaria quadrata (tranne il pa-ramento, la cuspide e le monofore), l’ar-chitrave del portone centrale, i portalidel transetto, frammenti di tarsìe e scul-ture. Il primitivo prospetto medievale fu ri-disegnato nel 1702 in forme barocche daPietro Fossati e rifatto in ‘stile’ romanico-
pisano-lucchese nel 1933. Anche l’in-terno, a tre navate con presbi-
terio sopraelevato e tran-setto, ha subìto ampi ri-
maneggiamenti seicen-teschi nel corpo lon-gitudinale. Addossa-to alla controfaccia-ta è il pulpito*, rea-lizzato da Gugliel-mo da Pisa tra il1159 e il 1162 per il
Duomo della sua cittàe donato a Cagliari dal
comune toscano nel1312; nel 1670 fu smem-
brato in due parti e i quattroleoni posti alla basedelle colonne tra-
sferiti ai piedi del presbiterio.Nelle navate laterali si aprono tre cappel-le per parte: da notare (1a a destra.) Le noz-ze di Cecilia e Valeriano di Pietro Angelettie una gotica Madonna nera in legno dora-to (sec. XIV; 2a). Il transetto, con la primitivastruttura ad arconi, conserva nel bracciodestro una cappella in stile gotico catala-no, a pianta poligonale e volta nervata: il
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

trittico di Clemente VII, di attribuzione in-certa (Gerard David o scuola di Rogiervan der Weyden), occupa la parete sopral’altare. Dal transetto destro si raggiun-gono la sagrestia dei Beneficiati, l’aula ca-pitolare e il santuario scavato nella rocciae diviso in tre cappelle. Ritornati nell’aulacentrale, una scala conduce al presbite-rio, cinto da una balaustra in marmo di sti-le barocco; vi sono sistemati manufatti inargento e in ferro della produzione arti-giana sarda e iberica del ’600. Nel transettosinistro si apre una piccola cappella pisa-na con bifora. Nella cappella centrale del-la navata sinistra è di rilievo un Martirio diS. Barbara di pittore napoletano del sec.XVIII. Le volte sono state affrescate dal sar-do Filippo Figari tra gli anni trenta e ses-santa del Novecento. Locali annessi ospi-tano il Museo capitolare, che custodisce iltesoro del duomo: manufatti (in parte diproduzione locale) tra i secoli XVI e XIX, epreziosi paramenti sacri.
Palazzo viceregio (C3). Attuale sede del-la Prefettura e aula di riunione del Consi-glio provinciale, fu dimora dei viceré spa-gnoli e sabaudi. È di impianto catalano, rin-novato dai piemontesi. La sala di rappre-sentanza fu affrescata tra il 1894 e il 1895dal perugino Domenico Bruschi, che siispirò alla storia sarda per sei grandi com-posizioni siglate S.P.K. (Senatus Populu-sque Kalaritanus).
43
Per via Martini, si arriva in piazza Indi-pendenza (B3), delimitata dal conser-
vatorio delle Figlie della Provvidenza(1740), dalla torre di S. Pancrazio
(v. pag. 42), dal palazzo delleSeziate (così chiamato per le‘sedute’ in cui il viceré ascol-tava le richieste dei reclusinella vicina torre) e dalla se-de del Museo archeologico(v. sotto) progettata all’iniziodel xx secolo da Dionigi Sca-no. Con una deviazione invia La Marmora, prima disuperare il voltone che im-mette in piazza Arsenale e
porta alla Cittadella dei Mu-sei, si raggiunge la chiesa del-la Purissima.
La Purissima (B-C3). Costrui-ta nel 1554 per volontà della
nobildonna cagliaritana Gerola-ma Rams, insieme a un conventochiuso nell’800, la chiesa reca sulportale d’ingresso lo stemma deiBrondo, che vi esercitavano il pa-
tronato. L’interno è a una navata, cappel-le laterali e presbiterio rialzato. Tra i pre-ziosi arredi si segnalano un trittico di An-tioco Casula del 1593 (1a cappella destra),un’ancona lignea settecentesca all’altaremaggiore e un S. Girolamo di Lorenzo Cà-varo (1a cappella sinistra).
Cittadella dei Musei* (B3). Vi trovanoposto: la Pinacoteca nazionale, il Museosiamese Cardu, la Mostra di cere anato-miche di Clemente Susini e il Museo ar-cheologico qui trasferito da piazza Indi-pendenza nel 1993. La Cittadella occupal’area sin dal 1825 destinata all’Arsenalemilitare; i resti delle fortificazioni pisane,aragonesi, spagnole e sabaude sono ora in-globati nel recente e panoramico com-plesso progettato da Pietro Gazzola e Li-bero Cecchini. Accanto agli ambienti mu-seali trovano posto anche gli Istituti uni-versitari di Studi sardi e Antichità, Ar-cheologia e Arte.
Museo archeologico nazionale*. Mate-riali di altissima qualità testimoniano leculture antiche e tardoantiche che si sonosuccedute nell’isola, dal Neolitico (6000a.C.) sino all’età altomedievale (sec. VII-VIIId.C.). Provenienti dalle stazioni neoliti-che ed eneolitiche, dalle sepolture prei-storiche “domus de janas”, dai nuraghi eda tombe a pozzo, sono esposti: dell’eraprenuragica, vasellame ceramico decora-to e statuine di dee-madri in pietra e osso;
1.1 Cagliari: Castello
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

1.2 Cagliari: la città bassaItinerario solo in parte pedonale e suddiviso in più percorsi (pianta alle pagg. 40-41)
Il tragitto riguarda una porzione moltoampia della città e tocca i quartieri stori-ci ai piedi di Castello: Stampace, Marina eVillanova. È per questo consigliabile fra-zionarlo in più visite distinte. Uscendo daCastello per porta Cristina, si entra inStampace, che con Villanova costituival’area di espansione della città antica. Ilquartiere, ripartito idealmente da via Azu-ni in Stampace alto e Stampace basso,conserva ancora la struttura urbanisticamedievale. Nell’uniformità delle abitazio-ni, in gran parte ancora abbandonate al de-grado, spiccano le chiese di S. Michele e S.Anna. La visita a Stampace è però ancheconoscenza delle testimonianze delle ci-viltà che hanno attraversato la storia di Ca-gliari. L’anfiteatro romano e la villa di Ti-gellio, nella parte interna del quartiere, e,già ai margini di S. Avendrace, la necropolidi Tuvixeddu e la Grotta della vipera (rag-giungibili in auto o con le linee di bus 1 e9), confermano l’appartenenza di questi
luoghi all’antico insediamento punico e ro-mano. Conclude l’itinerario, riportandonel cuore della città, la sosta in piazzaYenne e la discesa per largo Carlo Felice,alla cui estremità sorge, di fronte al porto,il Palazzo comunale. Il lato opposto del lar-go Carlo Felice delimita il rione Marina, undefinito quadrilatero che richiama la strut-tura del castrum romano: lo segnano, inbasso, la palazzata ottocentesca di viaRoma e il porto, in alto via Manno (l’anti-ca sa Costa, oggi fulcro commerciale del-la città) e a est viale Regina Margherita.L’andamento delle strade, regolare nellaparte pianeggiante più vicina al mare, per-de linearità quando comincia a salire ver-so il colle, divenendo ripido sotto le forti-ficazioni di Castello. Il quartiere, antica-mente chiamato Lapola, era cinto da mu-ra, demolite alla metà dell’Ottocento. L’ab-bondanza di edifici religiosi (in parte scom-parsi) suggerisce di privilegiare in una ra-pida visita almeno le chiese del Santo Se-
dell’era nuragica, armi e lingotti di rame,forme di fusione per armi e strumenti dalavoro, decine di bronzetti**, databili dal-l’età del Ferro (900-750 a.C.) sino al perio-do fenicio, che raffigurano navicelle voti-ve, guerrieri, lavoratori esacerdoti ritratti in variepose; reperti fenici, punicie romani, tra cui spiccanogli splendidi gioielli punicidi Tharros*, paste vitree,avori, manufatti in osso,statue, stele, cippi, monete,vasi greci e romani; prezio-si oggetti di oreficeria del-l’età tardomedievale.
Pinacoteca nazionale*.Comprende retabli, tele,stemmi e arredi dal ’400 al’700, oltre a un’esigua colle-zione di pitture e sculture deisec. XIX e XX. La parte più in-teressante della raccolta è co-stituita dai retabli quat-trocenteschi provenien-ti dalla distrutta chiesa di S. Francesco inStampace, tra cui il retablo della Porziun-cola del Maestro di Castelsardo e quelli diPietro e Michele Càvaro e di Antioco Maì-nas, i maggiori esponenti della cinque-
1 Cagliari e il suo territorio
44
centesca scuola di Stampace. Più modesteappaiono invece le opere dei secoli XVII eXVIII. La sezione contemporanea è occupa-ta dalla ritrattistica di Giovanni Marghi-notti e Giuseppe Sciuti, dai busti di An-drea Galassi, Vincenzo Vela, Giuseppe Sar-
torio, Gavino Tilocca, insieme alle teledi artisti sardi della metà del secolo XXcome Stanis Dessy, Cesare Cabras,Pietro Antonio Manca, Mario Delita-la. Alla Pinacoteca è annessa ancheuna ricca e interessante collezione
artigianale-etnografica.
Museo siamese Cardu.Di proprietà comuna-le, comprende oltre1300 pezzi: armi, va-sellame e oggettiprovenienti daSiam, Laos, Celebes,
Giava, Malacca, Cina.
Mostra di cere anatomi-che di C. Susini. Racco-glie modelli anatomici in
cera colorata, minuziosi e perfetti. Furonocreati dal celebre ceroplasta fiorentinoClemente Susini, tra il 1803 e il 1805, per l’a-natomista di Olzai Francesco Antonio Boi,su incarico del futuro sovrano Carlo Felice.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

1.2 Cagliari: la città bassa
45
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
polcro e di S. Eulalia e, restauri permet-tendo, di S. Agostino in via Baylle. Viale Re-gina Margherita e, più in alto, il Terrapie-no indicano a occidente l’inizio di Villanova(Città nuova), che fu il quartiere dell’e-spansione di Cagliari verso la campagna.Il confine orientale si è progressivamentespostato nell’ultimo secolo, dando originesoprattutto nel secondo dopoguerra anuovi grandi quartieri. Scomparse le mu-ra che cingevano il nucleo storico, Villa-nova continua a mantenere nella partepiù antica la vocazione ‘rurale’ delle sueabitazioni. Tra case basse e uniformi, pri-ve di architetture pubbliche o private di ri-lievo, si nascondono infatti molti orti egiardini. Dalla salita del Terrapieno si rag-giungono i giardini pubblici e la Galleria co-munale d’Arte moderna. Scendendo per ivicoli ripidi e le scalette che tagliano tra-sversalmente il quartiere, merita di esse-re conosciuta la chiesa di S. Domenico. Sitorna quindi indietro in piazza S. Giacomo,dove sorgono la chiesa e l’oratorio delCrocifisso, punto di partenza delle pro-cessioni che animano i riti della SettimanaSanta. Verso est, con un lungo percorso apiedi ben oltre Villanova, si arriva alla ba-silica paleocristiana di S. Saturno. A orien-te la basilica di Bonaria domina il colle difronte al mare. Dalla direttrice di vialeDiaz, sottostante alla chiesa, si accede algrande recinto della Fiera della Sardegna,aperta tra aprile e maggio con un’esposi-zione campionaria annuale.Ancora più avanti, deviando a destra pri-ma di arrivare al Poetto, la grande spiaggiadei cagliaritani, merita una visita S. Elia, ilborgo dei pescatori.
S. Michele (C2). Uno dei maggiori esempidel barocco spagnolo nell’isola, fu co-struita dai Gesuiti nel XVII sec. insieme al-la contigua casa del Noviziato, ora sede del-l’Ospedale militare. Un portico a tre arca-te immette nell’atrio dove è collocato il pul-pito di Carlo V, scolpito a bassorilievo.Dal pergamo l’imperatore avrebbe assi-stito alle cerimonie religiose indette nel1535 in occasione della spedizione controTunisi partita dal porto di Cagliari. L’in-terno della chiesa, a pianta ottagonale cu-polata e cappelle radiali, riprende l’ab-bondanza di ornamentazioni del prospet-to. La sagrestia, affrescata da Giacomo Al-tomonte, conserva tra i molti quadri Lastrage degli innocenti, opera di grandi pro-porzioni dipinta nel primo Settecento dal-lo stesso Altomonte e dal napoletano Do-menico Colombino.
S. Anna (C2). Costruita tra il 1785 e il 1817,è in stile tardobarocco di ispirazione pie-montese, con ampia scalinata d’accesso inmarmo bianco e due campanili (il secondoinnalzato negli anni trenta). L’interno, a uni-ca navata con cappelle laterali e presbite-rio, conserva tra gli arredi anche una sta-tua del beato Amedeo di Savoia, opera delsassarese Andrea Galassi. L’edificio subìgravi danni nei bombardamenti del ’43,ma fu fedelmente ricostruito.
S. Efisio (C2). Sorge dietro la chiesa di S.Anna, ed è dedicata al martire cristiano na-tivo di Elia, in Asia Minore. Il raccontoagiografico vuole che Efisio, inviato in Sar-degna da Diocleziano per combattere ibarbaricini e gli iliensi, sia stato ucciso aNora nel 304 per non aver rinnegato lasua religione. Nacque così una devozioneche si rafforzò dopo il 1652, quando nel-l’estremo tentativo di salvare la città dauna terribile pestilenza i consiglieri civicisi rivolsero al santo, legando Cagliari al vo-to perpetuo di un rito annuale di ringra-ziamento. Dalla chiesa settecentesca, edi-ficata sul probabile carcere del soldatoromano, parte ogni 1° maggio una grandesagra* che fonde religiosità e folclore.Centinaia di partecipanti in costume tra-dizionale, convenuti da ogni parte dell’i-sola, sfilano a piedi o su “traccas” (carri abuoi bardati a festa) secondo un precisocerimoniale. Li accompagnano miliziani acavallo, suonatori di “launeddas” e i mem-bri dell’arciconfraternita di S. Efisio. Pre-ceduta a cavallo dall’“Alternos”, rappre-sentante della municipalità, la processio-ne è chiusa dal cocchio dorato con una sta-tua lignea del ’600 di modesta fattura cheritrae il santo in fogge spagnolesche. Ilcorteo raggiunge la massima solennità invia Roma per sciogliersi in viale Pula, dadove il simulacro comincia il viaggio ver-so Nora per ritornare a Cagliari, con pro-cessione ridotta, il 4 maggio.
Anfiteatro romano e villa di Tigellio. Apoca distanza l’uno dall’altra (rispetti-vamente in viale Fra’ Ignazio e in via Ti-gellio), sono tra le maggiori testimonian-ze del periodo romano. L’anfiteatro* (B2),del sec. II d.C., conserva gran parte dellegradinate ellittiche, la cavea, le recinzio-ni e il podium da cui i maggiorenti assi-stevano ai giochi. La villa di Tigellio (C2)prende il nome dal musico sardo amico diCesare e Cleopatra, vissuto nel I sec.a.C.,ma nessun elemento storico avvaloraquesta relazione. I ruderi del comples-

so, da tempo recintati e osservabili a di-stanza, mostrano un sistema di tre domusad atrio tetrastilo, impluvium e tablinumcon vani laterali e altri ambienti nellaparte retrostante. La casa del tablino di-pinto e la casa degli stucchi conservano iresti di eleganti decorazioni.
Necropoli di Tuvixeddu (A1, f. p.). Di ori-gine fenicio-punica, fu utilizzata anche dairomani. Gli scavi, iniziati nel XIX secolo,hanno messo in luce centinaia di tombeprevalentemente a pozzo verticale, a unao due sepolture e ricche di corredi fune-rari, databili tra il sec. VI a.C. e il I d.C. Diparticolare rilievo sono la tomba dell’Ureo,dalla figura alata ritratta nella fascia pa-rietale interna, e quella del combattente, incui è dipinta la figura di un guerriero, for-se il divino Sid liberatore da tutti i mali. At-tualmente la necropoli è visitabile solodietro appuntamento con la Soprinten-denza. Attende attuazione un progetto diparco archeologico e museo.
Grotta della vipera* (A1, f. p.). All’iniziodi viale S. Avendrace, prosecuzione di via-le Trento (B1), protetta da una cancellata,la grotta scavata nella roccia è contrasse-gnata dall’emblema di due serpenti scol-piti nel frontone. Risale al sec. I d.C. e ori-ginariamente aveva la forma di un colom-baio, con atrio e colonne ora scomparsi.Deve la sua notorietà alle iscrizioni in gre-co e latino che raccontano la storia di Ati-lia Pomptilla, devota moglie di Cassio Fi-lippo, che si offerse agli dei per liberare ilmarito dal pericolo di morte.
Piazza Yenne (C2-3). Cuore di Stampace,la sovrasta il bastione di S. Croce, che necostituisce uno scenografico sfondo. In-titolata al viceré sabaudo Yenne e cinta inparte da palazzotti ottocenteschi, è stata
46
risistemata con nuova pa-vimentazione, panchine,vasconi decorativi e lam-pioni. Una colonna in pie-tra, datata 1822, indica l’i-nizio della strada, volutada Carlo Felice, che con-giunge il capoluogo sardoa Sassari e a Porto Torres.Un monumento al sovra-no sabaudo si alza pocopiù avanti, in cima al largoomonimo. La statua, cheritrae il re in foggia roma-na, fu commissionata dagliStamenti sardi ad Andrea
Galassi nel 1827, ma collocata sul basa-mento in granito (disegnato da GaetanoCima) solo nel 1860. Singolare la posaassunta dalla figura in bronzo, che indicauna direzione opposta a quella dellastrada che intende celebrare.
A ridosso della scalinata di S. Antonio la chiesadel Santo Sepolcro, ha la stessa intitolazione del-l’antica confraternita (detta anche dell’Orazio-ne e Morte) che curava la sepoltura dei poverinel piccolo cimitero oggi occupato dalla piazza.Di impianto tardogotico, a navata unica, pre-sbiterio coperto da volta a crociera e cappellelaterali, conserva tracce evidenti di interventiin epoca barocca: a questa fase è da ricondur-re la grande Cappella della Pietà, costruita nel1686 dal viceré Lopez de Ayala; un bel retabloligneo reca l’effigie della Vergine della Pietà.
S. Agostino (D2). La chiesa, progettatada Giorgio Palearo (il Fratino) nel 1577, èuna delle poche architetture rinascimen-tali in Sardegna. Vi era annesso il conven-to degli Agostiniani, smantellato nella se-conda metà dell’800. Gli scavi hanno ri-portato in luce reperti romani e tardoan-tichi, che sembrano ricollegare tutta l’areaa una complessa struttura termale. L’edi-ficio ha prospetto sobrio e lineare, appe-na arricchito dai motivi floreali della cor-nice dell’architrave. Nell’interno con pian-ta a croce greca, con bracci voltati a bot-te e sormontati da una cupola emisferica,preziosi arredi e altari in legno dorato.
Risale al sec. XV, ed è parrocchiale del quar-tiere Marina, la vicina chiesa di S. Eulalia. Co-struita in stile gotico catalano, a navata unicae cappelle laterali, occupa un’area antichis-sima, messa in luce da scavi recenti, dove so-no affiorati resti di una via lastricata e di edi-fici romani. Sul retro della chiesa è il museoche raccoglie il tesoro di S. Eulalia: argenti,preziosi paramenti sacri, crocifissi e statue li-gnee, con alcuni pezzi pregiati provenienti
1 Cagliari e il suo territorio
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

dalla bottega dello scultore settecentescoGiuseppe Antonio Lonis.
Galleria comunale d’Arte moderna*(A3). Da piazza Marghinotti la lunga e pa-noramica salita del Terrapieno conduce aigiardini pubblici. In fondo all’area verdesorge una palazzina in stile neoclassico,che in origine svolgeva funzioni di polve-riera. Riattata alla fine degli anni venti,ospita la Galleria d’Arte moderna e, in lo-cali collegati, la Biblioteca e l’Archiviostorico comunali. La Galleria conservauna collezione di sculture e pitture delleneoavanguardie italiane degli anni ’60 e ’70,affiancate a quelle degli artisti sardi che sisono ricollegati alle ricerche internazionalicontemporanee. Trovano posto anche leopere degli artisti isolani del Novecento,cui sono dedicate in prevalenza le mostretemporanee. Dal gennaio 2001 la Galleriasi è arricchita di una eccezionale colle-zione di oltre 700 opere dei maggiori arti-sti del Novecento, appartenuta all’avvo-cato romano Francesco Paolo Ingrao edonata dalla signora Elisa Mulas.
S. Domenico* (C4). Il primo impianto ri-salirebbe, secondo la tradizione, al 1254,ma la chiesa tardogotica, ora quasi inte-ramente distrutta, fu iniziata ai primi del’400. I danni della seconda guerra mon-diale imposero la riedificazione del com-plesso. L’architetto Raffaello Fagnoni ela-borò il progetto di recupero delle partiantiche sopravvissute, da inglobare nelnuovo edificio inaugurato nel 1954. Ne è ri-sultata una costruzione dal prospetto incalcare, con ampia gradinata e campanilea canna quadrata, interno a navata unicacon due altari laterali, presbiterio so-praelevato, sovrastato da cupola ogivale.L’antica chiesa gotica funge da cripta: nel-la grande cappella del Rosario (1580; 5a dasinistra) si conserva uno stendardo che gliarchibugieri sardi avrebbero innalzatonella battaglia di Lepanto del 1571. L’in-gresso al convento si apre su via XXIVMaggio, da cui si accede al chiostro a pian-ta quadrata, risparmiato dalle bombe. I di-versi stili dei bracci ne rimandano la co-struzione a tempi distinti: quelli a sud-ovest, coperti da belle volte a crocieragemmate, appartengono alla fine del ’400,gli altri due al XVI secolo.
Piazza S. Giacomo (C3). Nella piazza siraccolgono la chiesa di S. Giacomo e, a fian-co, l’oratorio del Crocifisso*. La chiesa, lacui esistenza è già documentata nel 1346,
1.2 Cagliari: la città bassa
47
conserva ancora lo schema catalano a na-vata unica con ‘capilla mayor’ rialzata ecappelle laterali. Ampliata e dotata di cam-panile tra 1438 e 1442, subì nel ’700 l’oc-cultamento delle strutture tardogotiche.L’attuale prospetto neoclassico fu dise-gnato da Gaetano Cima nel 1838. Dopo ibombardamenti è stata riparata con suc-cessivi interventi che hanno riportato inluce gli elementi gotici di alcune cappelle.Tra gli arredi è degno di nota (1a cappellasinistra) il gruppo del Sepolcro in terra-cotta policroma (sec. XV-XVI).L’oratorio del Crocifisso (o del Santo Cri-sto) fu edificato fra 1665 e 1667 su una pre-cedente struttura. Nell’interno si custo-discono le statue lignee dei sette Misteri diCristo, scolpite da Giuseppe Antonio Lonisa metà del sec. XVIII e tuttora portate in pro-cessione durante la Settimana Santa. I ri-ti, seguiti con commossa partecipazionepopolare, sono di ascendenza spagnola eobbediscono a un complesso cerimoniale.
La processione dei Misteri è organizzata dal-l’arciconfraternita del Crocifisso (operante dal1616): il venerdì precedente la Domenica dellePalme i confratelli accompagnano le statue delLonis in sette chiese del centro storico, la-sciando in ognuna un simulacro. All’arcicon-fraternita della Solitudine (1608) è affidata laprocessione del Cristo morto che il VenerdìSanto porta i simulacri del Cristo e dell’Addo-lorata da piazza S. Giacomo al Duomo, attra-verso viale Regina Elena e le vie Mazzini, De Can-dia e Canelles. Un analogo corteo parte dall’o-ratorio del Crocifisso alle 15 e percorre le vie Su-lis, Garibaldi e Sonnino alla volta della chiesa diS. Lucifero in piazza Ss. Cosma e Damiano. Lamattina di Pasqua avviene “s’incontru” tra lastatua del Cristo risorto e quella della Madon-na. Il rito parte ancora da piazza S. Giacomo esi conclude in via Garibaldi.
S. Saturno* (D4). Sorge nella piazza inti-tolata a Cosma e Damiano, i santi protet-tori della corporazione dei medici e deglispeziali, ed è una delle più antiche chiesedi tutta l’isola: l’area che la circonda èconnessa alla necropoli romana orientalee paleocristiana. Il primo impianto risaleal V-VI sec., sul martyrium del santo ca-gliaritano Saturno: la struttura era a crocegreca sovrastata da una grande cupolaemisferica. Dai Vittorini di Marsiglia, cui fuaffidata nel 1089, fu trasformata in sensobasilicale. Al gusto romanico-provenzale sidevono il completamento del braccioorientale, diviso in tre navate, e il corpo an-teriore, che con il crollo della volta as-sunse la funzione di atrio. La distruzionedei bracci a nord e a sud coincise con
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

l’abbandono dei monaci, che determinò ladecadenza dell’edificio di culto. Colpita daibombardamenti del 1943, la basilica fu ri-pristinata nel dopoguerra.
Nella vicina via S. Lucifero (D4) si troval’Exmà, il mattatoio cagliaritano; costruitonel 1845 su progetto di Carlo Barabino e rin-novato nel 1892, è stato restaurato e adibito acentro culturale. La struttura, che ha recupe-rato in gran parte l’edificio originario, è arti-colata in locali affacciati su un grande spazioaperto. Accoglie mostre temporanee, confe-renze, spettacoli.
Nostra Signora di Bonaria* (E-F5). La col-lina da cui prende il nome (Buon’aria, per-ché distante dai miasmi pestilenziali cheavvolgevano le sottostanti spiagge di suSiccu) è un luogo storico: ospitò infatti l’in-sediamento delle truppe aragonesi primache conquistassero il Castello nel 1326. Al-la dominazione catalano-aragonese si rial-laccia il santuario, la parte più antica del-l’intero complesso che comprende anchela basilica e il convento dei Mercedari.Nonostante i rimaneggiamenti ottocente-schi che ne hanno allungato il corpo cen-trale, la basilica conserva lo schema ori-ginario a navata unica con presbiterio a ba-se poligonale e cappelle laterali. Pure ara-gonese è la torre campanaria, i cui ruderisi vedono sul retro della costruzione. Il bel
48
portale gotico proviene invece dalla chie-sa di S. Francesco in Stampace, distruttanel 1875. Sull’altare maggiore è collocatala statua lignea della Madonna, che se-condo una leggenda sarebbe qui appro-data nel 1370. Nella scalinata che scendeverso il mare, una colonnina segna il pun-to in cui sarebbe stato ritrovato il simula-cro della Vergine, ora protettrice dei na-viganti. Più fondatamente però la statua ri-sale alla seconda metà del ’400. Nella sa-grestia del santuario si può visitare unasingolare collezione di imbarcazioni d’e-poca in miniatura e altri ex voto dei sec.XVII-XVIII, offerti da pescatori e marinai. Labasilica fu edificata nel 1704 su progetto diFelice De Vincenti, poi rimaneggiato daGiuseppe Viana. La monumentale costru-zione, con prospetto in calcare e lungascalinata d’accesso, interno a croce latinadivisa in tre navate e cupola ottagonale al-l’incrocio dei bracci, è uno degli elementicaratterizzanti del paesaggio cittadino.
A sud-est, oltre lo stadio calcistico, è il vecchioBorgo S. Elia, già di pescatori e sorta di ap-pendice della città. Il quartiere di piccole abi-tazioni in parte risanate e di caseggiati co-struiti negli anni settanta, ospita un caratteri-stico mercato domenicale del pesce. Il Lazza-retto, antico ricovero per gli equipaggi delle na-vi ritenute infette, è stato restaurato e apertoalla visita: è sede di un museo del fumetto sar-do e di mostre temporanee.
1 Cagliari e il suo territorio
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

49
1.3 Il territorio di CagliariItinerario automobilistico attorno al capoluogo con arrivo a Gùtturu Mannu, km 67 escluse ledeviazioni (carta qui sotto)
Se i guasti nel territorio che cinge Caglia-ri sono molti, non sono meno numerosi,tuttavia, i frammenti di natura, di storia, diarte, di folclore che meritano di essereconosciuti. Per una veduta d’assieme deipaesaggi dell’hinterland e del Campida-no meridionale si consiglia di salire sulcolle di S. Michele*, nella periferia nord-ovest: con un percorso che si snoda entroun parco, fra vegetazione spontanea e pra-ti verdi, si raggiunge sulla cima l’omonimoCastello di epoca pisana, recentementerestaurato ma non ancora aperto al pub-blico; da questo punto panoramico, il piùalto della città con i suoi 120 m, si può os-servare Cagliari circondata dal mare, daglistagni e dalle montagne del Sulcis a oveste da quelle del Sàrrabus a est. Dall’altraparte della città si può seguire l’asfalto diviale Europa (D-E6) e raggiungere il colle diMonte Urpinu. Ammantato di pini e im-preziosito da laghetti artificiali, popolati dioche e anatre, il colle, nella parte più ele-vata, offre un panorama suggestivo con glistagni e le saline del compendio del Mo-
lentàrgius, gli abitati che assediano glispecchi d’acqua, le montagne che chiu-dono l’orizzonte. La zona umida è un’oasidi eccezionale importanza per la varietà eil numero di uccelli che vi trovano rifugio,come si vede quando si percorre l’asseviario di scorrimento veloce che aggira lacittà costeggiando lo stagno tanto da vi-cino che è possibile scorgere fenicotteri, ai-roni o garzette a pochi metri dalla strada,oppure il lungomare che divide le acquestagnanti dalla sabbia di una delle spiaggepiù vaste d’Italia, quella del Poetto, o quan-do si viaggia lungo viale Marconi, lam-bendo i canneti del Bellarosa Minore. L’a-sfalto di entrambi i percorsi porta nel ter-ritorio di Quartu Sant’Elena, la terza cittàdella Sardegna per numero di abitanti. Aessa si salda ormai, senza interruzione,l’abitato di Quartucciu, che a sua volta sicongiunge con Selàrgius, così come que-st’ultimo si unisce a Monserrato, che s’in-contra con Pirri.Ciascuno di questi centri ha radici nel vec-chio mondo rurale e ne conserva il ricor-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

do nelle case dai grandi portali e dai mat-toni di fango e paglia, nelle chiesette me-dievali, nelle sagre, nei costumi, nei dolcid’una volta. Dove non ha imperversato ilcemento affiorano ogni tanto, come tes-sere disperse di un antico mosaico, resti divillaggi neolitici, ceramiche del primo Cal-colitico sardo, tombe monumentali e poz-zi sacri d’età nuragica, insediamenti punici
50
e romani, chiese bizantine. Alcune di que-ste tessere, come la tomba di giganti di IsConcas, lungo le pendici del Sette Fratel-li, e il villaggio nuragico di Fanèbas, nelcomplesso montano di Gùtturu Mannu,sono inserite in suggestive oasi naturali. In
una di esse, a GùtturuMannu, riecheggiano,a fine estate, i bramitidei cervi in amore.
Molentàrgius*Si percorre viale Mar-coni, da Cagliari ver-so Quartu. All’ingressodi Quartu si gira a de-stra in via Turati e siprosegue in via della
Musica, percorsa la quale si svolta, semprea destra, per via Is Arenas, una stradasterrata che costeggia lo stagno di Mo-lentàrgius sino alla cosiddetta Città delsale, le vecchie strutture dell’industriadelle saline, alla periferia di Cagliari versocapo Sant’Elia e il Poetto. Si possono esplo-rare così i segreti dello stagno e conosce-re da vicino i suoi eccezionali abitatori: fe-nicotteri rosa dal collo sinuoso, falchi dipalude che solcano l’aria in cerca di prede,garzette dalla livrea candida, avocette dallungo becco ricurvo, polli sultani chescompaiono tra i canneti del BellarosaMinore. È un pianeta a sé, dove la vitascorre tra richiami nascosti, pigre nuota-te, tuffi nell’acqua, voli improvvisi. Neigiorni degli arrivi autunnali, quando mi-gliaia di esemplari delle specie più diver-se si ritrovano assieme, lo stagno diventaun vero spettacolo: sembra che vi si fe-steggi, tra battiti d’ali e voli radenti, unagrande sagra dedicata al dio dei nomadidell’aria. Ma lo spettacolo più affascinan-te Molentàrgius lo offre da qualche anno aquesta parte in primavera quando i feni-cotteri, creando una splendida macchia ro-sa, si raggruppano a migliaia sugli arginiper nidificare (v. box qui accanto).
Alcuni anni fa, quando l’inquinamento dello sta-gno era ancora sotto controllo, il complessodel Molentàrgius vedeva in attività anche l’anticaindustria del sale (v. box a pag. 52), già cono-sciuta al tempo dei fenici. Poi i liquami hanno in-vaso le vasche evaporanti delle saline e la pro-duzione si è spenta del tutto. L’auspicata isti-tuzione del Parco di Molentargius dovrebbeportare a un risanamento delle zone inquinate,al ripristino delle attività delle saline e a una mi-gliore fruizione da parte dei visitatori, anche conla possibilità di percorrere in canoa i canali checosteggiano lo stagno collegandolo al mare.
Per i milioni di uccelli che, di stagione instagione, migrano dalle zone fredde alleregioni più calde, attraversando da norda sud il Mediter-raneo, la Sarde-gna è la sedeideale per ripo-sarsi prima di ri-prendere il vo-lo. Sono soprat-tutto gli stagni, ein particolarequelli della par-te meridionaledell’isola (a cli-ma più temperato), ad attirare queste le-gioni di visitatori volanti. È stato calco-lato che nel solo stagno di Molentàr-gius, ai bordi del grande lido cagliarita-no del Poetto, abitano 177 delle 330 spe-cie che compongono l’intera famigliadegli uccelli sardi, più di un quarto del-la più grande famiglia degli uccelli eu-ropei. In certi periodi dell’anno arrivanoa superare anche i 10 mila individui.Di questi abitatori delle zone umide ilpiù amato è il fenicottero, che sverna inSardegna da ottobre a marzo-aprile. Isuoi luoghi sardi di riferimento sono inparticolare, oltre quello di Molentàr-gius, gli stagni del Sinis, presso Orista-no, e di Sant’Antìoco. Una certa quantitàdi esemplari si ferma anche negli stagnisettentrionali di Stintino e Alghero e inquelli meridionali di Muravera e Villa-simìus. «Se alcuni restano nell’isola an-che durante l’estate - scriveva qualcheanno fa Attilio Mocci Demartis, emeritostudioso dell’avifauna isolana - questisono per la maggior parte immaturi nonancora pronti alla cova». Ma da qualcheanno in qua i fenicotteri hanno ripresoa nidificare a Molentàrgius. Nell’Orista-nese li chiamano sa genti arrubia, ‘il po-polo rosso’: basta vederli levarsi in vo-lo, con le fiammeggianti ali spiegate,per capire il perché.
Sa genti arrubia
1 Cagliari e il suo territorio
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Quartu Sant’ElenaDa via della Musica si raggiunge il centro diQuartu Sant’Elena (m 6, ab. 68 384). In viaEligio Porcu, al N. 271, una tipica casa cam-pidanese ospita il Museo etnografico “Il ciclodella vita”*: una raccolta di reperti risa-lenti a un periodo storico compreso tra ilXVIII e il XX secolo e provenienti da tutta laSardegna permette di ripercorrere i mo-menti significativi della vita, dalla nascita al-la morte, della società agro-pastorale sardae dei rituali propiziatori ad essi legati. Den-tro la città raccontano il passato le chiesettemedievali di S. Maria di Cepola e di S. Pietrodel Ponte; richiama lontani riti pagani ilcarro a buoi a forma di prua di nave che,nella sagra di S. Giovanni, trasporta in pro-cessione sino alla chiesa campestre di S. An-drea, sette giovinette, “is traccheras”, ve-stite con i costumi della tradizione.
Da Quartu Sant’Elena, raggiungendo lacirconvallazione 554, si può imboc-care la statale per Muravera, girare adestra al bivio per Piscina Nuxedda eproseguire sino a San Pietro Paradiso,dove s’incontra, nella zona di Is Con-cas, a destra della strada, una ‘tombadi giganti’*, un monumentale sepolcronuragico con la grande esedra, le fos-se sacrificali e il bètilo.
SelàrgiusLungo la statale 554 la segnaleticaindica, dopo Quartucciu, l’acces-so per Selàrgius (m 11, ab. 26 612).Si è nella Kellarious bizantina egiudicale, ma il paese affonda ra-dici ben più antiche nell’area prei-storica di Su Coddu, che ha resti-tuito numerosi reperti del Neoli-tico di S. Michele d’Ozieri e scoriedi fusione di rame e argento delprimo Calcolitico sardo. Purtrop-po gran parte dell’area archeolo-gica è ormai sepolta sotto il ce-mento dell’hinterland: ne sanno qualcosale vecchie domus campidanesi, le case acorte dai grandi portali archivoltati e daimuri in “làdiri” (mattoni di fango e pa-glia), sempre più sacrificate ai bisogni del-la città che cresce. Di esse solo alcune re-sistono tra la via Roma, dove s’incastonail carcere seicentesco dei marchesi diQuirra, nella cui struttura è in allestimen-to un museo archeologico che raccoglie ireperti provenienti dai siti del territorio se-largino, e la piazza Si’ e Boi, dove la cimi-niera in mattoni rossi d’una ex distilleria diliquori sfida in altezza la cupola della par-rocchiale dell’Assunta.
1.3 Da Molentàrgius a Settimo San Pietro
51
Qui, sulla sinistra della parrocchiale, èperò un gioiello dell’arte romanica a ri-chiamare l’attenzione: la piccola chiesa diS. Giuliano*. Costruito con materiale dispoglio d’età romana, come mostrano ete-rogenei fusti di colonne e capitelli, il pic-colo tempio, datato tra XII e XIII sec., è con-siderato, pur nelle sue minute dimensioni,una “mirabile opera di architettura me-dievale”. In esso, da qualche tempo, si è in-nestato un rito recente, quello della pro-messa ai figli futuri fatta ogni anno da unagiovane coppia di sposi che, in settembre,si unisce in matrimonio nella chiesa del-l’Assunta legandosi simbolicamente conuna catena, così come vuole l’usanza di “sacoia antiga”, lo sposalizio della tradizione.
Settimo San PietroAll’uscita da Selàrgius si attraversa la sta-tale 554 per Settimo San Pietro. Bastano po-
co più di 3 km per raggiungere il paese (m70, ab. 5829). Dopo le prime case si svoltaa sinistra, in via Gramsci, e si va avanti si-no a incontrare, sempre a sinistra, la stra-da che conduce alla collina di Cùccuru Nu-raxi, che nel suo grembo accoglie un tem-pio nuragico a pozzo. Il colle «divenne la se-de di un singolare edificio religioso per ilculto naturalistico delle acque – scrivel’archeologo Enrico Atzeni – di un santua-rio nell’inusitata proiezione in luogo alto eisolato, visibile a grande distanza, e nell’i-nedita articolazione con un nuraghe». Dalla strada per Cùccuru Nuraxi si rag-giunge anche il Golf Club Meirana, un cam-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

po pratica che sarà ampliato sino a di-ventare un percorso a diciotto buche.
SestuSi torna indietro sino alla statale 554 e sisvolta a destra in direzione del bivio perSestu (m 44, ab. 13 998). Dal bivio al pae-se sono 6 km. Si attraversa per intero l’a-bitato verso nord per raggiungere, dopomeno di 5 km, la chiesa di S. Gemiliano; ro-manica, a due navate (XIII sec.), vi si cele-bra ai primi di settembre una grande sagradedicata al santo. Il colle su cui sorge iltempio ha rilevante interesse anche perl’archeologo: per un lungo arco di secoli,in tempi diversi, vi hanno vissuto, in mo-desti villaggi di capanne, comunità neoli-tiche, calcolitiche e nuragiche.
AssèminiDista da Sestu una decina di chilometri; lasi raggiunge dalla statale 131 e da qui sul-la 130. Nel cuore del nucleo storico delpaese (m 6, ab. 23 109), che si raccoglie at-torno allo svettante campanile della par-rocchiale di S. Pietro (sorta nell’XI sec., maricostruita nel XVI), merita una visita, pocopiù a sud, la bizantina piccola chiesa di S.Giovanni*, con pianta a croce greca in-scritta e campanile a vela, del X-XI sec.;conserva all’interno alcune epigrafi giu-dicali in caratteri greci.In paese sono numerosi i laboratori di ce-ramiche. Nella Mostra Mercato dell’Arti-gianato locale (in via Lazio), curata dall’I-
1 Cagliari e il suo territorio
52
stituto Sardo per l’Artigianato, si possonoconfrontare i diversi metodi di lavorazio-ne delle ceramiche e acquistare, oltre aqueste, elaborati dell’artigianato.A ridosso dello stagno di Santa Gilla, pres-so l’Istituto Tecnico Giua, è allestito il Mu-seo di Storia naturale Aquilegia: le sue sa-le sono dedicate agli aspetti paleontolo-gici, geologici, zoologici e botanici dellaSardegna, di cui sono ricostruiti, a scopodidattico, due ambienti tipici, quello la-gunare e quello montano. Il richiamo mag-giore, però, Assèmini ce l’ha lontano dal-l’abitato, nell’oasi di Gùtturu Mannu. Ci siarriva percorrendo verso sud la stradache conduce agli impianti dell’Enichem,l’industria chimica di Macchiareddu, invista delle candide saline di Santa Gilla. Sisvolta poi verso ovest, in direzione dellamontagna. Tra lecci e lentischi, carrubi eoleandri, cisti ed eriche, una strada bian-ca s’inerpica dentro l’oasi verde, raggiun-ge la chiesetta di S. Lucia, il bivio per la mi-niera abbandonata di S. Leone, la diga diS. Antonio e, ancora oltre, la zona di Is Pau-ceris dove affiorano ruderi e ceramiche diun insediamento punico-romano.
Più avanti s’incontra un incrocio e si prende adestra per la fonte di Fanèbas, un’ottima sor-gente frequentata già nella preistoria. In que-st’angolo di montagna sembra che storia e na-tura si siano alleate per comporre un mosaicodi grande fascino con i resti muschiati d’un vil-laggio nuragico nascosto tra i lecci e l’acqua lim-pida di un attraente laghetto.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Tra Cagliari e Quartu, subito alle spalle del vasto litorale del Poetto, che è la gran-de spiaggia dei cagliaritani, si stende per oltre 500 ettari lo stagno di Molentàrgius.Il suo nome racconta la sua storia. Molenti, nella Sardegna meridionale, è il nomedell’asinello che, nelle case contadine, girava sa mola, il piccolo mulino domesti-co. E molentargiu è l’uomo che guida l’asinello. Molentargius, ‘asinai’, erano gliuomini che nei secoli passati venivano qui a trasportare sino al luogo dell’imbarcoil sale prodotto nelle saline dello stagno.Un tempo dallo stagno si estraevano altri sali oltre il cloruro di sodio, cioè il nor-male sale marino. Si calcola che la produzione annua raggiungesse, anche in tempirecenti, le 130 mila tonnellate. Una serie di canali e poi quello principale, detto diTerramàini, fornivano alle chiatte che andavano al mare vicinissimo una comodavia per il trasporto del prodotto. L’attività delle saline diede vita nel tempo nonsoltanto a strutture per la lavorazione e la conservazione del prodotto, ma anchead una sorta di piccolo villaggio, oggi destinato ad altri usi, con edifici propricome la palazzina della direzione e addirittura anche un piccolo teatro, oggi intel-ligentemente restaurato (e che si chiama, non a caso, il Teatro delle Saline). Mamentre l’attività saliniera si va esaurendo con l’apparire di nuovi concorrenti sulmercato mondiale, Molentàrgius viene trasformato in un parco naturale, impor-tante per la sua vegetazione e soprattutto per la grande attività di specie di uccelliche vi abitano o che vi vengono a svernare.
Le saline di Molentàrgius

2 Il Sulcis e l’Iglesiente: mare e miniere
53
Profilo dell’areaMare e miniere abbandonate ma non solo, in questa terra dipianure, colline e montagne boscose. Tanta archeologia, in-nanzitutto, giacché l’uomo scelse di viverci già dai tempi piùremoti. Chi sale sul pianoro di Montessu può pensare che gliuomini non potevano trovare 5000 anni fa luogo migliore per far riposare i loro morti:tombe scavate nella roccia, chiuse da portelli di pietra e custodite da simboli divini inun anfiteatro naturale che guarda verso il mare. Ma furono soprattutto i fenici e i puni-ci che privilegiarono questa parte di Sardegna per i loro insediamenti: Sant’Antìoco, No-ra, Monte Sirai. Navigatori e commercianti, approdati attraverso rotte già percorse daimicenei, che scelgono gli approdi migliori, che costruiscono case e templi, che porta-no la scrittura. E lasciano la suggestiva testimonianza del tophet. Luogo di sacrificio cruen-to per gli dei, come ci hanno raccontato gli storici romani, o terra consacrata ai fanciullimorti prematuramente, come ci dicono gli archeologi. Pochi luoghi invitano al silenziocome il tophet di Sant’Antìoco. Nella valle di Àntas le colonne d’un tempio punico-romanoreggono la dedica al Sardus Pater, il dio dei sardi divenuti ormai romani. E poi gli edifi-
ci del culto cristiano: la piccola chiesa romanica di S. Efisio, a due passi dal mare, dovea maggio ritorna ogni anno il santo per ricordare il suo martirio, la cattedrale di S. Ma-ria di Monserrato rimasta a guardia del villaggio deserto di Tratalìas, il santuario diSant’Antìoco con le tombe dei primi cristiani, le chiese di Iglesias. E con gli edifici le an-tiche tradizioni religiose: la suggestiva processione sulla spiaggia di Nora per Sant’Efi-sio, i riti della Settimana Santa a Iglesias e Teulada, il matrimonio mauritano a Santadi.E, infine, l’archeologia industriale: le montagne di detriti, le gallerie, i pozzi, i miseri vil-laggi, gli eleganti edifici della direzione e un’intera città, Carbonia. Un patrimonio immensoche dovrebbe costituire la parte più consistente del Parco geo-minerario della Sardegna.Sullo sfondo, il paesaggio naturale. Il mare con lunghe spiagge di sabbia finissima e sco-gliere frastagliate: le dune dorate di Piscinas, la splendente baia di Chia, le Colonne diCarloforte, il Pan di Zucchero di Masùa. Ma anche grandi boschi come le foreste demanialidi Gùtturu Mannu-Pantaleo, Pixina Manna, Is Cannoneris e Marganai-Oridda, con alcu-ne aree di ripopolamento del cervo sardo.E per gli amanti della speleologia le grotte: quella di Su Benatzu di Santadi, scelta dallegenti nuragiche come luogo di culto, quella vicina di Is Zuddas con le sue bianchissimearagoniti, quella di Su Mannau, nascosta tra i boschi dell’Iglesiente.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

2.1 Da Cagliari a Sant’AntìocoItinerario lineare per la Costa del Sud e Santadi, km 131 (carta a pag. 57)
54
Il percorso segue nella prima parte le co-ste del Sulcis mentre nella seconda si ad-dentra all’interno della regione. Con-sente quindi di apprezzare anche il tipi-co paesaggio interno con gli abitati spar-si (in particolare fra Teulada e Santadi)e monumenti come la necropoli a do-mus de janas di Montessu e la pregevo-le Cattedrale di Tratalìas.Dalla zona del porto di Cagliari si prendela strada a scorrimento veloce che co-steggia il nuovo porto canale e ci si im-mette nella statale 195. Dopo circa 30 kmuna deviazione sulla sinistra consente diarrivare a Pula e all’antica Nora. Ci si reim-mette poi nella statale 195 e arrivati al km44 si segue la strada a sinistra che porta aChia e alla Costa del Sud. Si ritorna quindisulla statale 195 che raggiunge in breveTeulada; da qui si prende la strada perSantadi. Si attraversano diverse piccole fra-zioni ormai quasi disabitate, sorte intorno
ai vecchi “medaus” e “furriadroxius”, e sitrovano le grotte Is Zuddas. Arrivati a San-tadi, si prende l’uscita per Giba-Narcao-Ca-gliari e, all’incrocio, si prosegue diritti, siattraversa il piccolo centro di Villaperuc-cio e si va verso Narcao per raggiungere l’a-rea della necropoli di Montessu (cartelloindicatore sulla sinistra).Ritornati sulla strada per Narcao ci si di-rige nuovamente verso Villaperuccio e sisegue il cartello indicatore per Is Pintus;dopo 5 km si devia a sinistra per Tratalìas.Uscendone si prosegue verso San Gio-vanni Suergiu e, arrivati a un incrocio, siprende per Sant’Antìoco, immettendosi asinistra nella statale 126. Si arriva, infine,all’istmo artificiale che congiunge la Sar-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
degna all’isola di Sant’Antìoco e al suoomonimo centro principale.
PulaIl paese (m 15, ab. 6393) si segnala per lavilla S. Maria progettata da G. Cima nel1838 in stile neoclassico e, soprattutto, peril Museo archeologico Giovanni Patroni,che utilizza una vecchia struttura a duepiani con ampio loggiato e due piccolicortili interni, mantenendo le forme tipi-che dell’architettura locale. I materialiesposti provengono in parte dagli scaviantichi e recenti del vero e proprio abita-to di Nora, in parte da ritrovamenti effet-tuati sull’istmo e nei fondali marini. Si-gnificativi i materiali provenienti dalloscavo ottocentesco del tophet punico constele figurate databili dal sec. V al III a.C.; leraffigurazioni riportano alla sfera religio-sa con rappresentazioni della divinità informa umana ma più frequentemente in
forma simbolica. Vi sonoinoltre corredi provenientidalla necropoli punica(sec. V-III a.C.) nei quali èben documentata la cera-mica a vernice nera, im-portata da Atene. I mate-riali delle necropoli roma-ne (sec. II a.C.-III d.C.) ripe-tono tipi ampiamente dif-fusi nel mondo romano,compresi alcuni bei conte-nitori in vetro. Anfore e an-core, provenienti da recu-peri subacquei nei fondaliprospicienti la zona di No-ra, testimoniano gli intensi
traffici che facevano capo alla città inepoca punica e romana.
S. EfisioFuori dell’abitato di Pula, presso l’areadegli scavi di Nora, si trova la piccola chie-sa, una delle più antiche del Cagliaritano;conserva intatta la fisionomia romanicache alla fine del sec. XI le diedero i mona-ci Vittorini, in forme che derivano dall’ar-chitettura franco-provenzale. Nonostan-te le modeste dimensioni, la sua strutturarisulta monumentale e il suo interno estre-mamente suggestivo. Dalla navatella didestra si scende alla cripta dove è il locu-lo che, secondo la tradizione, contenne icorpi dei santi Efisio e Potito. La chiesa è

legata alla tradizione del martirio di S. Efi-sio ed è quindi il punto di arrivo della pro-cessione che ai primi di maggio porta il si-mulacro da Cagliari a Nora.
Nel circondario di Nora, più precisamente sul-la penisola di Fradis Minoris, si può visitare ilCentro di Educazione ambientale “Laguna diNora”. La struttura principale comprende unaquarium con le specie ittiche più rappresen-tate nei mari sardi e una sala con vasche cheospitano gli organismi della fauna acquaticache vivono sul fondo del mare. Un percorso sul-la penisola di Fradis Minoris consente di ac-quisire informazioni sull’ecosistema lagunare edi osservare la flora e la fauna tipica delle zoneumide. Il centro si occupa anche di recuperare,assistere e curare gli esemplari feriti di delfinie tartarughe marine.
Nora**Di questo importante scalo fenicio, poicentro punico e quindi fiorente città ro-mana sappiamo poco dalle fonti letterarieed epigrafiche, ma molte notizie ci pro-vengono dagli scavi archeologici che sisusseguono nell’area della città e che con-tinuano a fornire nuovi dati (pianta qui sot-to). Certamente tra la fine dell’VIII e l’iniziodel sec. VI a.C. esisteva un consistentecentro fenicio che alla fine dello stesso sec.VI passò sotto il controllo cartaginese. Po-co resta della città punica, ma i ricchi ma-teriali di corredo delle tombe ci dannol’immagine di un florido centro mercanti-le. Durante il periodo romano lo status di
2.1 Da Cagliari a Nora
55
municipium è documentato da un’iscri-zione, mentre numerosi miliari testimo-niano l’importanza della città, soprattuttofra II e III sec. d.C., epoca alla quale risale lamaggior parte delle strutture ora visibili.Verosimilmente le scorrerie dei vandali ele incursioni di pirati arabi provocarono ilrapido decadere della città.La visita all’area archeologica consentedi vedere i resti di alcuni edifici tipici del-la città romana ma, soprattutto, una riccae originale testimonianza di mosaici, ca-ratterizzati dall’uso pressoché esclusivodei colori bianco, nero e ocra. Immediatamente a sinistra dell’ingresso al-l’area vi sono alcuni ruderi di un edificiotermale. Si incontra poi la grande piazzadel Foro (1) pavimentata in andesite, cosìcome tutta la rete viaria. Vicino alla piaz-za si conserva un tempio con un prònao disei colonne e altare, grande cella e picco-lo penetrale (2). Continuando il tracciatoviario si trova uno degli edifici meglio con-servati, il teatro (3), datato fra l’epoca diTraiano e quella di Adriano: sotto il pal-coscenico, originariamente in legno, ri-mangono dei grandi dolii, forse destinatiad ampliare i suoni. Ben conservati i restidelle Terme a mare (4) che presentanosui lati nord ed est due porticati da cui siaccedeva all’interno. Un altro complessoimportante è quello dedicato alla divinitàsalutifera Esculapio con una grande ter-razza mosaicata (5) databile al sec. IV d.C.:forse qui si celebrava il rito dell’incuba-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

56
2 Il Sulcis e l’Iglesiente: mare e miniere
zione, per ottenere dal dio i rimedi ai ma-li da cui i devoti erano afflitti. Oltre alle pic-cole terme (6) e alle Terme centrali (7), sisegnala quanto resta del cosiddetto tempiodi Tanìt (8), cartaginese, donde la vista spa-zia sull’aggregato urbano.Gli edifici di abitazione sono costituiti daagglomerati di piccole case con uno o duevani ma anche da abitazioni signorili del-le quali la meglio conservata è la casa del-l’atrio tetrastilo (9), preziosa testimonian-za del tipo di abitazione patrizia separatadal centro urbano vero e proprio. Vi sonopreservati in gran parte i mosaici pavi-mentali; notevole in particolare quello conNereide su centauro marino.Recenti interventi nell’area archeologicacon la realizzazione di passerelle di legnoconsentono la visita anche ai disabili.
Verso e oltre ChiaLa costa fra Santa Margherita di Pula ePorto di Teulada, affiancata da una stra-da panoramica che consente un percor-so agevole ed estremamente suggestivo,costituisce uno dei tratti più interessan-ti del litorale sulcitano. È caratterizzatada uno sviluppo mosso e frastagliato,con dolci o aspri declivi che spesso giun-gono fino al mare, alternati a calette sab-biose e a cordoni di dune, mentre dalmare affiorano qua e là scogli e isolotti.Nella vegetazione costiera, varia e rigo-gliosa, spiccano vaste formazioni a mac-chia di ginepro.Tutto il primo tratto di costa vede proli-ferare ville e alberghi, spesso in nettocontrasto con l’armonioso ambiente na-turale: una piacevole eccezione è costi-tuita dal piccolo agglomerato di Chia (m
13) dalle poche case immerse nel verde. Prima di Chia una deviazione di 4 km con-sente di visitare a Domus de Maria (m 66,ab. 1525) il Museo archeologico comunale,sito in corso Vittorio Emanuele. In attesadella ristrutturazione dell’intero edificio,il museo ospita una mostra provvisoria de-dicata agli scavi dell’antica Bithia. Sonoesposti corredi di tombe fenicie (VII sec.a.C.) e romane (I sec. a.C.–I sec. d.C.) venutiin luce dalla necropoli una ventina d’annifa. Vi è, inoltre, una selezione dei materialidella stipe votiva del tempio di Bes, sca-vato negli anni sessanta del secolo scorso;si tratta di ex voto costituiti principal-mente da statuette di figure umane, moltosemplici come manifattura ma estrema-mente espressive, che indicano con le ma-ni le parti del corpo di cui chiedono laguarigione.Oltre Chia una breve deviazione consentedi accedere al mare fin sotto la torre di Chiache faceva parte, con quelle di Budello,Malfatano e Piscini, del sistema di difesaapprontato nei sec. XVI-XVII contro le escur-sioni barbaresche.Tra il promontorio di Chia e il monte Co-goni si trovano i resti dell’antica Bithia,fondata dai fenici e vissuta con alternevicende fino a epoca tardoromana. I restiattualmente visibili del centro, un tempoimportante, sono scarsi.A ovest della torre si stendono le spiaggedi Chia orlate da bellissime formazioni didune, colonizzate da secolari ginepri.
Costa del Sud*Contrasta con la ridente piana di Chia ilgranitico capo Spartivento, caratterizza-to da emergenze rocciose e dal faro che lo
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

sovrasta. A partire da questo punto e lun-go tutta la fascia territoriale fino al picco-lo golfo detto Porto di Teulada, la morfo-logia costiera si modifica bruscamente.In questa parte di litorale, denominataCosta del Sud, si alternano alti tratti roc-
57
ciosi e piccole rade, in un ambiente natu-rale quasi integro. Tutto il percorso è unsusseguirsi di splendidi panorami, ma èparticolarmente suggestivo quello che sigode dal capo Malfatano. Questo pro-montorio scistoso, sormontato dalla tor-re omonima (m 64), chiude il cosiddettoPorto di Malfatano, caratterizzato dallapresenza di alcune calette ciottolose edall’isoletta di Tueredda sullo sfondo.
TeuladaDisposto sul fondovalle dei rilievi monta-ni che lo racchiudono, il centro (m 50, ab.4233) presenta un tessuto viario moltovario e singolare. La chiesa della Madonnadel Carmelo, con forme già neoclassichenel prospetto molto semplice, risale altardo Settecento e conserva all’internobegli arredi marmorei. La chiesa di S. Fran-cesco ha invece forme tardogotiche, conaula coperta da capriate lignee, facciatasemplice con finestra ottagonale sul por-tale e campanile a vela.Chi visita il paese nel periodo pasquale
2.1 La Costa del Sud
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

può seguire, il Venerdì Santo, il notevole ri-to della Deposizione del Cristo dalla croce,detto “s’Iscravamentu”.Particolarmente interessante è l’artigia-nato teuladino, che produce soprattuttobellissimi ricami dai punti delicatissimi eraffinati, arazzi, tappeti, lavori in sugheroe in pelle e caratteristiche pipe in terra-cotta con coperchio di rame ottonato.
SantadiIl borgo agricolo, diviso dal rio Mannu indue nuclei (m 107 e 135, ab. 3875), domi-nato dall’ottocentesca chiesa di S. Nicolò,conserva tra i segni del passato la fortez-za di Pani Loriga, fenicio-punica, che, ar-ticolata in una necropoli e un’acropoli,ingloba precedenti strutture nuragiche edomus de janas.Nel nucleo più antico dell’abitato, in unedificio degli inizi del Novecento che ri-specchia nella struttura di base le tipicheabitazioni contadine (“furriadroxius”) del-l’area sulcitana si trova la Casa-museo “SaDomu Antiga”. Gli ambienti principali si af-facciano sulla strada, mentre sul retro am-pio spazio è occupato dal cortile con ilpozzo e dagli ambienti di lavoro. I vani del-l’abitazione sono stati arredati con l’in-tento di rappresentarne l’originaria fun-zione. Oltre ai semplici mobili tradiziona-li e al telaio, nella casa sono custoditi sva-riati attrezzi per il lavoro dei campi, tra cuiun carro a buoi e un aratro, e utensili im-piegati per la trasformazione dell’uva ela conservazione del vino.Nei pressi del Municipio, in una strutturamoderna, è allestito il Museo archeologico,di imminente apertura. L’allestimento rias-sume, anche con l’ausilio di pannelli illu-strativi dei monumenti più importanti, levicende della preistoria sulcitana, dandoparticolare spazio ai reperti rinvenuti nel-la necropoli di Montessu; di speciale enotevole effetto la ricostruzione idealedel ritrovamento di numerosissimi vasiin terracotta di età nuragica nella grotta-santuario di Su Benatzu.
Grotte Is Zuddas*Si aprono nel calcare cambrico del monteMeana (m 236). Particolarmente sugge-stive sono la bellissima sala dell’Organo,che deve il suo nome a una colonna sta-latto-stalagmitica che ricorda quello stru-mento, con pareti ricoperte da cristalli dibianchissime aragoniti aghiformi, l’impo-nente salone del Teatro e la sala delle Ec-centriche, nella quale rarissime aragoniti diun bianco abbagliante ornano la volta.
58
Nella campagna vicino all’abitato di Villape-ruccio (m 64, ab. 1128) è un allineamento dimenhir. Sulla provinciale per Narcao sopravvi-ve il furriadroxiu di is Meddas: sulla corte apianta quadrata si affacciano la residenza pa-dronale e le basse case dei contadini.
Necropoli di Montessu*Sull’altopiano di Montessu (o monte Essu,m 278) si trova un parco archeologico conuno dei più importanti e suggestivi siti dietà prenuragica della Sardegna: una ne-cropoli a “domus de janas”, scavata inuno splendido anfiteatro naturale.Le tombe hanno forme e dimensioni di-verse ed erano chiuse all’origine da portellidi pietra; alcune conservano decorazioniincise o in rilievo collegate al culto delledue divinità principi del mondo prenura-gico: la dea Madre e il dio Toro. Le simbo-logie più ricche e più complesse si trovanonella tomba detta delle spirali per il motivoche orna le pareti della camera sepolcrale,ma la tomba più bella è quella in cui cornascolpite in bassorilievo ornano la voltacon stile quasi baroccheggiante e una pro-tome taurina a tutto tondo fa da scalino.Quattro notevoli tombe monumentali han-no ampi padiglioni e allineamenti di gros-se pietre che delimitano, nella parte anti-stante, un’area più o meno circolare.
TratalìasNel medioevo era il centro più importan-te del Sulcis; in tempi recenti la formazio-ne del vicino invaso di monte Pranu haprovocato gravi dissesti nell’antico paese,che è attualmente quasi disabitato, e por-tato alla costruzione di una nuova Tra-talìas (m 17, ab. 1149), con interessanti for-me di paese modello. Nel vecchio centro, dove si conservano al-cune case che mantengono l’impianto ori-
2 Il Sulcis e l’Iglesiente: mare e miniere
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

ginario, si può ammirare la cattedrale di S.Maria di Monserrato*, risalente al 1213,come testimonia un’epigrafe sulla faccia-ta. Elementi caratteristici della chiesa so-no le due losanghe sulla facciata, di deri-vazione pisana, e la scaletta d’accesso altetto, lasciata in vista nel suo ultimo trat-to. La facciata, divisa orizzontalmente dauna cornice modanata e da archetti pensilisu mensole scolpite, ha nella parte infe-riore un bel portale con lunetta, inseritotra esili lesene e sormontato da un rosonelobato. I fianchi e l’abside sono ornati dateorie di archetti pensili spartiti da lesene.Di grande interesse le sculture sui capitellidel portale sul lato meridionale, di deri-vazione pisana, e il bassorilievo raffigu-
2.1 Da Tratalìas a Sant’Antìoco
59
rante due leoni affrontati sull’architravedel portale sul lato settentrionale.Delle tre navate quella centrale è absida-ta, il presbiterio è rialzato e illuminato dauna finestra, la copertura è in legname sucapriate. Alla sinistra dell’altare maggiore,Madonna in trono fra S. Giovanni Battista eS. Giovanni evangelista, interessante trit-tico tardocinquecentesco.
Si attraversa l’istmo di Sant’Antìoco, lungoquasi 3 km, costruito dai cartaginesi e com-pletato dai romani (i ruderi di un loro ponte apiù arcate segnano ancora l’antico tracciato).Conserva segni di più antica frequentazione:due pietre in trachite, dette popolarmente “supara” e “sa mongia”, il frate e la suora, sono duemenhir risalenti all’epoca prenuragica.
2.2 Le isole sulcitaneItinerario composito, da Sant’Antìoco a vari siti dell’isola di San Pietro (carta a pag. 60)
Delle isole sulcitane Sant’Antìoco (108.9km2) è collegata da un istmo (v. sopra) al-la terraferma e San Pietro (51 km2; v. pag.62) è raggiungibile via mare.La cittadina di Sant’Antìoco è ricca di te-stimonianze archeologiche, Calasetta eCarloforte presentano caratteristiche deltutto particolari rispetto agli altri centrinon solo della zona ma dell’intera Sar-degna. L’ultima parte dell’itinerario por-ta alle zone naturali maggiormente signi-ficative di San Pietro.Oltre l’istmo che collega una serie di iso-lette formatesi in seguito agli apporti flu-viali del rio Palmas, si entra nell’abitato diSant’Antìoco, situato sulla sponda orien-tale dell’omonima isola, la più grande del-l’arcipelago sulcitano. Partendo da piazzaDe Gasperi, seguendo via Calasetta e per-correndo una strada cheattraversa campagne e vi-gneti, si arriva al secondocentro dell’isola, Calaset-ta. Dal molo, ubicato aoriente dell’abitato, parto-no le corse per Carloforte el’isola di San Pietro (30 mi-nuti di navigazione). DaCarloforte si possono se-guire diversi percorsi che,su strada asfaltata, condu-cono ai punti costieri più si-gnificativi dell’isola colle-gati anche con linee pub-bliche delle FMS. Partendodal lungomare verso nordsi può arrivare in località laPunta, nell’estremo setten-
trione dell’isola. Un’altra strada litoranea,partendo dal porto verso sud, lambisce lacosta orientale e meridionale dell’isola.Un terzo percorso, infine, conduce, semprepartendo dall’estremità meridionale delpaese, al capo Sandalo.
Sant’AntìocoNel luogo dell’attuale abitato (m 7, ab. 11868) i fenici fondarono, verso il 750 a.C.,Sulci, che fiorì in maniera sorprendente.Con la conquista della Sardegna da partedei romani nel 238 a.C., la città mantenne,grazie anche al commercio dei minerali delterritorio iglesiente, la sua importanzatanto da essere elevata, probabilmentenel corso del sec. I d.C., alla condizione dimunicipium.Di queste vicende numerose testimonian-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

ze sono visibili grazie anche a diversi in-terventi di scavo. Le più cospicue si pos-sono vedere nella parte alta del centroattorno al fortino sabaudo.A nord del castello, sotto il declivio, si si-tua l’acropoli della città punica. Tutta la zo-na ha subìto diverse vicende col passaredel tempo: acropoli fortificata sotto i pu-nici, sede di una struttura templare in etàromana, fu infine, in periodo tardoromano,nuovamente ristrutturata per scopi at-tualmente ignoti. Si può vedere un trattodelle mura che difendevano l’acropoli pu-nica, costruite in blocchi di trachite squa-drati e risalenti al sec. IV a.C. La strutturatemplare di epoca romana (sec. II a.C.) sitrova a meridione del complesso fortifi-cato ed è disposta a diversi livelli.
60
La necropoli punica ipogeica occupa pra-ticamente tutto il colle su cui sorgono il ca-stello sabaudo e la piazza di Chiesa; letombe puniche sono costituite da una ca-mera sotterranea, semplice o doppia, ac-cessibile mediante un lungo e stretto cor-ridoio in discesa con gradini, scavato nel-la roccia a cielo aperto.Molto meno resta della necropoli romanapoiché essa fu impiantata proprio sopraquella punica ipogeica. Dopo un periododi abbandono fu utilizzata in periodo cri-stiano, come mostrano sarcofagi apertinel pavimento oppure ricavati nello spes-sore delle pareti, talora sormontati da ar-cosolio. Verso la base del pendio dell’a-cropoli si trovano i resti dell’anfiteatro ro-mano, databile intorno al sec. II d.C.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

A circa 400 m di distanza dall’acropoli,impostato su un’alta emergenza rocciosatrachitica, si colloca il tophet* fenicio-pu-nico, le cui testimonianze si protraggonoper oltre sei secoli, dal VII al I a.C. La visi-ta segue un percorso obbligato ed estre-mamente suggestivo, essendo state la-sciate sul posto molte urne originali (altresono copie). Sul fianco occidentale del ri-levamento trachitico una spaccatura ver-ticale naturale della roccia, dove sono sta-te trovate ceneri con frammenti di ossici-ne e un forte strato di bruciato, costituivail luogo di arsione per il sacrificio.
Museo archeologico. In attesa di siste-marvi in modo più congruo i materialiprovenienti dagli scavi di Sant’Antìoco,una parte di essi è esposta nei locali ri-strutturati del Monte Granatico cittadino.Le testimonianze di epoca preistorica nelmoderno museo sono piuttosto ridotte,mentre meglio documentata è la più anti-ca presenza semitica nell’isola grazie allascoperta e allo scavo dell’insediamento fe-nicio arcaico nell’area del Cronicario. Èquesto il più antico insediamento civile fe-nicio finora scoperto in Sardegna, svilup-patosi tra la metà dell’VIII e i primi decen-ni del sec. VII a.C. Ma la maggior parte deireperti sono di epoca punica e romana.Stele e urne ricompongono uno spaccatoesemplificativo del tophet. La selezionedelle stele rappresenta le tipologie prin-cipali, dalle rappresentazioni più stretta-mente simboliche a quelle figurative.Ampio spazio è dedicato alla necropolipunica di Sulci. Nei corredi appartenenti aisingoli inumati che, dentro i sepolcri, era-no sistemati in bare lignee, sipuò notare la presenza ricor-rente di due forme ritualiutilizzate nelle cerimoniefunerarie puniche: la broc-ca con orlo a fungo e quel-la biconica a orlo lobato.Gioielli aurei, collanine inpasta vitrea e i tipici sca-rabei in diaspro verde di-stinguono alcuni dei cor-redi. Per quanto concer-ne l’età romana i materia-li riguardano da un latotestimonianze di vita quo-tidiana, quali pentole dacucina e piatti di uso co-mune adoperati nelle casedi prima età imperiale, dal-l’altro i corredi funeraridelle necropoli, con i qua-
2.2 L’isola di Sant’Antìoco
61
li si giunge alla tarda epoca imperiale ro-mana, intorno al III-IV sec. d.C. L’esposi-zione del Monte Granatico è arricchita dauna serie di pannelli didattici che presen-tano immagini grafiche e fotografiche del-le principali aree archeologiche.
Il santuario di S. Antìoco*, edificato su uncimitero cristiano e una chiesa di età bi-zantina, appare oggi profondamente tra-sformato da interventi successivi. La chie-sa, di pianta longitudinale, con aula a trecampate, transetto e presbiterio absidato,è coperta da volte a botte con una cupolaall’incrocio dei bracci.I Vittorini ebbero il santuario nel 1089 dal‘giudice’ Torchitorio di Cagliari; lo re-staurarono, creando probabilmente il rac-cordo fra la chiesa e le attigue catacombe,e nell’ingresso alle catacombe realizzaro-no la cripta con l’altare. Recenti interven-ti di ripulitura delle superfici murarie e ilrifacimento dei pavimenti hanno consen-tito il recupero di numerosi frammentimarmorei scolpiti di epoca bizantina. Nel’600, dopo il ritrovamento delle reliquie delsanto, si aggiunse all’aula una campata; nel’700 fu costruita l’attuale facciata di formetardobarocche.In una piccola nicchia nel vano destro deltransetto si trova un grande reliquiario inlegno intagliato e dorato che ne contieneuno più piccolo in argento dorato, creatonel ’600 per custodire le reliquie del corpodi S. Antioco.Al di sotto della chiesa si trovano la crip-ta e il nucleo principale delle catacombe.La cripta ospita il sarcofago-altare che siritiene abbia conservato le spoglie del
santo ed è adornata con colonnemarmoree recuperate da
edifici di varie epoche. Lecatacombe sono state rea-lizzate sfruttando per lopiù i precedenti ipogei pu-nici e modificandoli se-condo le nuove esigenze,per cui sono caratterizzateda percorsi irregolari e in-tricati. La varia tipologiadelle sepolture testimonial’utilizzo per un lungo arcodi tempo (sec. IV-VII d.C.).In alcuni punti si possonopercepire resti della deco-razione dipinta che inte-ressava, originariamente,
molte delle tombe, come laparte inferiore della figuradel Buon Pastore.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

In uno degli ambienti la tradizione collocala cosiddetta camera del Santo, il luogo,cioè, dove questi si sarebbe recato a pre-gare e a morire di fronte ai soldati romanigiunti per arrestarlo. La denominazionepopolare è stata certo influenzata dall’e-sistenza di un tipo di tomba diverso dai so-liti, detto a “baldacchino”, con pilastriche si alzano sino alla volta e databile frai secoli V e VI d.C.
Presso il fortino di età sabauda, nella parte piùantica dell’abitato, si può visitare il Museoagropastorale del Sulcis, allestito in una strut-tura, il cui primo impianto è databile al XVIIIsec., composta da una parte coperta e ungrande cortile secondo uno schema comuneagli ambienti di lavoro di area sulcitana. Sonoesposti attrezzi collegati alle varie attività:coltivazione dei campi, raccolta e la-vorazione del latte, viticoltura e vi-nificazione, panificazione.
CalasettaIl paese ha una storia recente: sor-se infatti nel 1769 quando nucleifamiliari di origine ligure, resi-denti nell’isola tunisina di Ta-barka, si stabilirono presso la pic-cola insenatura di Cala di Setache diede poi il nome all’abitato.Si aggiunsero in seguito anche fa-miglie piemontesi, ma l’improntache tuttora permane nei costumie nel dialetto è quella genovese.La struttura dell’abitato (m 9, ab.2744), a maglia regolare con tes-suto viario a scacchiera, è invecedi tradizione piemontese.Pur non possedendo monumentiarchitettonici di qualità questoborgo di pescatori e viticoltoricolpisce per il suo spiccato ca-rattere, con le case tinteggiate dibianco o di colori pastello, sullequali emerge la parrocchiale, modestoesempio di barocco piemontese, e in cimaalla collina, la torre del XVII secolo.
Isola di San PietroLa presenza di alcuni nuraghi indica chegià genti protosarde vi si erano insediate.Fu poi frequentata dai punici che la chia-mavano Inosim (isola degli sparvieri) eabitata dai romani, ma non si hanno noti-zie di popolamento nell’alto medioevo.L’isola fu concessa nel 1736 da Carlo Ema-nuele III a un nucleo di liguri di originepugliese, i cui ascendenti erano stati por-tati a forza nel 1540 nell’isola tunisina diTabarka; altri tabarchini si aggiunsero
2 Il Sulcis e l’Iglesiente: mare e miniere
62
in seguito, negli anni tra il 1750 e il 1755.
Carloforte*. È l’unico comune (m 10,ab.6606) dell’isola, singolare per valoreambientale e tradizioni che lo differen-ziano dagli altri centri sardi; venne edifi-cato a partire dal 1738 secondo un trac-ciato viario a sud e a nord dell’asse cen-trale che congiungeva i tre poli costituitida piazza Carlo Emanuele sul mare, l’at-tuale piazza della Repubblica al centro ela parrocchiale sul fondo.Le case, bianche o tenuamente colorate,con balconcini a mensola, si sviluppanolungo strade rigidamente ortogonali spes-so molto strette (i "carrugi") o seguendo lecurve di livello della collina con sugge-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
stive scalette e archi di raccordo. Ci sipuò soffermare nella piazzetta della par-rocchiale di S. Carlo Borromeo, semplicema armoniosa, e vedere, nella via XX Set-tembre, l’oratorio della Madonna delloSchiavo che conserva all’interno formeispirate al rococò. Deriva il suo nome dalsimulacro della Madonna in tiglio nero po-sta sull’altare maggiore e proveniente, pro-babilmente, da un’imbarcazione di cui co-stituiva la polena. (v. box a pag. 63).Di un certo interesse è la chiesa di S. Pietro,che nelle forme attuali risale al tardo Set-tecento ma che fu riedificata sulle rovinedi una duecentesca dedicata ai Novelli In-nocenti, a ricordo di un naufragio in cui

perì una parte dei giovinetti che intorno al1212 si avventurarono nella semileggen-daria “Crociata dei fanciulli”.Nella parte alta dell’abitato si possonovedere i resti delle fortificazioni e delle mu-ra che definivano il perimetro urbano,pressoché quadrangolare. Nel settecen-tesco forte Carlo Emanuele III il Museo ci-vico raccoglie testimonianze storiche sul-la nascita e lo sviluppo della colonia ta-barkina e una consistente collezione diconchiglie del Mediterraneo; documentainoltre l’attività principale degli abitanti, lapesca del tonno.
La Punta, Punta delle Colonne, la Caletta.Le coste rappresentano uno degli aspettipiù interessanti dell’isola di San Pietro, so-prattutto nella parte occidentale dove l’a-zione demolitrice dovuta all’erosione ma-rina ha creato strapiombi, grotte, falesie,rientranze di suggestiva bellezza. La costaorientale si presenta invece bassa, rettilineae sabbiosa. Per poter ammirare nella lorointerezza gli scorci più belli è consigliato ilperiplo dell’isola in barca, ma alcune loca-lità si possono raggiungere su strada.Dalla periferia nord di Carloforte si può ar-rivare a la Punta, dove resistono due ton-nare con le infrastrutture e le apparec-chiature un tempo utilizzate per la lavo-razione alimentare dei tonni; di fronte sitrova l’isola Piana con la tonnara omoni-ma, da sempre proprietà di genovesi.Prendendo invece la direzione sud, pas-sando accanto alla torre S. Vittorio, attual-mente utilizzata come osservatorio astro-nomico, si può seguire la costa sud-orien-tale con le sue numerose spiagge: quella di
2.2 L’isola di San Pietro
63
Girìn, quella detta di Punta Nera (dal pic-colo promontorio che la divide in due),ove si apre una grotta sepolcrale della pri-ma età del Bronzo, e la spiaggia di Bobba.Da qui, presso Punta delle Colonne, si pos-sono facilmente raggiungere a piedi le fa-mose Colonne, due suggestive guglie tra-chitiche emergenti dall’acqua, ultimi resi-dui di una coltre lavica demolita dal mare.Proseguendo sulla strada costiera si per-viene alla provinciale per la Caletta, ma sipuò prendere una breve deviazione a si-nistra per visitare l’ampia cala Mezzaluna,con le sue maestose falesie. Su queste ilmare ha inciso le stupende grotte, habitatideale, in un tempo non molto lontano, vi-sto che permane nel ricordo degli anziani,della foca monaca.Rientrati nella strada principale si prose-gue a sinistra per la bellissima spiaggia del-la Caletta, incastonata tra la punta dei Can-noni e la punta Spalmatore.
Capo Sandalo. Dalla zona meridionale diCarloforte, costeggiando le saline, dove èspesso possibile vedere gruppi di fenicot-teri, si prosegue in direzione ovest. Attra-versando l’interno dell’isola si incontranovarie cave dei giacimenti non più coltivati dimanganese, diaspri, ocre rosse e gialle e di-stese di vigneti punteggiati dalle “barac-che”, le tipiche case bianche di campagnache caratterizzano l’entroterra di San Pietro.La provinciale termina nel piazzale di ca-po Sandalo con ampio panorama su tuttala costa ovest. Sul promontorio sorge il fa-ro, costruito nel 1864, punto di riferimen-to per gran parte del traffico marittimo nelTirreno occidentale.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Dal 711 sin quasi alla metà dell’Ottocentola Sardegna è stata preda ambìta prima da-gli arabi e poi dai pirati barbareschi. Qual-che tentativo di conquista all’inizio, poifrequenti razzìe: di bestiame e di viveri,non di rado anche di uomini e donne. La più famosa e dolorosa impresa dei pi-rati si svolge nella notte fra il 2 e il 3 set-tembre 1798. Cinque navi barbareschesbarcano trecento uomini a Carloforte edopo due giorni e due notti di saccheggioripartono portando con sé più di otto-cento abitanti, uomini, donne e bambini.I carolini abitano nell’isola di San Pietrosoltanto da una sessantina d’anni. Daquando erano stati invitati a trasferirvisifuggendo da Tabarka, un’isoletta davan-
ti alla costa della Tunisia. Portati a Tuni-si, vengono venduti come schiavi. Li aiu-ta la religione, perché i tunisini sono tol-leranti in materia. Potevano battezzare ifigli, qualche coppia di fidanzati, fattaprigioniera insieme, poté sposarsi.Un giorno del 1800 un giovane, NicolaMoretto, trovò sulla spiaggia una statuadella Madonna: era - come ha argomen-tato lo storico Giuseppe Vallebona - la po-lena caduta dalla prua di un bastimentoche forse si chiamava “Immacolata”.Quando nel 1803 i carolini, liberati incambio di molto denaro, poterono tor-nare in patria, portarono con sé la statua,che ora si venera col nome di Madonnadello Schiavo.
La Madonna dello Schiavo

2.3 L’IglesienteItinerario circolare, con partenza e arrivo a Cagliari, toccando Iglesias e Carbonia, km 224 deviazioni escluse (carta a pag. 57)
64
Tragitto piuttosto lungo e vario, con alcunitratti un po’ disagevoli ma di estremo in-teresse paesaggistico. Nella prima parte siattraversano alcuni borghi agricoli delCampidano centrale per poi inoltrarsi nelGuspinese e nell’Iglesiente, visitando cen-tri grandi e piccoli strettamente collegatiin passato all’attività mineraria.Dalla statale 131 dopo il km 11 si esce al bi-vio per San Sperate, per poi proseguireverso Villasor in un paesaggio di pianuracon orti intensamente coltivati. Da questocentro si prende la statale 196 e, dopoaver deviato al km 22.4 sulla destra per vi-sitare Villacidro e la cascata di Sa Spèn-dula, la si percorre fino a Gùspini. Attra-versato questo paese, si esce verso Ter-ralba e si trova subito il bivio per Monte-vecchio. Si arriva in questo piccolo centrominerario dopo poco più di 9 km su unpercorso brullo, però interessante. Da
Montevecchio una strada bianca (km 10)ma estremamente suggestiva, sulla qualesi affacciano numerosi edifici minerari divarie epoche ormai abbandonati, condu-ce a Ingurtosu. Da qui la strada (semprebianca) prosegue verso la spiaggia di Pi-scinas, attraversando altri insediamentiminerari abbandonati tra i quali spiccaquello di Naracàuli. Da Piscinas si ritornaa Ingurtosu e si prende la strada asfaltatache immette nella statale 126. Questa at-traversa Fluminimaggiore (prima del pae-se è possibile deviare sulla costa, versoBuggerru) e conduce a Iglesias. Tra questi
due centri si consigliano due deviazioni en-trambe segnalate: una per la grotta di SuMannàu, che si raggiunge dopo 1.5 km sustrada in parte a fondo naturale, e l’altraper il tempio di Àntas (km 2.2 di strada).Da Iglesias si prosegue, sempre sulla sta-tale 126, verso Carbonia in un paesaggioprofondamente segnato nel primo trattodalla secolare utilizzazione mineraria. Do-po 8 km si trova a destra l’imbocco dellastrada panoramica costiera per i centri mi-nerari di Nèbida e Masùa. Dopo altri 12 kmsi incontra, presso le case di Sirai, la de-viazione a destra (strada asfaltata, km1.9) per la fortezza fenicio-punica di mon-te Sirai. Da Carbonia, ritornati all’incrociodi Sirai, si prosegue per Villamassargia epoi per Domusnovas. Da qui ci si immettesulla strada a scorrimento veloce 130 e sirientra a Cagliari passando per Siliqua,con possibile deviazione per Uta.
San SperateFiorente centro agricolo del Campidano (m41, ab. 6836), noto per il gran numero dimurales che ornano le pareti esterne del-le case. Divulgata intorno al 1968 per ope-ra dell’artista Pinuccio Sciola, nativo delluogo, questa forma d’arte è stata appli-cata alle modeste dimensioni dell’archi-tettura paesana. San Sperate si è copertodi vivaci colori con l’esecuzione di questidipinti murari ispirati a forme figurative la-tino-americane. Oltre ai murales fra le vie e le piazzette delpaese si possono vedere molte sculture in
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

pietra, opera dello stesso Pinuccio Sciolao di suoi allievi.
VillasorNel grosso centro agricolo (m 25, ab. 7251)resta uno dei rari edifici non religiosi del-l’architettura gotico-catalana in Sardegna,la cosiddetta casa-fortezza, palazzetto ba-ronale fortificato, situato tra le vie Ca-stello e Baronale. La costruzione dell’edi-ficio risale agli anni immediatamente suc-cessivi al 1415; è dotato di contrafforti e diquattro torrette a merlatura guelfa; il ca-rattere gotico si evidenzia in particolarenelle due finestre che si aprono sulla fac-ciata principale, di forma rettangolare consoglia e stipiti in pietra e architrave. Nel-le sale si conservano le originarie impal-cature in legno sorrette da mensole di le-gno intagliato o di pietra.
VillacidroGrosso borgo agricolo (m 267, ab. 14 980)disposto scenograficamente alla base diimponenti roccioni di granito rosa, è com-posto da due settori, dei quali quello piùalto costituisce il nucleo più antico, sortoattorno alla piazza ove si affaccia la par-rocchiale di S. Barbara (XVI sec.) con por-tale architravato sormontato da un tim-pano curvilineo spezzato. Il campanile è acanna quadrata con monofore ogivali. L’in-terno, a una navata con volta a botte, è ar-ricchito da settecenteschi arredi rococò:il fonte battesimale, l’altare maggiore inmarmo policromo e il pulpito in marmobianco. Sempre del ’700 è l’interessante or-gano a canne.Di fronte alla parrocchiale si trova l’ora-torio della Madonna del Rosario, addossatoai resti del Monte Granatico, e all’angolo divia Parrocchia l’oratorio delle Anime, dalsemplice prospetto con cornice modana-ta e un campanile a vela.Nella parte bassa del paese, in piazza deiMille, è il lavatoio pubblico costruito nel1893, validissimo esempio di architetturain ferro; consta di due padiglioni a piantaquadrangolare raccordati da un corpocentrale, con pilastri e archi finementedecorati. Oltre alle vasche è inserita unafontana in pietra con stemma decorativoe tre bocche a testa di putto. Nel cimiteroè sepolto lo scrittore Giuseppe Dessì(1909-77) nativo di Villacidro.
Dal paese si possono fare diverse escursioni inun ambiente di mezza montagna dove la mac-chia mediterranea cede il passo a lecci, casta-gni, noci con un sottobosco ricco di funghi,
65
orchidee selvatiche e ciclamini. Una delle più fa-cili è quella che conduce alla cascata di SaSpèndula* in un percorso semplice e con bel-le viste verso la montagna.È consigliabile visitare anche la seicentescachiesa di S. Sisinnio, che spicca bianca su unaspianata a destra del rio Leni, immersa tra oli-vastri secolari. La chiesa è cinta su tre lati da unloggiato con tetto a travature lignee poggiantisu pilastrini con capitelli di foggia diversa.
Gùspini e ÀrbusNel primo paese (m 130, ab. 12 971) meri-ta una sosta la parrocchiale di S. Nicolò, delsec. XV, con arredi coevi, mentre nella vi-cina Àrbus (m 311, ab. 7338) si visita il Mu-seo del coltello sardo*, con la ricostruzio-ne di un antico laboratorio del fabbro conarnesi dell’Ottocento. La rassegna di col-telli comprende esemplari antichi, pro-dotti moderni rappresentativi della pro-duzione di tutti gli artigiani sardi contem-poranei e i migliori prodotti dell’artigia-nato locale.
Montevecchio e IngurtosuLa zona da Gùspini e Arbus verso la costaoffre, in particolare con le miniere di Mon-tevecchio (m 355) e Ingurtosu (m 250),testimonianze significative di archeolo-gia industriale. A partire dalla secondametà dell’800 le miniere sarde, conosciu-te fin dall’antichità, furono sfruttate inmodo intensivo, ma la ricorrente crisi del-l’industria estrattiva ha portato spessoall’abbandono di veri e propri insedia-menti risalenti nella maggior parte dei ca-si all’Ottocento.La miniera di Montevecchio* è stata nel pe-riodo successivo alla seconda guerra mon-diale una tra le più grandi e produttived’Europa. A testimonianza di ciò riman-gono i cumuli di detriti, i caseggiati dei poz-zi, gli impianti e gli edifici del villaggioche attualmente ospita gli abitanti rimasti,pochi superstiti di una popolazione benpiù numerosa. L’antica attività e il relativo
2.3 Da San Sperate a Villacidro
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

benessere si riflettono in particolare nel-l’elegante palazzina della direzione, re-centemente restaurata; ospita la rasse-gna biennale Arresojas (coltelli), dedicataa questa attività artigianale.Se il piccolo agglomerato e la sua minieratentano faticosamente di opporsi alla cri-si incombente, del tutto abbandonato è ilcentro minerario di Ingurtosu, che, realiz-zato nel sec. XIX, conserva, accanto alle va-rie ma in genere cadenti costruzioni cheebbero funzioni logistica e abitativa, ilcomplesso direzionale della miniera. Sitratta di un’ampia costruzione con corteinterna in pietra a vista, dalla tipica ar-chitettura neoclassica con particolari li-berty, quali l’elegante ballatoio ligneo.
La vicina spiaggia di Piscinas*, oltre che per labellezza non deturpata da moderne costruzio-ni, riveste particolare interesse per la presenzaalle sue spalle di una vasta formazione di dune,unica nell’isola per dimensioni e caratteristicheecologico-paesistiche. Per un raggio di circa 3km2 alle montagne di sabbia dorata, alte fino a50 m, ancora in movimento, si alternano quel-le ormai consolidate dove vegetano bellissimiginepri. L’albergo Le Dune ha il lungo corridoiod’ingresso ricavato dalla galleria di una antica
2 Il Sulcis e l’Iglesiente: mare e miniere
66
miniera: nel 1985 è stato riconosciuto Monu-mento nazionale.
Prima di arrivare a Fluminimaggiore (m 58,ab. 3227), borgo fondato nel 1704, si ha sulla de-stra una deviazione per Buggerru (m 51, ab.1229), ex centro minerario posto in una gola di-gradante verso il mare. In piazza suggestive sculture ricordano undrammatico sciopero di minatori (1904), tragi-camente represso nel sangue.Nel centro abitato di Fluminimaggiore si trovail Museo paleontologico con fossili di estremo in-teresse rinvenuti, in prevalenza, nel Fluminesema anche provenienti da località straniere. Lagrotta di Su Mannàu è la più lunga cavità dell’I-glesiente finora conosciuta, quasi 6 km. Per uncerto tratto è attrezzata per visite guidate, magli amanti di speleologia che vogliano visitarel’intera grotta possono rivolgersi sul posto alGruppo Grotte Fluminese.
Tempio di Àntas**La suggestiva valle di Àntas, anticamentericca di boschi e giacimenti di ferro, cu-stodisce numerose testimonianze ar-cheologiche delle quali il tempio dedicatoin età romana a Sardus Pater Babi (o Ba-bay) costituisce l’aspetto più emozionan-te: dopo ampi interventi di restauro, ap-pare oggi come un edificio di stile greciz-zante con basamento a pianta rettangola-re tripartita, provvisto di quattro colonnesulla fronte e preceduto da una scalinata.Salendo si arriva al pronao o vestibolocon colonne a basi attiche e capitelli a
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Il Sulcis e l’Iglesiente occupano il qua-drante sud-occidentale dell’isola. Quasidefilati rispetto alle grandi direttrici via-rie (che vanno da sud a nord avendo percapilinea Cagliari e Sassari-Porto Torres,lungo i 230 chilometri della “Carlo Feli-ce”), hanno avuto negli ultimi centon-cinquant’anni una storia tutta loro. È quiinfatti che è nata e si è svolta la grande av-ventura della storia mineraria dell’isola.Le miniere dell’Iglesiente erano già co-nosciute nell’antichità, forse fin dal tem-po dei popoli nuragici, certo fin da quel-lo dei fenici e dei cartaginesi. I romanimandavano qui, ad metalla, la gente di cui
volevano sbarazzarsi. Nel medioevo, Vil-la di Chiesa (Iglesias) fu la città dell’ar-gento e sul finire del Duecento ebbe un in-sieme di norme, conosciute come il Bre-ve di Villa di Chiesa, che regolavano mi-nuziosamente l’attività mineraria. Ab-bandonata o trascurata nei secoli, ripre-se con un’autentica esplosione di con-cessioni e di lavori a metà dell’Ottocento.Arrivavano capitali, tecnici e maestranzeda ogni parte del mondo. Sul finire del se-colo nacquero qui, fra gli oltre diecimilaminatori, i primi nuclei socialisti. Entratoin crisi subito dopo la fine della secondaguerra mondiale, quel mondo è ormaiquasi tutto archeologia industriale (nel-la foto, Montevecchio); alcune miniere sipossono già visitare, ma un Parco geo-minerario, storico e ambientale (il pri-mo del mondo), che comprenderà ottoaree dislocate in differenti punti dellaSardegna, ne salverà il ricordo.
Memoria delle miniere

tre fasi di sviluppo urbanistico: quella diimpostazione medievale, contenuta al-l’interno delle fortificazioni pisano-arago-nesi; quella verificatasi nell’800 con l’e-spansione delle attività minerarie; quelladel secondo dopoguerra tesa a colmare ivuoti dell’edilizia precedente.Particolarmente interessante è lo schemadel primitivo insediamento del quale ri-mangono talune chiese e i ruderi dellestrutture militari, mentre non è rimastonulla dell’apparato civile. La maggior par-te delle sostituzioni degli edifici più antichiavvenne nell’800; lo sviluppo program-mato si svolse all’esterno delle antichemura, lungo direttrici volte a raccordare lacittà sia con le miniere adiacenti sia con lastazione ferroviaria, inaugurata nel 1871. Sisistemò la vasta piazza Sella e venne co-struito il Municipio in forme vagamenteclassiche. Di quel rinnovato benesseredella città sono testimonianza diversestrutture in stile liberty, tra le quali il belpalazzetto Spada in via Matteotti.
volute ioniche. Si varca poi la soglia di unportale monumentale e si entra nel vanomediano, che conserva parte del pavi-mento con un semplice mosaico a tesserebianche e nere ed è decorata da pilastri ad-dossati alle pareti.Nel muro di fondo due porte danno ac-cesso a due piccoli vani che costituisconoil penetrale, il settore più sacro del tempio.Davanti a loro si aprono due bacini qua-drati, destinati a contenere acqua lustra-le per cerimonie di purificazione.Lo scavo ha evidenziato, al di sotto dellastruttura attualmente visibile, le testimo-nianze edilizie del precedente luogo diculto punico. È probabilmente ad Augustoche si deve la costruzione del primo tem-pio romano; sotto l’imperatore Caracalla,tra 213 e 217 d.C., esso subì un profondorestauro come testimonia l’iscrizione sul-la fronte dell’edificio.
Deviando a sinistra dalla statale per Iglesias, ver-so la frazione San Benedetto, si può raggiungereil giardino montano di Linasia dove, su una su-perficie di circa un ettaro, sono riproposte lepiante endemiche della zona.
2.3 Dal Tempio di Àntas a Iglesias
67
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
IglesiasPur essendo frequentata in età punica eromana, è solo a partire dalla conquistapisana che Iglesias (m 200, ab. 29 375; pian-ta a pag. 68) acquista grande rilevanza, di-ventando, col nome di Villa di Chiesa, lacittà sarda più importante dopo Cagliari. Ilmaggiore splendore lo raggiunse, in parti-colare, quando appartenne alla potente fa-miglia dei conti di Donoratico: sotto i dellaGherardesca la città crebbe, si arricchì dichiese, protetta dalle mura e dal castello diSalvaterra, e venne organizzata sul model-lo dei comuni toscani con proprie leggi (ilfamoso Breve di Villa di Chiesa) e il dirittodi coniare moneta. Lo statuto regolamen-tava, tra l’altro, anche lo sfruttamento mi-nerario e, all’avanguardia per i tempi, pre-vedeva interventi sociali per i lavoratori del-le miniere. Ma la conquista aragonese, par-tita proprio da Iglesias nel 1324, segnò l’i-nizio del declino della città. Nell’800 losfruttamento minerario venne nuovamen-te incrementato da gruppi industriali dellaPenisola, ma in anni recenti la crisi dell’at-tività mineraria ha coinvolto anche Igle-sias. La città si sta ora costruendo una nuo-va economia, anche con lo sviluppo turi-stico legato alla valorizzazione degli im-pianti e dei villaggi minerari ormai dismessi.Il tessuto topografico di Iglesias riflette le
La cattedrale di S. Chiara* (B2) si trovanell’unica vera piazza del nucleo antico,quella del Municipio, sulla quale si affac-ciano anche il Municipio ottocentesco e ilpalazzo dell’Episcopio, di fine ’700.La chiesa, edificata fra 1285 e 1288, come ri-corda una lapide inserita al lato del porta-le, fu ampliata e trasformata in stile goticocatalano tra 1576 e 1588; tra Sei e Settecentofurono invece realizzate le cappelle latera-li coperte da volta a crociera e il retablo diS. Antioco con le pitture e le statue checontiene. All’interno, pregevoli arredi e,

tra i numerosi argenti, la Croce astile tar-dogotica con Pietà scolpita nel riccio, ope-ra di argentiere cagliaritano del ’500. Vi siconservano anche numerose statue e al-cuni dipinti: in particolare la grande tela set-tecentesca con la Vergine Assunta e santi.
Nel centro storico. Lungo il fianco sinistrodel Municipio la via Satta e, ancora a sini-stra, la via Don Minzoni conducono allachiesa di S. Francesco (B2), risalente aun’epoca imprecisabile tra XV e XVI sec.ma certamente rimaneggiata nel ’500. Hafacciata a capanna, con portale a ogiva or-nato da semplici colonne e due piccolirosoni. All’interno sui capitelli, peducci egemme, si stende una decorazione moltovaria sia per le forme adottate che per i te-mi decorativi. Particolarmente interes-
68
sante è la decorazione dei capitelli del-l’arco d’accesso al presbiterio con diver-si episodi, probabilmente legati alla vita diS. Francesco.In piazza Manzoni, il santuario di S. Mariadelle Grazie (B2), molto suggestivo per lasua posizione fra le antiche case dell’in-sediamento medievale, è degli inizi delXIV secolo ma fu notevolmente modificatonel ’700. Della primitiva struttura la fac-ciata conserva solo la parte inferiore conportale a lunetta e cornice di archetti pog-gianti su piccole mensole. L’interno, adaula unica con piccole cappelle laterali, ècaratterizzato da un ampio presbiterioquadrangolare, con cupola ottagonale,datato da un’epigrafe al 1708. Nella sa-grestia si conservano varie tele e statue li-gnee settecentesche.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Verso il Castello. Da piazza Sella (B2-3),punto di ritrovo della città (monumento,opera di Giuseppe Sartorio, a QuintinoSella, promotore nell’800 del rinnovatoimpulso dell’industria mineraria in Sar-degna), si imbocca verso nord-ovest l’an-tica via Eleonora d’Arborea, all’inizio del-la quale sopravvive qualche lembo dellemura medievali. Al termine, dallo slargodella porta Fenza, si stacca la via Ghibel-lina che sale lungo le pendici meridionalidel monte Altai alle rovine del castello diSalvaterra (A-B2). Costruito nel sec. XIII, ilcastello fu utilizzato anche in epoca ara-gonese ma, perduta la sua importanza mi-litare, andò quasi completamente in rovi-na nella seconda metà dell’800, contem-poraneamente alla distruzione della cintamuraria della città. La struttura difensivaera contigua all’antica porta di S. Antonio,una delle quattro che si aprivano nellacinta fortificata. Di questa avanzano ormaipochi resti, costituiti da alcune torri ecortine merlate.
Chiesa della Madonna di Valverde. Ex-tramuraria (la si raggiunge da piazza Sel-la per le vie Valverde e Cappuccini), co-struita tra 1285 e 1290, ricalca in modimeno eleganti il prospetto della Catte-drale. Nuova è, invece, la decorazione chesi sviluppa sulle mensole e nei fianchi conmotivi geometrici e soggetti animali in uncontesto gotico. Sul lato destro le menso-le antropomorfe e le foglie riverse ricor-dano la decorazione della chiesa di S. Ma-ria di Tratalìas. All’interno, radicalmentetrasformato alla fine del ’500, il presbiterioha una bella volta a crociera con gemmapendula scolpita con una Madonna colBambino di tipo rinascimentale.
Prima di lasciare Iglesias.Al N. 4 di via Roma, nel-l’Istituto tecnico minera-rio G. Asproni (C1-2), èconservata un’interes-sante raccolta di minera-logia e paleontologia,mentre nel pianoterra èricostruita con bell’effet-to una galleria discavo.L’aspetto dellacittà dell’800 lo sicoglie percorren-do via Cattaneo(B1), lungo la qua-le si succedonounità edilizie lega-
2.3 Da Iglesias a Monte Sirai
69
te all’intensa attività mineraria del perio-do. Sul lato sinistro si notano le palazzineadibite a uffici amministrativi e il vecchioospedale di S. Barbara destinato ai mina-tori infortunati, mentre sul lato destro siconservano le più modeste vecchie case adue piani dei lavoratori.Fuori dall’abitato, una ripida salita rag-giunge la chiesa di Nostra Signora di BuonCammino (A1) dalla quale si apre un vastopanorama sulla città e dintorni.
La strada per Nèbida e Masùa ricalca un trac-ciato un tempo di interesse esclusivamente mi-nerario, ma consente scorci paesaggistici tra ipiù belli dell’isola. Superata la spiaggia di Fun-tanamare prosegue verso i piccoli centri di Nè-bida (m 175) e Masùa (m 141) che sorgono sulcostone roccioso a picco sul mare. Da Masùa sipuò ammirare lo splendido faraglione dettoPan di Zucchero per la forma e il candido colo-re della roccia calcarea. A ridosso della cala è visibile il complesso del-la miniera di porto Flavia con ingresso apertodirettamente sulla falesia.
Fortezza di Monte Sirai*Verso il 725 a.C. l’altura di monte Sirai (m191) fu occupata dai fenici con lo scopo dicontrollare la via di penetrazione verso lefertili piane sulcitane, la via d’accesso allericchissime miniere dell’Iglesiente e le stra-de di collegamento con la pianura del Cam-pidano. A questo primo periodo, che duròfino agli ultimi anni del sec. VI a.C., sono daattribuire l’impianto dell’acropoli, in formeprobabilmente in gran parte differenti daquelle attuali, e l’impianto della necropolia incinerazione.Alla fine del sec. VI a.C. anche monte Sirai,
come molti altri insediamenti fenici,passò ai cartaginesi. Da questo
momento l’insediamento creb-be di dimensioni, la ne-
cropoli a incinerazio-ne fu abbandonata efu costituito il monu-mentale impianto del-la necropoli con tom-
be a camera ipo-geica. All’iniziodel sec. IV a.C. l’a-cropoli e partedel pianoro furo-no racchiusi inun impianto for-tificato organicoe sorse il tophetcon l’annessaarea templare.Con la conquista
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

romana della Sardegna l’impianto urba-no subì ampie ristrutturazioni, ma verso lafine del sec. II a.C. il centro fu completa-mente abbandonato per cause non anco-ra ben accertate.La visita dell’area archeologica (ore 8-tramonto; pianta qui sopra) può iniziaredalla cosiddetta opera avanzata (1), uncomplesso di edifici ubicati davanti allafronte dell’acropoli. Nell’area dell’abitatofortificato si può notare, sulla destra, unarientranza: probabilmente il posto di guar-dia per una sentinella. Procedendo sisbocca sul piazzale principale dell’acro-poli (2); vi si affacciano numerosi edifici:il più importante è il poderoso mastio,che, costruito sulle rovine di una più an-tica torre nuragica, costituisce l’operaedilizia più robusta sulla quale facevaperno la difesa dell’abitato e nel cui in-terno era ospitato un luogo di culto. L’a-spetto attuale è quello relativo all’ultimafase di vita dell’abitato.Fuori dell’acropoli si trovano la necropoli(3) e l’area sacra extraurbana. Nell’area fu-neraria sono visibili, seppure appena ac-cennate, le fosse della necropoli fenicia a in-cinerazione, mentre di fronte a sinistra sipossono scorgere i corridoi gradinati diaccesso alle tombe sotterranee, eseguite inepoca punica. Lungo le pareti loculi, desti-nati a contenere i defunti, e nicchie, nellequali talvolta veniva posta una parte delcorredo di accompagnamento. Su un pila-stro nella roccia è scolpito a rovescio ilsimbolo di Tanìt, massima divinità femmi-nile per i cartaginesi.
70
L’area sacra si componedel tophet (4) e di un sacel-lo contiguo. Una gradina-ta monumentale, ai piedidella quale erano depostele urne e le stele, conduce-va a un tempio che ripetelo schema dei santuari fe-nici e punici: vestibolo, an-ticella, cella o penetrale evano di servizio.
CarboniaSebbene non offra emer-genze architettoniche si-gnificative, costituisce uninteressante esempio di“città nuova”(m 111, ab. 31980), interamente progetta-ta. Fu costruita, infatti, nel1937-38 in seguito all’im-pulso dato alle miniere dal-la politica autarchica e dal-
le “sanzioni” applicate all’Italia dalla So-cietà delle Nazioni. L’aspetto urbanistico di Carbonia è deci-samente cambiato negli ultimi anni perl’integrarsi di programmi abitativi pub-blici e privati; uscita dalla grave crisi eco-nomica dell’attività mineraria degli annisettanta, lo sviluppo dei commerci e deiservizi l’ha fatta diventare polo di attra-zione per i nuclei del circondario.La tipica edilizia del borgo pianificato ori-ginario si concentra attorno a piazza Ro-ma, ai cui lati si dispongono i più impor-tanti edifici pubblici, dall’uniforme para-mento in conci di trachite a bugnato ru-stico. Sul lato est la parrocchiale di S. Pon-ziano, con campanile modellato, in scalaridotta, su quello di Aquileia, ospita alpiano terra una cappella votiva dedicata aS. Barbara, patrona dei minatori. Sul latoalla destra della chiesa si trovano la Torrecivica (ex littoria) e il Teatro, mentre suquello opposto è situato il Municipio. Ilquarto lato si apre sui giardini pubblici, de-lineati dai viali lungo i quali furono edificatii complessi residenziali più rappresentativie le sedi delle società carbonifere.Imboccando via Napoli, si incontra al N. 4un ampio parco con un edificio costruitoalla fine degli anni trenta come residenzadel direttore delle miniere. L’edificio è se-de del Museo archeologico Villa Sulcische, seppure in una sistemazione provvi-soria e parziale, offre un quadro delle vi-cende culturali del Sulcis, dalla preistoriaall’età paleocristiana e altomedievale. Duestazioni multimediali offrono un pro-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

gramma sull’insediamento fenicio e puni-co di Monte Sirai.Non lontano, in via Campania, è il Museocarboniense di Paleontologia e di Speleo-logia, che raccoglie reperti sardi, in parti-colare del Sulcis.
DomusnovasDell’antico borgo altomedievale perman-gono solo scarse tracce nella chiesa di S.Barbara, costruita all’interno delle muraquando Domusnovas (m 152, ab. 6756) eraun villaggio fortificato e faceva parte delsistema difensivo costruito dai pisani aprotezione di Villa di Chiesa (Iglesias) edel bacino minerario dell’Iglesiente. L’antica facciata costituisce oggi la parteposteriore dell’edificio, rimaneggiato tra’600 e ’700; l’attuale facciata è opera di re-cente esecuzione.La parrocchiale della Madonna dell’As-sunta mostra, invece, l’impianto tipico del-le chiese settecentesche a croce latina,con volta a botte; la facciata è in pietra ne-ra ispirata a forme romaniche.In via Garibaldi si può visitare, su richiesta,l’Esposizione etnografica “Sotgiu”, allestitain un edificio in pietra e “làdiri” (mattonicrudi), risalente agli anniquaranta del secolo XIX. Ol-tre ottocento pezzi, espostiin un piccolo ambiente conpavimento in terra battutae camino e in un cortile por-ticato, illustrano i modi divita di un’economia agro-pastorale.
Da Domusnovas parte unastrada asfaltata che attraversala grotta calcarea di S. Gio-vanni e sbocca poi nella forestademaniale di Marganai-Orid-da, una delle più interessantizone naturalistiche dell’isola.La grotta di S. Giovanni*, for-matasi per l’erosione del fiumeche scorre ora incavato late-ralmente, è una delle pochis-sime cavità naturali percorri-bili in auto. L’ingresso è postoalla base di un’ampia pareteche inghiotte la strada pro-vinciale; sulla sinistra si nota-no le opere di captazione del-la sorgente carsica che convoglia l’acqua per gliacquedotti di Cagliari e Domusnovas. Presso en-trambi gli imbocchi residuano avanzi di mura ci-clopiche, verosimilmente di epoca nuragica.All’interno non esistono o quasi concrezioni sta-lattitiche ma in diversi punti si trovano grandivasche stalagmitiche.
71
SiliquaPunto di contatto fra Sulcis-Iglesiente eCampidano, l’abitato (m 66, ab. 4268) van-ta la parrocchiale di S. Giorgio, d’impiantogotico catalano, con presbiterio e cap-pelle a volte gemmate e ornate di rilievi, ela seicentesca chiesa di S. Sebastiano, dalbel frontone ad arco inflesso.
In vista del paese, a sud, è il colle lavico coro-nato dalle rovine del castello di Acquafredda(m 253) eretto dopo il 1267 dai conti pisanidella Gherardesca; alle sue mura sono legate levicende tragiche seguite alla morte del conteUgolino ricordato nell’Inferno dantesco.
Nel borgo di Uta (m 6, ab. 6755), 2.5 km a suddella statale 130, con deviazione a una dozzinadi km dopo Siliqua, si può ammirare una tra lepiù belle e importanti architetture romanichedell’isola, la chiesa di S. Maria*. Edificata daiVittorini tra il 1135 e il 1145, con maestranze diambito francese e pisano, giunta a noi presso-ché intatta nella decorazione dei capitelli, nel-le sculture sulle mensole, nel fregio arabeg-giante che chiude il primo ordine della faccia-ta, si presenta a tre navate, la centrale absida-ta. Il campanile a vela, di età gotica, è formatoda un largo arco a tutto sesto. L’interno pare piùvasto del reale per la risonanza della luce e
l’ampiezza degli intercolumni; le colonne, cheriutilizzano materiale di spoglio, hanno capitellidi varia foggia che rivelano, come le belle de-corazioni scultoree dell’esterno, il confluire dimodi stilisticamente diversi. Anche la pila del-l’acquasantiera reimpiega un bel capitello co-rinzio d’epoca bizantina.
2.3 Da Carbonia a Uta
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

3.1 Il SàrrabusItinerario circolare, da Cagliari a Cagliari, per la costa sud-orientale e l’interno, km 145senza le deviazioni (carta a pag. 73)
Vario e ricco di scorci paesaggistici, è perla prima metà costiero: alla parte sino a Vil-lasimìus e alla Costa Rei, molto frequenta-ta dai cagliaritani e punteggiata di inse-diamenti stabili e stagionali, segue quellasino a Muravera, meno ‘battuta’ e in qual-che parte solitaria; viene infine il percorso
Profilo dell’areaQuando, nella prima metà dell’Ottocento, ebbe modo di vi-sitare la fascia sud-orientale della costa sarda, Alberto La Mar-mora si trovò in uno dei territori «più fertili dell’isola e allostesso tempo uno dei più malsani», caratterizzato dall’assenzadella popolazione, allontanatasi a causa delle incursioni barbaresche; e abbandonatoperciò «ad agricoltori e a pastori nomadi». A distanza di tanto tempo è stata vinta la ma-laria che, favorita dalla presenza di stagni costieri, costituiva il rischio maggiore per chisi avventurava in quelle plaghe; mentre si conserva un aspetto dei luoghi solitario e qua-
si desertico che, alternato a tratti coltiva-ti con metodi moderni, evoca atmosfere dapaesi coloniali. La natura delle regioni in-terne – in questo triangolo tra Cagliari,Villasimìus e Jerzu – è ugualmente solitaria,ma la vegetazione spontanea (macchia ebosco) e l’affiorare delle rocce (i “tacchi”calcarei a nord, le guglie granitiche a sud)dànno l’idea di una regione selvaggia, pra-ticata soltanto da pastori e cacciatori.Sparsi qua e là, a volte isolati a volte riuni-ti in gruppi di due o tre, sorgono i villaggi –in crescita di popolazione quelli della costa,in calo quelli dell’interno – attaccati in par-te alle forme tradizionali dell’economia e inparte impegnati nella ricerca di nuove pro-spettive, legate inevitabilmente al turismo.Le maggiori attrattive sono perciò in quellirivieraschi, che riescono a offrire, oltre a unmare segnalato a più riprese per la qualitàdelle sue acque, i prodotti genuini della ter-ra e un ricco ventaglio di manifestazioni
tradizionali. Così, mentre San Vito è la patria del più noto tra i suonatori di launeddas – lostrumento primordiale a tre canne che accompagna con i suoi accenti delicati i momentidella festa – Villasimìus ha appena inaugurato un’area marina protetta, creata per salva-guardare l’integrità delle spiagge e la popolazione vegetale e animale dei fondali. I paesi del-l’interno si affidano alle ricchezze che vengono dal passato: così, se Orroli ha il suo gigan-te preistorico di pietra rossa in nuraghe Arrubiu, Armungia punta sulla memoria del “suo”personaggio, Emilio Lussu, e sugli strumenti con i quali pastori, contadini e artigiani af-frontavano la fatica quotidiana. Ovunque poi, col contributo crescente delle aziende agri-turistiche, così connaturate a questo territorio, si scoprono e si riscoprono prodotti ecibi che sfuggono alla omologazione della produzione industriale.
72
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
3 Il Sàrrabus e il Gerrei: la montagna meridionale
di valle e di collina sul fianco del gruppo delSette Fratelli, uno dei tratti più suggestividell’Orientale Sarda. Si possono quindi al-ternare le soste lungo le spiagge o le sco-gliere con le escursioni in zone alte di bo-schi e acque cristalline: domina ovunque lanatura granitica delle rocce e del terreno.

3.1 Il Sàrrabus
73
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Il fondo stradale è generalmente buono, iltracciato molto tortuoso nella parte finale.
Dal golfo di Quartu a capo BoiLasciata la città e la zona d’acqua tra lo sta-gno e il golfo di Quartu, si continua per po-co in zona pianeggiante, quindi le pro-paggini del gruppo montuoso del SetteFratelli rendono vario e movimentato ilpaesaggio. La strada ora corre all’inter-no, ora si affaccia su tratti incantevoli dimare, dove le scogliere si alternano allespiagge ritmate dalle antiche torri di guar-dia. All’interno, arido e desertico, i rilievigranitici sono coperti da modesta mac-chia. In tutta la fascia costiera si moltipli-cano i villaggi turistici, intervallati da qual-
che tratto rimboschito a pini ed eucalipti.Nella zona di Solanas la strada si inerpicasu uno sperone roccioso; poi, allo sboccoverso l’altro versante, la vista sul capoBoi e, più lontano, sul capo Carbonara.
VillasimìusIl paese (m 41, ab. 2835) sorge a un paio dichilometri dal mare, in zona abitata sin daitempi più antichi, come dimostrano i restinumerosi, ma di non grande rilievo, delleepoche prenuragica, nuragica, fenicio-pu-nica e romana. Il centro attuale è sorto nel 1822, ma ilmaggior impulso allo sviluppo è venuto apartire dagli anni sessanta con la valoriz-zazione turistica che, grazie alla ‘scoperta’

3 Il Sàrrabus e il Gerrei: la montagna meridionale
74
del mare limpido e delle magnifiche spiag-ge, ha fatto di Villasimìus un frequentatoluogo di vacanza.Il paese, divenuto così centro di servizi peri villeggianti, presenta alcuni motivi d’in-teresse. Per primo il Museo civico, che inuna casa padronale del centro storicoespone: nella sala del Mare i frutti dei ri-trovamenti nei vicini fondali; in quella delSantuario i resti di un tempio fenicio-ro-mano; in quella del Territorio i reperti da-gli insediamenti romani; in quella del Re-litto quanto ha restituito una nave catala-na del Cinquecento. Nella casa parroc-chiale si conserva una statua marmorea didonna (romana, forse del sec. I d.C.), rin-venuta tra gli scarsi resti di un edificiotermale, che per anni è stata scambiata, evenerata, come una Madonna.
I veri tesori di Villasimìus sono lungo le coste.Se ne può avere un’idea con un’escursione al ca-po Carbonara (6 km), al termine di una penisolaprotesa verso sud che segna il confine tra il ma-re del versante meridionale della Sardegna equello della costa orientale. Alla destra il golfodi Carbonara, con in fondo il capo Boi; a sinistrail piccolo stagno di Notteri, quindi il lungo bian-chissimo arco sabbioso della spiaggia di Simìus,con in fondo la punta Molèntis (‘degli Asini’) e,al largo, l’isoletta di Serpentara. Si passa vicinoal porticciolo e si giunge a un piazzale che ha difronte l’isoletta dei Cavoli: tutto questo tratto dimare e di costa, sino a capo Boi verso Cagliarie sino a cala Pira verso nord, è stato di recentesottoposto ai vincoli di un’Area marina protettadetta di Capo Carbonara, istituita al fine disalvaguardare i beni naturali e regolare il mol-tiplicarsi degli insediamenti; quasi come unauspicio, nell’agosto del 2000 è stato avvistatoun rarissimo esemplare di foca monaca.Tra i resti del passato si può vedere la grandetorre seicentesca dalla pianta a stella che do-mina il porto, aperta alla visita, e le tombe ru-pestri, a domus de janas, in prossimità dellaspiaggia del Riso.Per conoscere meglio il mare di Villasimìus ci sipuò imbarcare su uno dei battelli dal fondotrasparente (aquavideo) che compiono quoti-dianamente, nella buona stagione, escursioni in-torno al capo Carbonara. Il percorso tocca sem-pre il punto in cui si trova, in un fondale di 10 m,la Madonna del naufrago: realizzata in un bloc-co di trachite dallo scultore Pinuccio Sciola, èstata collocata nel 1979 tra il capo Carbonara el’isola dei Cavoli, in un passaggio irto di diffi-coltà nel quale si sono verificati numerosi nau-fragi. Da allora, la seconda domenica di luglio,si celebra un festa che comprende una pro-cessione a mare sino al simulacro.
Tra Castiàdas e Olìa SpeciosaDopo lunghi lavori di bonifica, che furonoavviati oltre un secolo fa con una colonia
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
penale, queste terre pianeggianti hannopotuto manifestare tutte le loro potenzia-lità. E nelle fattorie sparse intorno a Ca-stiàdas (m 168, ab. 1308), Olìa Speciosa(m 60) e altri nuclei si è sviluppata una di-screta attività agrituristica: quasi ovun-que si possono assaggiare i cibi locali, inmolti casi si può anche pernottare, acqui-stare i prodotti del luogo, tra i quali il mie-le, e praticare l’equitazione. Presso priva-ti e alla cantina sociale si può far provvistadi vini: il Cannonau, qui particolarmenteforte e profumato, la Mònica, la Malvasìa.
San PriamoLa piccola borgata agricola (m 9) alla con-fluenza della strada da Villasimìus nell’O-rientale Sarda (statale 125), prende nomedalla chiesa di S. Priamo, collocata su unospuntone di roccia: costruita nel Sette-cento in luogo dedicato da secoli al cultodell’acqua, conserva al suo interno una do-mu de janas nonché una piccola sorgente.Poco più distante, sulla destra della stataleper Cagliari, il nuraghe Asoru, in granito,con torre centrale alta 7 metri.
Dall’Orientale Sarda diretta a Muravera si puòdeviare a destra per Torre Salinas, un tratto dicosta ancora intatto e poco affollato. La stra-della che in meno di un km giunge al mare hasulla sinistra lo stagno delle Saline; sul fondo do-minano la spiaggia e tutta la zona, dall’alto diuna collina, i resti della torre costruita nel ’600dagli spagnoli per impedire lo sbarco dei pre-doni africani. Di lassù si vedono bene le bianchespiagge di Salinas, a nord, di Cristolaxedu e Co-lostrài a sud: negli ultimi anni sono state più vol-te segnalate per la purezza e limpidezza delle ac-que. Dietro la spiaggia di Colostrài si stende lostagno omonimo, adibito a peschiera, che si puòraggiungere con un sottile nastro d’asfalto chepiega sulla destra prima della torre. Lo popolanoaironi, anatre, polli sultani, falchi di palude.
MuraveraIl centro (m 11, ab. 4648), situato ai marginidella piana alluvionale costruita dal Flu-mendosa (il cui letto è ora povero d’acquee ricco di canneti e oleandri), costituiscecon i vicini Villapitzu e San Vito (v. itine-rario 3.2) quasi un continuum di circa 20mila abitanti che sembra aver assorbito iprimi flussi turistici senza rimanerne tra-volto e senza snaturarsi.La zona, fertile e riparata dai venti, pun-teggiata di stagni pescosi, fu popolata sindall’antichità, ma nel corso dei secoli la vi-ta delle popolazioni è stata ostacolata dal-le incursioni dal mare e dalle inondazioniprovocate dal fiume. Oggi, chiuse alcuneminiere, perno dell’economia è l’agricol-

tura: rinomate in particolare le colture de-gli agrumi. E intanto Muravera – ma ancheVillaputzu e San Vito - punta sul turismo,che può contare qui su ambienti naturaliancora intatti e sulla loro varietà: paese ecampagna, monte e mare, fiume e stagno.Il fascino dell’area è accresciuto dal per-sistere di alcune attività tradizionali. Quisi intrecciano ancora cestini artigianali esi trovano prodotti genuini come il miele,il vino e i dolci preparati da sempre per legrandi ricorrenze: amaretti, paste di man-dorla (gueffus), formaggelle (pàrdulas),pan di sapa (pan’ ’e saba).La riprova dell’attaccamento di questepopolazioni alle tradizioni si ha soprat-tutto in occasione delle feste: le principa-li sono per Muravera sant’Agostino, a fineagosto, per Villaputzu santa Vittoria, ametà ottobre, per San Vito quella del san-to omonimo, a metà giugno. Alle proces-sioni e ai balli prendono parte gruppi in co-stume tradizionale: a Muravera quellofemminile si distingue per ilvelo bianco di pizzo, i cor-petti variopinti sulle gonneviolacee; quello maschileper il gilè in orbace e il col-letto di pizzo che guarni-sce la camicia. Compaiononumerose anche le “trac-cas”, i carri tirati dai gioghidi buoi ormai scomparsi inbuona parte dell’isola, e siesibiscono i maestri delle“launeddas”, l’antichissi-mo strumento a tre canneche ormai sopravvive sol-tanto in questa zona e nel-l’Oristanese. Costruisconocon le proprie mani gli strumenti, e alcu-ni di loro li vendono.
Andando da Muravera verso San Vito, prima delponte sul Flùmini Uri, affluente del Flumendo-sa, si può imboccare sulla sinistra la strada afondo naturale che, in poco meno di 4 km, con-duce alla miniera d’argento di monte Narba,ora abbandonata. Lungo il percorso ampie zo-ne a bosco e alcune domus de janas, le tombeprenuragiche scavate nella roccia.
Da San Priamo a CagliariLasciata la piatta pianura costiera pun-teggiata di stagni, si imbocca (percorren-do il tratto iniziale dell’Orientale Sarda) lalunga valle tracciata tra i rilievi dai rii Pi-cocca, Cannas e Màlliu; questa si va via viarestringendo, mentre le masse rocciose sifanno più imponenti e minacciose sullastrada: si giunge così, dopo una decina di
3.1 Da San Priamo a Muravera e a Cagliari
75
km, al punto più suggestivo del percorso,l’arco dell’Angelo: una grande punta digranito rosato si sporge al di sopra dellastrada, che ha alla parte opposta il fon-dovalle con le acque limpide del fiumecircondate da una folta vegetazione.La strada continua poi a salire tortuosa fi-no al valico di Arcu ’e Tidu (passo del Co-lombaccio, m 426); da qui inizia la discesaverso Cagliari: segue la valle del rio Longu,incassata tra le propaggini del monte Ser-peddì, a destra, e quelle del Sette Fratelli,a sinistra, con ai lati i rilievi boscosi che sindall’Ottocento accolgono gruppi di case divacanze dei cagliaritani; quindi le zonecoltivate a vite e la pianura.
A destra del valico Arcu ’e Tidu, dove si trova an-che la cantoniera di Campu Omu, una stradaasfaltata conduce in 7 km a Burcei (m 648, ab.3010), il paese più alto della provincia di Caglia-ri. Fondato nel ’600 da pastori, è noto per la pro-duzione delle ciliegie. Oltre l’abitato una strada
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
a fondo naturale, percorribile in auto, conduce in8.5 km alla punta Serpeddì (1067 m) dalla quale siha un’ampia vista panoramica.
Sempre dal passo Arcu ’e Tidu un bivio a sini-stra, in corrispondenza di quello per Burcei,conduce invece, dopo breve tratto su fondonaturale, alla caserma della Forestale UmbertoNoci, nella quale è stato allestito di recente il Mu-seo del Cervo sardo (preavvisare per telefono,070 27991 o 831038). I reperti riguardano la va-rietà sarda del cervo, “Cervus elaphus corsi-canus”, in pericolo d’estinzione e protetta: so-no pelli, corna di esemplari di diversa età, tro-fei, stampe e materiale audiovisivo.Tutt’intorno le foreste delle pendici del montedei Sette Fratelli (m 1023), nelle quali ci si puòinoltrare proseguendo sulla stessa strada. Do-po 6 km si giunge alla ‘Caserma Vecchia’ da do-ve, con una camminata di un paio d’ore, si puòraggiungere la vetta. Si attraversa un fitto boscodi lecci, sughere e corbezzoli, nel quale trovanorifugio rare specie animali.

3.2 Il GerreiItinerario lineare nel Sud-est dell’isola, da Cagliari a Ballao, km 209 senza le deviazioni(carta a pag. 73)
76
Il viaggio conduce nelle zone interne piùimpervie e inaccessibili, e di fatto menofrequentate della regione. Dalle campa-gne del Campidano ci si inoltra tra i rilie-vi del Gerrei, poi verso le coste disabitatedel Salto di Quirra per piegare di nuovo al-l’interno, lungo la valle del rio Pardu, tra isuperbi “tacchi” dell’alta Ogliastra, quin-di in un’altra plaga desertica, quella diPerdasdefogu. Le ‘tratte’ sono: 70 km daCagliari ad Armungia, lungo la statale 387e da San Nicolò Gerrei su vie secondarie;30 da qui a Villaputzu su un’altra secon-daria; quindi 50 per arrivare a Jerzu se-guendo l’Orientale Sarda sino a pochi kmdal paese; altri 59 per raggiungere Ballao.
DolianovaAl centro di una zona dolce e amena di col-tivazioni, il paese (m 212, ab. 8044) fondala sua economia su un’agricoltura vivacee varia: una cooperativa di olivicoltoriproduce olio e olive da tavola; presso laCantina sociale si trovano Nuragus, Nasco,Moscato e Malvasia, tutti a Doc; tra i ca-seifici, specializzati nelle varietà del pe-corino, uno confeziona anche una parti-colare crema di formaggio piccante.Capoluogo della Partiolla, Dolianova fuun tempo sede della diocesi di Dolìa, e diquel periodo conserva uno straordinariomonumento, la chiesa di S. Pantaleo*.Costruita in tre diversi periodi, tra la se-conda metà del sec. XII e la fine del XIII, fon-
de e armonizza lo stile pisano del primo eun misto di romanico e gotico del secondocon gli influssi islamici del terzo. A una pa-rete esterna è aggiunto un sarcofago ro-mano sostenuto da due colonne; all’inter-no, con rustiche colonne dagli stili diver-si, un’ancona d’autore spagnolo (Il marti-rio di san Pantaleo), un Arbor Vitae (Albe-ro della Vita), affresco scoperto di recen-te che rappresenta simbolicamente tuttoquanto è derivato dal Cristo, e un raro ba-cile battesimale in arenaria del periodopaleocristiano.
Sant’Andrea FrìusSi abbandona il territorio ondulato siste-mato a colture mediterranee per entrare inun tratto arido di colline incolte, utilizza-te a pascolo.I terreni sono però nuovamente coltivati amandorli, olivi e viti intorno al piccolocentro di Sant’Andrea Frìus (m 300, ab.1926): la popolazione, fortemente legata al-le tradizioni, celebra una bella festa il 23maggio in onore dei santi protettori Andreae Isidoro. Da qui, verso oriente, la strada sifa subito scoscesa, su e giù per la vallatadel rio Coxinas; quindi, dopo un pianoro,si tuffa in una zona ancora più aspra e sel-vaggia, con i monti Cùccuru Orru a de-stra e Ixi a sinistra. Dopo una decina di kmpresso l’omonima cantoniera è il PranuSànguni (Pianoro del Sangue), così dettoperché i fiori spontanei gli danno a perio-di un colore rossastro.
San Nicolò GerreiA San Nicolò (m 365, ab. 994), piccolo ca-poluogo del Gerrei, si può far sosta al ca-seificio (in località S’Acquadròxiu) chevende formaggi ovini e caprini e, in vaset-ti, la Crema del Gerrei, formaggio fuso pic-cante. Quindi si prende a destra sulla pro-vinciale per Villasalto con altro percorsotortuoso nella valle del rio Tolu; dopo 8 kmbivio a sinistra per inoltrarsi in una zona digrandi roccioni calcarei. E finalmente com-pare Armungia.
Armungia*Si nota subito il nuraghe che, raro esempionell’isola, si conserva in buone condizioniproprio al centro dell’abitato (m 366, ab.633), adiacente all’ex casa comunale. Que-sta ospita il piccolo Museo etnografico S’O-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

mu de is Aìnas (‘La Casa degli attrezzi’),con strumenti del lavoro domestico, delcontadino, del pastore e del cacciatore; euna mostra fotografica su Emilio Lussu, loscrittore e uomo politico antifascista(1890-1975) che ad Armungia nacque e fe-ce ripetutamente ritorno. Anche nei suoiscritti torna il ricordo degli anni dell’in-fanzia, delle leggendarie battute di cac-cia, di una civiltà antica e originale: «Sononato in un piccolo villaggio della montagnae credo di aver conosciuto gli ultimi avan-zi di una comunità patriarcale senza clas-si e senza stato». La sua casa, nel rioneCannedu, è tra le più belle tra quante siconservano dell’edilizia tradizionale lo-cale basata sull’impiego di scaglie di schi-sto: fa parte di un percorso di visita col-legato al museo che comprende anche ilnuraghe, alcune altre abitazioni del centrostorico e un’officina di fabbro.
Strada del FlumendosaOltre Armungia si continua su percorsosempre asfaltato e con una breve discesatortuosa si raggiunge, per imboccarla sul-la destra, la statale 387 che congiungeBallao con San Vito e l’Orientale Sarda:un’arteria dal percorso moderno, con via-dotti e gallerie, che consente di giungeremolto rapidamente al mare nonostantel’asperità del territorio attraversato. Siprocede a mezza costa sul versante destrodella valle, che è tortuosa e a tratti moltostretta perché dovuta esclusivamente al-l’erosione fluviale. Nel paesaggio domi-nano qua e là alcune masse roccioseconformate a “tacco”. I versanti delle al-ture sono ricoperti dalla macchia medi-
77
terranea. Dopo una ventina di chilometriil Flumendosa descrive un grande mean-dro, chiamato S’Arcu de sa rena (L’arco disabbia) perché ha formato una spiaggia eun piccolo lago.
San Vito e VillaputzuSi trovano come Muravera (v. pag. 74),con cui presentano diverse analogie, aimargini della piana alluvionale del Flu-mendosa; una zona di antico insediamen-to, se si considera che in territorio di Vil-laputzu (m 8, ab. 5016) sorgeva la città fe-nicia di Sàrcapos (da cui, sembra, il nomeSàrrabus), che utilizzava un porto realiz-zato alla foce del Flumendosa e curava inparticolare gli scambi con l’Etruria.La tessitura, ancora ben viva sia a San Vi-to (m 13, ab. 3970) sia a Villaputzu (oltreche a Muravera), produce coperte, tova-glie e tappeti. Per questi ultimi viene usa-ta la tecnica “a pibiònes”, cioè ad acini, cherende il tessuto soffice e consistente allostesso tempo.Tra i monumenti merita una visita la pic-cola chiesa di S. Lussorio, a San Vito: situataai margini dell’abitato, verso la parte alta,si raggiunge con una strada in salita, se-gnalata, che si stacca dalla via centrale pri-ma di uscire verso Villasalto. Ha linee sem-plici e massicce, con due grossi con-trafforti sulla facciata, che termina concampanile a vela, e un piccolo portico la-terale. L’interno, a una sola navata, ha co-pertura in legno e volta a botte.
Interessante la discesa al mare di Porto Corallo,6 km oltre Villaputzu: imboccata una stradaben segnalata subito dopo il paese, si passa sul-la destra di uno stagno formato dalle acquedel Flumendosa, poi di un’altura dove si scor-gono i resti del castello di Gibas, quindi si giun-ge in prossimità di una delle tante torri elevatedagli spagnoli: qui nel 1812 la popolazione riu-scì a respingere uno degli ultimi attacchi dei pi-rati saraceni. Si costeggia il porto turistico e sicontinua su una strada a fondo naturale checonsente di esplorare la costa.
Verso TertenìaLungo la 125 Orientale Sarda in direzionenord, si continua su un percorso semprelontano dal mare sino a incontrare a circa15 km da Villaputzu, vicinissima alla stra-da ma nascosta da una casa diroccata, lacampestre chiesa di S. Nicola, unico esem-pio in Sardegna di edificio sacro costruitoin mattoni cotti. Fu realizzata dai pisani instile romanico. Sul colle a destra si notanoi ruderi del castello di Quirra, costruito in-torno al ’200 dai ‘giudici’ di Cagliari. Qui è
3.2 Da Dolianova a San Vito e Villaputzu
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

l’aspro Salto di Quirra (‘salto’ è termineche significa area incolta).La strada continua poi ancora lontana dalmare, dal quale è separata da una serie dirilievi: qualche km dopo la chiesa di S.Nicola si entra in provincia di Nùoro. Nelterritorio, sempre scarsamente abitato,larghi tratti desertici, di rocce e piccolamacchia, si alternano a piane coltivate.
TertenìaNel paese (m 121, ab. 3710), che ha sosti-tuito l’originaria economia mineraria conle attività agricole e pastorali ed è ora im-pegnato nella valorizzazione turistica del-la costa, si può fare una sosta per cono-scere i prodotti locali, i formaggi e i dolcidella tradizione; presso privati si trovanobuoni vini. Nella bella stagione, pressodue chiese campestri si svolgono le due fe-ste principali, con processioni, costumi,canti e balli tradizionali: il 2 agosto quelladi S. Pietro apostolo; il 1° settembre quel-la della patrona S. Sofia.
Al mare si arriva con una strada che si staccadall’Orientale Sarda all’altezza del paese: untempo conduceva a una miniera di barite. Dopoaver osservato il panorama dal passo Arcu deSàrrala (m 233) si scende in una stretta piana co-stiera che termina con spiagge alternate a sco-gliere sulle quali si affacciano insediamenti tu-ristici ricavati in parte dalle vecchie case dei mi-natori. La zona è caratterizzata dalla presenza dinuraghi: a ridosso dell’arco sabbioso di Sa FoxiManna, facilmente raggiungibile, si trova il nu-raghe Aleri; ripresa la strada verso sud si trovasulla destra il Longu, molto alto, uno dei pochiche conservi ancora la copertura. Più oltre, unatorre aragonese e il villaggio turistico San Gio-vanni di Sàrrala con il suggestivo nuraghe Su Con-cali, che ha due piccole torri aggiunte.
JerzuLasciata l’Orientale Sarda al valico Genna’e Cresia (‘Porta della Chiesa’, m 267), conpercorso sempre in salita si raggiunge Jer-zu (m 427, ab. 3391). Prima di entrare inpaese sosta piacevole e panoramica allafonte Bau ’e Munsa, con piccola oasi verde.In alto dominano le strutture della grandeCantina sociale. Allo spaccio si trovano tut-te le varianti del Cannonau, che qui do-mina incontrastato: rosso, rosato e riser-va a Doc, quindi ancora rosso, rosato, dry,dolce e persino bianco.Una passeggiata lungo la via Umberto, laprincipale del paese, offre di tanto in tan-to scorci panoramici sulla profonda vallatadel rio Pardu, a nord-est. Nelle localitàPerda Puntuta e Sa Ibba s’Ilixi sono presentigruppi di domus de janas.
3 Il Sàrrabus e il Gerrei: la montagna meridionale
78
Una breve deviazione, lasciando per il mo-mento il bivio per Perdasdefogu, conduce in me-no di 2 km a Ulàssai, tranquilla borgata di altacollina (m 775, ab. 1650). All’ingresso un cartellosulla sinistra indica la vicina cooperativa ditessitrici Su Màrmuri: usando lana sarda, cotonee lino, produce con diverse tecniche tappeti,tende, asciugamani e copriletti. Motivo domi-nante della decorazione, la figura della capra.Dal locale della cooperativa una strada prose-gue a monte dell’abitato, quindi – sempre asfal-tata – si inerpica ripida in una stretta valle conorti e zone coperte di pini, tra alte masse roc-ciose: sono le pareti strapiombanti di altipianicalcarei, caratteristiche di questa zona e notecome tacchi o tònneri. A poco più d’un km dalpaese, una strada asfaltata, per gole e aspri“taccus” di grande suggestione, giunge all’in-gresso della grotta Su Màrmuri*, attrezzataper la visita, che richiede una guida.Al ritorno al paese la prima strada a sinistra con-duce a un interessante monumento alla donna,realizzato in un vecchio lavatoio pubblico periniziativa dell’artista Maria Lai, nativa del luogo:all’interno le corde tese al soffitto rievocano lafatica del telaio.
Da Jerzu a PerdasdefoguRipreso il percorso per Perdasdefogu siprocede in zona pittoresca e panoramica,caratterizzata da altri enormi tacchi. Pocodopo la possibilità di una breve sosta è of-ferta dalla campestre chiesa di S. Anto-nio, sulla sinistra della strada, in area rim-boschita a pini; festa con balli tradiziona-li il 13 giugno. Dopo una salita ci si affacciasu un’altra spettacolare distesa di tacchi,quindi si passa a una zona di masse colli-nari arrotondate, coperte prevalentementedalla macchia: una delle aree meno po-polate dell’isola.Si giunge infine a Perdasdefogu (m 599,ab. 2430; nel nome, ‘Pietre di fuoco’, è for-se il ricordo di un’antica attività vulcani-ca), che nell’abitato e nel territorio ospitainsediamenti e poligoni militari. Di recen-te è stata restaurata e riaperta al culto, nel-la parte alta del paese, la paleocristianachiesa di S. Sebastiano.
Approfittando di una bella strada asfaltata sipuò deviare sulla sinistra, all’uscita del paese,per un’escursione di circa 20 km al monte Car-diga (m 676): si procede in un paesaggio calca-reo desertico, con ampia vista su una serie disommità collinari arrotondate tutte a macchiedi cisto e corbezzolo. Alcune stradelle si iner-picano sul fianco del monte, che, insieme ad al-cune fontane, conserva parti dei grandi boschidi elci che un tempo lo coprivano per intero eche ospitano ancora interessanti varietà dellafauna originaria: cinghiali, gatti selvatici, mar-tore, pernici, astori, aquile ecc. Dalla cima la vi-sta è spettacolare.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

EscalaplanoNel paese (m 338, ab. 2575), oltre a nu-merose abitazioni in pietra, interessante laparrocchiale di S. Sebastiano, in via Ro-ma, con rosone traforato e bassorilievid’impronta rinascimentale all’interno (Mar-tirio di S. Sebastiano e Vergine e Apostoli).In direzione di Orroli, a 3 km dal paese, unastradella a sinistra conduce su un cocuz-zolo con querce da sughero dove si trovala chiesa di S. Giovanni, luogo di una festatradizionale il 24 giugno. Ampia vista sulpaese e dintorni e, nelle rocce intorno, ledomus de janas di Sa Fossada.
Più avanti una stradella asfaltata sulla sinistradella strada di Orroli conduce in meno di 10 mi-nuti alle rive di un lago artificiale, il Mulàrgia, sulquale si affaccia un punto di ristoro con cucina
3.1 Da Jerzu a Ballao
79
Funtana CobertaSulla strada per Ballao (di nuovo in pro-vincia di Cagliari) una carrareccia sulla de-stra porta dopo 100 m alla Funtana Cober-ta, pozzo sacro nuragico del tipo più anti-co, costruito cioè, come i nuraghi, con pie-tre lavorate solo in parte: una scalinataconduce alla camera sotterranea, alta piùdi 5 m, che va restringendosi verso l’alto colsistema a tholos, come nelle torri nuragi-che, appunto; il tutto in materiale calcareo.
BallaoIl paese (m 90, ab. 1039) è in un bassopianoro, lungo un’ansa del Flumendosa, inuna zona abitata sin dai primordi. L’ag-glomerato non ha edifici di pregio, maconserva molte abitazioni realizzate conuna tecnica antichissima: in pietra sci-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
specializzata in cibi tipici locali. Lungo il per-corso, bella vista sullo specchio d’acqua con al-cune rive di terra rossa.
Ancora oltre sulla via per Orroli una fontana congrande abbeveratoio sulla destra indica il pun-to nel quale si devia per il vicino nuraghe Ar-rubiu*. È uno dei più grandi sinora conosciuti,circondato come è da un abitato utilizzato an-che in epoca romana. Molto grandi e articolateanche le costruzioni nuragiche e difensive: latorre centrale, alta 16 m, è circondata da cinquetorri minori collegate da un bastione che deli-mita un ampio cortile interno; un più vasto an-temurale alterna altre sette torri a lunghi mu-raglioni, cui si aggiunge verso sud-est ancorauna muraglia con cinque torri. Nelle vicinanzeè il villaggio nuragico di Su Putzu di un centinaiodi capanne con tempio sacro a pozzo, con cor-tile a mezzaluna per i pellegrini.
stosa nella parte bassa, quindi in làdiri, imattoni d’argilla e paglia cotti al sole in usonel Campidano. Il paese viveva un tempoanche delle attività minerarie di Corti Ro-sas, oggi abbandonate: gli appassionati diminerali possono raggiungere (con unastrada a destra dopo il ponte sul Flumen-dosa, sulla strada per Escalaplano) la zo-na degli scavi, che si compivano a cieloaperto, e trovare negli ammassi di resi-dui bei cristalli di antimonite.Feste tradizionali si svolgono il lunedì dopoPasqua nella chiesetta campestre di S. Cleo-fe: il 29 giugno per i Ss. Pietro e Paolo; il 22luglio per la patrona S. Maria Maddalena; ilprimo lunedì di ottobre per S. Vitalia.Da Ballao è possibile raggiungere (12 km)San Nicolò Gerrei (v.pag. 76).

4 Trexenta, Marmilla e Sarcidano:la Sardegna delle colline
80
Profilo dell’areaLa Trexenta, la Marmilla e il Sarcidano, situate nella parte cen-tromeridionale della Sardegna, sono regioni ricche di storia,tradizioni e ambienti naturali particolari. Una moltitudine diritrovamenti archeologici testimoniano la presenza dell’uo-mo già dal Neolitico: le cave di ossidiana del monte Arci, le statue-menhir del Sarcida-no, i circoli megalitici a “cromlech” del territorio di Làconi, i villaggi e i santuari nura-gici di Barùmini e di Santa Vittoria di Serri non sono che gli aspetti più conosciuti di que-ste regioni, che custodiscono “domus de janas”, “tombe di giganti”, pozzi sacri e nura-ghi sparsi in tutto il territorio. Gli abitanti sono fieri delle proprie tradizioni: è ancorapossibile vedere al lavoro i ramai di Ìsili, le tessitrici di Mògoro e di Sàrdara e le cera-miste di Villanovaforru, o degustare piatti tipici accompagnati dagli ottimi vini dellaTrexenta. Sono proprio i produttori di questi vini, in particolare del Nuragus, che pro-pongono, in collaborazione con le cantine del Campidano, un itinerario enogastronomicopercorribile con il “trenino verde”. Ma l’aspetto più caratterizzante di queste zone è quel-lo ambientale: le aree di monte Arci e della Giara, per la loro unicità, sono inserite in unprogetto di salvaguardia che prevede l’istituzione di due parchi regionali. Sulla Giara,un altopiano basaltico dal profilo trapezoidale, vivono gli unici esemplari di una razza
di cavalli selvaggidalle piccole dimen-sioni, dalla lunga co-da e dagli occhi amandorla che pa-scolano nei boschidi sughere e si abbe-verano nei “paùlis”,laghetti che in pri-mavera si ricopronodella fioritura dei ra-nuncoli acquatici. Il monte Arci sovra-sta il Campidano diOristano, dividendo-lo dall’alta Marmilla,con il suo profilo “aschiena d’asino”, co-me lo chiamano igeografi . Di originevulcanica, supera di
poco gli 800 metri di altezza nella sua cima più alta, la Trèbina Longa, e conserva testi-monianze di presenze umane che si possono far risalire a parecchi millenni fa: le cave diossidiana, la lucente pietra nera, furono infatti sfruttate già nel Neolitico antico dalle gen-ti protosarde, che utilizzavano “l’oro nero” come materiale per fabbricare utensili e ar-mi o come merce di scambio con le genti della Toscana, della Liguria e della Corsica. I re-sti degli insediamenti sono inseriti in un ambiente naturale ancora sufficientemente in-tegro, fatto soprattutto di boschi di lecci e sughere, a cui spesso si associano piante dicorbezzolo: in autunno, la contemporanea presenza di fiori e frutti su questi arbusti re-gala al visitatore uno spettacolo di colori, profumi e sapori indimenticabile, a cui si puòaggiungere spesso la raccolta di funghi di cui il sottobosco del monte Arci è ricco. Negli ultimi anni, tutto il territorio si è arricchito di iniziative che vanno dalla costitu-zione di consorzi turistici all’allestimento di nuovi musei territoriali, dall’apertura di azien-de agricole e conserviere all’introduzione di nuove forme di allevamento, come quellodegli struzzi e dei bufali nelle campagne di Ortacesus, alla creazione dell’albergo diffusoo di servizi di bed & breakfast in case private.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

4.1 La Trexenta e la MarmillaItinerario lineare, da Cagliari a Senorbì e a Sanluri, km 102 escluse le deviazioni (carta qui sopra)
81
Si svolge sino a Monastìr sulla statale 131;di qui a Suelli lungo la statale 128 per poitoccare, seguendo strade provinciali ebrevi tratti della statale 197, gli abitati diGuasila, Villanovafranca, Villanovaforru eSàrdara; un breve tratto sulla 131 e si è aSanluri. Terre di nude e ondulate collinemioceniche, la Trexenta e la Marmilla han-no molto in comune. Entrambe portano isegni di un’antica tradizione contadina le-gata soprattutto alla produzione di cerea-li, di quel grano duro che per lunghi seco-li ha dato impulso all’economia delle duesub-regioni. Campi coltivati a grano e fo-
raggio, vigneti, mandorli, vecchi ulivi, greg-gi al pascolo ne caratterizzano ancora ipaesaggi, così come nei piccoli centri so-no un denominatore comune le ultime ca-se a corte dai portali archivoltati. La mi-tezza del clima, la fertilità del terreno, lapresenza di piccoli corsi d’acqua hanno fa-vorito la nascita di primi insediamenti giànel Neolitico medio e non c’è paese chenon possieda aree archeologiche; cui si af-fiancano, non di rado, interessanti musei.Tracce di un lontano passato si colgonoanche nelle sagre che fondono assiememondo pagano e fede cristiana.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

PimentèlDalla statale 131, all’altezza dell’abitatodi Monastìr, ci si immette nella statale 128per Senorbì e, dopo 10 km, si svolta a si-nistra per Pimentèl (m 154, ab. 1224). Èquesto il paese delle “domus de janas”del-la necropoli preistorica di S’Acqua Salida,nelle campagne di Pranu Efisi. Dall’abita-to si segue verso nord l’asfalto per Guasi-la e, al quarto incrocio con le strade dicampagna, si svolta a sinistra per incon-trare, dopo circa 350 m, su un rilievo diroccia arenaria, una necropoli di otto tom-be ipogeiche. Sempre dalla strada perGuasila, svoltando alla prima strada bian-ca che s’incontra da Pimentèl, si arriva do-po 300 m alla domu de janas di Corongiu: èla tomba dove sembra di cogliere neglielementi decorativi e nei simboli a spira-le «lo schema di un viso umano – spiegal’archeologo Giovanni Lilliu – in particolarequello della dea degli occhi», immagineidealizzata della dea Madre di tradizioneneolitico-calcolitica.
SenorbìÈ uno dei centri più grossi e rappresenta-tivi della Trexenta (m 199, ab. 4347). Qua-si al centro dell’abitato, in piazza Munici-pio, è una casa ottocentesca, con il log-giato (“sa lolla”), con l’acciottolato delcortile, (“s’impedrau”), con il pozzo e lestalle. È il nuovo Museo archeologico Sa do-mu nosta, istituito di recente per acco-gliere ed esporre, innanzitutto, i preziosireperti venuti alla luce nella necropoli pu-nica e romana di monte Luna, dove tombea pozzo e a fossa hanno restituito anfore afasce dipinte, brocche a bocca trilobata,piatti, lucerne, coppe, monete dei sec. IV eIII a.C., anelli e pendenti in oro con scara-bei incastonati, orecchini, collane, brac-ciali, rasoi in bronzo. Non lontano dalla ne-cropoli sono stati individuati, a Santu Te-ru, anche i resti dell’abitato cui apparten-gono, quasi certamente, i corredi funera-ri. Gli insediamenti sono stati inseriti in unParco archeologico, all’interno del qualesorge un complesso ricettivo composto daun bar ristorante, una sala convegni e unasaletta didattico-espositiva dove, trami-te un sistema di telecamere a circuitochiuso collegato ad alcune tombe, è pos-sibile osservare l’interno delle sepolture ela collocazione dei corredi.È lo stesso museo a ricordare che MonteLuna ha conosciuto insediamenti anchemolto più antichi di quello punico, come di-mostrano i frammenti di ceramica deco-rata, le lame e le cuspidi in ossidiana, da-
4 Trexenta, Marmilla e Sarcidano: la Sardegna delle colline
82
tabili al IV millennio a.C. Comunità neoliti-che erano ben presenti, però, anche in al-tre aree del territorio di Senorbì: «La loca-lità di Sa Turriga – conferma Giovanni Lil-liu – ha restituito il più grande ed elegantedegli idoli sardi di Dea Madre», una statui-na di oltre 42 cm d’altezza, di tipo cicladi-co. Alla Madre di Dio è dedicata invece, suun colle alla periferia nord del paese, lachiesetta campestre di S. Maria di Segolai,un piccolo tempio romanico edificato ver-so la metà del XIII secolo.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Da Senorbì si può compiere una deviazione dal-l’itinerario per dedicare qualche ora alla ne-cropoli preistorica di Pranu Mutteddu*. L’areaarcheologica dista una ventina di chilometri e lasi raggiunge percorrendo verso est, la strada tor-tuosa che supera la piccola frazione Arixi, si la-scia alle spalle le case di San Basilio e svolta a si-nistra verso Goni. Dal bivio si va avanti per cir-ca 6 km sino a incontrare, sempre sulla sini-stra, prima del paese, una carrareccia che por-ta ai menhir e alle tombe a circolo della necro-poli: un’area suggestiva per quei misteriosi mo-noliti in arenaria allineati su una radura dell’al-topiano, tra sughere imponenti e secolari, schie-rati come antichi guerrieri, di fronte alla stradabianca che li divide da una singolare tomba a cir-colo con al centro una grotticella artificiale, sca-vata con grande maestrìa in un unico blocco dipietra. Di rilevante interesse archeologico.
SuelliDa Senorbì bastano 3 km d’asfalto per in-contrare, verso nord, il paese (m 254, ab.1182), di quel san Giorgio di Suelli, “epi-scopus Barbariae”, vissuto tra X e XI sec.,cui la tradizione popolare attribuisce gran-de umiltà, amore per il prossimo e sor-prendenti miracoli. Le spoglie del santo so-no conservate nel santuario che si ergesu un piazzale dentro l’abitato, a fianco del-

4.1 Da Senorbì a Sàrdara
83
la chiesa di S. Pietro. Qui si rinnova, in pri-mavera, la grande sagra che Suelli dedicaal suo vescovo. Il tempio di S. Pietro con-serva una pregevole ancona del ’500, ope-ra di Pietro e Michele Cavaro, che raffigu-ra una Madonna col Bambino e i Ss. Pietro,Paolo e Giorgio vescovo. Sulla destra del-la cattedrale si erge la chiesa del Carmine,gotico-aragonese.Al fascino del sacro, Suelli unisce il gustodel profano con la bella casa padronaledella famiglia Ruda, una sorta di museo-ri-storante che raccoglie assieme oggettidel mondo contadino e vecchi sapori del-la cucina d’una volta.
GuasilaDa Suelli l’itinerario punta verso ovest e,attraversando Sèlegas e Guamaggiore,giunge a Guasila (m 211, ab. 3038), La suaParrocchiale è uno degli esempi più si-gnificativi dell’architettura sacra neo-classica di cui è stato artefice nel’Otto-cento Gaetano Cima. All’interno richia-mano interesse pregevoli sculture di Giu-seppe Antonio Lonis. All’Assunta, nei gior-ni di Ferragosto, Guasila dedica un inso-lito rito profano, quello di “S’acchixed-da”, un rodeo che vede protagonisti gliscapoli del paese e una povera giovenca.Alla vigilia della sagra , di buon mattino,la giovenca viene prima liberata e poi in-seguita senza tregua da giovani cavalieri.Vince chi per primo riesce a prenderla allaccio. A questa sagra, da qualche anno,è stato abbinato il Palio dell’Assunta, det-to anche Palio dei Comuni, perché vi par-tecipano rappresentanti di tutti i Comunidell’Isola. Nel moderno e funzionale Ip-podromo i cavalieri cavalcano “a pelo” eal vincitore viene consegnato il drappo ri-camato in oro zecchino con l’effigie dellaVergine Assunta.
VillanovafrancaIl paese (m 300, ab. 1552), che apre la por-ta alla Marmilla, si stende tra fertili colline,raccolto attorno alla grande cupola e allosvettante campanile a canna quadrata del-la parrocchiale di S. Lorenzo. A meno di unchilometro e mezzo dall’abitato, sul dorsodi una collina che domina la vallata di RiuMannu, s’incontra il complesso megaliticodi Su Mulinu, che ha rivelato interessantiparticolari sulla nascita delle torri a tholos,nei secoli del Bronzo medio, e sui rituali sa-cri praticati nella prima età del Ferro. I re-perti provenienti da questi siti sono espo-sti nel Museo archeologico comunale, ospi-tato nel vecchio Monte Granatico.
VillanovaforruIl borgo (m 310, ab. 704) è qualcosa di piùche un semplice paese della Marmilla. È unlaboratorio di idee, di iniziative, di scom-messe che hanno come fulcro il vecchio edi-ficio del Monte Frumentario divenuto Mu-seo archeologico*. In esso sono raccolti gliaskoi, i grandi ziri, i vasi piriformi a deco-razione geometrica, le lucerne, i portabra-ce, le scorie di fusione di piombo e rame delcomplesso nuragico di Genna Maria (sec.XV-VII a.C.; v. sotto), che lunghi e pazienti sca-vi hanno portato alla luce sulla sommità diuna collina a poca distanza dal paese.
A ovest del paese, sulla strada per Collinas,una sterrata supera i 408 m del colle omonimosino al complesso fortificato e villaggio nura-gico di Genna Maria*. Dal torrione centrale delBronzo medio al bastione trilobato del Bronzorecente, rinforzato da un antemurale con torri,delle quali quattro ancora riconoscibili, crebbenella prima età del Ferro un abitato abbando-nato nel sec. VIII a.C. per ragioni rimaste ignote.Luogo sacro deputato al culto agrario di De-metra e Core per più di ottocento anni, è dal1969 oggetto di scavi sistematici.
Con una deviazione di 7 km verso est, si rag-giunge, superata Lunamatrona, il caratteri-stico abitato di Siddi (m 184, ab. 845), doveun’antica dimora padronale, casa Steri, risa-lente al sec. XVII, ospita il Museo delle tradizioniagroalimentari della Sardegna. Con un accu-rato progetto etnografico e antropologico, ilmuseo si propone di ricostruire l’intreccio direlazioni fra il cibo, le sue tecniche di lavora-zione, i modi di consumo e la vita sociale chesi svolgeva dentro la casa. Ritornando versoVillanovaforru, sulla strada per Collinas, sicosteggia a nord la Giara di Siddi, chiamata “SaCorona arrubia” per la sua conformazione eper la sua copertura di licheni rossi. Ai suoipiedi è stato realizzato il Museo naturalisticodel Territorio, su una collina che diventeràun Parco geobotanico mediterraneo speri-mentale. Una seggiovia permette di raggiun-gere la sommità della Giara, a oltre 300 m di al-tezza, ricca di testimonianze archeologiche: lapiù importante è Sa Domu ’e s’orcu , una tom-ba di giganti tra le più grandi e meglio con-servate dell’intera isola.
SàrdaraSi va verso la statale 131. Al bivio, dove ap-pare verso occidente, su un colle, la sa-goma scura delle rovine del castello diMonreale (XIII sec.), appartenuto ai ‘giudi-ci’ di Arborèa, si svolta a destra per Sàr-dara (m 155, ab. 4423). Proprio dentro l’a-bitato è il tempio nuragico di S. Anastasia,conosciuto come “sa funtana ’e is dolus”,la fonte che cura i dolori. Molta parte deireperti sono ora esposti nel Museo civico,
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

dove spiccano anche due splendide sta-tuine in bronzo con gonnellino assiro tro-vate nel sepolcro nuragico di Sa Costa,alla periferia del paese. Accanto al com-plesso nuragico si erge la tardogotica chie-sa di S. Anastasia (XV sec.).Lungo la provinciale per Pabillonis, si tro-va il moderno complesso termale di S. Ma-ria is Acquas, sorto sui resti dell’anticoimpianto romano di Aquae Neapolitanae.Avvolte dal verde di un boschetto di eu-calipti, le terme si trovano accanto all’o-monima chiesetta in stile gotico che ametà settembre si affolla di fedeli per lagrande sagra dedicata sia alla Madonna siaal culto delle acque.
SanluriÈ l’ultima tappa dell’itinerario. Dentro ilpaese (m 135, ab. 8581), si fa subito nota-re la sagoma quadrata, dominata da quat-tro torrette merlate, dell’unico castellomedievale sardo non in rovina, ma addi-rittura abitato e curato con attenti re-
4 Trexenta, Marmilla e Sarcidano: la Sardegna delle colline
84
stauri. La sua costruzione viene fatta ri-salire al XIII sec., anche se è conosciuto co-me il castello di Eleonora d’Arborea, ‘giu-dicessa’ dal 1383 al 1402. I locali del ca-stello, che appartiene attualmente ai con-ti Villasanta, sono stati trasformati in salemuseali che espongono cimeli, armi e ban-diere del Risorgimento, in gran parte pro-venienti dalla reggia napoletana di Capo-dimonte, dove erano raccolte sino al 1927.Alcune sale sono dedicate anche alla sto-ria d’Italia nelle due guerre mondiali. Al pri-mo piano un’interessante raccolta di ce-roplastiche.Dentro l’abitato merita una visita la ba-rocca parrocchiale di Nostra Signora delleGrazie, già gotico-aragonese ma rifatta tra1781 e 1786 da Carlo Maino e AntonioIgnazio Carta su evidenti modelli pie-montesi. Di Giovanni Marghinotti è una Ma-donna delle anime (2a cappella destra),mentre la 3a cappella sinistra custodisce,in un retablo scolpito e dorato, un note-vole Crocifisso ligneo del ’400.
4.2 Le Giare e il SarcidanoItinerario lineare, da Sanluri a Barùmini e a Gergei, km 81 deviazioni escluse (carta a pag. 81)
Si svolge quasi interamente lungo le stata-li 197 e 128, consentendo deviazioni ai pie-di delle Giare. A 3.8 km da Sanluri (bivio diVillasanta) s’imbocca la 197 toccando insuccessione las Plassas, Barùmini, Gèstu-ri e Nuragus, dove si devia a sinistra per Ge-noni e Làconi, con un anello che si chiudesu Nurallao; di qui la 128 reca a Ìsili, a Ser-ri e a Gerrei. Isola nell’isola, giardino pen-sile, perla verde: la fantasia si è impegnataa fondo per esprimere in due parole il fa-scino di sa Jara, la Giara di Gèsturi. Vasti bo-schi di sughere, bacini imbriferi, cavalliniallo stato brado e testimonianze archeo-logiche ne fanno uno degli angoli più pre-ziosi della terra sarda. L’altopiano basalti-co s’innalza sulle basse colline miocenichedella Marmilla e del Sarcidano e domina co-me una fortezza naturale i centri abitati chelo circondano. In tempi recenti ciascuno diquesti paesi ha costruito la ‘sua’ stradasugli impervi sentieri delle “scalas”, deipassaggi naturali, e sui tracciati di “su cam-minu ’e garru”, i vecchi percorsi del carroa buoi, per raggiungere con facilità e tene-re sotto assedio l’isola dei cavallini. A Ìsili, nel Sarcidano, vivono gli ultimi “ar-ramanaius”, quegli artigiani del rame daicaratteri slavi e dalla misteriosa parlata,“su romaniscu”, che la tradizione consi-dera eredi d’una comunità zingara. Abili
maestri di quest’arte, tra incudini e alti sga-belli a treppiede continuano a plasmare edecorare, con maestria e pazienza, cal-daie e “cupas”, bracieri dai riflessi dorati,pentole e “artàinis”, padelle dai neri manicidi ferro.
Las PlassasAl bivio di Villasanta, dalla statale 131 di-verge la 197 per Villamar (m 108, ab. 3055),il paese dei murales, della chiesetta roma-nica di S. Pietro (XIII sec.), del retablo del1518 di Pietro Càvaro, conservato nellatardogotica chiesa di S. Giovanni Battista. Siattraversa l’intero abitato e si prosegue indirezione di Barùmini. Bastano poco più di6 km per vedersi venire incontro, dopoqualche curva, una delle immagini più sug-gestive della Marmilla: la collina perfetta-mente conica di las Plassas, incoronatadai ruderi di un castello giudicale degli Ar-borea e delimitata sullo sfondo dalla sa-goma inconfondibile della Giara di Gèstu-ri. Sulla sommità, sotto le rovine medieva-li, conserva tracce di un insediamento nu-ragico; alla base, la seicentesca chiesa di S.Maria Maddalena a croce greca.
BarùminiPrima di entrare nell’abitato si scorge, a oc-cidente del paese, la mole del complesso
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

quadrilobato di Su Nuraxi** (pianta qui inbasso), una ‘reggia’ megalitica che vederacchiusi in sé molti secoli di storia, dalBronzo medio (sec. XVI-XIII a.C.), cui appar-tiene il primo impianto della torre centra-le, alla seconda età del Ferro (sec. VI-III a.C.;una reggia iscritta dal 1997 nella “Lista delPatrimonio dell’Umanità UNESCO”. Fra i re-sti grandiosi, isolati su un colle dominan-te la vasta e integra solitudine della Mar-milla, si riconoscono il nuraghe centralepolilobato a tre camere so-vrapposte (sec. XVI-XIII a.C.),il successivo bastione arti-colato in 4 torri, il pozzoprofondo 20 m, un più re-cente baluardo. Distruttonel sec. VII a.C., il villaggio furicostruito e abitato sino aetà romana. Dal nuraghe lecase di Barùmini (m 202,ab. 1453) distano solo po-che centinaia di metri. Den-tro l’abitato si fa notare, ac-canto alla parrocchiale del-l’Immacolata, costruita informe tardogotiche nel XVIsec., la casa degli Zapata(chiusa per restauri), che ri-chiama gli anni della domi-nazione spagnola. Resisteal tempo, poco distante, lamedievale chiesa di S. Gio-vanni Battista: uno dei pi-lastri che dividono le duenavate absidate ha dei bu-chi lungo gli angoli, dovesi legavano, in attesa del-l’esecuzione, i detenuti con-dannati a morte.
Da Barùmini bastano 3 km perraggiungere Tuìli (m 208, ab.1221), ai piedi della Giara. Qui,a fine agosto, alla periferia delpaese, sotto il sole cocente,
85
vengono radunati i cavallini spinti a valle dal-l’altopiano per “sa marca”, il rito anacronisticoe crudele della marchiatura a fuoco che, seb-bene imponga non lievi sofferenze agli animali,viene ancora proposto come spettacolo turi-stico. Tuìli merita più interesse per l’architetturadi stile spagnolo coloniale della bianca chiesa diS. Antonio, avvolta nell’ampio muro di cinta, pergli eleganti edifici neoclassici, come la villa Pit-zalis, progettata da Gaetano Cima, e la villaAsquer; per la parrocchiale di S. Pietro, che si er-ge su un piazzale costellato di frammenti di
4.2 Le Giare e il Sarcidano
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

antiche mole e che conservaall’interno un retablo* delMaestro di Castelsardo, da-tato all’anno 1500 e restituitoallo splendore di un tempograzie a un intervento di re-stauro. Il paese, punto di par-tenza per escursioni guidateal Parco della Giara di Gesturi,si sta arricchendo di iniziativeturistiche e culturali, come ilrecupero di antiche strutture utilizzate per l’al-lestimento del Museo della Musica etnica e delMuseo delle Auto storiche.
GèsturiDa Barùmini si prosegue verso Gèsturi(m 310, ab. 1445), il paese che possiede lapiù ampia porzione della Giara. L’abitatoconserva ancora molto dell’architetturarurale e si raccoglie compatto attorno al-la parrocchiale di S. Teresa d’Avila (XVIsec.). Seguendo la via principale, dopola bianca facciata della chiesetta di S. Ma-ria Egiziaca (XVI sec.), si incontra il cartellogiallo per la Giara di Gèsturi**. La stra-da asfaltata per il pianoro s’inerpica tor-tuosa sino al ciglio basaltico dove prendeinizio, a un cancello di legno, una dellestrade bianche che attraversano l’alto-piano. A poca distanza si erge il protonu-raghe di Bruncu ’e Màdugui*, che dominadall’alto le colline della Marmilla. L’arcai-co monumento è considerato un impor-tante esempio dell’evoluzione del mega-litismo nell’isolaA una cinquantina di metri dal bastionemegalitico si estende, verso l’interno, unvasto agglomerato di capanne preistori-che. Dal cancello di legno la strada bian-
86
ca penetra nel pianoro tramirti, lentischi, fiorituredi cisti e profumo di eli-crisi e si inoltra verso l’ac-qua degli stagni, Paùli Oro-meo, Paùli Aba Mingiàu,dove non è difficile, nellabuona stagione, incontra-re i cavallini.
GenoniÈ il paese (m 447, ab. 1022) che vanta laproprietà del maggior numero di cavallinidella Giara. Appare dominato dal piccolopianoro di Santu Antine, con i resti di unafortezza punica sulla quale il primo cri-stianesimo ha eretto una cappella intito-lata ai santi Costantino e Elena.
LàconiSi prende per Làconi (m 550, ab. 2359), checome Genoni appartiene al Nuorese: è ilpaese delle statue-menhir, del parco mar-chionale, dell’oasi di Su Dominariu, doveuna volta allevavano mandrie di cavalli “ismilanesos”, i milanesi. Alle statue-menhir ilpaese ha dedicato il Museo archeologicocomunale*. I monoliti recano scolpiti dop-pi pugnali e misteriosi simboli antropo-morfi rovesciati, i cosiddetti “capovolti”. So-no gli affascinanti testimoni della lungaevoluzione delle pietre fitte. Alcune di essehanno trovato ospitalità sotto la casa mu-nicipale, di fronte al parco e alla monu-mentale villa dei marchesi Aymerich*, neo-classica, progettata da Gaetano Cima. Den-tro i confini di Làconi ci sono anche i ruderidel castello giudicale avvolti dal verde se-colare del parco.
4 Trexenta, Marmilla e Sarcidano: la Sardegna delle colline
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Si chiamano giare, in Sardegna, dei brevialtipiani isolati che si ergono con ripidepareti sul paesaggio circostante. Il piùfamoso è la Giara di Gèsturi, lunga 12chilometri, larga 4, alta fra i 500 e i 600 me-tri. Vasto terrazzo basaltico, arido e de-serto, è popolato dalla macchia medi-terranea da cui spuntano sughere con-torte dal tempo e dal vento. Qua e là deipiccoli specchi d’acqua offrono da berealla straordinaria popolazione della Gia-ra, i cavallini. Si chiamano così perché so-no di altezza modesta, poco più che po-nies, ma con tutta la bel-lezza, la resistenza e lanevrilità dei loro fratellimaggiori. Appartengono
a proprietari dei paesi circostanti, ma vi-vono tutto l’anno a pascolo brado, unitiin folti branchi: all’avvicinarsi dell’uomoscattano tutti insieme, la loro fuga è unapiccola sinfonia di rumori e di colori.Non si sa quanto siano antichi. Un temposi pensava che fossero selvatici da sem-pre. Oggi li si ritiene discendenti di ungruppo di cavalli che, abbandonati peruna delle tante vicende della storia sarda,si sarebbero rifugiati qui e si siano pro-gressivamente inselvatichiti. Piaccionoai cacciatori di frodo e qualcuno ne ven-
de la carne: ma la consa-pevolezza della loro im-portanza è ora semprepiù diffusa.
I cavallini della Giara

NurallaoDa Làconi si punta verso sud, in direzionedi Ìsili, e si incontra l’abitato di Nurallao (m390, ab. 1437), ben conosciuto per le sta-tue-menhir che, a circa 3 chilometri dalpaese, nell’area archeologica di Aiodda*,sono state rinvenute come materiale di riu-tilizzo in una tomba di giganti. La tomba harestituito frammenti ceramici, spilloni dirame o bronzo e «spesso riproponenti, in-cisi o in bassorilievo, i simbolici motivi del-le statue-menhir di Làconi».
ÌsiliSolo 8 km dividono Nurallao da Ìsili (m523, ab. 3156), importante centro del Sar-cidano che dentro l’abitato raccoglie ufficiamministrativi, piccole industrie, attivitàcommerciali e artigianali. Qui resistono gliultimi eredi di quell’antica arte del rame chela tradizione vuole di origine zingaresca eche ha radici nelle vecchie case del rione diCoroneddu. Ìsili offre anche il gusto e la buo-na fattura di tappeti, arazzi, coperte e bi-sacce impreziositi dai vecchi simboli ere-ditati dall’arcaico telaio in legno e canna epresenti anche nei preziosi lavori del legnointagliato. In paese sono da visitare la par-rocchiale di S. Saturnino (XIV sec.) e la chie-sa di S. Giuseppe Calasanzio (XV sec.) ma so-prattutto, alla periferia dell’abitato, vicinoal campo sportivo, il complesso nuragico diIs Paras*, trilobato, uno degli esempi piùperfetti e armonici di quell’architettura.Per far conoscere la tradizione dei ramai,ma anche delle tessitrici di Ìsili, è stato re-centemente aperto il Museo per l’Arte del ra-me e del tessuto*. Nell’ex convento di S. Giu-seppe, una costruzione seicentesca, sonoraccolti gli attrezzi e i prodotti dei ramai intutte le fogge e per tutti gli usi. Al piano su-periore sono esposti splendidi arazzi tes-
4.2 Le Giare e il Sarcidano
87
suti con disegni e metodi tradizionali, macon materiali inusuali.
La Giara di SerriUna giara più piccola, anch’essa nata da co-late di basalto di lontane eruzioni vulcani-che, è il petroso altopiano di Serri. Quinon ci sono cavallini e non sono molti gli al-beri che danno ombra ai pascoli, ma un ri-chiamo forte c’è ugualmente: il grande san-tuario nuragico di S. Vittoria*. Ci si arrivada Serri (m 617, ab. 781), lungo la stradinache sale al pianoro. I ruderi del santuario siritrovano assieme alla campestre chiesa diS. Vittoria, collegata alla settembrina sagradel ringraziamento per i frutti della terra.Un muro di cinta divide l’area sacra del tem-pio a pozzo da quella del recinto delle feste.Poco lontano sorgono le abitazioni dei cu-stodi del santuario e, in disparte, l’ampiacostruzione circolare per le riunioni ‘poli-tiche’, per le assemblee dei «prìncipi dellastagione delle aristocrazie nuragiche, dalsec. X al VI a.C.» (Giovanni Lilliu). La visitaal santuario nuragico può essere prece-duta da quella all’Antiquarium, nei giardinidel Comune, dove foto aeree e pannelli il-lustrativi permettono una maggiore com-prensione della grandiosità dell’insedia-mento di S. Vittoria.
Da Serri si può visitare Gergei (m 374, ab. 1505),che dista circa sei chilometri. È il paese dell’o-lio, prodotto e imbottigliato da due modernifrantoi, e della buona cucina. Ma Gergei, che ri-chiama interesse anche per non pochi e prege-voli dipinti sacri del XVI sec. custoditi nella coe-va parrocchiale di S. Vito, ha fama soprattuttoper un arcaico rito che si celebra il 3 febbraio,giorno di S. Biagio, quando i bambini portano inprocessione e in chiesa per la benedizione “susessineddu”, un grappolo di frutti legati assiemeda un’erba palustre, “su sèssini”.
4.3 Intorno al monte ArciItinerario lineare da Mògoro a Villaurbana, nell’Oristanese interno, km 60 senza le deviazioni(carta a pag. 81)
Da Mògoro (5 km dal bivio di PonteCracàxia, sulla Carlo Felice: 62 km da Ca-gliari, 32.4 da Oristano) si raggiunge Mor-gongiori (8 km) e, seguendo la statale 442,Àles (6.5 km; di qui, deviazione al monte Ar-ci). Al bivio di S. Lucia (18 km) si prende asinistra piegando a nord-ovest verso Mo-gorella, Villaurbana e Siamanna, in dire-zione di Oristano. È un percorso che con-sente una buona conoscenza di alta Mar-milla e Brabaxana. Sebbene non superi inaltezza gli 812 m con i rilievi più elevati di
Trèbina Longa, il monte Arci appare im-ponente e maestoso sulle basse collinedell’alta Marmilla e sulla piana solcata dal-l’asfalto della statale 131 di Carlo Felice. Eral’Eldorado del Neolitico, una fonte inesau-ribile di quell’‘oro nero’ che ha precedutola storia dei metalli. Con l’ossidiana si pro-ducevano, molto meglio che con la selce, la-me taglienti, punte di freccia, bulini, ra-schiatoi. Con un colpo secco su un nucleogià predisposto si staccavano lame per-fette e affilatissime, più taglienti di un ra-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

soio. In tutto il Mediterraneo la sua pre-senza è limitata a pochissime aree. La Sar-degna fu sicuramente una delle mete piùambite per la qualità e l’abbondanza deigiacimenti del monte Arci. Nel fitto dei bo-schi e lungo i corsi d’acqua si moltiplica-rono così, nell’arco di più millenni, centridi raccolta e officine litiche, dove le ossi-diane traslucide e opache venivano scheg-giate, lavorate, commer-ciate e portate anche interre lontane. Ne sonouna conferma le ossidia-ne sarde rinvenute in To-scana, Liguria, Provenza,Catalogna. In Corsica ilvetro vulcanico del mon-te Arci è stato raccolto,nella grotta sepolcrale diCuracchiagghiu, in unostrato che risalirebbe al6610 a.C. e, ancora, nel-l’abitato preistorico diBasi-Serra di Ferro, traceramiche di circa 7750anni or sono.
MògoroIl bivio della Carlo Feliceper Mògoro è vigilato adistanza dal rilievo del nuraghe di Cuccu-rada, al centro di una campagna di scaviche lo ha riportato alla luce nella sua im-ponenza, tanto da renderlo visibile anchedalla statale. Mògoro (m 132, ab. 4971) è ilcentro più attivo e popoloso dell’alta Mar-milla e si fregia del titolo di capitale del te-laio della tradizione. Tappeti e arazzi ven-gono ancora prodotti, nel centro pilota SuTrobaxu, all’ingresso del paese, con telai inlegno perfettamente ricostruiti sul model-lo di quelli tradizionali. Su di essi si perpe-tuano gusti, forme, colori di lontana ereditàcon figure stilizzate di liocorni, pavoncelle,colombe, upupe, tralci di vite, rose e garo-fani, danze e fontane. La tessitura si spe-cializza per ciascun tipo di lavoro: a “pi-bionis” per i tappeti, a “briabi” per tovagliee panni comuni, a “bagas” per gli arazzi,opere d’arte, quest’ultimi, impreziosite dal-l’oro e dall’argento dei broccati.Il momento più importante per le artigia-ne del telaio è la Fiera del Tappeto, che sitiene a Mògoro per due settimane tra luglioe agosto e vede raccolti assieme capola-vori di mezza Sardegna.Il paese si segnala anche per la baroccaparrocchiale di S. Bernardino e soprattut-to per la chiesa del Carmine (XIV sec.), tar-doromanica con elementi gotici.
88
MorgongioriSopra l’abitato (m 351, ab. 967), ai piedi d’u-na grande croce, si apre nella roccia unaprofonda fenditura che nasconde, nel buiopiù totale, due rampe di scale in pietrad’un tempio ipogeico d’età nuragica. È SaDomu ’e is Caombus, la ‘Casa dei colombi’,dove si praticavano misteriosi culti. Per vi-sitarla è necessario un regolare permesso
della Soprintendenza ar-cheologica di Cagliari eOristano. Dal paese,prendendo la stradaasfaltata per la pineta diIs Benas, si può compie-re una prima escursionetra i paesaggi del monteArci e vedere da vicinoSa Trèbina, un ciclopicotreppiede naturale for-mato da due torrioni ba-saltici. Prima di iniziarela salita, si può visitare ilCentro di Documentazio-ne ambientale per rac-cogliere informazioni sulParco naturale di MonteArci, visitare una mostrafotografica sugli aspettinaturalistici del territo-
rio, o usufruire dei servizi di guida per ilparco e i siti archeologici.
ÀlesAltri 6 km di curve, tutti in discesa, porta-no ad Àles (m 194, ab. 1691), capoluogo del-l’alta Marmilla, sede di una delle più anti-che diocesi della Sardegna e paese nataledi Antonio Gramsci (1891-1937), grandefigura politica e intellettuale precocemen-te stroncata da una lunga detenzione nel-le carceri fasciste. Sulle case del centro, ac-corpata al Palazzo vescovile, al Semina-rio e all’oratorio della Madonna del Rosa-rio, spicca imponente, con la grande cu-pola e le due torri campanarie, la Cattedralebarocca di Domenico Spotorno, costruitatra il 1683 e il 1688 sulle rovine del tempiopreesistente, travolto dal crollo del vecchiocampanile. Ricca di marmi e opere in legnointagliato, come il prezioso coro in noce del-la metà del ’600 di Ambrogio Ziquina e unCrocifisso trecentesco, la chiesa è cono-sciuta anche per il suo tesoro di ori e ar-genti sbalzati e cesellati, capolavori di abi-li artigiani dei sec. XV, XVI e XVII. Dalla cat-tedrale si diparte la strada principale delpaese, la via Umberto. Bisogna percorrer-la quasi tutta per giungere alla casa nataledi Antonio Gramsci, indicata da una lapide
4 Trexenta, Marmilla e Sarcidano: la Sardegna delle colline
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

in marmo incastonata sul muro esterno.Porta il suo nome anche la piazza in calcaree basalto con il sole di pietra dello sculto-re Giò Pomodoro. La si incontra entrandoin paese, sulla strada di Morgongiori.
Subito prima di entrare ad Àles venendo daMorgongiori, e prima di una collina divisa in duedall’asfalto, si svolta a sinistra per raggiungere,dopo 9 km di curve e d’asfalto, una delle zonepiù suggestive del monte Arci: il bosco di leccie la sorgente di Acqua Frida. Da qui nelle gior-nate terse si domina parte dell’Arborèa e tuttala piana di Oristano sino al mare.
PauPoco più di 3 km separano Àles da Pau,un paesino (m 315, ab. 367), che nascon-de tra il nuovo cemento piccole case inpietra provate dal tempo. Nella parte al-ta dell’abitato una strada sale verso ilmonte e porta al camping di S’Onnixeddu.Qui, ancora venti anni fa, una spessa col-tre di ossidiana nera lastricava il terrenoe dava un fascino particolare alla zona.Ora l’“antica fabbrica” è scomparsa, mabasta frugare con gli occhi tutt’intornoper scoprire infinite scaglie nere e lu-centi. L’ossidiana è dappertutto, è partedella natura vulcanica della montagna ea volte se ne scoprono anche rari fram-menti di un bel rosso mattone. A valle delcamping, dentro la pineta di Giuanni Cor-rias, grosse scaglie di vetro nero sonostate incastonate, per devozione di al-cuni fedeli, intorno al simulacro dellaMadonna nera d’Oropa.
Villa VerdeDa Pau si prosegue per Villa Verde (m 204,ab. 401), l’antico Bànari, che nel 1952 ha vo-luto prendere il nuovo nome dal verde del-la sua montagna. Un vasto patrimonio dilecci e roverelle avvolgeva il paese ancorain anni recenti, sino a un grande incendionell’estate del 1983. Ora di quel mare di al-beri non restano che radi frammenti e ri-mane la giovane lecceta che offre la suaombra ai ruderi megalitici del villaggiopreistorico di Brunch’e s’Omu*, vigilato dal-le torri di un nuraghe polilobato. Ci si ar-riva, dall’abitato, svoltando a sinistra e se-guendo lo stretto nastro d’asfalto che s’i-nerpica tortuoso sino alla fonte di Mitz’eMraxani. Qui si lascia la macchina e si pro-segue a piedi seguendo la strada biancache s’immette tra i resti di ciclopiche ca-panne, evidenziate in parte dagli scavi diun cantiere archeologico. L’insediamento
4.3 Da Àles a Villaurbana
89
nuragico, che nasconde più a valle ancheun pozzo sacro, semisepolto da materialedi crollo, colpisce per l’arcaicità delle strut-ture e per la sua vastità, circa tre ettari.
Al castello di MedusaAl bivio di Escovedu si svolta a sinistraverso Làconi. Al bivio di S. Lucia, dove se nestanno solitari, l’uno accanto all’altra, unnuraghe e una chiesetta campestre, si va asinistra per Asuni. All’interno dell’abitato siprende la strada asfaltata per il castello diMedusa. Dopo circa 4 km s’incontra sulla si-nistra una strada bianca. Si lascia la mac-china e si prosegue a piedi. Il paesaggio èaspro e tormentato, ma denso di storia eleggende. Questa è la terra di Brabaxana,dove si apre la porta della Barbagia, non acaso difesa e vigilata dall’antica fortezza, ri-dotta ormai a poche rovine. Per la leggen-da le vestigia sono dell’antico castello di reMedusa: un “castrum” il cui primo impian-to risale all’età romana, messo a protezio-ne della zona dalle incursioni barbaricine,poi utilizzato anche in periodo giudicale.Per visitarlo, il periodo migliore è all’iniziodella primavera, quando il sole è già tiepi-do e le acque torrentizie dell’Araxisi e delFlumineddu danno spettacolo scontran-dosi impetuose ai piedi del bianco torrionedi calcare silurico, alto circa 210 m. Dall’altoil panorama è, nello stesso tempo, superboe impressionante.
VillaurbanaIl paese (m 84, ab. 1847), su cui si arriva daAsuni per Mogorella, richiama particolareinteresse per l’elevato numero di nura-ghi, ben 58 su un territorio di 58 km2, e perle oasi di verde che conserva sul versan-te settentrionale del monte Arci. Con l’aiu-to di una buona guida (si può chiedere perquesto indicazioni in paese) meritano diessere visitati i boschi e le sorgenti diS’Utturu ’e su Cadru, di S’Arangiu Aresti, diIs Aruttas Santas, dove si fa ammirare unascultura lavica a fessurazione colonnare.Oggetto di richiamo sono anche il com-plesso nuragico polilobato di Craddaxus,con le capanne del villaggio e la tomba digiganti, e la grotticella funeraria preistoricadi Sa Conca ’e s’Òmini, che secondo unaleggenda è la prigione dove si custodiva ilsegreto delle ragazze madri che vi veni-vano sepolte vive per espiare la colpa di“sa pecca”, del peccato commesso.Da Villaurbana, per Simaxis, si può rapi-damente raggiungere Oristano.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Profilo della cittàTorri medievali, il campanile ottagono della Cattedrale, le cu-pole di chiese e palazzi rivestite di tegoli iridescenti e le al-tissime palme verticalizzano lo skyline orizzontale della città,conferendole un’ atmosfera andalusa orientaleggiante. Que-sto è il retaggio del medioevo, quando Oristano era la capitaledi un regno (il giudicato d’Arborèa) e gli ultimi giudici-re combattevano tenacemente con-tro le armate degli invasori catalano-aragonesi. Andare per le strade lastricate del centro, munite delle targhe viarie che ripetono i no-mi antichi delle rugas (vie), è un incamminarsi lungo il tempo perduto, dove la pietra,il mattone, il ferro battuto respirano ancora l’aura della città antica.Vi è un brevissimo giro di giorni in cui, ogni anno, l’oristanese si riscuote dal destino
silenzioso dei secoli e si anima di una passione che diresti ebbrezza della vita. È quan-do la domenica di quinquagesima e il successivo martedì, ultimo di Carnevale, si cor-re in sa ruga de Santa Maria, di fronte alla grande Cattedrale, la Sartiglia, una delle ulti-me corse equestri all’anello dell’intera Europa. Nell’immediato entroterra del golfo omonimo, al centro della costa di ponente della Sar-degna, Oristano (m 9, ab. 33 017; pianta a pag. 93) si estende all’estremità occidentaledi una vasta e piatta terrazza alluvionale, delimitata a nord dal fiume Tirso, a ovest dal-le dune litoranee e a sud dallo stagno di Santa Giusta.La caratterizzazione ‘lacustre’ di Oristano è già documentata nel VII sec. dallo scrittorebizantino Giorgio di Cipro che menziona lo stagno di Aristiane (Aristianes limine), men-tre sin dal sec. XII il nome della città è analizzato, con una falsa etimologia, come “AureumStagnum” e nel suo stemma è raffigurato un lembo di terra emergente da una laguna do-rata. In realtà il nome deriva dal prediale Aristianum, cioè dalla denominazione dei fon-di posseduti in quest’area, nel periodo romano, da un Aristius. L’entroterra del golfo diOristano, estremamente fertile e caratterizzato da stagni pescosi, risulta interessato inetà antica da tre formazioni urbane collegate da strade: Tharros sul capo S. Marco a nord,Neapolis a sud-est del capo Frasca e Òthoca presso l’odierna Santa Giusta.Intorno al sec. VI, al principio dell’età bizantina, risale la prima testimonianza del nuo-vo centro: una necropoli sorta intorno all’ecclesia di S. Maria Assunta, destinata a divenirenell’XI sec. la cattedrale cittadina. Un complesso di cause (interrimento dei porti, pira-
90
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
5 Oristano e il Sinis

Profilo della città
91
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
teria saracena, caduta demografica) portò al progressivo spopolamento di Tharros e diNeapolis, mentre Òthoca, ribattezzata Sancta Justa, perdeva importanza rispetto ad Ari-stiane, difesa dalle acque del mare e delle lagune. Nel 1070, con il trasferimento delle au-torità politiche e religiose da Tharros in Oristano, la città divenne capitale del giudica-to d’Arborèa e sede dell’arcivescovo arborense.Dalla fine del XIII sec. il nucleo della città medievale, detto Pottu, era circondato da unacortina muraria turrita che definiva un perimetro subcircolare, delimitato dalle odier-ne vie Mazzini, Solferino, Cagliari, Diego Contini e da piazza Roma. Le porte d’accessoalla città erano due: porta Manna (grande) a nord, aprentesi sul prospetto della torre diSan Cristoforo, nella piazza Roma, e porta Mari (del mare o della laguna), a sud-ovest,distrutta nel 1907, presso la scomparsa torre di S. Filippo in piazza Manno.Il castello, il palazzo giudicale, la Cattedrale con l’episcopio, la chiesa conventuale di S.Francesco e altri minori edifici chiesastici, un ospedale e la “ruga mercatorum” eranoconcentrati a ridosso della linea occidentale delle mura. Gravitante sul lato opposto del-le mura è la trecentesca chiesa di S. Chiara con l’annesso convento delle Clarisse. Ester-no al circuito murario risulta Su Brugu, il borgo, o meglio i borghi, i quartieri popolarisorti lungo le strade che si dipartono dalle porte cittadine: Pontixeddu (Ponticello), nel-la via Tirso, Congidargius (via Fìgoli), Maddalena (presso l’oratorio omonimo, piazza Ma-riano), None (via Aristana), S. Lazzaro (via Cagliari, via Gramsci).Dopo la dissoluzione degli altri giudicati sardi, avvenuta nel sec. XII, la città di Oristano,per sottrarsi all’interessata alleanza dei pisani, si appoggerà agli aragonesi, favorendo nel1323 la costituzione del Regnum Sardiniae et Corsicae, che lasciò indipendente il vasto epotente giudicato d’Arborèa.Alla metà del sec. XIV il grande sovrano arborense Mariano IV, e successivamente i figliUgone III ed Eleonora d’Arborèa, si trovarono costretti a schierare le proprie armate con-tro i catalano-aragonesi. La guerra, durata con alterne vicende oltre mezzo secolo, si con-cluse con la sconfitta degli Arborèa a Sanluri (1409). I tre secoli di dominio aragonese espagnolo furono la causa di un profondo declino delle sorti della città.Nel sec. XVIII (e ancora di più nel XIX) la città conosce uno sviluppo architettonico-ur-banistico notevole con la ricostruzione della Cattedrale (in forme barocche) e l’edifi-cazione delle chiese del Carmine e di S. Efisio (tardosettecentesche), di S. Francesco eS. Vincenzo (in forme neoclassiche). Il dinamico accrescimento attuale della città (cheha raddoppiato la popolazione nell’ultimo quarantennio) è legato alla costituzionedella quarta provincia sarda (1974).I nuovi quartieri (Città Giardino, S. Nicola, Torangius), caratterizzati prevalentementeda palazzine, vanno ribaltando il carattere originario della città, distesa sulla pianura,con vaste case di làdiris (mattoni di fango) circondate da alti muri di cinta da cui tra-boccano i rami fioriti del gelsomino e del glicine. Solamente gli altissimi palmizi che svet-tano tra le cupole iridescenti della Cattedrale e del palazzo Arcais conferiscono anco-ra alla città quel carattere orientaleggiante che colpì i primi viaggiatori in Sardegna.Il territorio pianeggiante intorno al capo-luogo è detto Campidano di Oristano, o,con un nome moderno, Arborèa. Recen-temente si sono spostate le lancette dellapresenza dell’uomo nell’Oristanese finoal VII millennio a.C. Gli uomini del Neoliticoe dell’Eneolitico (V-III millennio a.C.) po-polarono ogni lembo del territorio, depo-nendo i loro morti nelle fosse o nelle do-mus de janas di Cabras e di San Vero Milis.Fra 2500 e 1800 a.C. sorsero i primi nuraghi.Ma dopo l’età dei fenici e dei cartaginesi eil dominio romano e vandalico, con il pe-riodo bizantino l’insicurezza dei mari por-terà a un progressivo spopolamento deiterritori costieri, di Tharros e del Sinis inparticolare. L’affermazione di Aristianequale capitale del giudicato d’Arborèa nonporterà alla ripresa antropica del Sinis,che ancora oggi appare un deserto umano.

Dalla piazza Manno ci si dirige lungo le vieVittorio Emanuele e Duomo, su cui pro-spettano la Cattedrale e la chiesa di S.Francesco. Da qui si fa ingresso nella piaz-za Eleonora. Si devia a sinistra in corsoUmberto (via Dritta), percorrendolo sino
alla piazza Ro-ma, dominatadalla torre diMariano II.Da questapiazza si im-bocca la viaParpaglia conla cinquecen-tesca casa diEleonora e l’ot-tocentesco pa-lazzo Parpa-glia sede del-l’Antiquariumarborense. La-sciato il mu-seo, si prende
a sinistra la via S. Chiara con il trecentescoconvento e chiesa delle Clarisse, sino al-l’incrocio con la via Garibaldi. Si segue adestra la via Garibaldi sino allo sbocco a si-nistra nella via Mazzini dominata dal tor-rione spagnolo di Portixedda. Si retrocedenella via Garibaldi fino alla via La Marmo-ra (a sinistra) seguendola sino al bivio a si-nistra per via del Carmine, con la chiesa e
92
5.1 OristanoItinerario urbano, pedonale, di circa 2 km (pianta della città a pag. 93)
«La Sartiglia - ha scritto Peppetto Pau, il più stimato studioso della storia della sua città- è quanto di più genuino rimane agli oristanesi dell’era giudicale. Essa è il perpetuarsidei tornei e delle giostre che qui si celebravano fin da quando Oristano era capoluogodel più felice ‘giudicato’ isolano».Una giostra medievale, dunque, che ha assunto sin dalle origini, forse, la sua aria spa-gnolesca che si esprime nei colori dei costumi e negli stessi nomi dei protagonisti. Acominciare da su Cumponidori, che è il capo della corsa: indossa il costume degli agri-coltori (è infatti il gremio, cioè la corporazione, degli Agricoltori e quella dei Falegnamia curarne la complessa organizzazione), ma ha il capo avvolto da numerosi fazzolettidi seta che gli fissano sul viso una maschera cerea, misteriosamente androgina; intornoalla testa una mantiglia, che culmina in un cilindro nero assai poco medievale. In ma-no tiene un mazzetto di fiori campestri, detto sa pippìa de maju, la bambola (o la bam-bina?) di maggio, col quale saluterà gli spettatori. Anche il nome Sartiglia pone i suoiproblemi: lo si ricollega a una parola spagnola che metterebbe insieme tanto la cor-sa agli anelli quanto l’aspettativa della fortuna che le si lega. Al comando de su Cum-ponidori una muta di cavalieri si sfida, l’ultima domenica e l’ultimo martedì di Car-nevale, a una sequenza di galoppate in cui vince (e porta fortuna) il cavaliere che colsuo stocco infilerà più stelle, appese in alto sulle teste della folla festante.
La Sartiglia
il convento rococò dei Carmelitani. Daqui, lungo via Francesco Crispi, si risale indirezione di piazza Manno.
S. Maria Assunta (B1). La Cattedrale è ilfrutto di una ricostruzione (architetto Gio-vanni Battista Arieti di Alghero) in formebarocche del 1721-33 della struttura goti-ca del primo venticinquennio del sec. XIII.L’alto campanile ottagonale è assegnato alsec. XV, ad eccezione della cella campa-naria e dell’iridescente cupola a corona im-periale, del XVIII.L’interno a croce latina presenta una navataunica con transetto terminato alle testateda cappelloni neoclassici. Il presbiterio so-praelevato è ornato da tele di GiovanniMarghinotti (sec. XIX) e, al centro, da una te-la ovale con l’Assunta di Vittorio AmedeoRapous (sec. XVIII). Notevoli (1a cappella adestra) una statua lignea policroma del-l’Annunciata di Nino Pisano (sec. XIV) e dueframmenti di amboni romanici della pri-ma metà del sec. XII con Daniele nella fossadei leoni e Due leoni che abbattono due cer-biatti. Nel sec. XIV i marmi furono riusati co-me predella di ancona, e scolpiti con scenebibliche e di santi da un artista barcello-nese. Nel transetto destro si apre la goticacappella del Rimedio (sec. XIV), con volta acrociera gemmata; sulla parete destra è l’i-scrizione funeraria del canonico giurista Fi-lippo Mameli che reca la data 1349.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Nel sagrato della Cattedrale si conserva, in unambiente ipogeo, la scalinata d’accesso al Duo-mo romanico e gotico e alcune tombe a casso-ne bizantine del VI secolo, del tutto simili aquelle di Karales e Cartagine, riferibili alla pri-ma area cimiteriale dell’Aristiane bizantina.
S. Francesco (B1). La chiesa, neoclassica,con pronao ionico e aula a impianto cen-trale cupolato, venne realizzata dal ca-gliaritano Gaetano Cima (1840), dopo la di-struzione del tempio gotico del 1250 circa;di questo residuano resti del prospetto, in-corporati nell’attiguo Distretto militare.All’interno è collocato, sull’altare a sini-stra, il Cristo crocifisso**, detto di Nico-demo, massima espressione della scultu-ra lignea di ambiente catalano del sec. XVpresente in Sardegna.Lo splendido chiostro* gotico della metàdel XIII secolo, riformato secondo il gustocatalano nel XVI secolo, è in corso di re-stauro ad opera della Soprintendenza aiBeni architettonici. Ne è prevista la tra-sformazione in centro culturale.
Piazza Eleonora (B1). Vi sorge il monu-mento marmoreo alla giudicessa Eleonorad’Arborèa eseguito nel 1881 da Ulisse Cam-bi. Sulla sinistra è il Palazzo comunale,già neoclassico convento degli Scolopi.
93
Piazza Roma (A1). La piazza, di forma ir-regolarmente trapezoidale, si sviluppa al-l’esterno della cinta muraria medievale, dicui sussiste la massiccia torre di S. Cri-stoforo, o torre di Mariano II (1290). Apianta quadrilatera, la torre, costruita inblocchi di arenaria, costituiva l’ingressoprincipale della città, attraverso l’ogivaleporta Manna, inquadrata entro un fornicea tutto sesto. Alla sommità si eleva una cu-riosa torretta campanaria del sec. XV.
La torre è detta anche di San Cristoforo poichéal suo interno venne inserito un retablo delsanto, protettore dei viandanti, forse sin dal xvsecolo. L’ incasso per accogliere il piccolo re-tablo, rimesso in luce nei recenti accurati re-stauri, è visibile alla destra di chi entri attra-verso la porta gotica.
Antiquarium arborense* (B1). Il museo diOristano fu costituito nel 1938 con l’ac-quisto della raccolta archeologica di EfisioPischedda.La collezione, allocata nell’ottocentescopalazzo Parpaglia, comprende utensili inossidiana e vasellame dai centri preistoricidel Sinis, una ricca serie di vasi votivi(sec. XII-X a.C.) dal nuraghe Sianeddu di Ca-bras, alcuni bronzi nuragici e il più ampio
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

5 Oristano e il Sinis
94
S. Chiara (B2). Eretta intorno al 1343, si pre-senta con un sobrio prospetto in conci diarenaria, arricchito da due monofore cie-che e da un rosone. L’interno, fatto ogget-to di restauro, mostra l’originaria cappel-la presbiteriale con volta a crociera e bifo-ra inquadrata da un arco acuto sul fondo.A sinistra l’epitafio di Costanza di Saluzzo(1348), nonna di Eleonora d’Arborèa.
Torrione di Portixedda (B2). Su un basa-mento tronco-conico, in conci di arenaria,si innalza un corpo cilindrico provvisto ditre saettiere. Scavi eseguiti nel 1992 hannoconsentito di datare la fortificazione alperiodo spagnolo (seconda metà del xvsec.) e di individuare una preesistentetorre quadrata giudicale.
Nostra Signora del Carmine (B1). È la piùleggiadra architettura rococò della Sarde-gna. Dovuta alla munificenza del primomarchese d’Arcais (1785), la chiesa, pro-gettata da Giuseppe Viana, mostra il doratoprospetto di arenaria, scandito da parasteioniche e da un finestrone a rene che sor-monta lo stemma gentilizio degli Arcais.
5.2 Il Campidano di OristanoDue percorsi circolari (km 62 e km 70), con Tharros e S. Giusta come fulcri (carta a pag. 95)
Un primo tratto dell’itinerario da Oristanoraggiunge verso nord il Rimedio (km 2): daqui si segue la provinciale 1 fino al km2.370, quindi a destra la provinciale 3 finoa Cabras (km 1); lambendo le lagune, lun-go le provinciali 4 e 6 si arriva a San Gio-vanni di Sinis (km 12) e a Tharros, l’anticacittà fenicia. Da questa località si retroce-de sino al bivio a sinistra per S. Salvatoredi Sinis (km 5.5), da cui si procede sullaprovinciale 7 per 8 km, sino al bivio a si-nistra della provinciale 66 per Putzu Idu(km 7), fiancheggiando la salina dei feni-cotteri. Da qui si può compiere l’escur-sione marittima fino all’isola di Mal di Ven-tre, per secoli covo dei pirati. Si ritorna aPutzu Idu e percorrendo la provinciale 10per 9.5 km si arriva all’innesto con la sta-tale 292, che si segue in direzione di Riolae Nurachi fino alla Beata Vergine del Ri-medio (km 11); e da qui lungo la provin-ciale 1 si è in breve a Oristano. Nel secondo tratto, dal capoluogo si rag-giunge (in 1 km) Santa Giusta, centro di ori-gine fenicia; all’uscita dell’abitato si se-gue la provinciale 49 per Arborèa (km 12)e successivamente la stessa per 2 km,prendendo il bivio a destra per la provin-
ciale 69 e seguendola sino al km 2, de-viando quindi a destra sino a Marceddì(km 7.5), borgata di pescatori. Da questalocalità si retrocede sino alla biforcazionedella provinciale 49, da cui si prosegueverso Terralba (km 6), innestandosi nellastatale 126, e seguendola, per 6 km attra-verso Marrubiu, fino all’inserzione dellaCarlo Felice, all’altezza del km 76.200. Siprocede lungo la statale 131 in direzionenord (con la deviazione a destra al km77.600 per Is Bangius), per 10 km fino allosvincolo di Santa Giusta, da cui si procede(km 5) sulla provinciale per Oristano.
CabrasSulle sponde della vasta laguna omoni-ma, l’abitato (m 6, ab 8966), di origine me-dievale («masone de Capras» in un docu-mento del XII sec.) possedeva un castellodei signori d’Arborèa, di cui sussistonoscarse strutture in laterizio sul bordo del-la laguna, dietro la cinque-seicentesca par-rocchiale di S. Maria. Nel 1997 è stato inaugurato il Museo civicodi Cabras, robusta struttura quadrilatera inrossa trachite eretta sull’ orlo dello stagnonella via Tharros. Vi è disposta con aggior-
complesso di corredi funerari delle tombefenicie e puniche di Tharros, tra cui unamaschera ghignante in terracotta. Chiu-dono l’esposizione numerosissime cera-miche e vetri di epoca romana, da Tharrose da varie parti del Sinis.In una sala del museo sono esposte due ta-vole di un trittico con storie di S. Martino(inizi sec. XV) e vari scomparti di un’an-cona con santi francescani di Pietro Càva-ro (1533), conservata in S. Francesco.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

nati criteri museografici un’ampia raccoltadi reperti dai villaggi neolitici ed eneoliticidel territorio (in particolare da Cuccuruis Arrius), da nuraghi e da villaggi nuragicidel Sinis e soprattutto dalla città di Tharros,di cui è ricostruito uno spaccato del tophetcon urne cinerarie, stele e cippi. Lo stagnodi Cabras* in carte duecentesche è deno-minato Maris (Mar’ ’e Pontis, a indicarne lagrande estensione, circa 2000 ettari, e l’im-portanza del ponte romano che consentivai collegamenti fra le importanti città diTharros e Òthoca).
I sistemi arcaici di pesca at-tuati su barche di giunco («fas-sonis») erano inquadrabili nelregime feudale d’uso della la-guna, di proprietà privata sinoagli anni settanta del Nove-cento. Questi sistemi hannolasciato il posto, con il pas-saggio del compendio laguna-re al demanio regionale, a piùaggiornate modalità di itticol-tura non sempre redditizie ri-spetto al passato. L’ecosiste-ma lagunare che comprende,oltre alla laguna di Pontis, glistagni di Sa Màrdini (con lasettecentesca peschiera) e diMistras offre uno straordinariohabitat e varie specie di avi-fauna stanziale e migratoria:numerosi, e purtuttavia unici,gli aggraziati fenicotteri.
San Giovanni di SinisDa Cabras lungo la provin-ciale si giunge al villaggiobalneare di San Giovannidi Sinis (m 7), costituito,
95
5.2 Cabras e il Sinis
in origine, attorno alla cattedrale del ve-scovo tharrense, intitolata a S. GiovanniBattista. La chiesa sorse intorno al VI sec.,con schema a croce greca e corpo cupo-lato centrale, che traeva ispirazione dalmodello cagliaritano di S. Saturno. Nel IX-X sec. la cattedrale venne ampliata am-morsando al nucleo originario un avan-corpo a tre navate, mutando la pianta incroce latina.A sud, oltre San Giovanni, fra dune di sab-bia coronate da falasco e qualche super-stite esempio delle tradizionali “barracas”
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

dei pescatori, intelaiate in tronchi con pa-reti e spioventi in canne e fascine, si giun-ge all’area archeologica di Tharros.
Tharros**Tharros (pianta a fronte) è una città bi-mare, come Corinto. I fenici prediligevanole penisolette affusolate per fondarvi le lo-ro colonie. Infatti questi promontori con-sentivano alle navi di collocarsi a riparodei marosi in una delle due rade, qualun-que fosse la direzione del vento. I fenici co-stituirono la città intorno al 730-700 a.C. es-senzialmente come scalo commerciale.Nei sec. VII e VI il raggio d’azione dei mer-canti di Tharros è vastissimo, andandoda Cipro all’Egitto, dalla Ionia all’Etruria,dalla Spagna al mondo celtico. La con-quista della Sardegna a opera di Cartagine(510 a.C.) non influenzò il predominio ma-rittimo di Tharros. L’avvento del dominioromano (238 a.C.) segnò invece un’inver-sione nelle fortune dell’antica città: il nuo-vo orientamento dei traffici commerciali,diretti a Roma, ne determinò la decaden-za dal 77 a.C. Durante il periodo imperia-
96
Una convenzione internazionale li haiscritti fra le zone umide più importantidel mondo: gli stagni dell’Oristanese siestendono su una superficie complessivadi 6 mila ettari. Il più famoso è lo stagnodi Cabras, 2 mila ettari. È - come scrivo-no geografi e biologi – l’ambiente palustrepiù importante della Sardegna e uno deiprincipali d’Europa.In comunicazione col mare, non soloospita molte specie di uccelli acquatici (ilfistione turco vi ha la sede più intensa-mente nidificata d’Italia; e insieme anatreselvatiche, il tarabuso, l’airone rosso –nella foto in alto – la folaga, il pollo sul-tano), ma è anche densamente popolato
di pesci, in par-ticolare spigole,anguille e so-prattutto mug-gini. Già dal me-dioevo esiste-vano qui dellepeschiere che,perfezionate coltempo, arriva-vano a riforniredi pesce (nellafoto in basso, la barca detta “fassoni”)gran parte dei paesi della Sardegna in-terna: in molte zone dell’isola il muggineè ancora chiamato ‘pesce di Oristano’. Ilmuggine è anche centrale nella gastro-nomia dell’Oristanese, cui fornisce lamerca (che è lo stesso pesce bollito inuna forte salamoia) e più ancora la bot-targa, derivata dalle sue uova, ricercatacome profumatissimo condimento.Lo stagno di Mistras, nell’area dell’anticaTharros, è il regno dei gabbiani e dei fe-nicotteri. Quello di Sale Porcus, versoPutzu Idu, è “oasi permanente di prote-zione faunistica”; nello stagno di Is Benassi pesca il caniottu, un’orata di piccola ta-glia e grande profumo.
5 Oristano e il Sinis
Gli stagni di Oristano
le la città, elevata probabilmente al rangodi colonia onoraria, riebbe il suo ruologuida di centro del commercio interna-zionale. Le prime comunità cristiane, suc-cedute forse a un nucleo giudaico, ap-paiono documentate dal IV sec., mentreun’organizzazione vescovile è attestatadal VI secolo.L’insicurezza dei mari in età bizantinaportò alla riduzione della città in un ca-strum mentre la popolazione civile do-vette costituire il nuovo centro di Sines,presso la chiesa di S. Giovanni di Sinis.L’imperversare delle flottiglie saraceneportò a un progressivo decremento dellapopolazione, sino all’abbandono di Thar-ros-Sines nel 1070, a favore della non di-stante città di Oristano.La visita dell’area archeologica prende lemosse dal piccolo locale, all’ingresso de-gli scavi, in cui sono esposte la pianta ge-nerale della città, le planimetrie degli edi-fici principali e la documentazione foto-grafica di manufatti fenicio-punici resti-tuiti dalle campagne di scavi attivate nel-l’area urbana a partire dal 1956. La città si
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

5.2 L’area archeologica di Tharros
97
strada principale, che mette in comuni-cazione i quartieri meridionali con il pia-noro di Muru Mannu. La via, che presentaal centro le fognature (oggi ricoperte da untavolato), disimpegnava, sui due lati, sta-bilimenti artigianali, negozi e diversi localidi ristoro (tabernae, cauponae; 2).Alla sommità del pianoro la vista guadagnaa nord l’intera regione del Sinis. Si prose-gue verso un’arena subcircolare delimitatada un terrapieno, cinto da una strutturamuraria composita, e destinato a riceverele gradinate in legno: in questo spazio si ri-conosce il modestissimo anfiteatro di Thar-ros (sec. II-III d.C.), dislocato in periferia, for-se per evitare pericoli alla comunità, in ca-
rivela, sostanzialmente, nel suo aspettotardoromano (sec. III-IV d.C.), benché nonmanchino testimonianze cartaginesi e al-tomedievali.Lasciato il locale espositivo si prende a de-stra la strada lastricata in basalto, per-correndola fino a una piazzetta (compi-tum), che ospitava un’edicola consacrata,probabilmente, alle divinità che proteg-gevano i crocicchi, i Lares compitales. Sullato nord prospetta un ampio edificio qua-drangolare (1): si tratta di un cisternone odel castellum aquae, serbatoio conclusivodell’acquedotto (sec. II-III d.C.) che ali-mentava una fontana pubblica.Dalla piazzetta si risale, a nord, lungo la
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

so di fuga delle bestie feroci utilizzate nel-le “venationes”. L’arena di Tharros occu-pa parzialmente l’area del tophet (3), ilsantuario proprio delle città fenicio-pu-niche, destinato ad accogliere le urne ci-nerarie dei bambini nati morti o defunti intenera età, consacrati al dio Baal e, dal vsec. a.C., anche alla dea fenicia Tanìt. Iltophet di Tharros, in uso tra il sec. VIII e ilII a.C., venne impiantato sulle rovine diun villaggio nuragico costituito da capan-ne circolari (sec. XV-XIV a.C.).Oltre il tophet si individuano le fortifica-zioni settentrionali della città (4). Scavihanno messo in luce i resti delle muracon torri quadrate, in blocchi regolari diarenaria, della cinta cartaginese (fine sec.VI a.C.), cancellate da una cortina murariain blocchi poligonali di basalto, dotata didue postierle, in età romana repubblicana(sec. II a.C.). Coevo a queste mura romaneè il fossato con il terrapieno provvisto dimuro di controscarpa in tecnica poligo-nale, che, colmato nel sec. I a.C. fu adibitoentro il sec. I d.C. ad area cimiteriale.Si ripercorre a ritroso la strada dall’anfi-teatro fino al compitum, mentre la vistaspazia, verso sud, sull’erto promontorio diSan Marco, che chiude la penisoletta del Si-nis, e, oltre il braccio di mare del golfo diOristano, sul lungo promontorio della Fra-sca, sopra il quale si stagliano i monti az-zurri dell’Arcuentu e del Linas.Si discende, dal compitum, a sinistra ver-so il golfo. Lungo la strada lastricata, a si-nistra, emerge il grande complesso (nondel tutto scavato) delle terme III, mentre adestra si individuano i resti del tempiocartaginese delle semicolonne doriche (5),intagliato in parte nell’arenaria, databile alprincipio del sec. III a.C.La strada si arresta di fronte alle terme I (6)del sec. II d.C., riutilizzate dai cristiani nelv sec. per costituire una basilica con bat-tistero (7) a vasca esagonale. Quest’ultimoè visibile a nord delle terme. Dalle terme Ia destra si raggiunge un edificio con duecolonne rialzate e restaurate. Si tratta,probabilmente, di un tempio a quattro co-lonne, di ordine corinzio, che risale al 50a.C. circa.Seguendo la strada si giunge in un piazzaletrapezoidale che conserva il lastricatoesclusivamente nel settore destro: il Forodi Tharros, la piazza degli affari su cuigravitavano gli edifici pubblici principali.Il lato sud-est della piazza era delimitatodal portico di accesso alle terme II, detteanche terme del Foro (8), del 200 d.C. La-sciate alle spalle le terme II, si risale lungo
5 Oristano e il Sinis
98
la strada a sinistra, tra isolati di modesteabitazioni, per ritornare al compitum e, daqui, all’uscita degli scavi.All’esterno dell’area recintata, sul pendiooccidentale del colle di Torre di San Gio-vanni, si osservano resti di una cinta mu-raria tardoantica o altomedievale (forse ilkastron menzionato da Giorgio di Cipro),costruita riutilizzando i blocchi squadra-ti e le merlature a coronamento arcuatodella cortina muraria cartaginese del IVsecolo prima di Cristo.
San Salvatore Si retrocede lungo la provinciale sino al bi-vio a sinistra per San Salvatore (m 6), unvillaggio religioso sorto nel XVII-XVIII sec. at-torno alla chiesa omonima (per l’accessochiedere l’autorizzazione alla Soprinten-denza archeologica di Cagliari). All’inter-no dell’edificio una scala reca a un san-tuario ipogeico* pagano parzialmentescavato nella roccia e in gran parte co-struito (300 d.C. circa). Vi si praticava ilculto salutifero delle acque da parte degliadepti di una corporazione a carattere re-ligioso. Sugli intonaci figurazioni di divi-nità del pantheon romano (Ercole, Venere,Marte, Eros, una Musa), corse di carri,scene gladiatorie e immagini di navi, ri-prendono la simbologia della lotta che ladivinità conduce contro il male. Né pareslegata dal culto di salvezza la dedica del-la chiesa al Salvatore.Di qui si procede verso Putzu Idu, lungo lapiana del Sinis, fra le colline di basaltocostellate di nuraghi a sinistra e la lagunadi Cabras a destra.Imboccata la provinciale 66 a sinistra, do-po 3 km appare a destra l’abbacinante sa-lina di Sale Porcus, habitat della “zent’ar-rubia”, i fenicotteri.
Isola di Mal di VentreDa Putzu Idu, durante la stagione estivapartono le escursioni verso la suggestivaisola di Mal di Ventre, situata a 4.5 miglianautiche dalla costa.L’isola è un affioramento lungo 2 km su unmare di smeraldo, di graniti paleozoicicoronati da lentischio e assenzio e regnodi conigli, testuggini e rettili. Un nuraghelitoraneo, presso la cala dei Pastori, cera-mica fenicia dell’VIII secolo a.C., una strut-tura romana con elementi architettonici inarenaria e un modesto insediamento di etàbizantina, forse di carattere monastico,da cui proviene una lucerna con il mono-gramma di Cristo del VI secolo, segnalanola storia antica di questo breve territorio
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

insulare, che poteva ricadere nella sferad’influenza di Tharros. Da Putzu Idu, lungo la verde piana campi-danese, si rientra a Oristano per la se-conda parte dell’itinerario.
Santa GiustaIl centro (m 10, ab.4278), localizzato su unaterrazza alluvionale compresa tra la lagu-na omonima e lo stagno di Palmas, corri-sponde alla città fenicia di Òthoca (in se-mitico “la [città] vecchia”). Il nome odier-no è attestato a partire dal XII sec. in rela-zione al culto di una martire locale.Òthoca venne fondata dai fenici intorno al730 a.C. per usufruire tanto delle risorsecerealicole e di allevamento del Campi-
dano quanto della provvida ricchezza it-tica offerta dalla laguna. Gli scavi (1861-1866; 1910; dal 1984 sono in corso) hannorivelato resti della cinta muraria fenicia sulcolle della Cattedrale, tracce dell’abitato(quartiere attuale di Is Olionis) e, soprat-tutto, la necropoli di cui è visitabile pres-so la chiesa di S. Severa una tomba feniciaa camera costruita in blocchi di arenaria,utilizzata fino al sec. I a.C. I materiali degliscavi saranno esposti nel Museo di Òthoca,in allestimento. A epoca romana appar-tengono il ponte a cinque arcate (di cui so-lo due superstiti) che valica il rio Palmas
5.2 Dal Sinis a Santa Giusta
99
e un tratto della strada lastricata che col-legava Òthoca con Kàrales, ossia Cagliari.Sul poggio più elevato dell’area, all’in-gresso da nord, sede della acropoli antica,si innalza la cattedrale di S. Giusta*, in sti-le romanico, eretta nel 1135-45 da mae-stranze di educazione pisana, che utiliz-zarono la dorata arenaria del Sinis ravvi-vata da qualche sobrio inserto di marmocandido e di ferrigno basalto. Il prospettoè scandito da tre arcate che inquadrano ilportale, definito da pilastri con capitellizoomorfi, e da una trifora. Il colmo deltimpano è guarnito dal motivo del rombogradonato, di schietta ascendenza pisana.I fianchi sono ritmati superiormente da ar-catelle impostate, con alternanza, da men-
sole e da lesene. L’abside,solenne, è guarnita da se-micolonne.L’interno, profondamenteaustero, è suddiviso in trenavate da colonne in mar-mo e granito con capitelli ebasi prevalentemente dispoglio forse da edifici ro-mani di Òthoca. Il presbi-terio si innalza su una crip-ta di modello lombardo. A sud di S. Giusta, lungo lavia Giovanni XXIII, meritauna breve sosta la chiesa diS. Severa, caratterizzata daun bel prospetto in conci diarenaria, riportabile al XIVsecolo.
Verso ArborèaLasciata Santa Giusta, si su-pera il rio Palmas, lascian-do a destra il ponte e lastrada romana e si imboccala provinciale per Arborèa,con a destra la laguna di S.Giusta e a sinistra la PaùliTabentis, che talvolta ospi-
ta colonie di fenicotteri e altre specie del-l’avifauna, tra tamerici e cisti. La strada at-traversa il territorio di Cirras, di recenterimboschimento con lunghi filari di eu-calyptus, sino allo stagno di S’Ena Arrubia,dominato a sinistra dalla monumentaleidrovora di Sassu (1934) realizzata con lamagniloquenza dell’epoca in funzione delprosciugamento del vasto stagno di Sassu,a compimento della bonifica integrale del-la piana acquitrinosa che si stendeva traS’Ena Arrubia e lo stagno di Marceddì(1922-35).La spiaggia arenosa e bassa è guarnita da
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

una vasta pineta in cui si sono ambienta-te le specie della macchia mediterranea: ci-sto, lentisco, filliree, ginepri.Dopo alcune curve la provinciale assumeun rigoroso andamento rettilineo nord-sud, affiancato dai centri rurali di Sassu edi s’Ungroni, che richiamano ricordi e sa-pori romagnoli e veneti mediati dai nu-clei originari dei coloni.Superata la rigogliosa pineta Barany (asinistra), si giunge ad Arborèa, consideratala migliore esperienza urbanistica sardadel movimento architettonico del razio-nalismo tra le due guerre.
ArborèaLa cittadina (m 7, ab. 3943), fondata col no-me di Mussolinia di Sardegna nel 1928, siraccoglie intorno alla fiorita piazza S. Ma-ria Ausiliatrice dominata dalla chiesa par-rocchiale neogotica. Sul lato opposto sieleva il Palazzo comunale, caratterizzatodal gusto liberty tardivo che aveva as-sunto schemi e ornati medievali e rina-scimentali: al suo interno è esposta l’in-teressante Collezione civica archeologicacon reperti punici, romani e altomedie-vali derivati da necropoli del territorio.Unico nell’isola è un askòs* (vaso-otre) abusto di fanciulla, del sec. II a.C.
Oltre Arborèa una strada a destra conduce aMarceddì (m 1), villaggio di pescatori sullesponde della laguna omonima. La chiesa dellaVergine di Bonaria e la torre Vecchia, cinque-centesca (di difesa costiera), sono le testimo-nianze architettoniche di rilievo.Fa contrasto a sud il maestoso scenario di mon-ti azzurri e violetti, sino al pizzo dell’Arcuentu,dominato da un castello medievale dei giudicid’Arborèa, e il verdissimo altopiano della Fra-sca che chiude il golfo di Oristano. Lo stagno di
100
Marceddì (dal nome di un personaggio romano,Marcellinus) costituiva il “portus Neapolita-nus”, così detto dalla scomparsa città di Nea-polis, sulla riva opposta.
TerralbaAlla biforcazione della provinciale 49 siraggiunge Terralba (m 9, ab. 10 644), di ori-gine cartaginese, poi romana, sede epi-scopale tra il XII sec. e il 1503. Nel 1144 ven-ne compiuta la chiesa di S. Pietro, dallestesse maestranze di S. Giusta. Demolita inepoca imprecisata, fu ricostruita in for-me tardobarocche nel 1822.
Verso OristanoDa Terralba, lungo la statale 126, si transitanell’abitato di Marrubiu (m 7, ab. 5055), ‘vil-la nueva’ del sec. XVII, con una bella Par-rocchiale seicentesca dedicata alla BeataVergine, raggiungendo l’innesto con la su-perstrada Carlo Felice, lungo la quale si vain direzione di Oristano. La statale attra-versa il Campo S. Anna, sede di un vastis-simo bosco di lecci, roverelle e sughere, re-gno incontrastato di cervi e cinghiali finoagli inizi dell’Ottocento.Al km 77.6 è segnalata la deviazione a de-stra per is Bangius (km 1), dove gli scavihanno messo in luce un “praetorium”, conterme del sec. II d.C., utilizzato come resi-denza dal governatore della Sardegna du-rante i suoi spostamenti verso il centromontano dell’isola. Secondo la targa mar-morea del III sec. che vi è stata ritrovata,venne edificato lungo la strada secondariache permetteva il rapido collegamentocon Forum Traiani (Fordongiànus), sede diun distaccamento militare per il controllodelle “civitates Barbariae”, le popolazioniindigene della Barbàgia.
5 Oristano e il Sinis
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

6 Nelle terre d’Arborèa
101
Profilo dell’areaL’ampia area della Sardegna centro-occidentale che si esten-de dal Campidano di Oristano fino alla Planargia deve il suoaspetto all’intensa attività eruttiva di un vulcano, dai nu-merosi crateri, che ha prodotto il vasto complesso del mon-te Ferru (m 1050). Le colate trachitiche e basaltiche del vul-cano hanno caratterizzato gran parte del territorio giungendo, da un lato, tumultuosefino all’attuale pianura e al mare, e formando così un paesaggio aspro e dirupato, dal-l’altro, verso oriente, spandendo-si fino a creare l’ampia distesadell’altopiano di Abbasanta, ora ri-coperto di sughere, olivastri e len-tischi. Ai margini dell’altopianoscorre il Tirso: la valle del fiumepiù importante dell’isola fu, nel-l’antichità, fra le principali vie dipenetrazione culturale e com-merciale verso l’entroterra mon-tano. Causa a valle di rovinoseinondazioni, le sue piene sono oracontenute dal lago Omodeo, rea-lizzato fra 1918 e 1924. Costa, montagna, altopiano esponde del fiume conobbero sinodalla preistoria l’insediamentoumano che qui raggiunse, in etànuragica, espressioni di alto li-vello come nel caso del nuragheLosa di Abbasanta, o del pozzodi S. Cristina di Paulilàtino. In etàstorica il territorio ebbe due cen-tri urbani di notevole rilevanzaalmeno fino all’età altomedievale:Cornus, presso la costa, e For-dongiànus, sul Tirso, ai confini frala pianura ‘civilizzata’ e la monta-gna popolata dalle tribù barbaricine: presso entrambe le città passavano due impor-tantissime strade romane di collegamento fra il nord e il sud dell’isola. Nel medioevo l’a-rea era divisa fra il giudicato di Torres e quello di Arborèa, che hanno fra l’altro lascia-to un’eredità linguistica nelle due parlate, logudorese e campidanese, che si incontra-no rispettivamente a nord e a sud del monte Ferru. Restano, solenni testimonianze diquel periodo, numerose chiese romaniche che svelano influssi francesi, pisani e lombardie che costituiscono – si pensi a S. Nicola a Ottana o a S. Maria a Bonàrcado – esempi in-signi dell’architettura medievale religiosa in Sardegna. Ma quello che più colpisce in questa regione, e in particolare nell’altopiano di Abbasantae nella Planargia, è il fitto reticolo di muretti a secco: retaggio ottocentesco frutto del-le continue divisioni del terreno, in gran parte causate dalle successioni ereditarie. Og-gi la pastorizia transumante ha in parte ceduto il passo all’allevamento stabile con raz-ze bovine e ovine selezionate. I centri abitati, quasi tutti di origine medievale, sono sta-ti in alcuni casi travolti, a partire dagli anni sessanta, da un’ansia di rinnovamento chequalche volta ha modificato il loro volto antico, ma si sta già iniziando a pensare al lo-ro recupero. Resistono invece, conservando i loro aspetti più puri e genuini, alcune frale più antiche manifestazioni di fede del popolo sardo e, fra di esse, la sfrenata corsadell’«Àrdia» di Sèdilo che ogni anno ai primi di luglio commemora, con la vittoria del-l’imperatore Costantino su Massenzio, il trionfo del cristianesimo.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Si svolge nel primo tratto lungo la statale388, risalendo da Oristano la bassa valle delTirso e attraversando i centri abitati diSimàxis, Ollastra e Villanova Truschedu.Dopo la chiesa romanica di S. Lussorio e ilpaese di Fordongiànus, ci si inoltra nellamedia valle del Tirso percorrendo la stra-da per Abbasanta e deviando, dopo quasi8 km, per raggiungere il lago Omodeo chesi costeggerà sul lato occidentale, in unastretta vallata, fino a Tadasuni. Prima digiungere al grosso borgo di Ghilarza, unadeviazione lungo la strada a scorrimentoveloce da Nuoro ad Abbasanta permette lavisita al santuario di S. Costantino di Sèdilo(km 10) e, proseguendo (altri 15 km), al-l’importante chiesa romanica di S. Nicolaa Ottana. Da Ghilarza, seguendo il trattoterminale della Nùoro-Abbasanta e de-viando a sinistra sullo svincolo che im-mette nella statale 131 Carlo Felice, si rag-giunge facilmente l’imponente complessodel nuraghe Losa. Di qui, percorrendo l’al-topiano basaltico di Abbasanta sulla 131,dopo circa 3 km si devia per Paulilàtino. Ri-presa la 131, una deviazione ben segnala-ta a circa 4 km dall’ultimo svincolo per
Paulilàtino conduce in breve al suggestivosantuario federale nuragico di Santa Cri-stina. Toccando i centri agricoli di Bauladue Tramatza, ai limiti meridionali della pia-na di Milis, si segue la 131 sino a Oristano.
La valle del TirsoSi esce da Oristano lungo la statale 388.Nella frazione Silì (m 10), sulla sinistra sitrova la trecentesca chiesa della Madda-lena, d’impianto romanico ma dalle sug-gestioni gotiche rintracciabili negli ar-chetti trilobi e nella grande bifora del-l’abside. Si aprono sulla facciata un portalepisano e una finestra incorniciata da soli-de sagome, mentre il frontone è adornod’archetti pensili su due ordini.Sottopassata la 131, in meno di 10 km si èa Simàxis (m 17, ab. 2204), borgo agricolocui segue Ollastra (m 23, ab. 1301), chevanta la seicentesca parrocchiale di S. Se-bastiano, con aula di quattro campate supilastri più antichi e un arco trionfale,nonché la cripta della chiesa di S. Marco,cinquecentesca.La chiesa campestre di S. Costantino an-nuncia la diga di S. Vittoria. Oltre un’ansa
6.1 Da Oristano al lago OmodeoItinerario circolare che risale la valle del Tirso per poi tornare a Oristano, km 80 escluse ledeviazioni (carta qui sotto)
102
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

del Tirso è Villanova Truschedu(m 56, ab. 342), da dove un brevetratto di strada conduce verso nordalla tardoromanica chiesa di S. Gemiliano,edificata in trachite locale e ornata d’un ro-sone; intorno si trovano le “cumbessìas”,casette per pellegrini che vi si recavanoper le ricorrenti novene.La strada sale: alle spalle la vista spaziasulla piana e sul golfo di Oristano. Col Tir-so a sinistra, comincia la discesa verso lastorica chiesa di S. Lussorio.
S. LussorioFu costruita dai monaci Vittorini intorno al1100 sopra un ipogeo paleocristiano dove,secondo la tradizione, sarebbe stato se-polto san Lussorio, qui martirizzato du-rante le persecuzioni di Diocleziano del304. Il sito rientra nell’area cemeterialeextraurbana di Forum Traiani (Fordon-giànus). Del primitivo impianto romani-co, di influenze provenzali, la chiesa con-serva il fianco nord e l’abside. Il fianco sud,crollato insieme all’originaria volta a bot-te, fu ricostruito tra il 1250 e il 1270 men-tre la facciata, con portale gotico-arago-nese, è un rifacimento ancora più tardo(sec. XV). Dall’interno (visite a richiesta, t.078360110), si può accedere all’ipogeo do-ve sarebbero stati deposti i corpi dei mar-tiri Lussorio e Archelao. Formato da unlungo corridoio con un ambulacro latera-
6.1 Da Oristano a Fordongiànus
103
le, presentacopertura con volta a
botte e conserva ancora traccedi affreschi e di mosaici pavimentali data-bili ai secoli IV e V. Scavi effettuati in oc-casione di opere di restauro hanno rivelatola presenza delle fondamenta di un edificiosacro bizantino, che risale al VII secolo.
FordongiànusPiccolo centro (m 35, ab. 1112) del Bari-gadu a economia prevalentemente agri-cola, caratteristico per le abitazioni rea-lizzate in trachite rossastra e noto per lesorgenti termali, conserva cospicue te-stimonianze preistoriche nel territorio eimportanti monumenti d’età storica. Lanascita del centro, avvenuta probabil-mente verso la fine del I secolo a.C., fuprobabilmente dovuta anche alla presen-za delle acque termali. Il suo nome piùantico fu Aquae Ypsitanae, poi ForumTraiani, dal quale deriverebbe il nome at-tuale. Dal V secolo vi ebbe sede un vesco-vo. Sotto Bisanzio, munita di nuove forti-ficazioni e probabilmente con il nome diChrysopolis (città aurea), fu luogo di re-sidenza dei comandanti militari dell’isola.Fra le emergenze archeologiche d’età ro-mana che caratterizzano Fordongiànus(resti dell’acquedotto, dell’anfiteatro, diun ponte e di edifici urbani), la più signifi-
Lussorio era un apparitor, cioè qualcosacome un ufficiale giudiziario. Stava a Fo-rum Traiani, oggi Fordongiànus: una città-fortezza, costruita dai romani proprio difronte ai varchi dai quali i barbaricini,eternamente ribelli, potevano scendere arazziare nelle pianure.Nel 304 Lussorio viene travolto dallagrande persecuzione di Diocleziano. Af-ferma la sua fede cristiana ed è martiriz-zato sul posto. Il 304 è l’anno dei martiri,in Sardegna: muore a Cagliari sant’Efisio,a Olbia san Simplicio, a Sulci sant’An-tioco; muoiono a Torres i santi Gavino,Proto e Gianuario. Lussorio viene pre-sto venerato come santo (nella fotostatua del santo a Selàrgius). Già unsecolo dopo la sua morte si co-struisce, appena fuori le mu-ra di Forum Traiani, una crip-ta che diventa subito og-getto di grande devo-zione. Tanto che al suo
ingresso fu sistemato un corridoio perpermettere ai pellegrini di sfilare ordina-tamente di fronte alla tomba del santo: nelgiro dei secoli due interi strati di mosai-co si consumano davanti al sepolcro e nelVI secolo il vescovo Elia vi fa apporre unaepigrafe che dice: «Qui fu sparso il sanguedel beatissimo martire Lussorio».Quando la Sardegna finisce sotto l’in-
fluenza della Repubblica di Pisa, ilvescovo pisano Gerardo,nel 1084, trasporta le reli-
quie del santo in un mo-nastero che sorge al-
l’interno di un grande bo-sco, vicino alla città. Si
chiamerà S. Rossore,cioè Lussorio.
Lussorio e i suoi fratelli
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

cativa è senza dubbio il complesso terma-le* situato presso la riva sinistra del Tirso.La parte più antica è quella della grande pi-scina con portico, che sfrutta le acque cal-de naturali (54 °C di temperatura) e che sidata al sec. I d.C. Gli ambienti retrostanti alportico si datano invece agli inizi del sec.III. Alle spalle degli impianti termali è ilgrande spazio lastricato del foro sul qualesi affacciano una scalinata monumentale ei resti di un grande edificio, da alcuni rite-nuto un “hospitium” (albergo) da altri un
6 Nelle terre d’Arborèa
104
furti e azioni vandaliche: i resti dei suoitronchi fossilizzati riappaiono quando leacque del lago sono in secca. Alcuni di es-si sono stati trasportati presso la chie-setta di S. Maria a Soddì, all’esterno dellaquale sono attualmente esposti.
Dopo la diga di S. Chiara una diramazione sullasinistra consente la visita di alcune chiese cam-pestri con cumbessìas, le tipiche casette per l’al-loggio dei novenanti. Fra di esse, in vicinanza del-le sponde del lago, si segnala S. Serafino*, cir-condata da un grazioso villaggio che si anima in
occasione della novena per lafesta dell’arcangelo Raffaeleche si celebra il 24 ottobre. Lachiesa, il cui primo impianto ri-sale alla fine del XIII sec., pre-senta nella lunetta del portaledella facciata un concio in cuisono scolpiti l’Agnus Dei fraserafini e, nell’architrave delportale meridionale, un serafi-no e quattro personaggi in at-teggiamento di preghiera.
TadasuniNella casa parrocchiale diTadasuni (m 180, ab. 210),in via Adua N. 7, don Gio-vanni Dore, parroco del pae-
se, ha riordinato in esposizione una colle-zione*, unica nel suo genere in Sardegna, dioltre quattrocento strumenti musicali, dalui riuniti nel corso di oltre vent’anni. La rac-colta, che è visitabile previo accordo te-lefonico (tel. 078550113) sotto la guida delsacerdote, comprende in gran parte stru-menti specifici della tradizione sarda.
S. Pietro di ZuriLa chiesa, che sorgeva nel fondo della val-le ora ricoperta dalle acque del lago Omo-deo, è stata ricostruita negli anni venticon gli stessi conci in trachite rossa e se-condo le forme originarie. Come dice un’i-scrizione sulla facciata, la fabbrica fu rea-lizzata nel 1291, sotto il regno del ‘giudice’Mariano II d’Arborèa, da Anselmo da Co-mo, lo stesso architetto al quale si attri-buisce S. Pietro di Bosa. L’edificio, di for-me romaniche lombarde con tendenze go-tiche, ha subìto nel ’300 il rifacimento del-l’abside, di stile gotico catalano, e agli ini-zi del ’500, in occasione della costruzionedel campanile a vela su arcate, della par-te superiore della facciata. Fra i vari rilie-vi che ornano la chiesa si può osservare,all’esterno, una serie di personaggi che sitengono per mano: si tratta probabilmen-te di una raffigurazione della danza sardadetta “ballo tondo”.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
“macellum” (mercato), che conserva fral’altro un ambiente con tracce di affreschi.In via Traiano, nei pressi della chiesa par-rocchiale, merita d’essere visitata casaMadeddu, una dimora signorile di fine XVI-inizi XVII sec., con portale e finestre in fog-gia tardogotica aragonese.
Lago OmodeoRealizzato fra il 1918 e il 1924 per la pro-duzione di energia elettrica, per l’irriga-zione della piana di Oristano e di quellad’Arborèa e per regolare le piene del Tir-so, è il lago artificiale più vasto d’Italia eper un lungo periodo lo fu anche di tuttal’Europa. L’invaso, che prende nome dal-l’ingegnere Angelo Omodeo che lo pro-gettò, ha una lunghezza di oltre 20 km,una larghezza massima di 3 e può conte-nere fino a 402 milioni di m3 di acqua a unlivello di m 102 s.l.m. Lo sbarramento delcorso del Tirso fu praticato in una strettavalle rocciosa, con la costruzione delladiga di S. Chiara (1923), alta 70 m e lunga260. Nella vallata ora ricoperta dalle acquesi trovavano il paesino di Zuri e la chiesaromanica di S. Pietro, poi ricostruiti più amonte, mentre sul fondo sono rimasti unaquindicina di nuraghi, tre tombe di gigan-ti e una foresta pietrificata miocenica, pur-troppo irrimediabilmente devastata da

A circa un km dall’abitato di Sèdilo (m 283, ab.2545), sul fianco di una collina a breve distan-za dal lago Omodeo, è il celebre santuario di S.Costantino, edificio eretto nel 1789 probabil-mente su una preesistente chiesa medievale.Noto in tutta la Sardegna come Santu Antine, l’e-dificio, il cui interno è tutto un ex voto, ha ac-canto un bètilo, due stele d’età nuragica e nu-merosi cippi funerari romani qui collocati intempi recenti. Presso il santuario, racchiuso inun vasto recinto di cumbessìas, si celebra a lu-glio una fra le più famose e sentite feste popo-lari dell’isola che trova i suoi momenti più spet-tacolari il pomeriggio del 6 e la mattina del 7 nel-l’Àrdia**, spericolata cavalcata che rievocala vittoria dell’imperatore romano Costantino suMassenzio nella battaglia di Ponte Milvio (312).Il culto di Costantino, che non è riconosciuto co-me santo dalla Chiesa romana, fu probabil-mente introdotto in Sardegna dai bizantini, checonsideravano l’imperatore “isapòstolos”, cioèuguale a un apostolo.
Ottana (m 185, ab. 2563), situata nel Nuorese alcentro della fertile piana della media valle delTirso, fu probabilmente capoluogo di curatorianonché sede episcopale in età medievale, perpoi decadere nel xv sec., forse anche in segui-to alla malaria. Modesto borgo pastorale finoagli anni sessanta, nel suo territorio è stata ef-fettuata una discussa riconversione industria-le con l’installazione di moderni impianti chi-mici che hanno modificato l’assetto culturale edeconomico dell’area.La romanica chiesa di S. Nicola* è situata in po-sizione dominante nella parte sud dell’abitato.Realizzata in conci di trachite scura, fu portataa compimento nel 1160 con il lavoro di due di-verse maestranze che, pur operando forse con-temporaneamente, denunciano l’una influen-ze pisane (facciata e fianco sud), l’altra influs-
6.1 Dal lago Omodeo al nuraghe Losa
105
si del Maestro di S. Maria del Regno di Àrdara(fianco nord, abside e transetto). L’interno del-la chiesa, a unica navata coperta a capriate li-gnee, conserva una preziosa pala* databile al1339-44, attribuita al Maestro delle TempereFrancescane, pittore lorenzettiano che lavorò aNapoli, e commissionata dal vescovo di Ottana,Silvestro, e da Mariano d’Arborea. A Ottana sicelebra ancor oggi un carnevale di antichissimeorigini che vede protagonisti “merdùles” e“boes”, maschere raffiguranti esseri umani e ani-maleschi in lotta fra di loro, e la “filonzana”, vec-china deforme intenta a filare il filo della vita.
GhilarzaCentro (m 290, ab. 4627) dell’altopiano diAbbasanta dove l’edificio (corso Umberto57) in cui dal 1898 al 1908 abitò AntonioGramsci, è attualmente sede del Centrodocumentazione e ricerca “Casa Gramsci”e conserva, riordinati in esposizione mu-seale, numerosi cimeli e una bibliotecadove sono raccolti suoi scritti e tutte leopere a lui dedicate.In piazza San Palmerio, in una suggestivaambientazione medievale, è la romanicachiesa di S. Palmerio. Edificata tra il 1200e il 1225, con corsi alternati di conci in tra-chite scura e bianca, presenta una bellafacciata tripartita da arcate. A lato si ergeuna possente torre del ’400, bell’esempiodi architettura militare catalana, forse inorigine sede dei marchesi di Oristano, dalXVII sec. utilizzata come carcere, poi ab-bandonata e nuovamente usata come pri-gione dal 1893.
Nuraghe Losa**Il complesso del nuraghe Losa (v. anche al-le pagg. 106-107), in prossimità di Abba-santa (m 315, ab. 2798), è senz’altro da an-noverarsi fra i monumenti preistorici piùimportanti dell’isola. Presenta due fasicostruttive principali, entrambe presu-mibilmente ascrivibili alla seconda metàdel II millennio a. Cristo. La parte più anticaè formata da una torre a due piani, con ca-mere centrali sovrapposte (quella del pia-no inferiore è fornita di tre nicchie), co-perte a falsa volta e collegate da una sca-la elicoidale che parte dall’andito. Questastruttura fu successivamente inglobata inun bastione triangolare dotato di tre torri,due accessibili attraverso corridoi che siaprono subito dopo l’ingresso principale,la terza da un ingresso secondario sul la-to nord. Altre due torri con feritoie, rac-cordate da possenti cortine, proteggono lastruttura nella sua parte posteriore, men-tre di fronte all’entrata principale si ad-dossa una torre a due ingressi opposti, con
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

106
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

107
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

6.2 Il MontiferruItinerario circolare che da Oristano si spinge nell’estremo ponente nuorese, km 135 escluse le deviazioni (carta a pag. 102)
Si snoda attraverso le regioni storiche delMontiferru, della Planargia, del Màrghinee del Campidano di Milis. Si esce da Ori-stano in direzione nord seguendo la statale292 e, oltre Riola Sardo, si costeggiano lepropaggini del monte Ferru, percorrendol’ampia zona di dune sabbiose, ora in granparte rimboschita, di is Arenas. Giunti al-la costa, caratterizzata in questo trattoda belle falesie calcaree, una deviazione frale località balneari di S’Archittu e Santa Ca-terina di Pittinuri conduce (km 25 da Ori-stano) agli scavi di Cornus. Si prosegue fi-no a Cùglieri (km 15.5) da dove è possibi-le effettuare escursioni sul monte Ferru de-viando per la strada che conduce a SantuLussurgiu. Continuando verso nord, si transita perla Planargia, regione caratterizzata da unvasto altopiano che digrada sul mare, at-traversando Tresnuràghes e, entrati in pro-vincia di Nùoro, Suni (km 16 da Cùglieri). Diqui si imbocca la strada per Macomèr finoa Sindìa (km 10 da Suni) e, a circa 3 km dal-l’abitato, si devia per l’abbazia cistercensedi S. Maria di Corte. Si prosegue fino a Ma-
comèr, centro principale del Màrghine, epoi verso sud- ovest, nuovamente in dire-zione del Montiferru. A circa 14.5 km da Ma-comèr, rientrati in provincia di Oristano, sigiunge a San Leonardo de Siete Fuentes e,dopo 6 km, a Santu Lussurgiu, dove è un in-teressante museo etnografico. Si prose-gue verso sud fino a Bonàrcado (km 8.5) e,ormai nella fascia del Campidano supe-riore, a Milis (km 5.7) e a San Vero Milis (km5.8) per fare poi rientro a Oristano.
Verso Santa Caterina di PittinuriOltrepassati Nurachi (m 6, ab. 1623), nellacui parrocchiale di San Giovanni Battistasono i resti di una fonte battesimale pa-leocristiana, e Riola Sardo, si incontra iltratto più interessante dal punto di vistapaesaggistico. La strada corre tra le pendiciaspre del monte Ferru sulla destra e le du-ne sabbiose di is Arenas sulla sinistra. Pro-prio questa strada ha contribuito, insiemecon una serie di rimboschimenti, a conte-nere l’avanzata delle sabbie. Prima di que-sti interventi si estendeva per numerosichilometri un’area desertica unica nel suo
funzioni non ancora ben chiarite. Un cir-cuito murario più ampio doveva proteg-gere il villaggio che si estendeva intorno.
PaulilàtinoA Paulilatino (m 280, ab. 2580) è stato aper-to al pubblico, nel 1995, il Museo archeolo-gico-etnografico “Palazzo Atzori”. Al piano ter-ra della costruzione, risalente nel suo primoimpianto al XVIII sec., avevano sede gli ufficidel notaio Giovanni Antonio Atzori, pro-prietario della casa defunto nel 1900, mentreal primo piano era situata la parte abitativa.Attualmente l’esposizione comprende nu-merosi oggetti di interesse etnografico cheillustrano la vita e le attività agricole e pa-storali dei tempi passati a Paulilàtino. Nelcentro del paese, ove si conservano ancoranumerose vecchie case costruite in basalto,sorge la parrocchiale di S. Teodoro, d’im-pianto gotico-aragonese, affiancata da uncampanile con cuspide a cipolla.
Santuario nuragico di S. Cristina**Sorge a breve distanza dal villaggio di“cumbessìas” presso la chiesa di S. Cristina,che ne ha ereditato la tradizione religiosa(la festa si celebra la prima domenica di
6 Nelle terre d’Arborèa
108
maggio). Il monumento principale è il poz-zo sacro, forse l’esempio più mirabile di ar-chitettura religiosa nuragica nell’isola. Cir-condato da un recinto con sedili, si presen-ta composto da un profondo vano circolareaggettante, con una stretta bocca superio-re, al quale si accede attraverso un’ampiascala, realizzata in opera isodoma, che re-stringendosi gradualmente conduce diret-tamente sul fondo. A lato e alle spalle del-l’edificio è una lunga serie di vani a piantaquadrangolare, forse le logge di un mercato,che si aprono su un ampio spiazzo insiemecon una grande capanna circolare, proba-bilmente luogo di riunione dei maggiorentiche convenivano per la festa. Dal tempio,che risalirebbe al sec. X a.C., provengono fral’altro alcuni bronzetti fenici, databili fra il IXe l’VIII sec. a.C. Attraverso l’area delle cum-bessìas si possono raggiungere il nuraghe eil villaggio pertinenti al santuario. Nei pres-si della torre, che conserva ancora intatta lacamera centrale con copertura a tholos, èuna capanna rettangolare allungata, coper-ta a ogiva, da interpretarsi come ricoveroper animali e forse risalente a età romana. Sitratta di una tipologia diffusa presso Pau-lilàtino, durata fino a età moderna.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

109
genere in Europa, con dune mobili di sab-bia alte sino a 50 m di altezza. Al loro postoc’è ora una pineta presso la quale si è for-mato un fitto sottobosco popolato da nu-merose specie di animali selvatici.La costa si raggiunge a Torre Su Puttu, do-ve è una torre spagnola del XVII sec., e aS’Archittu, con bella vista di scogliere cal-caree purtroppo deturpate dalla vicinan-za di costruzioni sorte disordinatamen-te. Poco oltre, dopo il bivio per Cornus (v.sotto), è Santa Caterina di Pittinuri: una bre-vissima diramazione all’uscita dell’abitatoconduce alla cinquecentesca torre di Pit-tinuri, dalla quale si gode una veduta ve-ramente splendida della costa.
CornusIl nome di questa antica città è legato allefigure dell’eroe sardo-punico Ampsicorae del figlio Iosto che nel 215 a.C., nel corsodella seconda guerra punica, guidaronoun’insurrezione contro i romani. La lotta,che vide i sardi combattere a fianco delletruppe cartaginesi di Asdrubale il Calvo,culminò con la morte in battaglia di Iosto,il suicidio di Ampsicora e la conquista mi-litare di Cornus. L’area attualmente visita-bile, in località Columbaris, è adiacente alsito del centro punico e romano; com-prende la sede episcopale, che conserva iresti di due basiliche, di un battistero e diun’area cemeteriale in uso dal sec. IV fino alIX, abbandonati in seguito a scorrerie ara-be. Varcato l’ingresso, si incontrano subi-to sulla destra una lunga teoria di sepolcrie un edificio rettangolare noto come basi-lica sepolcrale per il gran numero di tom-be che contiene. Disposta perpendicolar-mente a questa prima struttura se ne in-contra subito un’altra, la cosiddetta basi-
lica maggiore. Dotata in origine di nartece,era divisa in tre navate con altare al centroe cattedra episcopale presso l’abside.Ancora adiacente e parallelo a questo edi-ficio era il battistero, con una serie di di-visioni interne; al centro sta la fonte bat-tesimale cruciforme dotata di scalini e in-globata in una struttura ottagonale.
Cùglieri e il monte FerruCentro della regione del Montiferru, a eco-nomia agro-pastorale, Cùglieri (m 483, ab.3198) deriva il nome dalla città romana diGurulis Nova, il cui sito ricadrebbe nelterritorio di questo comune. Nella parte al-ta del paese, che conserva ancora alcuniangoli pittoreschi, è la seicentesca chiesadi S. Maria della Neve, costruita su un pre-cedente impianto del XIII secolo.
Da Cùglieri è possibile effettuare escursionisul monte Ferru (m 1050) percorrendo almenouna decina di chilometri della strada che con-duce a Santu Lussurgiu. Sulla destra, salendo,si notano subito, sulla cima di un colle, i resti diCasteddu Ezzu, fortezza medievale restaurata,eretta dai giudici di Torres. Sul monte, a su-perfici spoglie e a picchi rocciosi, si alternanovaste distese di roverelle, lecci, maestosi agrifo-gli, talora associati con esemplari di Taxus bac-cata, detto anche “albero della morte” per le suebacche velenosissime.Subito dopo il complesso della Madonnina, luo-go di villeggiatura e di convegni culturali di pro-prietà di una fondazione cattolica sassarese,una stradetta asfaltata sulla destra (km 9.3 daCùglieri), che conduce al ripetitore Rai di Bad-de Ùrbara, consente di raggiungere la tenuta diSu Pabarile dove vivono cervi sardi e mufloni.
FlussìoIn questo piccolo centro della Planargia (m305, ab. 500) è tuttora vivo l’artigianato lo-
6.2 Il Montiferru
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

cale dell’intreccio dell’asfodelo per la la-vorazione di cestini e canestri in genereesposti per la vendita all’esterno delleabitazioni. Suggestivo lo spettacolo, inprimavera, degli asfodeli stesi ad asciugarelungo le vie del paese. Come nei centri vi-cini, a Flussìo (dove fra l’altro ha sedeuna cantina sociale) si può trovare l’ottimaMalvasia di Bosa, vino liquoroso dal coloredorato e dal profumo delicatissimo.
SindìaAl centro del paese (m 510, ab. 2073) sor-ge la romanica chiesetta di S. Pietro (per lavisita, t. 078541043), costruita intorno al1150-60 dai monaci cistercensi di S. Mariadi Corte. L’edificio presenta semplice fac-ciata a spioventi sormontata da campani-le a vela e abside decorata da archettipensili. Nella chiesa di S. Demetrio (chiavidal parroco), si conserva una bella statualignea di S. Demetrio della seconda metàdel XVII sec., forse proveniente dalla Spa-gna. La parrocchiale di S. Giorgio, due-centesca, mescola elementi romanici, go-tici e aragonesi, come nella cappella gen-tilizia dell’inquisitore Gavino Pintor Serra.
S. Maria di Corte*Bernardo di Chiaravalle, su richiesta diGonario II ‘giudice’ di Torres (che diven-terà beato dell’Ordine cistercense), inviòin Sardegna i Cistercensi che tra il 1147 eil 1149 fondarono l’abbazia di S. Maria diCorte o di Cabuàbbas. Gli stessi monaci in-trodussero il sistema delle grange, orga-nizzazione benedettina di aziende agrico-le che si estesero dalla Planargia al Màr-ghine svolgendo un ruolo determinantenel riassetto agrario del territorio. Il pri-mitivo impianto romanico della chiesa(chiavi presso il parroco di Sindìa), è daconsiderarsi fra gli esempi più antichi diarchitettura cistercense in Europa: si con-serva nel braccio sud del transetto condue cappelle, in parte dell’elevato del co-ro e nella sagrestia. Dell’antico monasterorestano soltanto le fondamenta dell’aulacapitolare e del chiostro, messi in lucenegli scavi del 1964.
MacomèrCentro (m 563, ab. 11 417) del Màrghine, si-tuato ai margini di un altopiano basaltico,passaggio obbligato lungo la più impor-tante via di comunicazione fra il nord e ilsud dell’isola, è luogo con un’altissimadensità di costruzioni nuragiche. Di unacerta rilevanza in epoca romana col nomedi Macopsissa, fu munito nel medioevo
6 Nelle terre d’Arborèa
110
di un castello oggi scomparso. Nella sot-tostante piana si svolse nel 1478 la batta-glia che, con la sconfitta del marchese diOristano Leonardo de Alagón, vide spe-gnersi le ultime speranze di scuotere l’isoladal dominio iberico. Oggi Macomèr, nodoferroviario e stradale, è forse il centro dimaggior vitalità della Sardegna centraleper gli allevamenti del bestiame e per l’in-dustria casearia. Da vedere il rione di San-ta Croce, nel quale ci si può addentrare apiedi partendo da piazzetta Garibaldi: nu-
merosi i portali e le finestre gotico-arago-nesi scolpiti nella trachite rossa di Bosa.Qualche pregio architettonico ha la par-rocchiale di S. Pantaleo, con facciata degliinizi del ’600 su un precedente edificiocinquecentesco; conserva fra l’altro unpregevole Crocifisso ligneo che risale allaseconda metà del XVII secolo.
Numerosi i monumenti preistorici nei dintorni.Su una collina prospiciente l’ospedale civile, do-minata dal nuraghe Ruggiu, monotorre, sonoscavate le domus de janas di Filigosa, tombe plu-ricellulari che hanno contraddistinto, con i lo-ro corredi, l’omonima cultura sarda dell’etàdel Rame. Di notevole interesse è il nuraghe S.Barbara*, raggiungibile dalla statale 131, forseuno dei più begli esempi di architettura nura-gica, con una maestosa torre rossa di muschiche svetta sul mastio. Per visitare le tombe di gi-ganti e i bètili di Tamuli, si prende la stradache dalla provinciale per Santu Lussurgiu sistacca per il parco di monte S. Antonio (devia-zioni segnalate), cono vulcanico ricoperto dauna fitta foresta di lecci, roverelle e sughere.
San Leonardo de Siete FuentesFrazione (m 684) di Santu Lussurgiu svi-luppatasi intorno al centro religioso di S.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Leonardo, dotata di alcune attrezzatureturistiche, è nota per la presenza, all’in-terno di un bel parco di lecci, olmi e ca-stagni, delle sette sorgenti (che hannodato nome alla località) dalle quali sgor-gano acque radioattive e diuretiche. Lachiesa di S. Leonardo fu costruita intornoalla metà del XII secolo. Ristrutturata in for-me gotiche nel XIV (apprezzabili soprat-tutto nell’interno mononavato), conservadel primitivo impianto romanico la parteinferiore della facciata e il lato sud. Pres-so l’edificio era un ospedale, oggi scom-parso, dove nel 1295 morì Guelfo, figlio delconte Ugolino della Gherardesca.
Santu LussurgiuPaese (m 503, ab. 2718) del Montiferru si-tuato all’interno di un cratere di originevulcanica, è tuttora centro di attività arti-gianali quali la tessitura dei tappeti, l’in-taglio delle cassapanche, la fabbricazionedi coltelli e soprattutto la produzione di sti-vali, selle e ogni altro oggetto connessocon la bardatura dei cavalli. Interessante, in piazza Mercato, la chiesadi S. Maria degli Angeli, costruita nel 1483da san Bernardino da Feltre. All’interno,presso l’altare maggiore del ’700, si con-serva il gruppo ligneo della Madonna degliAngeli, opera di fine ’500-inizi ’600, forseimportata dall’Italia meridionale. Di no-tevole interesse etnografico è il Museodella Tecnologia contadina in via DeodatoMeloni N. 2, visitabile previo appunta-mento telefonico con il maestro F. Salis, al-lestitore e curatore della struttura mu-seale (tel. 0783 550617-550706). La rac-colta consiste in oltre 2000 oggetti, siste-mati in un’ampia dimora padronale del’700, comprendenti soprattutto attrezzida lavoro e vari oggetti di uso quotidianotutti selezionati e raccolti nell’ambito del-la comunità di Santu Lussurgiu.
BonàrcadoIn questo paese agro-pastorale del Mon-tiferru (m 283, ab. 1707) si conserva un no-tevole complesso monumentale sacro –chiesa e santuario – che costituisce unimportante luogo di venerazione mariana,meta di pellegrinaggi soprattutto nei tregiorni della festa, tra 18 e 20 settembre. Ilsantuario della Madonna di Bonacattu* èuna piccola costruzione cruciforme alto-medievale (VIII-IX sec.) che si imposta su unprecedente ambiente termale romano. Lafacciata meridionale è frutto di una ri-
6.2 Da Macomèr a Oristano
111
strutturazione avvenuta intorno alla metàdel ’200, mentre restauri sono stati con-dotti una settantina d’anni or sono e poi,di recente, negli anni novanta. Nell’interno,una vasca con pavimento in mosaico ap-partenente alla fase romana e un bassori-lievo del ’500 in terracotta policroma del-la Madonna col Bambino.La romanica chiesa di S. Maria fu costrui-ta entro il 1147 dai monaci dell’annessomonastero camaldolese. Al primitivo im-pianto mononavato, del quale si conser-vano la facciata tripartita da arcate, la pa-rete sud e il primo ordine della torre cam-panaria, fu aggiunto negli anni 1242-68 unpiù ampio corpo a tre navate realizzatoprobabilmente da maestranze iberiche dicultura architettonica araba.
MilisIl paese (m 72, ab. 1668) si adagia ai piedidel monte Ferru, su una rigogliosa pianafitta di agrumeti, la cui coltivazione fu quiintrodotta già nel medioevo, probabil-mente dai Camaldolesi. Alla periferia sor-ge la romanica chiesa di S. Paolo: fu edifi-cata nel 1140-50 e completata, nel 1200-25con la realizzazione del paramento mura-rio bicromo della parte superiore dellafacciata in conci di trachite e di arenaria.L’interno, a navata unica con copertura acapriate lignee, custodisce un retablo del1503, dovuto forse a maestri catalani, raf-figurante una Crocifissione e una Madonnacol Bambino e angeli.Di un certo interesse, al centro del paese,il settecentesco palazzo Boyl (non ancoraaperto al pubblico) che conserva arredid’epoca e, di fronte, la quattrocentescaparrocchiale di S. Sebastiano.
San Vero MilisPaese del Campidano superiore, ove siproduce un’ottima vernaccia ed è ancoravivo il tipico artigianato dell’intreccio dicestini e canestri.Al centro dell’abitato (m 10, ab. 2494) è laseicentesca parrocchiale di S. Sofia, dal-l’interessante facciata con tre portali, in cuisi combinano elementi gotici e barocchi,e dal maestoso campanile con cupola a ci-polla. All’interno si conserva una sculturalignea di S. Sebastiano della metà del ’600.Un’altra pregevole statua lignea raffigu-rante S. Michele Arcangelo, di scuola na-poletana, anch’essa della metà del ’600, èvisibile nella vicina chiesa di S. Michele, diimpianto decisamente barocco.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Profilo della cittàRappresentativa delle tradizioni e dei valori delle zone internedella Sardegna, e insieme del loro recente processo di tra-sformazione, Nùoro (m 549, ab. 37 890) si stende a cavallo diuna dorsale prevalentemente granitica che dal monte Orto-
bene si allungain direzione nord-ovest. È capoluogo diprovincia (costituita nel 1927) in costanteespansione e centro di servizi ammini-strativi, culturali e commerciali.Il ritrovamento – nel 1975, durante lavori diristrutturazione di un vecchio stabile in viaBallero – di una tomba a poliandro asse-gnata a un periodo compreso tra i sec. VIIe VIII (tomba visibile nel Museo speleo-ar-cheologico), ha messo in luce la più anticatestimonianza della presenza stanziale del-l’uomo nell’attuale sito della città. Sul mon-te Ortobene, nei pressi dell’attuale fonteMilianu, sarebbe sorto un primitivo vil-laggio, abbandonato – una volta stabiliz-zatosi il dominio romano – in favore diuna località più a valle; il nuovo nucleo sa-rebbe sorto nella zona del rione cittadinodi Sèuna, così denominato dal ruscello(Ribu ’e Sèuna) sull’Ortobene.I primi documenti scritti risalgono al XIV se-colo: nelle Rationes Decimarum impostedal papa Giovanni XXII, Nùoro è presente
come uno dei paesi più tassati della diocesi di Ottana, e quindi come uno dei più im-portanti. Il toponimo Nùgor – molti nuoresi ancora oggi chiamano la loro città Nùgoro– è tuttavia già riportato in diversi registri dei sec. XI, XII e XIII. Concessa in feudo (dopoil 1478) alla famiglia Carroz, passò nel 1496 dalla diocesi di Ottana a quella di Alghero.Nel Cinquecento, sotto il dominio di diversi feudatari, la città registrò un notevole pro-cesso di crescita: nel sec. XVII contava 1600 abitanti e numerosi edifici sacri vennero adaggiungersi a quelli già esistenti di S. Croce e del Salvatore (fine ’500).Nel 1777 Nùoro, con i suoi 2782 abitanti, risulta il maggiore dei centri della zona; è abi-tata in prevalenza da pastori e contadini, ha un minimo di struttura urbana, con ampiestrade ed edifici; conta 15 chiese all’interno dell’abitato. L’Ottocento si apre con un pe-riodo di relativa tranquillità, ben presto interrotto a seguito delle disposizioni regie cheponevano fine all’uso comunitario della terra (editto delle ‘chiudende’, 1820). Una se-rie di sollevazioni popolari ebbe il suo culmine nel 1868 con la rivolta “de Su Connottu”a seguito dell’attuazione della legge del 1865 che aboliva gli usi e i diritti d’ademprivio. A cavallo dei due secoli la città esprimeva una vasta e originale attività culturale e so-cio-politica che traeva i suoi motivi ispiratori proprio dallo scontro fra la vecchia societàsarda e quella nuova espressa dallo Stato nazionale: basterà ricordare il poeta SebastianoSatta (1867-1914), la scrittrice Grazia Deledda (1871-1936), il saggista e uomo politico At-tilio Deffenu (1890-1918). Con la ricostituzione a capoluogo di provincia nel 1927 (era sta-ta sede di divisione amministrativa e di intendenza dal 1848 al 1859), la città conobbeun nuovo sviluppo urbanistico: numerosi edifici pubblici sorsero nei dintorni di via Def-fenu, di via Dante e di piazza Crispi; gli abitanti passarono dagli 8534 del 1921 agli 11 459del 1939 e ai 16 949 del 1951.Il secondo dopoguerra ha visto un’ulteriore accelerazione del processo di urbanizza-zione, insieme al progressivo mutamento della caratterizzazione agro-pastorale dellacittà in favore di quella amministrativo-burocratica.
112
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
7 Nùoro

L’abitato è attraversato in senso est-ove-st dal corso Garibaldi, il cuore della città,e dalla via La Marmora che, oltre piazzadelle Grazie, prosegue fino a piazza Sar-degna. Dalla già citata piazza delle Graziele strade che salgono verso nord (vie IVNovembre, Ferracciu, Saffi e Dante) con-ducono al centro amministrativo dellacittà (Palazzo comunale, Amministrazioneprovinciale, Prefettura, Camera di Com-mercio, Poste), al Liceo Ginnasio, alleScuole magistrali e al vecchio Ospedale.
Verso piazza Satta. Piazza Vittorio Ema-nuele II (B-C3), ampio spazio scosceso te-nuto a verde, comunicante con piazza Maz-zini, è nodo viabilistico fra i più importan-ti del centro cittadino. Da questa via Angioisale al vecchio quartiere che si dispone at-torno alla raccolta piazza Sebastiano Satta*(B3), sistemata nel 1967 da Costantino Ni-vola. Dipinti in bianco gli edifici e ricoper-to di lastroni di granito il terreno, lo scul-tore vi distribuì grandi blocchi di granitoimpreziositi da statuette in bronzo (gli ori-ginali sono esposti al MAN) che raffigura-no il poeta nuorese in diversi momentidella sua vita. Ne è derivato un insieme am-bientale che, proprio dal contrasto fra gliinserti recenti e certe modeste architettu-re ottocentesche (come la casa natale diSatta), trae carattere e pregio.
Il MAN, Museo d’Arte della Provincia diNuoro*. Una palazzina al N.15 di via Satta(dietro corso Garibaldi), già sede del-l’Amministrazione provinciale, ospita dalfebbraio 1999 il MAN, Museo d’Arte della
Provincia di Nuoro. Dei quattro piani espo-sitivi il primo e il secondo presentano unaselezione di opere di artisti sardi del No-vecento, prevalentemente di area nuorese,per la gran parte derivata da donazioni del-le amministrazioni pubbliche locali (laProvincia, ente proprietario e promotoredel museo, il Comune, la Camera di Com-mercio, l’Ente provinciale per il Turismo)e di privati. Di particolare rilevanza sonole opere di Antonio Ballero, Mario Delita-la, Giovanni Ciusa Romagna, Carmelo Flo-ris, Francesca Devoto, Mauro Manca, Ma-ria Lai, Costantino Nivola e Gino Frogheri.Il museo dedica grande impegno nell’or-ganizzazione di mostre temporanee, chevengono allestite nel piano terra e al quar-to piano dell’edificio.
Piazza Su Connottu. Una discutibile siste-mazione urbanistica l’ha ritagliata nell’an-tico tessuto della zona meridionale delquartiere di San Pietro. La si attraversalongitudinalmente (notare, verso sinistra,la cupoletta della vicina chiesa di S. Croce –B3 – di fine sec. XVI, che contiene un Cristoflagellato ligneo, forse seicentesco) e – difronte alla chiesetta di S. Carlo, semplice ar-chitettura (sec. XVII) di tipo rurale dall’in-terno disadorno – si prende la via Sassari.
Museo Deleddiano* (B3). È ordinato dal1983 al N. 28 di via Grazia Deledda, nella ca-sa in cui nacque la scrittrice (1871). Il mu-seo, completamente rinnovato nel 2000, èdi proprietà dell’ISRE (Istituto SuperioreRegionale Etnografico): raccoglie oggettipersonali, fotografie, autografi, prime edi-
113
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
La città e il monte OrtobeneItinerario pedonale interrotto dall’escursione, automobilistica, sull’Ortobene (pianta urbana a pag. 114)

zioni italiane e straniere delle opere, notedi stampa e testimonianze varie attinentialla vita e all’attività di Grazia Deledda.La casa è un dignitoso esempio di abita-zione nuorese, adeguata per dimensioni easpetto alle esigenze di una famiglia agia-ta della seconda metà dell’Ottocento.Unattento restauro le ha restituito l’origina-ria qualità architettonica, collegando l’or-ganizzazione degli spazi ai caratteri del-l’allestimento espositivo. In una parte del-le stanze del pianterreno, del cortile e del-l’ammezzato sono ricostruiti gli ambientidescritti da Grazia Deledda nell’opera au-tobiografica “Cosima”.
Si segue la via Aspromonte (B3) e poi a sinistrail panoramico viale Ciusa (A3). Sulla destra diquesto, che serpeggia ai margini delle espan-sioni nord-orientali di Nùoro, si incontra in po-sizione leggermente elevata la chiesetta della So-litudine*, edificata nei primi anni ’50 su disegnodi Giovanni Ciusa Romagna; sorge sul sito di unachiesa seicentesca cara a Grazia Deledda, chedal 1959 è qui tumulata.Dal piazzale antistante alla chiesetta una co-moda strada panoramica (di 7 km) risale il mon-te Ortobene*, snodandosi in un paesaggio dienormi massi granitici, cui gli agenti atmosferi-ci hanno conferito forme inconsuete, e di zonea fitta macchia spontanea frequentemente al-ternate a conifere piantate negli anni ’30. Vi si tro-va la chiesetta di Nostra Signora di Montenero, del1608, e la statua bronzea del Redentore, opera diVincenzo Jerace, inaugurata nel 1901.
114
Da quella data, alla fine d’agosto di ogni anno sicelebra sull’Ortobene la festa del Redentore*, oc-casione per una delle più importanti manife-stazioni folcloristiche della Sardegna, assai in-teressante per il concorso di gruppi nei costu-mi tradizionali e per le musiche e le danze. Va-stissimo il panorama che si domina dal roc-cione sormontato dalla statua.
Il Duomo (B-C3). In piazza Asproni è il mo-derno edificio sede della Biblioteca Seba-stiano Satta (B3) affiancato dall’ottocen-tesco palazzo Asproni, con decorazioni digusto neorinascimentale. Costeggiandolosi raggiunge l’alberata piazza S. Maria del-la Neve, dove prospetta l’omonima Catte-drale dalla neoclassica facciata con fron-tone, colonne ioniche e due campanili la-terali; decentrata rispetto alla zona piùrappresentativa della città, fu costruita apartire dal 1836 e terminata nel 1854.L’interno custodisce alcuni dipinti di uncerto pregio: nella prima cappella a destra,una pala di Bernardino Palazzi; alla pare-te fra la prima e la seconda cappella, unatela con Disputa di Gesù fra i dottori attri-buita a Luca Giordano; in fondo alla na-vata, una Deposizione del Palazzi. I pan-nelli della Via Crucis sono per metà di Car-melo Floris e per l’altra di Giovanni CiusaRomagna. Alla parete destra del presbite-rio, un Angelo che piange sul Cristo deposto,a lungo attribuito ad Alessandro Tiarini, forse dei primi dell’Ottocento.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Museo della Vita edelle Tradizionipopolari sar-de**(C3). Sorgesul colle di S.Onofrio, in uncomplesso rea-lizzato agli inizidegli anni ’60,aperto al pubbli-co dal 1976. Gli edi-fici, disegnati dal-l’architetto AntonioSimon, presentanouna tipologia e una distribu-zione spaziale tendenti a rico-struire un ideale villaggio sardotradizionale. Di particolare in-teresse per ricchezza e varietàrisultano la collezione di ve-stiario popolare festivo e quo-tidiano (fine ’800 e prima metàdel ’900), il repertorio di amuletid’argento e in pietre e materia-li vari, la raccolta di ornamentipreziosi e i materiali tessili. Sisegnala inoltre la sezione dedi-cata alle maschere tradizionalidel Carnevale barbaricino (i ma-muthones di Mamoiada, i thur-pos di Orotelli e i merdùles diOttana) nonché l’esposizionedi pani festivi e cerimoniali e didolci del Nuorese.
La sommità del colle di S. Onofrio(m 588), cui si perviene conti-nuando oltre il museo lungo il via-le omonimo, offre un gran panora-ma sulla città, il monte Ortobene eil Supramonte di Oliena.
Civico Museo speleo-archeo-logico (C3). L’edificio dellaScuola elementare F. Podda neè la sede provvisoria. Attivodal 1978, si è formato dalla fu-sione delle raccolte del Grup-po Grotte Nuorese – realizzatenel corso di numerosi anni diattività – con la Collezione co-munale di Nùoro, cui si sonoaggiunti in seguito i notevoliapporti di materiale prove-niente dalle campagne di sca-vo effettuate dalla Soprinten-denza archeologica nella pro-vincia di Nùoro, nonché quel-le di alcune raccolte private.
115
Madonna delle Grazie (B-C2). Oltrepas-sato in via Manzoni (N. 22), l’ex con-
vento dei Francescani, si raggiungenella piazza delle Grazie il santuarioomonimo, costruito negli anni ’50,dove annualmente (21 novembre)si celebra un rito di ringraziamento
per un presunto avvenimento mira-coloso del sec. XVII. Di maggiore inte-
resse è la vecchia chiesa delle Grazie, cuisi arriva seguendo alla destra del santua-rio la stretta via omonima; edificata dopola metà del ’600, è fra i pochi brandelli su-perstiti dell’antico rione di Sèuna.
«I Parchi letterari sono una scialuppa sul maretempestoso della vita d’oggi», ha scritto StanislaoNievo, presidente della Fondazione Ippolito Nievoche ha ideato la realizzazione di una serie di Parchiletterari soprattutto nel Mezzogiorno italiano. «Sco-po - dice ancora Nievo - salvare e preservare la qua-lità del territorio che abitiamo, nei casi in cui que-sti luoghi abbiano già avuto un incontro con ungrande poeta o scrittore della nostra letteratura».È nato così in Sardegna il Parco letterario dedica-to a Grazia Deledda, la grande romanziera vissutafra il 1871 e il 1936, che ha fatto del paesaggio sar-do, e in particolare di quello delle Barbàgie, losfondo di tanti suoi libri. I luoghi del parco sono so-prattutto nel Nuorese. Le ‘porte’ attraverso le qua-li vi si accede, per iniziare un percorso ricco di co-lori e di emozioni, sono a Nùoro, Galtellì e Monte-leone Rocca Doria. I percorsi tematici sono riferitialla vita e ai romanzi di Grazia Deledda, alla Sar-degna deleddiana, al suo romanzo Canne al vento,
al silenzio della magia, all’anima sarda, alle feste neisantuari campestri: tutti titoli che guidano allacomprensione dell’arte dell’unica italiana (nellafoto, la sua casa di Nùoro) insignita del PremioNobel per la letteratura (1926).
Il Parco letterario Grazia Deledda
7 Nùoro
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
116
Profilo dell’areaIl Gennargentu – alla lettera “Porta d’argento”, dai termini la-tini janua e argentum – oltre ad essere la principale eminenzamontuosa della Sardegna, ne è anche il cuore, e quasi il sim-bolo della fierezza e dello spirito di indipendenza dei sardi. Conle sue cime dolci, misteriose e inargentate troneggia solennesu un vasto territorio montano cui una lunga e tormentata vicenda geologica ha conferi-to un aspetto caratterizzato da paesaggi tutti diversi fra loro ma sempre aspri e selvaggi.A est è la lunga sequenza lunare dei calcari del Supramonte: una distesa bianca,
primordiale, rotta da improvvise vallate con foreste fittissime, da burroni e da baratriprofondi che danno l’idea che le cime, in realtà dalle quote modeste, appartengano a mon-tagne molto più alte. A sud è la regione dei “tacchi”, alti e scenografici torrioni calcareiche emergono solitari dagli altipiani e dalle profonde gole scavate dagli affluenti del Flu-mendosa. A ovest una lunga sequenza di rilievi, ora brulli e desolati, ora ammantati daforeste fittissime, digrada progressivamente fino alla valle del fiume Tirso. A nord infi-ne fa da contrafforte al Gennargentu l’altopiano granitico di Fonni, punteggiato da ra-de sughere piegate dal maestrale. Gran parte di questi monti, di enorme interesse na-turalistico e di struggente bellezza, è destinata a ospitare un grande parco nazionale che,una volta realizzato, sarà il più importante parco naturale di tutto il bacino del Medi-terraneo. Questa terra, piena di fascino ma impervia e inospitale, è conosciuta dal-l’antichità col nome di Barbàgia. Furono i romani a chiamarla Barbària perché abitatada genti che non riuscirono mai a sottomettere completamente e che, con le loro con-tinue incursioni nei centri colonizzati dalla pianura, costituirono per i dominatori un pro-blema plurisecolare. Lo stesso cristianesimo vi si diffuse lentamente e con grande dif-ficoltà: ancora alla fine del VI secolo il papa Gregorio Magno, in una lettera a Ospitone,‘dux’ dei barbaricini, si lamentava che questi vivessero come «insensata animalia», ado-rando alberi e pietre. Ancora oggi reminiscenze pagane sono ampiamente presenti in mol-te feste religiose della Barbàgia.Isolati dalla stessa conformazione orografica del territorio, gli abitanti di questa regio-ne hanno conservato quasi intatte usanze e tradizioni le cui origini varcano non di ra-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

do i confini della storia, un patrimonio culturale originalissimo accumulatosi nei seco-li, che solo negli ultimi decenni, venendo a contatto con la società dei consumi, è sta-to scalfito e in parte compromesso.Terra da sempre votata alla pastorizia, ma terra di pascoli magri, la zona montana delGennargentu è la regione con più bassa densità d’abitanti di tutta l’isola. Colpisce, nelpaesaggio, la quasi totale assenza di abitazioni rurali. La scarsa popolazione vive tuttaconcentrata in pochi grossi villaggi distanti fra loro. Questi, tutti di antica origine, spes-so isolati l’uno dall’altro, costituiscono ognuno un mondo a sé stante, con un propriodialetto, un proprio costume e proprie tradizioni. Villaggi dall’aspetto rude e pastorale, caratterizzati da vicoli stretti e scoscesi su cui siaffacciano le tipiche case barbaricine, nelle quali la scura severità delle facciate in pie-tra a vista è generalmente ingentilita da balconi, loggette, estrosi fumaioli, piccole cor-ti e frondosi pergolati. La recente edilizia pubblica e abitativa stride, spesso, con l’an-tico contesto in cui sorge e va rapidamente annullando la specificità di questi borghi.
Profilo dell’area
117
È un percorso di prevalente interesse pae-saggistico e naturalistico. Si svolge infat-ti lungo le pendici orientali del massicciodel Gennargentu, per lo più nell’ambitodella vasta area destinata a costituire ilgrande Parco nazionale del Gennargentu,consentendo di visitare alcuni dei siti dimaggior richiamo del futuro parco, ove an-cora vivono specie animali assai rare in Ita-lia. Le strade, anche se tortuose, sono tut-te asfaltate (meno la deviazione per la val-le di Lanaittu), a scarsa densità di trafficoe di eccezionale panoramicità.Da Nùoro, raggiunta in breve Oliena, si pro-segue in direzione di Dorgali, procedendoin una fertile vallata coltivata a vigne e oli-veti, ai piedi dell’erto versante settentrio-nale del Supramonte. Incontrata (5 km do-po Oliena) la deviazione per Su Gologone eper la valle di Lanaittu e superata su un pa-noramico viadotto la gola occupata dal la-go artificiale del Cedrino, ci si immette inbreve nella statale 125 Orientale Sarda. Aquesto punto, prima di proseguire a de-stra in direzione di Dorgali, si consiglia dideviare di pochi chilometri sulla sinistra perpoter visitare la suggestiva grotta di Ispi-nigoli, una tra le più grandi d’Italia.Dopo Dorgali, continuando lungo la statale125, si incontra subito sulla sinistra la de-viazione per Cala Gonone e si affronta iltratto più tortuoso ma più spettacolaredell’itinerario, raggiungendo Baunei do-po 46 km di curve e tornanti di grandiosapanoramicità. Usciti da Baunei, sempreseguendo la 125, si trova sulla sinistra ladeviazione asfaltata per Sa Pedra Longa;poi una rapida sequenza di curve in di-scesa, con ampie panoramiche sulla sot-tostante piana di Tortolì e sulla costa,
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
porta in pochi chilometri al livello del ma-re. Una breve deviazione sulla sinistraconsente di visitare il grazioso agglome-rato di Santa Maria Navarrese e di reim-mettersi subito dopo nella statale 125.Attraversati Lotzorai e Girasole, si rag-giungono rapidamente i centri di Tortolì eÀrbatax, quasi uniti fra loro.
Oliena*Documentata dal medioevo, Oliena (m379, ab. 7706) ebbe a partire dal XVII sec. unparticolare sviluppo collegato anche al-l’insediamento dei Gesuiti, ai quali fra l’al-tro si deve la creazione di scuole e l’intro-duzione dell’allevamento del baco da setae di più avanzati metodi di coltura dell’o-livo e della vite. Ancora oggi l’olivicolturae la viticoltura costituiscono una cospicuafonte di reddito; i vini, densi e forti, ap-prezzati e cantati anche da Gabriele D’An-nunzio, sono ricercati in tutta la Sarde-gna. Oliena è famosa anche per il suo ar-tigianato artistico e in particolare per ipregiati gioielli in filigrana e per gli sciallidi seta finemente ricamati. Il centro storico, per quanto alterato da re-centi interventi edilizi, continua a essereuno dei più caratteristici e interessantidell’isola. Nei vicoli tortuosi e stretti, suiquali sembra incombere la mole possentedel monte Corrasi (m 1463), si affaccianocasette dai muri bianchi di calce con pic-cole corti, scalette esterne, archi, pergolati,minuscoli balconi e aggraziati fumaiolidalle forme insolite: un’architettura spon-tanea e mossa cui si son rifatti gli architettidei moderni insediamenti turistici. Altroelemento caratterizzante del tessuto ur-bano di Oliena è il gran numero di chiese
8.1 Da Nùoro all’OgliastraItinerario lineare nel levante nuorese, dal capoluogo ad Àrbatax, km 121 deviazioni escluse(carta a pag. 119)

(ben undici!) che sorgono nell’abitato, perlo più di modeste dimensioni e di lineesemplici ma ingentilite da civettuoli cam-paniletti a vela. Fra queste si distinguono,all’ingresso del paese, la vecchia parroc-chiale di S. Maria, di origine duecentescama più volte rimaneggiata, e in corso Vit-torio Emanuele II l’attuale parrocchiale diS. Ignazio di Loyola, eretta dai Gesuiti neiprimi decenni del XVIII sec. accanto al loroseicentesco collegio; vi si conservano al-cune interessanti statue lignee seicente-sche e, in sagrestia, un bel retablo del ’500detto di S. Cristoforo.Fra gli edifici sacri minori risalta, in uno slar-go nella centrale via Deledda, la chiesa di S.Croce, caratterizzata da un rustico loggiato
8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
118
seguirsi di altipiani di calcare bianchissimo,quasi accecante, privi di corsi d’acqua e con ra-re macchie di vegetazione, nei quali si aprononumerose grotte ed emergono aspre cime roc-ciose: fra queste la punta Corrasi (m 1463), la piùalta del Supramonte. Su queste cime nidificanorapaci a forte rischio di estinzione, come ilgrifone e l’avvoltoio monaco.
Sorgente di Su Gologone*A circa 6 km da Oliena, sulla strada per Dor-gali, si incontra sulla destra una stradaasfaltata che conduce in soli 2 km alla sug-gestiva sorgente carsica di Su Gologone eall’omonimo hotel-ristorante, vero ‘san-tuario’ della gastronomia barbaricina.La sorgente è un potente fiotto d’acqua(300 litri al secondo) dato da un fiumesotterraneo che sgorga all’improvviso daun crepaccio naturale della roccia, de-fluendo in un profondo e limpidissimo la-ghetto sottostante. Un fitto boschetto dioleandri coloratissimi e, proprio sopra lasorgente, la rustica bianca chiesetta di No-stra Signora della Pietà esaltano la sugge-stione del luogo.
Poco prima della sorgente si apre sulla destrauna strada sterrata segnalata da cartelli turisticiche si inoltra nella valle di Lanaittu*, consen-tendo di raggiungere vari siti di eccezionaleinteresse. Si procede fra massicce dorsali cal-caree articolate in una serie interminabile di go-le, crepacci, guglie e paurosi inghiottitoi, ricchedi testimonianze preistoriche.In questa valle si aprono gli ingressi di alcunesuggestive grotte. Fra queste, Sa Oche (la voce),che pare derivi il nome dal rimbombo dellesue acque sotterranee, e Su Bentu (il vento), trale più lunghe d’Italia. Le due grotte, ricche di la-ghetti sotterranei e collegate fra loro, costitui-scono uno dei più interessanti fenomeni carsi-ci non solo d’Italia ma d’Europa.A breve distanza, più a sud, si apre una terzagrotta detta di Corbeddu, che deriva il nome daun famoso bandito ottocentesco che la utilizzòcome rifugio; scavi recenti vi hanno portatoalla luce importanti materiali paleontologici e re-sti umani risalenti al 15° millennio a.C. circa.Superata la valle di Lanaittu e proseguendoper un erto sentiero (è consigliabile servirsi diuna guida) si può raggiungere il monte Tìscali*(m 515), uno dei luoghi di maggior richiamo ditutto il Supramonte. È un’imponente rupe cal-carea alla cui sommità, in una grotta di cui èsprofondata la volta, fu costruito ( forse a ca-vallo tra il II e il I millennio a.C.) un piccolo vil-laggio nuragico**, visitabile e di affascinanteimpatto; imprendibile e pressoché invisibile, co-stituì probabilmente uno degli ultimi baluardidella resistenza delle popolazioni barbaricine al-l’invasione romana. I suoi resti, raccolti sotto l’a-la di roccia come in un grande tempio, sono an-cora di altissima suggestione.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
e da un campanile a vela a tre luci. Fra le feste a Oliena di particolare interesseè, la domenica di Pasqua, s’Incontru (l’In-contro): i simulacri del Cristo risorto edella Vergine vengono portati in proces-sione per le vie da due distinti cortei in co-stume fino a incontrarsi fra una folla esul-tante, mentre dai tetti e dalle finestre sispara a salve ripetutamente.
Apparentemente inaccessibile, con le sue can-dide pareti a picco sull’abitato, il Supramontedi Oliena* può essere raggiunto abbastanzaagevolmente. Una strada tortuosa e ripidissimama asfaltata e panoramica porta in pochi chi-lometri alla foresta di Maccione, una selva di lec-ci nella quale sorge un centro-rifugio dove sipossono assumere informazioni e contattarele guide per escursioni nella vasta area circo-stante. A quota più elevata infatti è tutto un sus-

Grotta di IspinigoliSi raggiunge dalla statale 125 percorrendouna breve deviazione (km 1.3) segnalata daun cartello turistico. È una delle più gran-di d’Italia, con uno sviluppo di circa 10 km,e la si visita su percorso attrezzato e illu-minato. L’ambiente di maggior suggestio-ne e interesse è un grande androne natu-rale, già frequentato in periodo nuragico epunico e quasi certamente utilizzato allo-ra come luogo di culto, al centro del qua-le troneggia un’enorme stalagmite di oltre38 m. Ai piedi si apre una profonda vora-gine detta l’abisso delle Vergini, dove for-se si celebravano in periodo punico ritipropiziatori con sacrifici umani: come ha
119
suggerito il ritrovamento, sul fondo dellavoragine, di ossa umane e monili femminilidi fattura punica, ora conservati presso ilMuseo archeologico di Dorgali.
DorgaliIn posizione dominante, a mezza costa delcalcareo monte Bàrdia (m 882) vicinissimoal mare, che tuttavia da qui non è visibile,Dorgali (m 390, ab. 8173) ha avuto negli ul-timi decenni un notevole e meritato svi-luppo turistico. Il paese accompagna infattia un mare incontaminato e a coste di in-comparabile bellezza un entroterra di ec-cezionale interesse paesistico e naturali-stico, ricco come pochi altri di importan-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

tessitura dei tappeti e nella lavora-zione del cuoio e della ceramica: se si
vogliono fare interessanti acquisti è suffi-ciente percorrere la centrale e sempre ani-mata via La Marmora.Sempre in via La Marmora, nei locali dellascuola elementare è anche visitabile il Mu-seo civico archeologico*, nel quale è espo-sta, accompagnata da chiari pannelli espli-cativi e da un’ampia documentazione fo-tografica dei siti, buona parte dei reperti diperiodo prenuragico, nuragico, fenicio-punico, romano e altomedievale restituitidai numerosi monumenti presenti nel ter-ritorio comunale.Al piano terra del Municipio, in viale Um-berto, ha invece sede il Museo “Salvatore
ti e belle testimonianze del passato.Nel centro storico, dove si conservanoancora alcuni begli esempi di architetturatradizionale in scura pietra scistosa e di-versi dignitosi palazzotti ottocenteschi,sorge un gran numero di chiesette, per lopiù seicentesche, di linee semplici ed es-senziali. Risalta, nel cuore dell’abitato,l’imponente settecentesca parrocchiale diS. Caterina, al cui interno si conservanodue maestose ancone lignee: una, nel tran-setto destro, è del 1770; l’altra, nel tran-setto sinistro, è stata invece realizzata nel1957 seguendo fedelmente il modello deigrandi retabli sardi del ’700. Di pregio sono i vini (soprattutto il Can-nonau) prodotti dalla locale Cantina so-ciale e i formaggi ovini e caprini prepara-ti dal locale caseificio o direttamente daipastori. Ma Dorgali vanta anche antiche tra-
dizioni artigiana-li, soprattutto
nell’orefice-ria, nella
8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
120
Fancello”: è dedicato all’omonimo artistanativo del luogo (1916-1941) la cui pro-duzione, nonostante sia morto giovanis-simo, comprende circa 400 pezzi cerami-ci, oltre disegni, tempere e incisioni.
Cala Gonone*Dista 9 km da Dorgali e si raggiunge per-correndo la strada che si dirama dalla125, la quale, superata una breve galleriascavata nel monte Bàrdia, offre d’improv-viso splendide panoramiche sulla sugge-stiva baia e sull’abitato.Piccolo borgo di pescatori (m 23) svilup-patosi attorno a un porticciolo da cui inpassato si imbarcavano legna, carbone eformaggio, Cala Gonone era già nell’Otto-cento meta tradizionale di villeggiaturaestiva per la borghesia nuorese. Il recentesviluppo turistico lo ha reso un impor-tante centro balneare dotato di una buonaorganizzazione alberghiera. Il suo piccoloporto è base di partenza per i battelli checon corse frequenti portano alle vicinesplendide cale accessibili solo dal mare ealla famosa Grotta del Bue Marino.
Cala Luna* si stende 7 km a sud di Cala Gono-ne e può essere raggiunta solo via mare. È do-tata di un punto di ristoro e d’estate è collega-ta da un regolare servizio di battelli con par-tenza da Cala Gonone e da Santa Maria Navar-rese. Un candido arenile lungo circa 800 m, unpiccolo stagno cinto da un fitto boschetto di co-loratissimi oleandri, gli imbocchi di otto grot-toni alla base di un’erta parete rocciosa ne fan-no una spiaggia delle più belle.
La Grotta del Bue Marino** si apre circa 5 kma sud di Cala Gonone ed è raggiungibile graziea un regolare servizio di battelli con partenza daquesto centro. È una delle più ampie e sugge-stive della Sardegna. Deriva il nome dal fatto diaver costituito uno degli ultimi rifugi mediter-ranei della foca monaca (nel dialetto locale “suboe marinu”). Ha uno sviluppo di circa 5 km edè visitabile su percorso attrezzato e illuminatoper circa 900 m. Le infinite fantastiche concre-zioni che si specchiano nei laghetti interni crea-no effetti di grande suggestione e spettacolarità.
L’ Orientale Sarda da Dorgali a BauneiDa Dorgali si raggiunge Baunei percor-rendo il tratto* più panoramico e sugge-stivo della statale 125 Orientale Sarda: 46km di curve continue in un paesaggio sel-vaggio e solitario, fra picchi dolomitici,gole profonde e ampie valli in cui la mac-chia mediterranea si alterna a boschi dilecci fittissimi e cupi. Un ambiente incon-taminato in cui è pressoché assente ognitraccia di presenza umana: alcune case
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

cantoniere ormai in abbandono e un al-bergo-rifugio al passo di Genna Sìlana (m1017), che può costituire la base di par-tenza per interessanti escursioni a piedinel sovrastante Supramonte di Urzulei; inparticolare nella gola di Gorropu**, unimpressionante canyon scavato dalla for-za delle acque del rio Flumineddu, carat-terizzato da pareti a picco che raggiungo-no un’altezza di oltre 200 metri.
BauneiCoreograficamente sovrastato da un ripi-do muraglione calcareo, è, nonostante lasua vicinanza al mare, un borgo (m 480, ab.4006) dall’aspetto montano. Da semprepaese di pastori – la tradizione lo vuolefondato da un capraro – oggi Baunei è im-pegnato nella valorizzazione turistica del-le sue coste, splendide e quasi inconta-minate, attorno alle quali si sta proce-dendo nella realizzazione di un parco na-turale marino. Di grande bellezza è ancheil vasto entroterra e in particolare il Golgo,selvaggio e spopolato altopiano calcareosopra l’abitato.Nel caratteristico, scosceso centro stori-co risalta, lungo la via principale, la par-rocchiale di S. Nicola, di impianto seicen-tesco ma ampiamente rimaneggiata, conuna piacevole copertura cupolata e con unportale ornato, staccato dal corpo dellachiesa, che funge da finta facciata.
Percorrendo un’apposita strada asfaltata di 4km che si stacca dalla statale 125, è raggiungi-bile Sa Pedra Longa, caratteristico, aguzzo pin-nacolo alto 128 m che si eleva dal mare, slan-ciato come una guglia. Alle sue spalle le cime deimonti Argennas (m 711), Giradili (m 757), Gin-nircu (m 811), che cadono anch’esse scoscesesulle acque del Tirreno.
121
Santa Maria NavarreseRidente località turisti-co-balneare (m 9), svi-luppatasi attorno all’o-monima rustica chiesa*di origine medievaleche la tradizione vuoleedificata dalla figlia delre di Navarra per adem-piere a un voto fatto du-rante un naufragio. Ac-canto troneggia un oli-vastro millenario di ec-cezionali dimensioni; abreve distanza è ben vi-sibile una massiccia tor-re seicentesca. Il sito èsplendido: al largo del-
la rada si possono ammirare le rosse roc-ce porfiriche dell’isola dell’Ogliastra.
TortolìAntico capoluogo del marchesato di Quir-ra e sede vescovile fino al 1927, si pre-senta oggi come una cittadina ordinata,moderna e particolarmente attiva (m 13,ab. 9673). Nel centro storico conserva inalcuni dignitosi palazzotti sette-ottocen-teschi, nell’antico Palazzo vescovile com-pletato da una curiosa copertura cupola-ta vagamente arabeggiante e soprattuttonella ex cattedrale di S. Andrea, di forme ba-rocche del tardo ’700, tracce rappresen-tative e importanti del suo passato.Negli ultimi anni in diverse piazze e stradedella cittadina sono state realizzate im-ponenti opere plastiche ad opera di artistidi fama nazionale e internazionale. È solol’inizio di un’operazione di più ampio re-spiro mirante alla creazione di un museod’arte contemporanea a cielo aperto chedovrebbe estendersi anche al territorio. A nord dell’abitato si trova lo stagno di Tor-tolì, uno dei più pescosi dell’isola e digrande importanza per l’avifauna palu-stre che vi stanzia soprattutto durante ilperiodo invernale.
ÀrbataxSviluppatosi alla base del pittoresco capoBellavista, attorno a una massiccia torrecostiera del ’600, è oggi un importantescalo portuale e un vivace centro turisti-co (m 10), praticamente unito a Tortolìper il notevole sviluppo edilizio degli ul-timi anni. È noto soprattutto per le sce-nografiche scogliere* di porfido rosso cheemergono dal mare nei pressi del porto. Digrande suggestione è il panorama che si
8.1 Da Dorgali ad Àrbatax
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

può ammirare dal belvedere presso il fa-ro del capo Bellavista (m 150). Àrbatax, ol-tre che scalo di linee di navigazione (Ca-gliari-Genova e Cagliari-Civitavecchia), èstazione terminale della linea ferroviariaCagliari-Àrbatax: una ferrovia a scarta-
122
mento ridotto dal tracciato incredibil-mente scenografico che, con partenza daÀrbatax, può essere percorsa per un trat-to anche su un trenino turistico con lo-comotiva a vapore: molto popolare, è co-nosciuto come “Trenino verde”.
8.2 L’Ogliastra e le BarbàgieItinerario lineare da Tortolì a Sòrgono, lungo le pendici sud del Gennargentu, km 130 esclu-se le deviazioni (carta a pag. 119)
Presenta un notevole interesse antropo-logico, perché consente di visitare alcunicentri fra i più caratteristici e conservati-vi della Sardegna. Ma il motivo di mag-gior interesse è dato dalla spettacolaritàdei panorami, grandiosi e sempre vari: siva dagli scenografici torrioni calcarei oglia-strini noti come “tacchi” alle profonde epaurose gole della Barbàgia di Seùlo, daifitti boschi di castagni della Barbàgia diBelvì ai dolci paesaggi collinari del più oc-cidentale Mandrolisai.La bellezza e la varietà dei panorami, uni-tamente alla bassissima densità di traffico,rendono meno pesante la tortuosità (ve-ramente notevole) del tracciato, che tut-tavia si svolge interamente su strade asfal-tate e solitamente ben tenute.A Tortolì si imbocca la statale 198 che,procedendo in un dolce paesaggio colli-nare, attraversa Lanusei; poi si viaggia inun ambiente più alpestre e si incontra sul-la sinistra la deviazione per la foresta di Se-leni. La strada diviene di straordinaria pa-noramicità quando, costeggiando la sco-scesa valle del rio Pardu, offre splendide vi-ste sul suggestivo muraglione calcareodei tacchi con il centro di Ulàssai e sui
monti del Gennargentu, davanti ai qualispicca l’inconfondibile slanciato profilodel monte Perda Liana.Attraversati i tre agglomerati di Gairo, siprocede con visuali sempre più ampie sul-l’accidentato altopiano dei tacchi di Jerzue si costeggia sulla destra una suggestivasuccessione di cocuzzoli dai fianchi diru-pati, dall’aspetto più simile a castelli dirutiche a rocce naturali.Si giunge così al valico di Arcuerì, da cui sidiparte sulla destra la strada per la forestadi Montarbu e per il monte Perda Liana.Poi, 8 km dopo Seùi, si lascia la statale198 e si svolta a destra per Seùlo. Da que-sto centro si raggiunge Gadoni percor-rendo una nuova strada di eccezionalepanoramicità e ci si immette poi nella sta-tale 295 che, correndo all’ombra di fitti e ri-lassanti boschi di castagni, porta ad Arit-zo e poi a Belvì, dove si imbocca una scor-revole provinciale che conduce ad Atzara.Da qui si segue la statale 128 che, corren-do in un paesaggio collinare coltivato a vi-gneti, offre la possibilità di deviare a sini-stra (lungo un’altra statale, la 388 del Man-drolisai) per il santuario campestre di S.Mauro e porta in breve a Sòrgono.
8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

LanuseiGraziosa e pittoresca cittadina (m 595,ab. 6189) immersa nel verde, è quasi so-spesa fra il mare e la montagna: l’abitato sistende in vista del Tirreno sul costone diun ripido colle.Per circa un quarantennio, nell’Ottocento,Lanusei fu capoluogo della provincia diOgliastra, poi soppressa; conserva anco-ra i segni dell’autorevole passato nell’im-pianto urbanistico del centro storico, in al-cuni palazzotti di bella architettura e nel-le numerose targhe che ricordano il pas-saggio di personaggi illustri; una ram-menta l’origine lanuseina della famiglia diGoffredo Mameli, l’autore dell’inno nazio-nale italiano.La cattedrale di S. Maria Maddalena, dei pri-mi del Novecento, ha linee semplici magradevoli. Sempre del XX secolo è anche lamaestosa chiesa di S. Giovanni Bosco, checon la sua alta cupola caratterizza il pro-filo urbano. Di un certo interesse è il Museodiocesano dell’Ogliastra che ha sede alprimo piano del Seminario vescovile invia Roma. È dedicato alla storia dell’O-gliastra e della diocesi. Unitamente ad al-cuni reperti archeologici, sono espostesuppellettili liturgiche, scritti medievali eimportanti documenti.
Dalla statale 198, percorrendo una breve stra-da asfaltata, si accede alla foresta di Seleni*, alecci, fittissima e cupa, che si stende su un al-topiano a 1000 m in un ambiente quasi incon-taminato. Le sorgenti, freschissime, sono par-ticolarmente numerose e la fauna abbondante:cinghiali, volpi, martore, poiane e altri rapaci.Poco distante dalla zona di sosta è facilmenteraggiungibile, seguendo le indicazioni dei car-
8.2 L’Ogliastra
123
telli turistici, quanto resta di un villaggio nura-gico comprendente alcune capanne e tombe digiganti; conserva suggestione per la bellezzadell’ambiente naturale che lo circonda.
GàiroÈ un comune formato da tre agglomeratidistanti fra loro. Il primo che si incontra èGàiro Sant’Elena (m 685), sede del comu-ne (ab. 1765), un centro realizzato per ini-ziativa statale negli anni cinquanta peraccogliere la popolazione del vecchio abi-tato, completamente abbandonato in se-guito agli smottamenti del terreno deter-minati dalle eccezionali piogge autunnalidel 1951 e 1953. Il nuovo centro è in posi-zione di grande panoramicità.Dopo 2 km di ripidissimi ma suggestivitornanti si incontra Gàiro Vecchio*; ag-grappato al fianco ripido della montagna,è un vero paese fantasma di grande fasci-no. Fra le case semicrollate e purtropposaccheggiate dei particolari architettoni-ci più significativi, risalta, ancora in di-screto stato di conservazione, la parroc-chiale di S. Elena, dalle gradevoli forme ot-tocentesche.Il terzo agglomerato del comune è GàiroScalo, o Taquisara (m 760): un centro pic-colo e raccolto sviluppatosi attorno a unastazioncina delle Ferrovie Complementa-ri Sarde, che si stende in una bella gola frail Taccu Isara (m 935) e la Perda Irsu (m1091): ripidi tacchi calcarei ricchi di grot-te, fra le quali particolarmente suggestivala grotta Taquisara o del Marmo, formata dadiverse gallerie ricche di concrezioni.
Circa 500 m dopo il valico di Arcuerì si dipartesulla destra una strada provinciale asfaltataper il lago alto del Flumendosa: è una deviazionelunga (oltre 30 km) ma di grande interesse pae-saggistico e naturalistico, che si consiglia vi-vamente. Lasciata subito a sinistra la chiesa del-la Madonna del Carmelo, nella quale si svolge,la terza domenica di luglio, una suggestiva festacampestre, dopo 6 km si incontra sulla destrala strada che porta alla foresta demaniale diMontarbu*, una delle meglio conservate del-l’isola. È un fitto groviglio di lecci, roveri, fras-sini, agrifogli e tassi che si stende per circa 30km2 a 1000 m d’altitudine, ospitando una faunaricchissima. Presso la caserma della Forestale,facilmente raggiungibile in auto, si può ottene-re ogni informazione su possibilità, modalità ecaratteri della visita.La provinciale prosegue costeggiando sulla de-stra l’alta muraglia calcarea del monte Tònne-ri (m 1323) e rasentando il nuraghe Ardasai, po-sto a dominio della profonda valle del Flu-mendosa. Si prosegue poi in vista della slan-ciata sagoma del monte Perda Liana* (m 1293),il più famoso e spettacolare dei “tacchi”, che
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

maestoso come un castello troneggia su un ca-ratteristico rilievo conico di roccia scistosa.Ai suoi piedi, secondo la tradizione, celebravanole loro feste gli “Ilienses”, il fiero popolo sardodal cui nome sarebbe derivato quello dellamontagna.Il lago alto del Flumendosa è un ampio bacino ar-tificiale che, come un fiordo, si distende fraboschi e foreste ai piedi del Gennargentu.
SeùiPrincipale centro della Barbàgia di Seùlo(m 820, ab. 1630), col lontano sfondo, oltreil Flumendosa, del Gennargentu. Attual-mente poggia la propria economia preva-lentemente sull’agricoltura e sull’alleva-mento, ma vanta una sua tradizione mi-neraria legata allo sfruttamento di un ric-co giacimento di antracite, attività inizia-tasi alla fine dell’800 e protrattasi sinoagli anni cinquanta del Novecento. La vec-chia laveria della miniera, a 3 km dal pae-se, è tuttora visibile e costituisce un inte-ressante esempio di archeologia indu-striale. Alla tradizione mineraria di questacomunità è dedicato un settore del localeMuseo della Civiltà contadina, pastorale, ar-tigianale, della Miniera e dell’Emigrante,che ha sede in un’aggraziata palazzina li-berty nella centrale via Roma.Nel centro storico, fra dignitosi palazzottiottocenteschi e begli esempi di rustica ar-chitettura locale in pietra scistosa, con ar-chi, balconate lignee e tetti in coppo, è in-teressante in via Sassari il vecchio edificiodel carcere baronale. Sorto agli inizi del’700 e sottoposto all’autorità del duca di
8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
Mandas, fu utilizzato ancora in epoca sa-bauda e poi fino al 1975 come carcere man-damentale; è stato restaurato rispettan-do le originarie strutture interne e arreda-to secondo il gusto tradizionale barbari-cino dell’800. La settecentesca parrocchialedi S. Maria Maddalena, profondamente mo-dificata nella sua struttura originaria, con-serva all’interno un bell’altare ligneo e unfonte battesimale seicenteschi.
Percorrendo un’apposita breve strada sterrata,che si diparte dalla provinciale per Seùlo, si ar-riva alla grotta di Is Janas, aperta in uno splen-dido scenario naturale; circondata da una fittaforesta di lecci, si sviluppa per oltre 200 m for-mando vari e suggestivi ambienti e inglobandoun laghetto sotterraneo. L’ambiente più ampioe spettacolare, dalla cui volta pendono infinitestalattiti, con pareti che paiono quasi decorateda preziosi merletti, è detto “sa ’omu ’e is janas”(la casa delle fate) per la presenza di tre gran-di masse stalagmitiche che, secondo la leg-genda, sarebbero appunto tre fate pietrificate.La grotta è aperta al pubblico per visite con gui-da su percorso illuminato.
SeùloÈ un piccolo borgo (m 799, ab. 1058) aeconomia agro-pastorale che sorge, cir-condato da gole profonde e da brulli tor-rioni calcarei, in un paesaggio aspro e sel-vaggio appena ingentilito da piccole vi-gne impiantate tutt’attorno al paese conuna paziente opera di terrazzamento. Daqueste vigne si ricava un corposo vinorosso ad alta gradazione alcolica molto ri-cercato nei paesi del circondario.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Il centro, che in passato ebbe una certa im-portanza, sì da dare il nome alla più meri-dionale delle Barbàgie, conserva nella par-rocchiale dell’Immacolata, risalente al XVIsec. ma varie volte rimaneggiata, il belportale gotico originario; non distante dalpaese è la seicentesca, campestre chiesadei Ss. Cosma e Damiano, con portale e ro-sone entrambi tardogotici.
Da Seùlo a GadoniI due paesi sono collegati da una stradaprovinciale che, già tortuosissima e a fon-do naturale, un recente ammodernamen-to del tracciato ha reso più breve e scor-revole senza nulla togliere alla sua pano-ramicità. La strada discende il ciglionedella profonda gola del Flumendosa, chesegna un netto confine fra la Barbàgia diSeùlo e quella di Belvì, offrendo grandiosiscenari su torrioni e altipiani calcarei, e su-pera il fiume su un ardito viadotto, il più al-to dell’isola, dal quale la vista spazia perampio tratto sulla profonda forra scavatadalle acque. Una serie di tornanti in salita,in un ambiente più rilassante, porta a Ga-doni, borgo agricolo (m 696, ab. 1002) cre-sciuto attorno alla cinquecentesca par-rocchiale dell’Assunta.
AritzoIl paese (m 796, ab. 1548), cinto da fitti ca-stagneti, è la più rinomata località di vil-leggiatura montana della Sardegna.Percorrendo il centrale corso Umberto I sinota sulla destra la gradevole parrocchia-
8.2 Da Seùi a Belvì
125
le di S. Michele Arcangelo, risalente al XIVsec. ma ampiamente rimaneggiata; all’in-terno sono di qualche pregio una statua li-gnea seicentesca raffigurante S. Cristoforo,un gruppo scultoreo intagliato policromodegli inizi del ’700 rappresentante la Pietàe alcune moderne tele del pittore localeAntonio Mura.Altri edifici degni di nota sono, semprenel corso Umberto I, la dimora patriziadegli Arangino, edificata ai primi del ’900in linee neogotiche, e, in una ripida scali-nata vicino alla parrocchiale, una massic-cia e severa costruzione in scura pietra sci-stosa, nata nel XVII sec. come carcere ba-ronale e utilizzata come carcere manda-mentale fino all’ultimo dopoguerra. Neilocali della scuola elementare è provvi-soriamente esposta, in attesa di avere piùconsona sistemazione in un apposito edi-ficio in fase di ultimazione nel suggestivoparco comunale di Pastissu, la Raccolta Et-nografica del Comune di Aritzo. È divisa indue sezioni, la prima dedicata all’abbi-gliamento tradizionale locale, la secondaalle arti e ai mestieri tipici del luogo, macomprende anche diversi interessanti og-getti relativi alla sfera magico-religiosa.Fra le produzioni artigianali di Aritzo èdegna di nota quella delle cassepanche in-tagliate in legno di castagno.
Meta di una piacevole passeggiata fra i boschipuò essere il monte Texile (m 975: raggiungibi-le anche in macchina), uno scenografico rilievocalcareo dal curioso profilo che ricorda la for-ma di un fungo e che si erge solitario di fronteal paese caratterizzando il paesaggio.
BelvìPiccolo e tranquillo borgo (m 660, ab. 794)a economia agro-pastorale, rivestì in pas-sato una certa importanza, tanto da dareil nome alla regione circostante. Come nella vicina Aritzo, a Belvì si produceuna gran quantità di nocciole, castagne esoprattutto ciliegie, per commercializzarele quali si svolge tutti gli anni, in una do-menica di giugno, la Sagra delle Ciliegie ac-compagnata da varie manifestazioni fol-cloristiche. Meritevole di visita è un pic-colo Museo di Scienze naturali, che ha se-de in via S. Sebastiano; comprende una se-zione di mineralogia, una di paleontologiae una di entomologia, più una nutrita col-lezione di animali impagliati tipici della fau-na sarda, inclusi alcuni rari rapaci.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

AtzaraDisteso in un dolce paesaggio collinareintensamente coltivato a vigneti, è un bor-go di origine medievale (m 540, ab. 1351)che conserva ancora abbastanza intattol’antico tessuto urbano, sviluppatosi sulnucleo dell’antica Villa di Leonisa. È so-prattutto nei rioni noti come su Frescu e saMontiga ’e josso che si rinvengono, negliedifici, tracce dell’epoca aragonese. Inuno slargo nei pressi della via principale ri-salta la cinquecentesca parrocchiale di S.Antioco in stile gotico aragonese: alla so-bria facciata merlata impreziosita da un ro-sone in trachite è addossata una massic-cia torre campanaria di linee tardoroma-niche; all’interno si conservano due pre-gevoli altari lignei di gusto barocco, unastatua lignea della Madonna col Bambinodel XVI sec. e preziose argenterie cinque-centesche. Altro edificio di un certo inte-resse è, in un vicolo vicino, l’antica casaparrocchiale, con finestre in trachite fine-mente lavorata di stile aragonese.In via Dante, in una vecchia casa padronalerecentemente ristrutturata, ha sede la Pi-nacoteca comunale d’Arte contemporanea:comprende oltre 50 opere di quasi tutti iprincipali artisti sardi del ’900, oltre ad al-
126
cune tele di pittori spagnoliche operarono ad Atzaranei primi decenni dellostesso secolo. Particolarerilevanza ha in questo pae-se la produzione artigiana-le di tappeti e arazzi fra ipiù belli dell’isola.
Il santuario di S. Mauro*, chesorge lungo la statale 388 perOrtueri, è tra i santuari cam-pestri più interessanti dell’i-sola. Risalente al XVI sec., as-socia armoniosamente formegotiche e manieristiche. È aunica navata con volta a bottee presenta una piacevole fac-ciata merlata in trachite gri-
gia impreziosita da un elegante portone rina-scimentale e da un bellissimo rosone gotico digrandi dimensioni scolpito in un unico blocco.La grande aula rettangolare interna è separatada un arco a tutto sesto dal presbiterio, so-praelevato e chiuso da una balustrata, an-ch’essa in trachite. Addossato alla chiesa etutt’attorno a essa si è andato sviluppando neltempo un caratteristico villaggetto di “muri-stènes”, le rustiche e minuscole casette altrovechiamate cumbessìas che fungono da ricoveroai pellegrini nei giorni della novena e della festadi S. Mauro, che si svolge il 26 maggio. L’insie-me, anche per il dolce paesaggio collinare chelo circonda, è di indubbia suggestione.
SòrgonoGiace in un’ampia conca circondato da bo-schi e vigneti, ed è il centro principale (m688, ab. 2024) del Mandrolisai, sede di uffi-ci amministrativi e di varie strutture per ser-vizi sociali. Nel centro storico si conserva-no alcuni begli esempi di rustica architet-tura locale e qualche dignitoso palazzottoottocentesco. La parrocchiale di S. Maria As-sunta, in una piazza lungo la via principale,conserva dell’originario impianto tardo-gotico solo il campanile del 1580.Rinomati i suoi vini, e in particolare il Can-nonau, prodotto dalla locale Cantina so-ciale e molto ricercato.
8.3 Tra Nùoro e il GennargentuItinerario circolare nel paesaggio semimontano della Barbàgia di Ollolai, km 158 deviazioniescluse (carta a pag. 119)
Il viaggio inizia e si conclude a Nùoro, cor-rendo lungo le pendici settentrionali e oc-cidentali del Gennargentu, e consentendodi raggiungerne abbastanza agevolmentele cime. Si svolge quasi interamente nellaBarbàgia di Ollolai, una regione da semprevotata alla pastorizia, nella quale è più vi-
va che altrove quella ‘civiltà sarda’ che siesprime, oltre che nella fierezza della gen-te, negli splendidi costumi, nella raffinataproduzione artigianale, nella originalitàdella musica e del canto, nelle numerose fe-ste dal sapore antico.Grande è anche l’interesse naturalistico
8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

e paesaggistico dell’itinerario, che pro-cede su strade asfaltate, a tratti moltotortuose, ma sempre di emozionante pa-noramicità.Da Nùoro si raggiunge Orgòsolo percor-rendo la strada che corre nella fertile val-le di Locòe; all’uscita del paese si può de-viare per il Supramonte e per la foresta diMontes. Raggiunta Mamoiada, ci si im-mette nella statale 389 che porta a Fonnicorrendo in un ambiente tipicamente pa-storale fra leccete e ampie distese a pa-scolo punteggiate da querce secolari. Iltratto Fonni-Dèsulo è il più panoramico ditutto il percorso: lasciata sulla sinistrauna deviazione per il monte Spada e per ilBruncu Spina, si procede tortuosamentefra fitti boschi solcati in inverno da sug-gestive cascatelle, fino a raggiungere ilpasso di Tascusì (m 1245), da cui è possi-bile raggiungere le cime del Gennargentu.Sono poi i castagneti a ombreggiare le in-terminabili curve che portano prima aDèsulo e poi a Tonara. Subito dopo ci si im-mette nella statale 128 che, oltre Ovodda,costeggia il lago artificiale di Gùsana e
8.3 Da Nùoro a Orgòsolo
127
porta a Gavoi. Di qui si procede quasisempre in vista dell’inconfondibile sagomadel monte Gonare, di natura granitica,perfettamente conico e coronato dall’an-tico santuario che, come un fortilizio, sor-ge sulla sua cima aguzza.Superato Sarule, noto soprattutto per isuoi tappeti tradizionali, si giunge a Oranie quindi a Oniferi. Usciti da questo borgo,poco prima di immettersi sulla strada ascorrimento veloce che riporta a Nùoro, èpossibile visitare, in un basso ciglioneroccioso, l’interessante necropoli delledomus de janas di Sas Concas.
OrgòsoloCentro di antichissima vocazione pasto-rale (m 620, ab. 4629), fra i più conserva-tivi del Nuorese, diventato quasi il paese-simbolo del mondo culturale barbarici-no. L’abitato, sebbene profondamente al-terato negli ultimi decenni, è caratterizzatonella parte più antica da ripidi e tortuosivicoli su cui si affacciano case rustiche edessenziali, a volte ingentilite da una piccolaloggia o da un pergolato.
Mural è parola spagnola. In realtà vienedal Messico degli anni venti, dove DavidAlfaro Siqueiros usò la pittura su muroper trasmettere i messaggi della rivolu-zione. Una pittura politica, una forma dipropaganda.Il 1968 è l’anno di nascita del muralismosardo. Il giorno del Corpus Domini a SanSperate, un villaggio contadino della pe-riferia cagliaritana, lo scultore PinuccioSciola e il pittore Antonio Sini comincia-rono, con amici e allievi, a dipingere suimuri delle case del paese.Che divenne, secondo il loroprogetto, un Paese-museo.L’anno dopo, in piena “con-testazione”, Francesco DelCasino, professore di dise-gno a Orgòsolo, produsseuna serie di manifesti (di-segnati, ma più spesso inci-si in xilografia) che ripren-devano i modi della pitturamessicana per dare voce aidrammatici problemi delpaese. Nel 1975, in occasio-ne del trentennale della Li-berazione, Del Casino e isuoi allievi trasferironoquelle immagini sui muri di
Orgòsolo: ora i soggetti erano più diret-tamente legati alla protesta del paese neiconfronti dello Stato, accanto alle figures’imponevano gli slogan, scritti quasi tut-ti in sardo. Orgòsolo conserva ancoraoggi molti dei suoi murales (nella foto), ri-cordo di un periodo “caldo” della vitacomunitaria ma anche sintesi efficace dialcuni temi ancora sul tappeto. Anchealtri paesi della Barbàgia (Bitti) e dellostesso Campidano (Serramanna, Villa-mar) parteciparono al movimento.
I murales di Orgòsolo
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
128
Una nota di colore nei grigi muri del cen-tro storico è data dal gran numero di mu-rales (circa 150), per lo più risalenti agli an-ni settanta: generalmente di contenutopolitico-sociale, documentano in manieraespressiva e immediata il contradditto-rio impatto fra vecchio mondo pastoralee nuove realtà contemporanee.Fra le diverse chiese dell’abitato sono di uncerto interesse il rustico oratorio di S. Cro-ce, risalente agli ultimi del ’500, e la sei-centesca chiesa dell’Assunta, da dove par-te, il giorno di Ferragosto, una suggestiva
processione accom-pagnata da un grannumero di cavalieri incostume che dopo iriti religiosi si esibi-scono in spericolateacrobazie equestri. Lafesta dell’Assunta* èuno dei più importan-ti appuntamenti fol-cloristici della Barbà-gia. Costituisce l’oc-casione più adatta perpoter ammirare losplendido costumetradizionale delle don-ne di Orgòsolo, unodei più particolari del-l’isola, con il grem-biule ricchissimo diricami geometrici a vi-vaci colori (in sardo,“antalena”) e col tipi-co fazzoletto di setacolor zafferano (“sulionzu”), acconciatoin maniera da coprirequasi interamente il
volto, e da far intravedere solo gli occhi.
Foresta di MontesAll’uscita di Orgòsolo si imbocca sulla si-nistra la provinciale 46 che porta dopo cir-ca 6 km all’altopiano di Pratobello, carat-terizzato da ampi pascoli intervallati da ve-re oasi di querce secolari. Giunti a un bivio,si prosegue dritto in un ambiente spogliopunteggiato da rocce affioranti e da quer-ce isolate. Il paesaggio cambia radical-mente quando, dopo 17 km da Orgòsolo,si giunge alla caserma della Forestale diFuntana Bona (m 1082), nella vasta areadella foresta demaniale di Montes, a bre-ve distanza dalla sorgente Funtana Bona edal sovrastante rilievo calcareo di monteFumai, ricco di grotte utilizzate un tempocome rifugio da pastori e banditi.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Il 16 gennaio in tutta la Sardegna “in-terna” è la festa dei fuochi, omaggio asant’Antonio Abate. La leggenda sacralo vuole “inventore” del fuoco, che egliportò dall’inferno agli uomini. Al centrodel paese si ammucchiano fascine in-torno a un grande albero (possibilmentevecchio e ormai cavo, scelto per l’oc-casione) e intorno al grande incendio siballa, si ride, si mangia e si beve. È l’a-pertura ufficia-le del Carnevalesardo. In quellostesso giornoescono a Ma-moiada i mamu-thones (la fotone raffigura u-no). Mascheremisteriose, già acominciare dalnome. Indossanola mastrucadei pa-stori, col vello ri-volto verso l’e-sterno, e sopra diessa una doppiacorona di sonagli,più grandi sullespalle, più piccolisul petto. Metto-no sul viso sa bi-sera, una ma-schera di legnorozzamente inta-gliato e tinto dinero, fissata daun grande faz-zoletto che copre anche il berretto, subonette. Escono per le vie del paese,avanzando con un passo cadenzato esussultante che fa squillare i sonagli.Dietro e accanto a loro, vestiti con unavivida blusa rossa e a viso scoperto,gli issokatores, i lanciatori di soka, il lac-cio di pelle usato per prendere il be-stiame. Lanciano la soka con grandeabilità, catturano gli spettatori e nondi rado anche gli stessi mamuthones.Le interpretazioni del rito (perché dirito si tratta) sono tante: forse un corteodi prigionieri e i loro vincitori. Nel Car-nevale di Orotelli escono i thurpos, tut-ti vestiti di nero, e a Ottana le masche-re beffarde dei boes e dei merdùles, im-pegnati in goffi duelli rusticani.
Il Carnevale

Dalla caserma della Forestale, al cui in-terno è raccolta un’interessante docu-mentazione delle varietà faunistiche e bo-taniche del territorio (qui è in atto un pro-gramma di ripopolamento dei mufloni), èvietato alle auto di proseguire. È però pos-sibile effettuare, in compagnia o dietro in-dicazioni delle guardie forestali, escur-sioni di estremo interesse: si può rag-giungere una foresta di lecci secolari (altipiù di 80 m) che, caso unico in Italia, nonè mai stata sottoposta a taglio; o l’impo-nente torrione calcareo di monte Novo S.Giovanni (m 1316) che, isolato, si ergedalla foresta con pareti a picco di oltre 70metri. Dalla sommità del torrione, gran-diosa roccaforte naturale abitata nell’an-tichità, la vista spazia sconfinata su granparte dei monti del Nuorese.
MamoiadaGrosso borgo (m 644, ab. 2618) a economiapastorale già documentato nel medioe-vo. Nel centro storico, che conserva qual-che antica abitazione con decorazioni diderivazione gotico-aragonese, risalta l’im-ponente cupola della parrocchiale di NostraSignora di Loreto, con rara pianta circola-re e piacevoli affreschi di gusto popolare-sco all’interno.Mamoiada è nota soprattutto per il suoCarnevale tradizionale caratterizzato dal-la presenza dei “mamuthones”, misterio-si personaggi vestiti di pelli, col viso co-perto da tragiche maschere lignee e conpesanti grappoli di campanacci sulle spal-le, che sfilano per le vie del paese mesta-mente e con passo cadenzato.
FonniQuesto grosso borgo (m 1000, ab. 4517)dalla salda economia pastorale si stendesu un pianoro granitico alle falde setten-trionali del Gennargentu: la posizione e l’al-titudine (è il comune più elevato della Sar-degna) ne hanno favorito lo sviluppo tu-ristico, facendone una rinomata stazionedi sport invernali, ben attrezzata.Sviluppatosi in un sito già frequentato inepoca preistorica e romana e documen-tato dal medioevo, Fonni conobbe a par-tire dal XVII sec. un particolare sviluppoeconomico e civile collegato anche all’in-sediamento di una comunità di France-scani e divenne presto il principale centrodella zona, soppiantando anche Ollolai, ilvicino borgo da cui deriva il nome di que-sta parte della Barbàgia.Nel centro storico, che conserva qualchebell’esempio di rustica architettura tra-
8.3 Da Orgòsolo a Fonni e alle cime del Gennargentu
129
dizionale in granito a vista, risaltano i dueprincipali monumenti: la parrocchiale di S.Giovanni Battista, che conserva traccedell’originaria struttura tardogotica, e labasilica della Madonna dei Martiri*. Que-sta, con l’annesso convento dei France-scani, è così intitolata perché accoglie unvenerato simulacro della Vergine realizzatoa Roma alla fine del XVII sec. con un impa-sto che si diceva ottenuto dalla frantu-mazione di ossa e reliquie di martiri.Il vasto complesso sorge nel cuore delpaese in un ampio piazzale cinto da cum-bessìas, i rustici ricoveri per i pellegrini. Lachiesa, originariamente intitolata alla SS.Trinità, risale agli inizi del ’600, ma venneampiamente rimaneggiata, assumendo l’a-spetto attuale fra 1702 e 1716. La struttu-ra dell’edificio e la pregevolezza degli in-serti e degli arredi, prevalentemente set-tecenteschi, fanno di questa chiesa uno deimaggiori esempi tardobarocchi della Sar-degna; di particolare interesse è la vastaserie di tempere parietali eseguite dai set-tecenteschi pittori locali Pietro Antonio eGregorio Are, raffiguranti con modi po-polareschi scene della prima diffusionedel cristianesimo nell’isola.
Le cime del GennargentuLa strada tra Fonni e Dèsulo corre fra imonti del Gennargentu, che hanno morfo-logia poco aspra. Le cime, dalle caratteri-stiche tonalità argentee, sono in generedolci, tondeggianti e quasi spoglie. La fit-ta vegetazione di alberi d’alto fusto dellependici si dirada man mano che aumental’altitudine, fino a divenire pressoché as-sente nella zona culminale. Qui è la vege-tazione arbustiva che presenta un parti-colare interesse scientifico, per le essenzerare e il gran numero di endemismi. Nonmeno interessante è la fauna, e in parti-colare l’avifauna: fra le cime volteggianoancora lo sparviero, il falco pellegrino,l’astore, l’avvoltoio grifone, l’aquila reale.
Le vette più alte sono il Bruncu Spina (m 1829)e punta La Marmora (m 1834). Il primo è rag-giungibile con estrema facilità seguendo la stra-da che si diparte, 5 km dopo Fonni, dalla pro-vinciale per Dèsulo e porta quasi fino alla vettache può essere guadagnata proseguendo per unbreve tratto a piedi. Vi si può giungere anche im-boccando al passo di Tascusì una strada asfal-tata che porta al rifugio S’Arena (1500 m), dalquale si può senza eccessiva difficoltà raggiun-gere a piedi il Bruncu Spina o, seguendo un per-corso più impegnativo, la punta La Marmora. Lavista spazia per 360 gradi abbracciando, nellegiornate terse, quasi tutte le coste dell’isola.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

DèsuloAntico borgo pastorale (m 888, ab. 3010)pittorescamente aggrappato alla monta-gna e cinto da fitti boschi di castagni, finoa non molti anni fa era, anche per la sua ru-stica tipologia edilizia, uno dei paesi piùcaratteristici dell’isola. Il recente sviluppoha in parte snaturato le caratteristichestoriche del centro, che conserva peròancora alcuni angoli molto suggestivi. So-prattutto negli scoscesi vicoli attorno al-
la parrocchiale nuova resistono alcuni be-gli esempi di architettura tradizionale inpietra scistosa con balconate lignee.Fra questi stretti viottoli non è raro in-contrare donne che indossano ancora og-gi l’antico costume locale, di squillanticolori rosso, giallo e blu.Nel centro è sempre viva l’antica tradi-zione artigianale dell’intaglio del legno,della tessitura dell’orbace e della confe-zione di dolci tipici. Sulla sinistra dellavia principale richiama l’attenzione l’exparrocchiale di S. Antonio Abate (XV sec.)di linee tardogotiche, con uno splendidopulpito ligneo del ’600; attualmente è in fa-se di restauro. Nell’attigua nuova parroc-chiale, è un bel Crocifisso del ’500, mentrealtre interessanti opere lignee, risalentiper lo più al XVII sec., sono visibili in altrechiese del paese.Sempre nel centro storico, nella casa chefu del noto poeta dialettale Antioco Casu-la (1878-1957), in arte Montanaru, ha sede
8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
130
il Museo Etnografico “Casa Montanaru”.Nei primi due piani sono documentati i co-stumi tradizionali e le attività produttivedel paese; nei piani superiori, ancora congli arredi originari, si conserva la biblio-teca e l’importante archivio del poeta.
TonaraCinto da fitti castagneti, è un altro anticoborgo pastorale (m 900, ab. 2447) che harecentemente scoperto una sua vocazione
turistica. Formatosi dalla fusione di tredistinti agglomerati, conserva un interes-sante tessuto urbano tutt’oggi nettamen-te diviso in tre rioni e caratterizzato da vi-coli stretti e scoscesi e da un’architetturarustica ed essenziale.Diverse vie e piazze sono vivacizzate dal-l’inserto di grandi sculture in pietra e in le-gno realizzate di recente da scultori isola-ni. La parrocchiale di S. Gabriele, lungo lavia principale, ricostruita agli inizi del No-vecento in sobrie linee moderne, conserval’originaria torre campanaria seicentesca.Particolare rilevanza ha nell’economia lo-cale la produzione artigianale del torrone,dei campanacci per gli armenti e dei tap-peti che ripetono motivi tradizionali sardi.
Interessanti le escursioni nei dintorni: in parti-colare quelle al monte Mungianeddu (m 1468;strada carrozzabile di 4 km da Arasulè, unodei tre agglomerati di cui si compone Tonara)e alla foresta demaniale di Uatzo.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Lago di Gùsana*È un ampio bacino artificiale realizzatosul fiume Taloro e sul rio Gùsana, perfet-tamente integrato nello splendido am-biente naturale che lo circonda, fra fitti bo-schi e aspre cime rocciose. Il lago è un vero paradiso per gli appas-sionati di pesca ed è dotato di modernestrutture alberghiere.Percorrendo per pochi chilometri unastrada sterrata che si diparte sulla destra
all’altezza del ponte sul rio Aratu, si rag-giungono i quattro alti menhir di Perdas Fit-tas, tutti a breve distanza l’uno dall’altro.
GavoiIl grosso borgo a economia pastorale (m790, ab. 3001) si va affermando anche co-me luogo di villeggiatura estiva. Sorge sulpendio di una suggestiva conca boscosa,con le caratteristiche case in granito di-sposte ad anfiteatro e dominate dall’altocampanile della parrocchiale di S. Gavino.Questa, di linee tardogotiche e risalente alXVI sec., presenta una facciata semplice maimpreziosita da un elegante rosone e da unportale rinascimentale, e conserva all’in-terno un bel pulpito in legno intagliatodel ’600 e uno splendido fonte battesimaledel 1706, anch’esso in legno intagliato e do-
7 Da Tonara a Orani
131
rato. Di un certo interesse, sull’alto delpaese, la rustica chiesetta di S. Antioco.
OraniDisteso in una conca verdeggiante domi-nata dal caratteristico cono di monte Go-nare, il paese (m 521, ab. 3163) fu in età me-dievale capoluogo della curatoria di Dore,poi residenza estiva del vescovo di Ottana;nel XVII sec. venne eretto in marchesato.Testimoniano l’agiatezza del passato di-versi severi palazzotti sette-ottocenteschie le numerose chiese che sorgono nell’a-bitato. Fra queste, tutte lungo la stradaprincipale o ben visibili da essa: Nostra Si-gnora d’Itria, di attardate forme gotiche,con facciata decorata da graffiti* nove-centeschi di Costantino Nivola; S. Gio-vanni Battista, seicentesca, con un bel pul-pito di legno intagliato con simbolo fran-cescano; la cinquecentesca Madonna delRosario, con volte affrescate; la parroc-chiale di S. Andrea, di tarde forme neo-classiche, che custodisce un pregevolepolittico di scuola sarda del XVI sec. raffi-gurante la Madonna in Trono col Bambino.Interessante e suggestiva è poi, alla peri-feria dell’abitato, l’antica parrocchiale diS. Andrea Apostolo, di cui sopravvivonoperò solo la maestosa facciata in pietra tra-chitica e il bel campanile di fattura gotico-aragonese, recentemente consolidato.Di grande interesse è il Museo Nivola* de-dicato al noto scultore contemporaneonativo del luogo. Ha sede nei locali e nelcortile del vecchio lavatoio pubblico benristrutturato, che dalla collina su Cantarusi affaccia sul paese con una splendidapanoramica. Sono esposte oltre trentaopere appartenenti per lo più all’ultimo pe-riodo della produzione nivoliana, dallametà degli anni settanta alla sua morte(1988). Risaltano, all’esterno dell’edificio,le due sculture di grandi dimensioni MagnaMater e su Muru Pringiu (il muro panciuto).
Il santuario di Nostra Signora di Gonare* puòessere raggiunto sia da Orani che da Sarule, sustrade in parte asfaltate. Intitolato alla Vergine,è uno dei più noti e venerati dell’isola e si ergesuggestivo sulla cima aguzza del monte Gona-re (m 1083), da cui la vista spazia tutt’intorno.Risalente al XII sec. (la tradizione lo vuole edifi-cato da Gonario, ‘giudice’ di Torres), fu am-pliato e rimaneggiato nel 1618, quando assun-se le forme attuali. Interamente in pietra a vista,privo di facciata e sorretto da massicci con-trafforti laterali, appare simile a un fortilizio piùche a un luogo di culto. L’8 settembre vi si svol-ge una suggestiva festa che richiama fedeli daogni parte della Barbàgia.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Necropoli di Sas Concas*La necropoli neolitica delle domus de ja-nas di Sas Concas (in prossimità della sta-zione ferroviaria di Oniferi) è la più vastadel Nuorese. È composta da quindici tom-be, alcune delle quali a pianta complessa,
8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
132
che si aprono su un bancone trachitico.Fra di esse quella detta ‘dell’Emiciclo’ pre-senta incise nelle pareti interne numerosefigure umane schematiche disposte ca-povolte, a significare forse il trapasso dalmondo dei vivi a quello dei morti.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
8.4 La costiera orientale e il monte AlboItinerario circolare nel Nuorese di nord-est, la Baronìa, km 158 senza le deviazioni (carta a pag. 119)
Parte da Nùoro e vi ritorna dopo un lungogiro che si svolge quasi interamente nellaBaronìa, regione che, per morfologia delterreno, vicende storiche e ambiente uma-no, si differenzia notevolmente da quellevisitate negli itinerari precedenti.Qui il paesaggio è caratterizzato da pianurefertili e da dolci colline, alla pastorizia si so-stituisce l’agricoltura. Su questa terra, ve-ra oasi di fertilità in un territorio avaro, mi-sero gli occhi i feudatari spagnoli, e da lo-ro derivò il suo nome: Baronìa. Che co-nobbe anche un periodo di profonda de-cadenza, a causa della malaria e delle con-tinue incursioni dal mare dei barbareschi,ma le tracce di un passato di rilievo sonotuttora evidenti nelle chiese e nelle antichedimore gentilizie presenti in alcuni centrie soprattutto a Orosei.Il percorso si svolge interamente su stra-de asfaltate, tranne il tratto Siniscola-Lulache è in parte ancora a fondo naturale eche può comunque essere evitato pren-dendo la strada a scorrimento veloce cheporta direttamente a Nùoro.Si esce dal capoluogo seguendo la statale129 che, aggirato il monte Ortobene, pro-cede in un paesaggio collinare a tratti col-tivato a vigneti e oliveti. Dopo circa 20 kmsi giunge al quadrivio la Traversa; da doveè possibile raggiungere a destra l’interes-sante villaggio nuragico di Serra Òrrios, asinistra la suggestiva tomba di giganti diS’Ena ’e Thomes. Proseguendo dritto siattraversa Galtellì e si giunge a Orosei.Qui ci si immette, in direzione di Sinisco-la, nella statale 125 che procede quasi pa-rallela alla costa, offrendo l’opportunità diaccedere, con diramazioni sulla destra,alle splendide spiagge e alle località bal-neari di Cala Liberotto, Capo Comino, San-ta Lucia e la Caletta. Da Siniscola ci si im-mette nella provinciale per Lodè che, conuna successione di ripidi tornanti, si ar-rampica lungo il versante settentrionaledel monte Albo: spettacolari le vedute sul-la sottostante vallata e sulla costa. Giuntialla cantoniera di Sant’Anna, si imbocca
sulla sinistra una strada in parte a fondonaturale ma di eccezionale panoramicitàche porta a Lula procedendo sempre ad al-ta quota e costeggiando la linea di crestadella lunga bastionata calcarea del monteAlbo. Attraversata Lula e incontrato sullasinistra il santuario campestre di S. Fran-cesco, si raggiunge la statale 131 che ri-porta in breve a Nùoro.
Villaggio nuragico di Serra Òrrios*Sorge in un altopiano basaltico fra olivi se-colari e macchia di lentischio. Fra i meglioconservati, presenta diversi aggregati dicapanne ad andamento circolare, gravi-tanti su cortili con cisterne e pozzi in co-mune. Rivestono particolare importanza,al limite ovest, i resti di due edifici rettan-golari, forse tempietti, che richiamano perle loro strutture le costruzioni a mègarondell’architettura micenea.

Dalla statale 129, deviando per 7 km sulla sini-stra in località la Traversa, si raggiunge, isola-ta in una verdeggiante pianura, la tomba di gi-ganti di S’Ena ’e Thomes*, uno dei monumen-ti più suggestivi della preistoria sarda. Al cen-tro dell’esedra presenta una splendida stelecentinata alta oltre tre metri e mezzo e scolpi-ta in un unico lastrone di granito.
GaltellìBorgo a economia agricola (m 35, ab.2397), fu capoluogo di curatoria e sede ve-scovile fino al 1496. Poi, la malaria e le in-cursioni dal mare dei barbareschi ne de-terminarono la decadenza.Nel piacevole centro storico, caratteriz-zato da case basse imbiancate a calce,con patii e loggette, sorge la bella parroc-chiale del SS. Crocifisso che nel rustico esuggestivo interno conserva un pregevo-le Crocifisso ligneo del XIV sec., una statuadella Trinità in legno policromo del ’500 eun grazioso organo settecentesco inta-gliato e dipinto. Dalla parrocchiale si rag-giunge in breve (verso la periferia) l’excattedrale di S. Pietro (XII sec.), di arcaicheforme romaniche con un rustico campa-niletto a torre cuspidata e un interessan-tissimo ciclo di affreschi romanici della fi-ne del XII-inizi del XIII secolo.Nel cuore del centro storico, in via Gari-baldi, merita una visita il Museo etnografi-co “Casa Marras”: un tipico esempio diarchitettura spontanea del luogo, risalen-
8.4 Da Nùoro a Orosei
133
te ai primi del ’700, rispettosamente re-staurata e arredata con i mobili originari.A pochi chilometri dall’abitato insistonosu una rupe i resti del castello di Pontes,edificato nel 1070 dai ‘giudici’ di Gallura.
OroseiDistesa in una fertile piana fra il mare e lefalde orientali del monte Tuttavista, nel si-to in cui sorgeva la romana Fanum Carisii,Orosei (m 19, ab. 5746) è il capoluogo sto-rico della omonima Baronìa. Nella parteantica del paese, composta e ben conser-vata, testimoniano l’agiatezza e l’impor-tanza rivestita da questo centro già dal me-dioevo le numerose chiese e un cospicuonumero di dimore gentilizie risalenti per lopiù ai secoli dal XV al XVIII. In una di queste,casa Guiso, nella centrale via Maiolu, ha se-de il Museo “Giovanni Guiso” che com-prende fra l’altro una interessante rac-colta di abiti da scena indossati anche daartisti famosi e una preziosa collezionedi teatrini d’epoca.Cuore del paese è la centrale piazza del Po-polo sulla quale si affacciano vari edifici re-ligiosi che le conferiscono un aspetto in-solito. La domina scenograficamente dal-l’alto la parrocchiale di S. Giacomo Mag-giore, dall’aspetto vagamente arabeggianteper il candido intonaco e per l’insolita co-pertura a cupolette; all’interno, con finis-simi stucchi dorati, si conserva un bel
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

battistero ligneo settecentesco. Addos-sata all’abside della parrocchiale è la sei-centesca chiesa di S. Croce, mentre sul la-to opposto della piazza sorgono la chiesadel Rosario, anch’essa seicentesca, e quel-la delle Anime (sec. XVIII), con copertura cu-polata e bel portico laterale.Altre chiese degne di nota sono – en-trando a Orosei da Galtellì – il santuariodella Madonna del Rimedio, rifacimentoottocentesco di uno più piccolo del XVIIsec., e la chiesa di S. Antonio Abate, risa-lente al XIV-XV sec., che conserva all’in-terno una pregevole statua lignea del san-to (XIV sec.) e degli affreschi (ma molto de-gradati) dello stesso periodo. Entram-be le chiese sono circondate da ampirecinti che inglobano antiche cum-bessìas. La festa del 17 gen-naio per S. Antonio Abate èresa particolarmente sug-gestiva dall’accensione, lasera della vigilia, di unenorme falò.
SiniscolaGiace in una fertile pianaalle falde nord-orientali del-la dorsale calcarea del mon-te Albo ed è il centro (m 39,ab. 11 020) più importantedella Baronìa, con un’eco-nomia tradizionalmente ba-sata sull’agricoltura.Il recente sviluppo edilizioha un po’ stravolto l’anticotessuto urbano. Tra i mo-numenti di qualche inte-resse sono la chiesa delRosario, ricca di statue epreziosi arredi e, nella centrale via Sassa-ri, la settecentesca parrocchiale di S. Gio-vanni Battista, dall’interno interamenteaffrescato e con una curiosità: un’insolitalapide datata 1627 che reca incise delle im-pronte di piedi e una misura d’altezza chesi vorrebbero riferite a Gesù Cristo.
Negli ultimi anni Siniscola ha conosciuto unnotevole sviluppo turistico che ha interessatole vicine località balneari di la Caletta (v. pag.174) e Santa Lucia*, piccolo borgo di pescato-ri sviluppatosi attorno a una massiccia torre co-stiera del XVII secolo e all’omonima chiesetta ot-tocentesca.Fra le splendide e suggestive spiagge risaltaquella di Bèrchida, famosa per il candore dellasabbia e la limpidezza dell’acqua.
8 Le Barbàgie: il cuore montano dell’isola
134
Monte Albo*Deriva il nome dal candido colore della suaroccia. È un’imponente bastionata calca-reo-dolomitica lunga 20 km e larga da 2 a5, che domina con cime comprese fra 1029e 1127 m il piatto paesaggio della Baronìa.Caratterizzato da altissime pareti a picco,da fiumi sotterranei, da profondi orridi eda numerose grotte naturali, è una zona dieccezionale interesse. Conserva in alcunitratti residue foreste di lecci con gigante-schi esemplari di corbezzolo, tassi e oli-vastri secolari, ma si presenta nel com-plesso, e soprattutto nella zona culmina-le, spoglio e arido, punteggiato solo da
contorti ginepri e da bassi arbusti.La catena culmina nel monte Turuddò
e nella punta Catirina che si elevanoentrambe a 1127 m, offrendo un
emozionante panorama cheabbraccia le piane della Ba-ronìa, la costa orientale, i
monti del Gocéano e ilGennargentu.
Santuario di S. Francesco di Lula*Bianchissimo e immersonel verde, dominato dallacandida mole del monteAlbo, è uno dei più sugge-stivi e importanti santuaricampestri della Sardegna.La tradizione lo vuole fon-dato nel ’600 da alcunifuorilegge nuoresi, e ilsanto che vi si venera –S. Francesco d’Assisi,ma per i sardi S. Fran-cesco di Lula – è con-
siderato il protettore dei banditi e dei “ba-lentes” (i valorosi): non di rado la sua pro-tezione veniva invocata anche prima del-le grassazioni o durante i conflitti a fuoco.La chiesa attuale, edificata nel 1795, è unrifacimento di una più piccola del XVII sec.e conserva all’interno una statua lignea delsanto di scuola napoletana del ’600.Tutt’intorno alla chiesa un gran numero dicumbessìas, i caratteristici ricoveri per inovenanti, formano un articolato e sug-gestivo villaggio.La festa di S. Francesco di Lula si svolge dal1° al 9 maggio: richiama sempre numerosifedeli da ogni parte della Baronìa e dellaBarbàgia, e a tutti viene gratuitamente of-ferto il pranzo dagli organizzatori.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Profilo della cittàDistesa sopra un tavolato calcareo dolcemente inclinato, almargine della pianura che scende verso il mare, Sassari (m225, ab. 120 649) è il secondo centro urbano della Sardegnaper consistenza demografica e per importanza economica,politica e culturale. Città a economia prevalentemente ter-ziaria, che si è gradatamente sostituita negli ultimi anni alle tradizionali e ricche atti-vità agricole, alla piccola e media industria (concerie, molini, oleifici) e al polo pe-trolchimico di Porto Torres. Il nucleo storico cittadino si identifica con l’antica città mu-rata della cui cinta restano significative tracce. Negli ultimi decenni tuttavia l’inse-diamento si è notevolmente esteso portando così i nuovi quartieri a inglobare gli an-tichi orti e gli oliveti che circondavano la città.Il sito ha conosciuto una frequentazione molto remota e in epoca romana, anche in se-guito alla fondazione nel sec. I a.C. della colonia di Turris Libisonis, il territorio sassa-rese appare intensamente popolato. Tuttavia il primo nucleo urbano risale all’alto me-dioevo. Il processo di formazione del luogo fu, all’inizio, piuttosto lento e casuale; in se-guito (sec. XII-XIII) lo sviluppo fu favorito dagli scambi commerciali con la penisola ita-liana. Alla fine del XIII risalgono gli Statuti del Comune di Sassari, un vero e proprio cor-pus normativo teso a regolare tutti gli aspetti della vita urbana e i rapporti col contado.Nel 1378 Sassari, nel corso della guerra tra il giudicato d’Arborèa e i d’Aragona, fu oc-cupata dalle truppe giudicali e rimase sotto il dominio dei ‘giudici’ d’Arborèa sino al 1420.Poi nel XV secolo venne pienamente inserita nel nuovo sistema istituzionale e ammini-strativo dell’isola che faceva parte, come regno autonomo, della federazione catalano-aragonese. Risale a questo periodo la fioritura del gotico catalano nell’architettura ci-vile e religiosa che ancor oggi connota la parte antica della città. Durante il dominio spa-gnolo sopravviene un periodo di crisi dovuto in gran parte alle guerre mediterranee eal ristagno dei traffici e delle esportazioni; eppure il XVI secolo coincide con una crescitacivile e culturale del capoluogo del Capo di Logudoro. Tra le città sarde, Sassari è quel-la che è stata più vicina alle esperienze dell’umanesimo e ai modelli culturali del rina-scimento italiano. Gli echi della classicità cinquecentesca si possono scorgere in alcu-ni edifici del centro storico, come palazzo d’Usini, nell’antica carra manna (oggi piazzaTola), o nella facciata della chiesa gesuitica di Gesù e Maria (oggi S. Caterina). Nel secolo successivo Sassari, impegnata in un’aspra tenzone municipalistica con Ca-gliari, fu colpita nel 1652 da una terribile epidemia di peste che falcidiò la popolazioneurbana e ne ridimensionò le ambizioni politiche. La seconda metà del secolo non fu peròun periodo di decadenza: la ripresa demografica e l’affermazione di nuove colture
135
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
9 Sassari

agrarie posero le basi dello sviluppo settecentesco. Soprattutto durante il regno di Car-lo Emanuele III (1730-73) e il ministero del conte Bogino (1759-73) si avvertono, all’in-terno di una cauta politica di riforma e di modernizzazione, segni di sviluppo dell’eco-nomia agraria e della vita civile, grazie all’istituzione dei Monti frumentari, all’incorag-giamento delle nuove colture (gelsi, patate), al restauro dello scalo portuale di Torres,alla incentivazione del commercio, alla riapertura dell’Università (1765).Negli anni 1793-1802 Sassari fu al centro delle rivolte antifeudali delle campagne logu-doresi. La repressione sabauda fu spietata. Nella prima metà dell’Ottocento si verificaun notevole sviluppo urbanistico della città, grazie al progetto di ampliamento del 1836orientato in direzione sud-ovest, verso la ‘strada reale’, ultimata nel 1829, che collega-va Sassari con Cagliari. Nella seconda metà del secolo venne demolita la quasi totalitàdelle mura e abbattuto il castello aragonese (del 1330 circa). La fine del secolo è un momento ricco di fermenti culturali nel campo letterario (E. Co-sta, P. Calvia), musicale (L. Canepa) artistico (G. Biasi) e politico. Nel ventennio fascista,la popolazione di Sassari continuò a crescere – 51 700 abitanti nel 1931 – e con essal’edilizia pubblica e privata. Tre nuovi piani regolatori, elaborati tra il 1929 e il 1942,definivano lo sviluppo periferico della città con la creazione del nuovo quartiere po-polare di Monte Rosello – collegato alla città da un ponte inaugurato nel 1934 – e delquartiere residenziale di viale Italia-Porcellana. L’intervento nel centro storico fu in-vece condizionato dalla logica del “piccone demolitore” con lo sventramento di un am-pio comparto adiacente al Duomo e al corso Vittorio Emanuele II noto come piazza De-molizioni (oggi piazza Mazzotti). Nel secondo dopoguerra Sassari, nonostante i limiti e le contraddizioni del suo svilup-po economico, ha marcato una certa vivacità culturale e politica: i sassaresi Antonio Se-gni, Enrico Berlinguer e Francesco Cossiga sono stati tra i protagonisti delle vicende piùsignificative dell’Italia repubblicana.
9 Sassari
136
L’antico nucleo urbano, un tempo delimi-tato dalle mura, è caratterizzato da inte-ressanti edifici monumentali e da un’anti-ca strada, il corso Vittorio Emanuele II, lamedievale Platha de Codinas che costi-tuiva la via principale della città. Lo sman-tellamento delle mura e delle porte, co-struite fra XIII e XIV sec. (oggi restano soloframmenti in corso Trinità, in corso Vico,in via Torre Tonda e in via Arborèa), nonconsente di cogliere, specie in direzionesud, la cesura tra la città medievale e quel-la ottocentesca. Alcuni sventramenti delperiodo fascista e del dopoguerra, la co-struzione di edifici moderni nella partepiù antica e i due grossi ‘grattacieli’ inpiazza Castello hanno contribuito ogget-tivamente al progressivo degrado del cen-tro storico della città, per il cui recuperosolo negli anni più recenti si assiste a unatimida inversione di tendenza. Diverse le vie d’accesso: da sud, da piaz-za Castello attraverso piazza Azuni e cor-so Vittorio Emanuele II; da nord, da piaz-za S. Antonio verso corso Vittorio Ema-nuele ; da est, da piazza Mercato verso viaRosello; da ovest, dal corso Margherita diSavoia, largo Porta Nuova e via Università.Preferendo il primo ingresso, si potrà sce-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
gliere tra due possibilità: scendere dal-l’ottocentesca via Luzzatti e, attraversopiazza Azuni dirigersi verso corso VittorioEmanuele II e girare a sinistra in via S. Ca-terina che immette nella zona monumen-tale dell’omonima chiesa, del Palazzo Du-cale, del Duomo e infine dell’Università edella chiesa di S. Maria di Betlem; oppureda piazza Azuni, a destra attraverso via C.Battisti e l’antica piazza Tola, ci si dirigeverso via La Marmora e poi a sinistra lun-go la caratteristica via Rosello (l’anticavia degli argentieri) in corso Trinità, con lasottostante seicentesca fontana del Ro-sello, poi riprendendo via Rosello per ri-mettersi nel corso e attraverso via Duomovisitare la zona monumentale della città.Ritornati, dal palazzo dell’Università, inpiazza Castello, l’itinerario, snodandosilungo piazza d’Italia e via Roma, proponela visita di aree più recenti.
Piazza Castello (B-C2). Prende nome dal-l’antico castello aragonese costruito in-torno al 1330, già sede del tribunale del-l’Inquisizione, demolito nel 1877, che sor-geva sul sito dell’attuale caserma La Mar-mora (1878-81), nel cui cortile si conser-vano gli stemmi dell’antica facciata. Al-
I quartieri storici e la città ottocentescaItinerario pedonale da piazza Castello al Duomo e a S. Pietro in Silki (pianta della città a fronte)

l’interno della caserma si può visitare il Mu-seo storico della Brigata Sassari, dedicatoalle eroiche gesta dei fanti sardi nella guer-ra 1915-18. Nella contigua via Politeamasorge il politeama Giuseppe Verdi (1884).Nel lato sinistro della piazza è la chiesa del-la Madonna del Rosario (C2), con facciatadei primi del XVIII sec., che conserva al-l’interno uno splendido altare maggiore*barocco in legno dorato, opera di artigia-ni locali (1686).
Corso Vittorio Emanuele II (B1-2). Era lavia principale della città medievale chelungo l’asse sud-nord tagliava in due Sas-sari. Denominata Platha de Codinas, per-ché scavata nel tufo, alla sua metà si apri-
Il centro storico
137
va la piazza del Comune con il Palazzo diCittà (area su cui attualmente sorge il Tea-tro civico). Nella parte superiore della via(l’attuale piazza Azuni, B2) stavano la de-molita chiesa gotica di S. Caterina e il pa-lazzo del Podestà, sede in seguito del go-vernatore del Capo di Logudoro. Nelle vielaterali erano collocate le misure pubbli-che. La maggior parte delle case avevaportici con botteghe di mercanti e arti-giani. Ci sono pervenute alcune case go-tiche del xv sec., come quella che sorge invia Canopolo (N. 20) e soprattutto quellanota come casa Farris (N. 23), con belle fi-nestre e bifore di stile gotico catalano,che mostra murati gli antichi portici. Si-mile impianto di tipo catalano si trova an-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

che nella cosiddetta casa di Re Enzo, delXV sec., con uno splendido portichettocon capitelli scolpiti, e nella casa con unbel portico gotico all’angolo con via deiCorsi. L’antico municipio è stato sostitui-to nel 1826 da un’elegante costruzioneneoclassica (N. 35) che attualmente ospi-ta il Teatro civico (B2), progettato da Giu-seppe Cominotti sul modello del Carigna-no di Torino. Fronteggia il teatro il neo-classico palazzo di S. Sebastiano, del se-condo decennio dell’Ottocento; a destra,la facciata barocca della chiesa di S. Andrea(1648), ispirata a modelli liguri. La via ter-mina allargandosi nella piazza S. Antonio(B1): a sinistra un frammento della cintamuraria medievale con una torre merlata;al centro, la colonna di S. Antonio (1954)del sassarese Eugenio Tavolara.Dinanzi alla piazza sorge la chiesa di S. An-tonio Abate (A-B1) ultimata nel 1709, conuna facciata semplice e ben proporziona-ta di gusto barocco. Capolavoro dell’ap-parato decorativo della chiesa è il retablo*dell’altare maggiore, in legno intarsiato edorato, del genovese Bartolomeo Augusto.Nella sagrestia sono custoditi il Santo dia-cono attribuito al pittore Giovanni Muru(prima metà del XVI sec.), o al Maestro diCastelsardo, e l’Addolorata di GiovanniMarghinotti.
9 Sassari
138
Le mura. Il luogo in cui si possono osser-vare i frammenti della cinta muraria me-dievale della città è corso Trinità (A-B1-2).Iniziate dai pisani nel XIII sec., vennero com-pletate dai genovesi nei primi decenni delXIV. Dal vicolo Godimondo è possibile ve-dere i camminamenti interni e la singolaresuccessione delle piccole case addossatealle mura. Una torre, appena più alta dellemura, si presenta come una sorta di corpoavanzato. Poco oltre sono murati tre stem-mi trecenteschi. Dinanzi sorge la chiesadella Trinità (B2) con un’interessante fac-ciata barocca dell’inizio del XVIII secolo.
Fonte Rosello* (A2). Già nota nel 1295,venne trasformata nell’attuale dimensionemonumentale a opera di lapicidi genove-si nel 1605-1606.Il gusto ancora rinascimentale compose uninsieme di due parallelepipedi sovrappo-sti, in marmo verde e bianco, coronatocon due archi incrociati, al cui culmine fuposta la statuetta equestre di San Gavino(quella che si vede è una copia del 1975dell’originale perduto). Agli spigoli dellabase sono le statue delle stagioni, copieeseguite nel 1828 di originali distrutti neimoti del 1795-96.
Piazza Tola (B2). È l’antica carra manna do-ve era posta la misura pub-blica, in sardo “carra”, e co-stituiva il centro della vitaurbana nel medioevo e nel-l’età moderna. Al centrodella piazza, il monumentoa Pasquale Tola, storico emagistrato sassarese, ope-ra di Filippo Giulianotti(1903). È notevole il palaz-zo d’Usini, costruito nel1577, che costituisce un ra-ro esempio di architetturacivile e tardorinascimenta-le in Sardegna. L’edificioospita la Biblioteca comu-nale con una ricca colle-zione di volumi, periodici,stampe, fotografie e mano-scritti riguardanti soprat-tutto la storia cittadina.
S. Caterina (B2). Già chie-sa di Gesù e Maria, fu co-struita tra 1580 e 1607 perla Compagnia di Gesù suprogetto di Giovanni deRosis secondo moduli con-troriformistici; la realizza-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

zione a opera delle maestranze locali nespezzò l’austera impronta manieristica.Nell’interno le coperture della navata cen-trale e delle cappelle con volte a crociera,gli archi del transetto e del capocroce ri-velano l’innesto sul progetto originale dielementi di derivazione gotico-catalana.Pregevoli i dipinti del gesuita fiammingoGiovanni Bilevelt (attivo a Sassari tra il1622 e 1652), tra cui l’Incoronazione dellaVergine e la Trinità.
Museo Arte Sassari*. È ospitato, dopo i la-vori di restauro ultimati nel 2001, nel-l’ampio edificio della Casa professa dellaCompagnia di Gesù, costruito tra il 1597 eil 1668 e un tempo sede del Convitto na-zionale Canopoleno. Raccoglie dipinti esculture provenienti dalle due Soprinten-denze, dalle collezioni del Comune e del-la Provincia, da donazioni private, offren-do un quadro dettagliato della cultura fi-gurativa sarda dal medioevo al Novecen-to. Al piano terra le opere relative ai secoliXIV-XVI: pur comprendendo autori comeVivarini e Mabuse, l’interesse si concentrasu artisti sardi quali il Maestro d’Ozieri (se-conda metà sec. XVI) e sui tradizionali re-tabli di derivazione catalana. Il primo pia-no raccoglie opere dei secoli XVII-XVIII, condipinti di Crespi, Sustermans, Marieschi eautori sardi; al terzo piano opere di artistisardi del XIX e XX secolo: Marghinotti, Bal-lero, Figari, Biasi, Delitala, Dessy.
Palazzo Ducale (o del Comune, B1-2). Dal1900 sede del Municipio, fu fatto costrui-re dal duca dell’Asinara e rappresenta ilpiù rilevante esempio di architettura civilesettecentesca della città. A dirigere la co-struzione dal 1775 al 1805 fu probabil-
139
mente Carlo Valino, che in-trodusse nell’edilizia sas-sarese schemi di deriva-zione piemontese. La so-bria facciata a tre piani,orizzontalmente scompar-tita da fasce e vertical-mente da lesene, presentale finestre del primo pianosormontate da timpani adarco a cuspide, e quelle delsecondo incorniciate da unmotivo rococò. L’androne,da cui parte una scala a te-naglia, affaccia su un ar-monico cortile.
Duomo di S. Nicola* (B1).La prima pieve romanica
risale al XII sec., mentre del Duecento è laparte inferiore del campanile, ripreso nel1756 con una snella sopraelevazione ot-tagonale. A partire dal 1480, e probabil-mente sino al 1505, la chiesa fu riedificatain proporzioni più ampie che richiamanola tipologia gotica catalana. Tra il 1681 e il1715 si svolsero i lavori che portarono al-l’attuale prospetto. L’architetto fu quasi si-curamente Baldassarre Romero, che sep-pe esprimere in maniera originale i moti-vi plastici decorativi del tardo baroccospagnolo mescolandoli al repertorio goti-cheggiante e classico. Sul portico con vol-te stellari si innalza l’alta fronte minuta-mente coperta da fitti intagli, su cui siaprono tre nicchie con le statue dei santiGavino, Proto e Gianuario e nel fastigio su-periore ad arco la statua di S. Nicola. L’in-terno a navata unica mantiene ancora l’an-tica fisionomia gotica; i restauri ultimatinel 1998 hanno messo in luce nelle cap-pelle laterali ulteriori architetture gotichee decorazioni tardocinquecentesche. Trai dipinti, pregevoli: nella seconda cappel-la destra la tela dei Ss. Cosma e Damiano,attribuita a Carlo Maratta, nella seconda asinistra la Fuga in Egitto del caravaggescoAlessandro Turchi e la Madonna del Tem-pietto (1626) del sassarese Diego Pinna, enel braccio destro del transetto UltimaCena di Giovanni Marghinotti.Da qui, attraverso la sagrestia dei Benefi-ciati dalla suggestiva volta a crociera mul-tipla in cotto retta da una colonna centralein granito (XVI sec.) e la sagrestia capito-lare, si accede alla settecentesca sala ca-pitolare dove è stato allestito il Museodel Tesoro del Duomo, che raccoglie im-portanti pezzi di argenteria (sec. XVI-XIX),paramenti sacri e opere d’arte di pregio;
Dal corso Vittorio Emanuele al Duomo
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

come il famoso Stendardo processionale*,dipinto a tempera e olio su tavola, operadi un ignoto artista della fine del ’400. Nell’ottocentesco altare maggiore è espo-sta la Madonna del Bosco, tempera su ta-vola di scuola senese del Trecento; a de-stra dell’altare un Crocifisso di scuolaspagnola del XVII secolo. A sinistra in unateca è conservata la seicentesca statuad’argento di San Gavino, opera forse di ar-gentieri locali. Eccellente lavoro di intaglioè il coro in legno di noce sardo di artigia-ni locali del primo Settecento. Nel bracciosinistro del transetto si trova il dipinto diVittorio Amedeo Rapous raffigurante S.Anna e il SS. Sacramento; alla parete de-stra, mausoleo di Placido Benedetto di Sa-voia conte di Moriana, opera del torineseFelice Festa (1807).
Nella chiesa di S. Michele (XVIII sec.), posta di-nanzi alla facciata della cattedrale, è stato al-lestito il Museo del Duomo, con buoni dipintitra cui la Madonna dell’Unità di Charles VanLoo, e interessanti opere di artigianato ligneocome il Letto della Vergine assunta di impiantobarocco (XVII sec.). Nella cripta sono esposti idiversificati e interessanti reperti archeologi-ci di età romana, altomedievale, medievale emoderna, e i frammenti scultorei provenientidagli scavi e dai lavori di restauro.
S. Maria di Betlem (B-C1). Fondata assie-me al convento nel 1106 dal ‘giudice’ Co-stantino e affidata ai Benedettini, passò ne-gli anni venti del XIII sec. ai Francescani. Ilcomplesso svolgeva una funzione istitu-zionale, raccogliendo attorno a sé i lavo-ratori organizzati nei “gremi”; in conti-nuità col passato, oggi il suo ruolo si eser-cita nell’annuale festa dei Candelieri*. Lasera del 14 agosto i grandi candelieri votividi legno intagliato, che qui si conservano,vengono portati in processione dai rap-presentanti dei gremi vestiti dei costumidel XIX secolo. La parte inferiore della facciata risale al1236-38 ed è il frammento più antico del-l’edificio. Sopra un ordine di arcatelle a tut-to sesto si innesta la parte superiore ri-costruita nel 1465 con un grande rosone eun timpano. Decorazioni e archetti coevisi sviluppano lungo il fianco sinistro, sulcui portale è stato recentemente postoun medaglione a rilievo, sempre quattro-centesco, raffigurante una Madonna. Trail 1829 e il 1834 si collocano gli interventidi Antonio Cano che rimaneggiò il presbi-terio e costruì la cupola ornandola di nu-merose statue. Conserva ancora l’originale carattere ca-
140
talano la cappella dei Muratori, subito a si-nistra dell’ingresso; le altre sei cappelleche si aprono sulla navata appartengonoad altrettanti gremi artigiani e vantano al-tari barocchi intagliati. Nella cappella a sinistra dell’altare mag-giore si conserva un gruppo ligneo dellaMadonna col Bambino della prima metàdel xv secolo. Interessante anche il pul-pito barocco, opera del sassarese Anto-nio Giovanni Contena (1741). Nell’ele-gante sagrestia settecentesca, Madonnain gloria e quattro santi, dipinto di Giaco-mo Cavedoni. Da qui si accede al chio-stro, in gran parte murato, che conservalapidi con iscrizioni medievali, catalane espagnole: al centro, la fontana del bri-gliadore (dal catalano “brillador”, zam-pillo), opera del XVI secolo.
Palazzo dell’Università (C2). La facciatarisale al 1929, mentre quella originaria è lafronte opposta che conserva ancora l’a-spetto cinquecentesco e prospetta suigiardini pubblici. La nascita dell’Universitàè legata al testamento del sassarese Ales-sio Fontana (1558), che lasciò tutte le sueproprietà per fondare un collegio univer-sitario. I corsi tenuti dai Gesuiti iniziarononel 1565; del 1617 è il diploma di Filippo III,riconoscimento ufficiale dell’Ateneo. Allafine del XVII sec., il prestigio dell’Universitàera alquanto decaduto e soltanto in se-guito alla riorganizzazione sabauda del1765 riprese nuovo slancio. L’edificio, co-struito tra il 1559 e il 1566 su progetto diFernando Ponce de Léon, e ampliato nel
9 Sassari
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

’600, si articola attorno a un chiostro cir-condato da un doppio ordine di logge. Unampio scalone conduce al piano superio-re, dove l’Aula Magna (1929) è decoratacon tele di Mario Delitala. Nel Rettorato siconservano ritratti di sovrani sabaudi, fracui quelli di Vittorio Amedeo III di Giovan-ni Antonio Molinari (1774-75) e di Carlo Fe-lice di Giovanni Battista Biscarra (1830), lastatua marmorea di Ebe (1836 circa) diAndrea Galassi e la mazza d’argento con isimboli delle facoltà (1765), del piemon-tese Giovanni Michele Graneri.La Biblioteca universitaria ha un patri-monio librario di oltre 250 000 volumi; frai manoscritti il celebre Condaghe di SanPietro di Silki (XI-XII sec.), uno dei primi do-cumenti in volgare sardo.
Piazza d’Italia* (C2). L’espansione otto-centesca di Sassari ha qui il suo fulcro,nato negli anni settanta del XIX secolo. L’in-sieme delle architetture che recingono ilsimbolico spazio di un ettaro, interrotto alcentro dal monumento a Vittorio Emanue-le II di Giuseppe Sartorio (1899), formanoun ambiente armonico e omogeneo. L’edi-ficio più rappresentativo è il maestoso,elegante palazzo della Provincia, proget-tato da Eugenio Sironi e Giovanni Borgninie costruito tra il 1873 e il 1880 in tardo sti-le neoclassico. La facciata, imponente maproporzionata, consta di tre ordini di fine-stre e culmina con un fregio. Al primo pia-no è visitabile l’aula consiliare*, decoratanel 1881 da Giuseppe Sciuti: vi sono raffi-gurati episodi salienti della storia cittadi-na; contiguo, l’appartamento reale. Sul la-to di fronte al palazzo della Provincia, il pa-lazzo Giordano (N. 19): progettato in stileneogotico da Luigi Fasoli nel 1878, ha duesale affrescate da Guglielmo Bilancioni.
Museo nazionale archeologico ed etno-grafico G.A. Sanna** (C3). L’edificio fu fat-to costruire dalla famiglia Sanna Ca-stoldi per conservarvi le collezioni la-sciate da Giovanni An-tonio Sanna, fi-nanziere e uomopolitico, e peraccogliervi ilgabinettoarcheologi-co dell’Uni-versità.Sorto nel 1932, l’ordi-namento e l’amplia-mento attuali risalgonoal dicembre 1986 (ma si
Dall’Università al Museo Sanna
141
Quando, nell’aprile del 1899, UmbertoI e la regina Margherita vennero invisita in Sardegna, a Sassari si pensòdi organizzare in loro onore una sfila-ta di uomini e donne (della sola pro-vincia di Sassari, che però si estende-va allora per metà Sardegna) nei lorocostumi tradizionali. Le cronache par-lano di 3 mila partecipanti e di qual-cosa come 600 cavalli.Nel 1951, quasi casualmente (un con-gresso nazionale del Rotary Club sisvolse su una motonave, che attraccòad Alghero), quella sfilata fu resusci-tata dai responsabili dell’Ente provin-ciale per il Turismo. Fu un successoclamoroso. Da quell’anno a una datafissa (prima il giorno dell’Ascensione,ora la penultima domenica di maggio)la Cavalcata sarda segna praticamen-te l’apertura della stagione turisticaisolana, sebbene la preceda, il 1° mag-gio, la grande sagra cagliaritana diSant’Efisio, che però conserva inbuona parte il suo carattere religioso.Donne di tutte le età, giovani e bambi-ni, anche qualche vecchio patriarca sidanno appuntamento a Sassari da uncentinaio di centri isolani e, indossatii costumi da festa tolti per l’occasionedalle cassepanche dove li ha relegatil’avanzare dei tempi moderni, sfilanolungo un percorso cittadino. Sonoancora migliaia, mentre più difficile siè fatto il reclutamento dei cavalli: maalla sfilata partecipano ancora centi-naia di coraggiosi cavallerizzi, che siesibiscono nelle acrobazie della“corsa a pariglia” e chiudono la mani-festazione con un grande, festosogaloppo finale. Uno spettacolo coraledi colori, di musiche, d’allegria, un’e-
mozionantei m m a g i n edel folclore
isolano.
La Cavalcata sarda
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

tenga presente la possibilità di probabiliriallestimenti). Collezioni e oggetti singo-li sono esposti in sale nuove o rinnovatesecondo i più recenti criteri del ‘museo fa-cile’, ‘per tutti’. Si compone di una pina-coteca, una collezione archeologica e unadi materiali etnografici relativi alla Sarde-gna (quest’ultima, in fase di restauro, nonè aperta alla visita). Il museo è dotato an-che di una Sala conferenze e di una Sala di-dattica (II e IV). L’insieme si articola in uncomplesso di diciotto sale, ognuna dellequali è provvista di pannelli esplicativi;chiare didascalie accompagnano quasiogni oggetto.Nella sezione archeologica, che è la piùampia, sono documentati i periodi della ci-viltà sarda dal Neolitico. L’esposizione èpreceduta (sala V) da una breve docu-mentazione sulle foreste pietrificate del-l’Anglona risalenti a 15 milioni d’anni fa. Lasala VI è dedicata quasi interamente al-l’altare preistorico di Monte d’Accoddi,nel territorio fra Sassari e Porto Torres. Al-le pareti i rilievi in forma di testa taurinache decorano varie tombe ipogeiche. Nel-le sale successive (VII-VIII) sono espostimateriali provenienti da necropoli prenu-ragiche a domus de janas. La parte finaleillustra le cosiddette tombe di giganti, ap-partenenti alla civiltà nuragica.Nella sezione medievale sono raccolti re-perti dei sec. IX-XVI che documentano so-prattutto la vita materiale della societàrurale e urbana del territorio sassarese.Al piano superiore (sala IX)è ampiamente documen-tata l’epoca nuragica. Ri-costruzioni in scala esem-plificano con apprezzabileprecisione i due tipi dinuraghi, a tholos e acorridoio; nelle vetrine,numerosi reperti cera-
9 Sassari
142
mici e materiali in bronzo di uso votivo. Al piano terra l’esposizione prosegue coni materiali d’epoca storica: per il periodopunico (sala X) una serie di stele funerarieprovenienti da Sulci, materiali fittili e nu-merosi scarabei e amuleti; per l’epoca ro-mana una cospicua raccolta di lucerne(sala XI), vasellame ceramico, vetri soffiatie oggetti d’oro. Importanti i documentiscritti, costituiti dalla tavola bronzea daEsterzili (nella Barbàgia di Seùlo) e dal di-ploma militare del soldato Ursarius.Attraverso pochi gradini si giunge all’am-pia sala inferiore (XII) nella quale sonoesposti materiali tardoromani: sarcofagimarmorei istoriati, sculture e mosaici pro-venienti da Turris Libisonis (la coloniaromana da cui discende Porto Torres).Nelle sale XI e XIII il ricco medagliere rac-coglie monete dal periodo punico (conesemplari rari e preziosi) fino a coniazio-ni di Vittorio Emanuele I, 1814-1821.
S. Pietro in Silki* (D1, f. p.). La chiesa, ilcui appellativo parrebbe derivato dalloscomparso abitato medievale di Silki, esi-steva già nel XII secolo. La semplice facciatache si apre con un grande atrio è del 1675;delle precedenti fasi costruttive restano laparte inferiore del campanile risalente alsecolo XIII, dai caratteri romanico-lom-bardi, e le strutture murarie della navata,edificate negli anni immediatamente pre-cedenti il 1477. L’interno è una spaziosa au-la coperta a botte lunettata, con quattrocappelle sul lato sinistro. La prima, dedi-cata alla Madonna delle Grazie, rappre-senta uno dei più armoniosi esempi del go-tico catalano in Sardegna, grazie anche airilievi scolpiti nella grigia pietra calcareadei capitelli e della gemma della volta (se-conda metà del XV sec.). Assai pregevole èl’altare maggiore in legno intagliato delXVII sec. nel quale è collocata la venerataimmagine della Madonna delle Grazie.
Di fronte alla chiesa sorge l’attualeconvento dei Frati Minori, nelquale è custodita una Visi-tazione* di anonimo pittore
attivo nella prima metàdel XVI secolo.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

10 La Nurra e il Paese di Villanova
Profilo dell’areaPartendo da Sassari diretti ad Alghero lungo la costa occi-dentale della Sardegna e i centri che la animano, e prose-guendo poi fino a Bosa attraverso Villanova Monteleone, si hala possibilità di visitare l’ondulata Nurra e un lembo del Lo-gudoro e del Meilogu, il cui confine è segnato dal territorio di Bosa. Il viaggio interessaquindi aree diversamente umanizzate e differenti anche sotto l’aspetto geografico. Nelprimo tratto, lasciata Porto Torres, si segue la linea costiera del golfo dell’Asinara e delMar di Sardegna per inoltrarsi, nel secondo, nel retroterra di un’isola che continua ad ave-re due diverse culture: quella costiera e quella delle alture interne. I due territori si pre-sentano completamente di-versi: pianeggiante e colli-nare nella prima parte delviaggio, con ridenti cittadinee pittoreschi borghi marinicui fa da sfondo l’azzurro diuno dei più bei mari del pia-neta; fortemente collinare emontagnoso nella seconda(allorché ci si addentra nelcosiddetto Paese di Villano-va), con borghi che, arroc-cati sulle alture, richiama-no il medioevo. Le numero-se torri spagnole, erette lun-go le coste contro le inva-sioni barbaresche soprat-tutto tra ’500 e ’600, ci dico-no la difficoltà del controllodel territorio contro inva-sori di ogni genere prove-nienti dal mare. Oggi que-ste zone, specialmente laNurra, sono ancora fertili,anche se il loro sottosuolo èandato via via impoveren-dosi d’acqua. Nelle zone interne non man-cano i resti di una civiltà fio-rente, magari il più delle vol-te d’origine straniera, testi-monianza del succedersi di ondate diverse di dominatori. La diversità del Logudoro con-siste soprattutto nella differente umanizzazione del territorio e in un più accentuato con-trasto di ambienti fisici, anche vicini l’uno all’altro. I primi insediamenti umani accertati in Logudoro e Meilogu sono databili al Neolitico an-tico (VI-V millennio a.C.). In questo territorio si sono sviluppate e succedute importan-ti culture: Bonuighinu (4000-3500 a.C., documentata sia in caverne sia in villaggi), SanMichele (3000-2000 a.C., che prende il nome dalle grotte presso Ozieri), Bonnànaro (1800-1600 a.C., dall’omonimo centro logudorese). Dal 1600 al 500 a.C. si sviluppò, come nel-le altre parti dell’isola, la civiltà nuragica, della quale restano qui numerose testimonianze.Il Meilogu, che interessa gli itinerari nella parte finale del rientro alla costa, può essereconsiderato l’estensione sud-occidentale del Logudoro, anche se il terreno si presentameno accidentato, come disteso in una fuga di colline verdeggianti, i cui fondovalle col-tivati a erbai e a legumi si orientano dolcemente verso il mare.
143
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

10.1 Al golfo dell’Asinara e ad AlgheroItinerario lineare da Sassari tra il mare e le colline del Nord-ovest, km 143 (carta a pag. 145)
144
Lasciata Sassari si imbocca il tratto finaledella statale 131 Carlo Felice che da Ca-gliari arriva a Porto Torres. Prima di que-sto centro si incontra il solare altare prei-storico di Monte d’Accoddi. Proseguendooltre Porto Torres, la strada, abbastanzascorrevole, si allontana per un tratto dalmare per riavvicinarvisi poi prima delcentro balneare di Stintino, cui segue lapossibile escursione all’isola del silenzio:l’Asinara. Ritornati al bivio di Pozzo S. Ni-cola si procede verso il borgo minerariodell’Argentiera. Si continua, inoltrandosi
all’interno della Nurra fino alla baia diPorto Conte e al promontorio di capo Cac-cia. Da lì, seguendo la costa, si ripercorrela stessa strada e si prosegue fino a rag-giungere Fertilia, lasciando sulla sinistra ilnuraghe di Palmavera. Dopo una brevedeviazione alla necropoli prenuragica diAnghelu Ruju (per arrivarci basta prose-guire da Fertilia in direzione dell’aero-porto e della “strada dei due mari”), sigiunge ad Alghero. L’itinerario è impor-tante perché consente al visitatore di co-noscere alcuni dei luoghi e dei centri bal-neari più suggestivi e rinomati della Sar-degna nord-occidentale: Porto Torres (19km), Stintino (29 km) con l’Asinara, Ar-gentiera (31 km), Porto Conte e capo Cac-cia, Fertilia (16 km), Alghero (6 km).
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Monte d’Accoddi*Dopo una dozzina di chilometri in pianu-ra da Sassari per Porto Torres si deviadalla 131 per il complesso prenuragico diMonte d’Accoddi, unico esempio in Sar-degna e nel Mediterraneo occidentale di al-tare megalitico dove si celebravano i ritipropiziatori della fecondità della terra. Èun enorme ammasso di pietra e terra re-staurato recentemente, con alla sommitàuna grande pietra sacrificale e due bètili:la struttura a tronco di piramide ricorda le“ziggurat” della Mesopotamia. L’altare, adetta dalla maggioranza degli studiosi, ri-sale all’età del Rame (2450-1850 a.C.).
Porto TorresAdagiata su un pianoro che digrada dol-cemente verso il mare del golfo dell’Asi-nara, è una delle cittadine (m 5, ab. 21 888)più importanti del Nord Sardegna, grazieal suo attivo porto, attraverso il quale sisvolge una grossa parte del traffico pas-seggeri da e per la Penisola: La nascita del-la città, che ebbe nome Turris Libisonis,avvenne probabilmente in età cesariana(46 a.C.) con la deduzione di una colonia(unica in Sardegna per quel periodo) di cit-tadini romani. La città ebbe impianto or-togonale, con orientamento nord-sud, la-sciato poi in eredità alla città moderna lacui via principale, il corso Vittorio Ema-nuele II, pare ricalchi nel suo ultimo trat-to la più importante via di comunicazionedella Sardegna romana: la “A Turre Kàra-les” (da Porto Torres a Cagliari), come a di-re l’attuale Carlo Felice. La floridezza eco-nomica della città fu determinata dal suoporto, presso il quale venivano imbarcatii cereali prodotti nel ricco entroterra del-la Nurra. Durante le persecuzioni di Dio-cleziano del 304, presso Turris avvenne ilmartirio dei santi Gavino Proto e Gianua-rio (la critica tende a considerare figurastorica soltanto Gavino): l’episodio si sa-rebbe rivelato determinante, con la co-struzione nell’XI sec. della splendida basi-lica dedicata a S. Gavino, per la prosecu-zione della vita nel sito. Infatti in età me-dievale la città, decaduta dopo essere sta-ta anche capitale del giudicato di Torres,si contrasse notevolmente fino a ridursi adue piccoli nuclei, uno presso la basilicae a un altro presso il porto.La rinascita, degli inizi dell’800, è dovutaa vari fattori fra i quali il rifiorire dei com-

merci grazie anche alla realizzazione del-la strada Carlo Felice. Ottenuta già da al-lora l’autonomia da Sassari, Porto Torressi è avviata a diventare un centro econo-mico di notevole rilevanza, con un vastoterritorio che comprende, fra l’altro, anchel’isola dell’Asinara.La città può essere visitata nell’arco diuna mezza giornata partendo dalla basili-ca di S. Gavino, alla quale si arriva, giun-gendo da Sassari, deviando in via Indi-pendenza. Raggiunto il corso Vittorio Ema-nuele, principale arteria cittadina, e suc-cessivamente il porto, ove campeggia unatorre aragonese del XIV sec., percorrendoin automobile il lungomare Balai si per-viene alla suggestiva rupe calcarea ovesorge la chiesetta di S. Gavino, sul pre-sunto sito del martirio dei santi turritani.Tornati indietro fino a piazza Umberto I, edeviando a destra per via Ponte Romano,si raggiungono l’Antiquarium e gli scavi ar-cheologici dell’antica Turris Libisonis.
10.1 Porto Torres
145
Basilica di S. Gavino*. Costituisce l’e-sempio più antico, più grandioso per di-mensioni e senz’altro fra i più insigni del-l’architettura romanica pisana in Sardegna.La menzione più antica della chiesa è nel“Condaghe di S. Pietro di Silki” di Sassari,riferibile all’anno 1065, sotto Barisone I; unaltro documento più tardo attribuisce lacostruzione al ‘giudice’ Comita. Edificatasulla collina detta monte Agellu sul sito diuna più antica basilica sepolcrale, la fab-brica presenta due absidi contrapposte,caratteristica unica in Sardegna e co-munque rarissima in Italia, e due ingressiper parte nei lati maggiori. Il paramentoesterno, realizzato in conci di calcare, sipresenta scandito da arcature sulle qualisi aprono, alternate, strette monofore. Nellato nord, sul quale prospettano le co-struzioni seicentesche del cosiddetto“atrio Comita”, si conserva l’unico porta-le romanico, riferibile alla seconda metàdell’XI sec., decorato con sculture di figu-
re umane e animali dalleinfluenze lombarde. Pres-so il lato sud si apre inveceil mirabile portale geminogotico-catalano, datato al1492, attraverso il quale siaccede attualmente alla ba-silica. L’interno, ampio esolenne, è diviso in tre na-vate, con arcate su robustipilastri cruciformi e colon-ne di reimpiego. La navatacentrale è coperta da ca-priate lignee, quelle latera-li da volte a crociera. Pres-so l’abside orientale sonoesposte, su un catafalco, lestatue lignee dei martiri tur-ritani (sec. XVII); nella na-vata settentrionale sonouna statua equestre di S. Ga-vino (inizi sec. XVII) e un’e-pigrafe in greco-bizantino(VII sec.) che commemorala vittoria di un duce Co-stantino sui longobardi chetentavano di invadere laSardegna. L’anticripta cu-stodisce alcuni pregevolisarcofagi romani istoriati.Di qui è possibile accederesia ai resti della basilica se-polcrale del VI sec., sia allacripta ove, entro tre sarco-fagi romani, si conservanole ossa ritenute dei martiriuccisi sotto Diocleziano.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

S. Gavino a Mare (o di Balai). Collocata to-pograficamente presso l’antica necropoliorientale di Turris Libisonis, fu edificata in-torno alla metà dell’800 sul luogo dove, se-condo la tradizione, sarebbe avvenuto ilmartirio e il primo seppellimento di Gavi-no, Proto e Gianuario. Proprio in memoriadi questo fatto, ogni anno nel mese dimaggio vengono qui trasportate dalla ba-silica di S. Gavino le statue dei tre martiri.La chiesa presenta, adiacenti, due ipogeiutilizzati come sepolture.
Terme Maetzke. L’edificio è così noto dalnome dell’archeologo che ne curò lo sca-vo alla fine degli anni cinquanta. Presentatre ambienti, dei quali uno absidato, ori-ginariamente con pavimenti mosaicati epareti con intonaci dipinti e rivestimentimarmorei, costruiti nella media età impe-riale romana. La parte mancante venne di-strutta nell’800 in occasione della costru-zione della vicina ferrovia.
Antiquarium Turritano*. Custodisce i re-perti archeologici provenienti dagli scavidi Turris Libisonis e inoltre l’interessanteCollezione comunale. Al piano terra rive-ste notevole interesse l’ara marmorea di C.Cuspius Felix, dedicata alla divinità egi-ziana Bubastis sotto l’imperatore Tiberio,e ritrovata presso il palazzo di Re Barbaro.Nel piano superiore si segnala un mosaicopolicromo* di tarda età imperiale, con dueiscrizioni funerarie corredate da simbolicristiani, facente parte della copertura didue tombe rinvenute nella zona di Balai.
Palazzo di Re Barbaro*. Si tratta in realtàdell’area pertinente alle cosiddette Ter-me centrali, ma che ha preso il nome dalmitico governatore che, come vuole latradizione, avrebbe condannato a morte itre martiri turritani.Subito dopo l’ingresso, presso l’Antiqua-rium, si incontrano i resti di un’insula, unquartiere abitativo facente probabilmen-te parte del primo impianto ortogonaledella colonia romana. Superata una stradalastricata in basalto (decumanus) si ac-cede all’imponente edificio termale (rea-lizzato in due fasi distinte nel II e tra la fi-ne del III e gli inizi del IV sec.), arrivando alfrigidarium, che conserva due vasche apianta rettangolare con decorazioni mu-sive a pelte e a motivi geometrici, e poi altepidarium, anch’esso mosaicato e conparte delle volte ancora in posto. Seguono,in successione, i tre ambienti dei calidaria,l’ultimo dei quali presenta ben conserva-
10 La Nurra e il Paese di Villanova
146
to, nell’abside, il pavimento poggiante supilastrini e le intercapedini alle pareti perla circolazione dell’aria calda.All’esterno, strade lastricate fiancheggia-no le terme; presso quella con orienta-mento nord-sud (cardo) si affacciava unportico sul quale si aprivano numerosilocali pubblici (tabernae). Attualmentel’interno dell’edificio termale è chiuso alpubblico e sono percorribili unicamente lestrade che lo fiancheggiano.
Terme Pallottino. L’edificio, databile aetà imperiale romana, prende nome dal-l’archeologo Massimo Pallottino, autoredegli scavi tra il 1940 e il 1942. Si conser-vano parzialmente alcuni ambienti, fra iquali quello settentrionale presenta un’am-pia vasca con il pavimento mosaicato conun motivo a losanghe e quadrati curvilinei.
Il ponte romano sul riu Mannu, realizzatoprobabilmente agli inizi dell’età imperiale,apparteneva alla strada che collegava Tur-ris Libisonis con Kàrales (Cagliari) se-guendo la costa occidentale.Il monumento, lungo 135 m, varca il fiumesu sette arcate a sesto ribassato di gran-dezza crescente da est verso ovest, perconsentire una graduale salita della stra-da dalla città verso la campagna, posta aun livello più alto. Grazie anche al suo ot-timo stato di conservazione (fino alla finedegli anni settanta era ancora aperto altraffico), è la più importante opera di que-sto genere della Sardegna romana.
Stintino*Usciti da Porto Torres la strada si allon-tana dal mare e, seguendo l’ampia curvadella costa del golfo dell’Asinara, puntaverso Stintino (m 9, ab. 1197), pittorescovillaggio di pescatori ora frequentato cen-tro balneare, posto quasi sull’estremitàdella penisoletta che si protende versol’isola dell’Asinara. Ha due porticcioli, benattrezzati, uno peschereccio e uno turi-stico. Fondato nel 1885 per trasferirvi gliabitanti dell’Asinara (v. oltre), il rinomatocentro di villeggiatura conserva il bel nu-cleo originario, di strade tagliate a maglierettangolari e linde casette sempre fre-sche di tinteggiature color pastello. Haspiagge indimenticabili: basti ricordarequella delle Saline e soprattutto quelladella Pelosa dalle acque smeraldine, pro-tetta dalla bassa isola Piana. Sia sulla pri-ma spiaggia che sulla seconda si trovanodue torri spagnole. Nello stagno di Casa-raccio vicino all’abitato, esteso per circa 10
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

ettari in una cornice di macchia mediter-ranea e palme nane, stazionano fenicotteri,garzette, aironi e cormorani.
L’Asinara*L’isola dell’Asinara è, con i suoi 52 km2 disuperficie distesi per quasi 18 chilometridallo stretto di Fornelli, a pochi metri dal-la verde spiaggia della Pelosa, sino allapunta dello Scorno, a nord, quasi la con-tinuazione della penisola della Nurra concui la Sardegna termina nella sua partenord-occidentale.Già conosciuta dai romani che la chiama-vano “Herculis insula”, l’isola di Ercole,punto di riferimento per tutti i navigantiche andavano dalla Spagna verso Roma ouscivano dalle tempestose Bocche di Bo-nifacio, fu popolata a partire dalla fine delmedioevo da alcune famiglie di pastorisardi e di pescatori liguri: questi addetti al-le tonnare del litorale, quelli alla custodiadel gregge. Ogni tanto dovevano difen-dersi dalle improvvise incursioni dei pirati:nella seconda metà del Cinquecento sullerive furono erette e fortificate torri d’av-vistamento e di protezione.Nel giugno del 1885 lo Stato italiano deci-se di impiantare qui una stazione di qua-rantena marittima internazionale e unacolonia penale all’aperto. L’intera isolavenne interdetta ai suoi abitanti (che era-no allora circa cinquecento) ed espro-priata. Con i pochi soldi degli indennizzi,45 famiglie ‘deportate’ si spostarono sul-la terraferma più vicina dove fondarono ilborgo di Stintino.Nel 1976 il governo decretava il vincolopaesaggistico dell’isola e il 28 novembre1997 veniva istituito il Parco nazionale
147
dell’Asinara. Ci sono spiagge di mare lim-pido, bellezze naturali quasi intatte, bran-chi di mufloni e una piccola congrega diasinelli bianchi. L’accesso all’isola è con-tingentato e regolato: informazioni pressola Direzione del Parco, a Porto Torres, viaIosto 7, tel. 079503388.
Oggi Argentiera (deviazione da Palmàdula: me-no di 6 km) è un piccolo villaggio (m 42) che di-mostra con chiara evidenza il suo abbandono.Vi fiorì, dalla metà dell’Ottocento fino agli annicinquanta del Novecento, un’intensa attivitàmineraria legata all’estrazione di piombo ar-gentifero e zinco. Anche i romani conoscevanola zona e ne sfruttarono le risorse del sotto-suolo. Il centro minerario, nonostante il suosquallore, ha tutto il fascino di un grande ‘pez-zo’ di archeologia industriale.
Lago di BaratzCon una breve diramazione dalla stradache conduce a Porto Conte si raggiunge illago di Baratz, unico naturale in un’isolaparticolarmente ricca di bacini artificiali,dalle acque verdastre e un po’ limacciosema circondato da una fresca oasi di albe-ri ad alto fusto, rifugio di varie specie di uc-celli stanziali e di passo.
A Porto Conte e alla Grotta di NettunoSi prosegue verso sud-ovest attraversouna ridente scacchiera di vigneti. Poi lastrada costeggia il mare fino ad arrivare almonte Timidone (m 361) quasi in cima alpromontorio calcareo di capo Caccia*. Ilpromontorio, dagli scoscesi, alti contorniintarsiati da aeree falesie e caverne, nidoe rifugio ai grifoni, chiude a U l’insenaturadi Porto Conte*, il “Portus Nimpharum” diTolomeo. Nella parete occidentale di capo
10.1 Da Porto Torres a Porto Conte
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Caccia, a strapiombo sul mare, si apre l’e-scala del Cabirol* (scala del capriolo),con i suoi 656 gradini scavati arditamentenella strapiombante parete rocciosa, cheportano all’entrata della Grotta di Nettu-no** Vi si può arrivare anche via mare coni numerosi traghetti che durante la sta-gione turistica partono ogni ora dal portodi Alghero. Illuminata elettricamente, lagrotta, fra le più suggestive del Mediter-raneo, può essere percorsa lungo una se-quenza di laghetti, stretti passaggi, ampisaloni con colonnati, dove la fantasia del-la natura ha disposto, con le concrezionicalcaree delle stalattiti e delle stalagmiti,scenari assolutamente fiabeschi. Quasi di fronte alla grotta è la Foradada,isoletta attraversata da una parte all’altrada una galleria naturale a fior d’acqua.Nella parete opposta a quella della grottadi Nettuno si apre l’ingresso alla grottaVerde, cui si accede dalla parte alta del pro-montorio vicino alla torre del Bulo (sec.XVII); la grotta è a 80 m più sotto, nel cuo-re della roccia, quasi a livello del mare. Alsuo interno sono stati trovati resti di pre-senza umana databili già al Neolitico an-tico. Alla grotta dei Ricami si arriva invecesolo dal mare, nella parete di capo Cacciache guarda verso Alghero; l’ingresso è a 4m sulla superficie dell’acqua. Le niveeconcrezioni cristalline dell’interno, limi-tatamente alle parti già esplorate, sonodavvero singolari per la ricchezza e lastraordinaria varietà delle forme.
Nuraghe di PalmaveraSulla statale 127 bis per Fertilia, costeg-giando la baia di Porto Conte (punteggia-ta di resti di ville romane minacciate da co-struzioni non sempre molto ponderate)con acque d’incredibile trasparenza, si
148
arriva al nuraghe di Palmavera, quasi af-facciato sulla strada. Risultato di una lun-ga serie di rifacimenti che vanno da primadel 1000 al sec. VIII a.C., il nuraghe, re-staurato e visitabile, ha una pianta carat-terizzata dall’aggiunta di un bastione el-littico e di una torretta alla grande torreche ne costituisce la parte centrale.Proseguendo verso Fertilia si possonoraggiungere, con brevi deviazioni, la baiae la torre del Lazzaretto (sec. XVII) e la no-ta spiaggia delle Bombarde.
FertiliaPopolosa frazione (m 9) di Alghero, è unadelle “città nuove” del fascismo, fondatanel 1936 come piccolo centro urbano cuidoveva far capo il vasto intervento di bo-nifica ‘integrale’ (come si diceva allora)nella vicina Nurra.All’inizio fu popolata da gruppi di famiglieferraresi, cui si aggiunsero, subito dopo lafine della seconda guerra mondiale, pro-fughi giuliani e dalmati provenienti dalleterre cedute alla Iugoslavia. Intorno al nu-cleo originale di case nello stile del razio-nalismo, raccolto intorno alla parrocchia-le di S. Marco e alla torre Littoria (ora sededi uffici amministrativi), si è sviluppata,lungo la costa, una bordura di ville co-struite in questi ultimi anni. Dal vasto lun-gomare dominato dal Leone di S. Marco,bella veduta sull’ampio golfo di Alghero.
Necropoli di Anghelu Ruju*Lasciando a sinistra il ponte romano di Fer-tilia, si segue la cosiddetta strada dei duemari per Porto Torres. La necropoli, at-tualmente piuttosto trascurata, si trova sulbordo a sinistra della strada, subito dopo ladeviazione per l’aeroporto di Alghero-Fer-tilia. È un complesso preistorico a domus de
janas fra i più importantidella Sardegna. Scopertonel 1905, è composto da 36tombe ipogeiche che rical-cano la tipologia architet-tonica delle abitazioni: il ve-stibolo è in qualche casopreceduto dal dròmos,mentre i vani laterali con-tornano quello principale. Qualche chilometro più avanti,sempre sulla «strada dei duemari», sulla destra si trovano gliingressi ai vigneti Sella e Mosca(tenuta I Piani). Nel 1902 i fra-telli Sella, biellesi, con il co-gnato Mosca impiantarono, su540 ettari di terreno incolto ac-quistato dal comune di Alghe-
10 La Nurra e il Paese di Villanova
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

ro, un’azienda vinicola che ancora oggi è la piùimportante in Sardegna: vi si producono eccel-lenti vini bianchi, rosati e rossi liquorosi, che ven-gono esportati ovunque. Tutto il territorio, del re-sto, ha una chiara vocazione vinicola come di-mostrano altre aziende, quali la Cantina sociale
149
di Santa Maria La Palma, a 7km da Fertilia sulla statale 291che conduce a Sassari.
Verso AlgheroSi raggiunge Alghero co-steggiando la lunga spiag-gia di S. Giovanni, lo stu-pendo ‘lido’ che dalla cittàgiunge fino a Fertilia. È unadelle spiagge più lunghe epiù larghe della costa sar-da. Ha sabbie profonde e fi-nissime dove allignano, apochi metri dal mare, pian-te di ginepri dalle grandi
contorte radici. Tra duna e duna fiorisco-no i bellissimi gigli della sabbia («Pancra-tium illyricum»), specie endemica dellaSardegna, della Corsica e della Capraia.Non coglieteli: sono protetti.
10.2 AlgheroItinerario pedonale tra i monumenti del centro storico (pianta a pag. 150)
Sebbene insista su un territorio dalla mil-lenaria vocazione abitativa, di Alghero*(m 7, ab. 40 594), sorvolando sulla paren-tesi romana, si può cominciare a parlaresoltanto dopo la conquista catalano-ara-gonese (1323) della Sardegna. OccupateCagliari e Sassari, ai catalani occorrevaun comodo approdo sul nord-ovest dell’i-sola. Alghero era una piccola fortezza por-tuale che la famiglia Doria aveva edificatonella prima metà del XII secolo. Così, nel1354 il re Pietro il Cerimonioso avanzòcon un’imponente spedizione catalano-aragonese. Pochi mesi dopo, la roccaforteveniva interamente ripopolata da genteproveniente dai domini iberici.Durante gli anni, seguendo le esigenze mi-litari, vennero abbattute le innumerevolipiccole torri genovesi, rinforzate e am-pliate le mura, innalzate torri più alte egrandi. Ma Alghero, che nel 1501 era stataelevata al rango di città e godette sempredei privilegi che i catalani garantivano al-le colonie d’oltremare, trovò i suoi mag-giori nemici nella scoperta dell’America enelle pestilenze. Nel ’500 si riaprirono leporte ai forestieri, palazzi e chiese creb-bero su se stessi, per non oltrepassare lemura della fortezza. Nel 1720 la Sardegnaera passata ai Savoia, ma Alghero non ave-va perduto la sua catalanità; tanto che,nel 1850, a uso degli algheresi, venne stam-pato un catechismo in lingua catalana.Ancora oggi molti degli abitanti parlano un
dialetto arcaico del catalano. Ma nell’800la città è troppo cresciuta: così, negli ulti-mi decenni del secolo, si abbattono le mu-ra che separavano Alghero da terra. È unparadosso, ma è solo a partire dal princi-pio della sua alterazione che si può parla-re di interesse degli algheresi verso il lorocentro storico, offeso da un bombarda-mento alleato il 17 maggio 1943, e dagliscempi di un’edilizia scriteriata. Il più im-portante valore documentale di Alghero èracchiuso nella mediterranea e catalanacittà vecchia. Ed è seguendo la via dellemuraglie che ne racchiudevano il perime-tro che ci si può immergere dentro la sto-ria di Alghero; andando per torri i cui spa-zi interni sono spesso adibiti a sale peresposizioni, e cercando le tracce delle mu-raglie che le legavano. Muraglie abbattuteo inghiottite dentro casermoni da parte diterra, ma ancora vive dalla parte del mare.
Torre del Portal o di Porta a Terra (C2).Fra le sette torri ancora esistenti nel tes-suto urbano è la più centrale (sec. XVI). Al-ta e imponente, ancora nell’800 segnava illimite tra città e campagna, e dai suoi por-tali, aperti dall’alba al tramonto, era con-sentito l’unico accesso dalla parte di ter-ra. Adesso, a murare il portale, vi è il mo-numento ai caduti.
Torre de Sant Joan o di S. Giovanni (C2).Sul vicino largo San Francesco, si erge
10.1 Da Porto Conte ad Alghero
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

quest’altra torre circolare dirimpetto al-l’antico Collegio dei gesuiti, anch’essa ri-salente al ’500. Le è stato scavato intornouna sorta di moderno anfiteatro.
Torre de l’Esperó reial* o dello Sperone(D2). Proseguendo verso il mare si arrivaalla piazza Sulis, davanti alla torre altri-menti nota come torre di Sulis*. Anch’es-sa a pianta circolare, è certamente la piùricca di storia e di storie. L’imperatoreCarlo V, nel 1541, vedendola non ancora ul-timata, diede alcuni preziosi consigli perla sua costruzione; dal 1800 al 1821 vi fu in-carcerato il patriota sardo Vincenzo Sulis.
Torre de Sant Jaume o di S. Giacomo(C1). Vi si arriva godendo del mare sulla si-nistra e della vista dei campanili e dei tet-
10 La Nurra e il Paese di Villanova
150
ti dei vecchi palazzi catalani sulla destra.È l’unica a pianta ottagonale e consentivauna discesa coperta sul livello del mare; intempi non lontani fu utilizzata come cani-le, e per molta gente è ancora la “Torredels Cutxus” (dei cani).
Torre de la Polvorera (B1). Proseguendoancora verso il mare si cammina sui ba-stioni Marco Polo, il primo tratto ancora vi-sibile dell’antica muraglia catalana. Dopoqualche minuto si è sulla punta estrema epiù alta della penisoletta rocciosa su cuivenne edificata la roccaforte. A guardiadella città e a riferimento dei marinai vi èla torretta su cui stava una lanterna, e die-tro è la torre polveriera (XVIII sec.), alle cuispalle si erge l’enorme edificio che fu ospe-dale, poi scuola e ora è un rudere cadente.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

I bastioni. Si prosegue con il mare giù sul-la sinistra, inquietante se visto attraversole feritoie nella muraglia. Dopo una sostasulla torre de Castilla (XVI sec., B1), un ma-gnifico belvedere, lungo i bastioni Magel-lano si arriva alla scalinata che dà sul por-to, da cui si comincia a intuire la grandemuraglia su cui si è passeggiato. Più avan-ti, a destra vi è il forte della Maddalena (B2,riattato ai primi del ’700), con la relativatorre intitolata a Giuseppe Garibaldi.
Adesso il perimetro militare in cui è racchiusala storia della “piccola Barcellona” è concluso;prima di voltare pagina, però, a chi non ha lapossibilità di vedere la città da una barca al lar-go del porto, si consiglia vivamente di prose-guire la passeggiata fino alla lanterna sul Molonuovo. È un lungo tratto, ma è come cammina-re in mare aperto stando a pelo d’acqua, equando finalmente si è all’estremità e si guardaindietro, l’idea del ritorno al passato è chiaris-sima: le enormi muraglie, che dalla parte del ma-re sono ancora integre, restituiscono viva l’im-magine di una città del periodo medievale.
Pláia Cívica. Si rientra in città attraversoPorto Salve, o Porta a Mare (B1), il vero esolo ingresso all’anima forte di Alghero,quella marinara. Si accede alla piazza me-dievale della città, la Pláia Cívica (B1-2), cuiè stato restituito l’antico selciato di la-stre e ciottoli. Da una delle finestre gotichedell’imperioso palau Albis (già De Ferrera),interessante esempio di architettura ci-vile del XVI sec., nel 1541 Carlo V salutò lafolla poco prima di salpare verso la cam-pagna d’Africa. In questa piazza erano an-che gli ingressi al palazzo della Dogana eal Palazzo comunale, al cui piano terra èospitato attualmente il Circolo dei Marinai.
151
Cattedrale di S. Maria (B1). Divenuta se-de vescovile nel 1503, Alghero volle unacattedrale degna di una città regia e dal se-condo quarto del XVI secolo diede l’avvioalla grandiosa fabbrica che avrebbe do-vuto emulare le architetture religiose ca-talane. Di stile gotico catalano sono, infatti,la zona absidale e l’alto campanile pri-smatico cuspidato, alla cui base si apre labella porta secondaria (porta petita). Cam-biato il gusto, la chiesa procedeva, se-condo schemi rinascimentali, nelle tre na-vate con ampio transetto e cupola otta-gona alla crociera. Nel 1594 i lavori eranoconclusi. Importanti testimonianze d’etàsabauda sono l’altare maggiore tardoba-rocco in marmi policromi del 1727 e nelbraccio sinistro del transetto il neoclassicomonumento funebre a Maurizio di Savoia,morto in città nel 1799. Nel 1862 alla fac-ciata manieristica fu addossato un pro-nao tetrastilo su alto stilobate con scali-nata centrale. Adiacente alla Cattedrale è il Museo dio-cesiano d’Arte sacra, che raccoglie il teso-ro del duomo e qualche pezzo notevole dialcune chiese cittadine. È aperto tuttol’anno: tutti i giorni d’estate e nei mesi in-vernali il sabato e la domenica.
Pláia del Bisbe. Sulla piazza del vescovo,o “del teatre”, si affaccia il Teatro civico dalbel prospetto neoclassico, edificato nel1862 da Francesco Poggi. Uno dei pochiteatri lignei conservati pressoché inte-gralmente, dopo un lungo restauro è sta-to riaperto al pubblico. Sulla piazza si af-facciano anche il settecentesco Palazzo ve-scovile e la cosiddetta casa Doria* (C1), opalau Machin, dal nome di un vescovo al-
10.2 Il centro storico di Alghero
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

gherese che l’abitò. Il palazzetto, databilealla metà del XVI secolo, è uno splendidoesempio di architettura gotico-catalana.Notevoli le elaborate finestre architravatea cortina con cornici a bilancia e il porta-le dagli influssi rinascimentali.Alla fine della strada vi è la chiesa della Mi-sericordia (C1), dove imprescindibile è il Cri-sto ligneo (dei primi anni del ’600), notevolescultura dalle braccia snodabili, che ognianno durante gli affascinanti riti spagnole-schi della Settimana Santa i ‘baroni’ de-pongono dalla croce in mezzo alla folla.
Chiesa di S. Miquel* o S. Michele (C1-2).Grande esempio (seconda metà del XVIIsec.) della cultura gesuitica in Sardegna, im-pulso culturale che ancora si intuisce sia al-l’esterno sia all’interno della chiesa. All’e-sterno, malgrado la colorazione risalgaagli anni ’60 del XX secolo, la bella cupola la-stricata di maiolica valenciana; all’internoBattesimo di Cristo, un ispirato Crocifissosettecentesco, e soprattutto il coro ligneo.
Chiesa di S. Francesc* o S. Francesco(C1-2). Tappa obbligata in ogni percorsoturistico della città, fu costruita alla finedel XV secolo secondo il gusto gotico ca-talano, come mostrano il presbiterio, al-cune cappelle e il campanile poligonale gu-gliato, salvatisi dal crollo del 1593. La ri-
152
costruzione trasformò l’aula originaria inun impianto a tre navate. Restaurata neglianni scorsi, oggi ospita nel bel chiostroquattrocentesco importanti manifesta-zioni musicali.D’interesse sono l’altare maggiore tardo-barocco in marmi policromi (1773) e lascultura lignea settecentesca del Cristoalla colonna, proveniente dalla scompar-sa chiesa di S. Croce.
Il 24 giugno 1355, pochi mesi dopo averla conquistata, re Pietro IV d’Aragona assegnavaad Alghero lo stemma della città: in alto le quattro barre d’Aragona, in basso «ondedel mare con un ramo di corallo che si erge in mezzo dalle onde verso su». Era la con-sacrazione di Alghero come centro di riferimento per la pesca del corallo nei mari sar-di: nel 1384 un altro editto reale imponeva a tutte le barche coralline che pescavanodal Capo di Napoli sino all’Asinara di fare scalo ad Alghero. Sappiamo che in quel pe-riodo si pescava da aprile a settembre e che in due mesi una barca poteva tirar su an-
che tre quintali di prodotto.La pesca del corallo, come si sa, è stata per secoliuna delle più distruttive: perché il cosiddetto “in-gegno”, il grande trave che la barca trascina sulfondo del mare in modo che i rami di corallo re-stino impigliati nella rete in cui è avvolto, lasciadietro di sé rami spezzati e piante divelte. In que-sti ultimi anni da una parte la pesca si è specia-lizzata, impiegando addetti subacquei che, sem-bra, provochino danni minori ai fondali, e dall’altrail corallo è stato protetto.Un tempo gran parte del prodotto finiva a Torredel Greco. Oggi lo si lavora, e bene, anche ad Al-ghero: così la città è tornata ad essere una piccolacapitale del corallo, che splende (come si vede nel-la foto) nelle vetrine di cento gioiellerie.
Il corallo di Alghero
10 La Nurra e il Paese di Villanova
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

10.3 Il Paese di Villanova e BosaItinerario circolare a sud di Alghero, da dove parte e ritorna, dopo km 120 (carta a pag, 145)
153
Il percorso consente di conoscere unoscorcio del paesaggio interno della Sar-degna, senza peraltro allontanarsi troppodalle zone costiere. Interessa la parte sud-occidentale del Logudoro e del Meilogu.Corre lungo strade tortuose ma dal fondoabbastanza buono, che per il primo trat-to (statale 292) salgono verso le alture delVillanovese (o Paese di Villanova) perscendere poi, seguendo a distanza il cor-so del Temo, verso l’attraente cittadina diBosa che il fiume attraversa nel suo trat-to finale. Si incontrano paesi lindi e ani-mati, con una certa memoria storica: Vil-lanova Monteleone (25 km), Pàdria (27km), Suni (21 km), Bosa (10 km), per farepoi ritorno ad Alghero (37 km).
Scala Piccada*La statale 292 per Villanova sale dal marequasi improvvisamente, arrampicandositortuosa per i tornanti di Scala Piccada(strada scavata col piccone); dalla canto-niera omonima (m 355) lo sguardo spaziasu Alghero, sul golfo e sulla possente sa-goma di capo Caccia. È uno degli spetta-coli naturali più belli della Sardegna: siha la sensazione di trovarsi in un sito benpiù alto anche perché i venti dominanti diponente e maestrale vengono su fragran-ti e salmastri dal mare aperto. Poi la stra-da prosegue tra formazioni rocciose, bo-schi di roveri e singolari cespugli di palmanana, uno dei tanti endemismi vegetalipresenti ancora nell’isola.A un paio di chilometri da Villanova Mon-teleone si trova sulla sinistra, proprio almargine della carreggiata, la fontana del Pa-radiso, così detta per le acque fresche eleggermente dolci, alle quali la tradizioneattribuiva sicure proprietà magiche controla tristezza e la sfortuna.
Villanova MonteleoneÈ un antico centro di allevatori (m 567, ab.2623) che vive agiatamente di pastorizia,di allevamento e di attività artigianali co-me la tessitura dei tappeti, degli arazzi edelle coperte di lana ruvida (fressadas). Ilpaese fu costruito dai profughi della vici-na Monteleone Rocca Doria che nel 1436fuggivano dall’assedio degli eserciti diSassari, Alghero e Bosa. Nella zona di Cal-via furono trovate 38 monete d’oro puni-che che sono conservate ora nei musei di
Cagliari e di Sassari. Oggi Villanova Mon-teleone è uno dei centri più importanti inSardegna per l’allevamento degli ovini esoprattutto dei cavalli da competizione. Davisitare la cinquecentesca parrocchiale diS. Leonardo da Limoges, in parte alteratadalla ristrutturazione del 1789.
Anche la chiesa della Madonna di Interrìos, aqualche chilometro dal centro abitato, con ilsuo vasto parco alberato, può essere meta diuna gita. Proseguendo sulla statale 292 per Bo-sa si incontra il lago artificiale del Temo e si la-sciano sulla sinistra il minuscolo borgo di Mon-teleone Rocca Doria (m 368, ab. 135) e il picco-lo centro agricolo di Mara (m 257, ab. 858). A unpaio di chilometri dal paese è consigliabile de-viare per i resti (due torri e due cisterne) del ca-stello di Bonu Ighinu, rocca medievale dei Doria.Più a monte, la chiesa di Nostra Signora di BonuIghinu dalla straordinaria facciata lavorata co-me un retablo ligneo.
PàdriaAi confini con il Meilogu sud-occidentale,fu un importante centro cartaginese, chia-mato poi dai romani Gurulis Vetus. Ri-mangono ancora parti di necropoli ed esi-ste un Museo civico archeologico dove siconservano olle, anfore ed embrici di epo-ca punica e romana. Nel medioevo Pàdria(m 304, ab. 874) appartenne al giudicatodel Logudoro; passò poi ai Doria e suc-cessivamente ai ‘giudici’ d’Arborèa.
La discesa su BosaLa statale 292 digrada dolcemente verso lacosta, entra in provincia di Nùoro, scorrein vista del nuraghe Nuraddèo e raggiunge,dopo una ventina di chilometri, Suni (m340, ab. 1286), piccolo centro della Pla-nargia che vive di agricoltura e pastorizia.Più in basso, sul mare, è l’elegante citta-dina di Bosa tagliata in due dal fiume Te-mo, navigabile, a monte, per un lungo trat-to e gonfio, fino a dilagare sui marciapiedie nei quartieri bassi, nei giorni di burrasca.
Bosa*La cittadina (m 2, ab. 7813; pianta a pag.155), che si stende in una bella conca sul-la destra del Temo, ha origini antiche, chealcuni studiosi datano già al sec. IX a.C. DalMille, divenuta feudo dei Malaspina, po-tentemente fortificata, seguì le vicende
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

storiche della regione conoscendo ancheuna notevole prosperità in grazia di unaposizione strategica che la faceva consi-derare «la chiave di tutta l’isola». Dal 1528decadde, anche in seguito all’ostruzionedella foce del Temo; furono i Savoia a pro-pugnarne il rilancio, favorendo la pesca delcorallo, anche se il vero risveglio econo-mico si ebbe nell’Ottocento con l’incre-mento delle attività artigianali (pelli e me-talli preziosi in particolare). L’edilizia del borgo medievale si è venutaadattando alla singolare conformazionea tronco di cono del colle di Serravalle, sulquale la città si è addossata per cercare laprotezione del castello: il quartiere di ori-gine tardomedievale di Sa Costa, che con-serva varie stratificazioni edilizie, man-tiene ancora oggi una suggestione storicanotevole, con i singolari viottoli che se-guono le curve altimetriche del colle, conle scalinate che interrompono asimmetri-camente il percorso orizzontale, con lestrutture urbanistiche arcaiche e sor-prendenti. In situazione di grave degrado,è attualmente quasi spopolato.
Castello di Serravalle** o dei Malaspina(B3). L’imponente complesso fu costruitoin varie fasi, a partire dal secondo decen-nio del XII sec., allorché vennero realizza-te, per iniziativa dei Malaspina, alcunedelle torri del mastio, con uno schema si-mile a quello del castello di S. Michele diCagliari. La grande torre, attribuita a Gio-vanni Càpula, è costruita in tufo trachiticodi color rosa chiaro; alla base il bugnato è
10 La Nurra e il Paese di Villanova
154
realizzato con conci di trachite rossa. Duesuccessivi ampliamenti portarono il com-plesso a raggiungere un perimetro di 300m intervallato da sette torri poligonali equadrate, racchiudendo una superficie dioltre un ettaro. Altre importanti modifiche,come per esempio i tre spalti terrapiena-ti per la postazione di armi da fuoco, fu-rono decise a partire dal 1468.All’interno della cinta, nella piazza d’armifu costruita nel XIV sec. la chiesa di NostraSignora di Regnos Altos (festa la secondadomenica di settembre), restaurata, al cuiinterno nel 1972 si rinvenne un notevole ci-clo affrescato*, riferito ad ambiente italo-provenzale e datato agli anni tra il 1350 eil 1370. Il ciclo è articolato sulle tre paretiprincipali del corpo di fabbrica primitivo(quindi non nel presbiterio e nell’abside,aggiunti successivamente), su due regi-stri divisi da una cornice marcapiano amensole; tra i numerosi santi raffigurati,Martino, Giorgio, Costantino con la madreElena, Cristoforo, Ludovico da Tolosa, Lo-renzo, Lucia, Marta, Giacomo Maggiore.
Il Carmine (B2). Sui ruderi della chiesa diNostra Signora del Soccorso, fu edificatonel 1779 il convento dei Carmelitani (cheoggi ospita il municipio) e l’annessa chie-sa del Carmine, consacrata nel 1810: a uni-ca navata con quattro cappelle per lato, sipresenta semplicissima, con una sola con-cessione al gusto isolano, riconoscibilenel raffinato gioco cromatico delle mem-brature in trachite rossa. La chiesa pre-senta un campanile e tre cupole disposte
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

asimmetricamente, oltre che sul presbi-terio, su due cappelle laterali. All’internodegna di nota è la bellissima bussola delpiù puro barocchetto piemontese.
Più a nord, presso il cimitero, è la chiesa di S.Giovanni (A2), con facciata a capanna del XIVsec., portale ad arco acuto modanato e rosone.L’interno a navata unica ha copertura lignea. Sul pendio collinare a sud-est del Carmine,esercita richiamo l’antico quartiere Sa Costa(B2-3), con stradine acciottolate collegate fra lo-ro da scalinate in trachite; caratteristica la ti-pologia edilizia, seppure povera e degradata.
Corso Vittorio Emanuele* (B-C2-3). Raf-finato spazio urbano, attraversa il quar-tiere Sa Piatta, con case elevate in altez-za, di fisionomia formatasi nel ’700. Il corso è fiancheggiato da case sette-ot-tocentesche (tra le quali si segnala, sullapiazza Costituzione, il palazzo Don Carlos;si vedano inoltre casa Scarpa e casa Uras,quest’ultima recentemente restaurata),con i graziosi balconcini decorati in fer-ro battuto, e più volte interrotto ai lati daarchi che danno accesso alle viuzze adia-centi pavimentate in basalto e ciottoli.
155
Cattedrale dell’Immacolata (B-C3). Fian-cheggiante il corso, venne rifatta nell’Ot-tocento, per opera di Salvatore Are, dopoche già nel xv sec. s’era intervenuti sullaoriginaria struttura (XII secolo).La facciata, divisa in due ordini da unarobusta cornice, è caratterizzata dal mo-vimentato ed elegante cappello sul portaled’ingresso. L’interno consiste in un’aulaspaziosa tutta sviluppata longitudinal-mente. Sul coro profondo insiste la cupo-la ottagona, decorata nel 1877 con unascena del Paradiso dantesco da EmilioScherer, del quale sono pure gli affreschisul catino dell’abside (S. Emilio, S. Priamo,la Madonna con sullo sfondo una vedutadella città ottocentesca) e quelli sui lati delpresbiterio. Interessanti anche il coro ligneo e i mobi-li della sagrestia, riferiti al 1803. Sulla tri-buna si segnala l’organo della fabbricaspagnola De Orqueña, inaugurato nel 1810e più volte restaurato.Nel Tesoro (sagrestia maggiore) sono con-servati alcuni notevoli pezzi di argenteria,tra i quali un prezioso reliquiario cinque-centesco di scuola cagliaritana, forse por-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

tato a Bosa in occasione dell’episcopatodel vescovo cagliaritano Antonio Cavaro.
Sas Conzas* (C2). Sulla sponda sinistra delfiume si trova il pittoresco quartiere arti-gianale con i grandi fabbricati che si af-facciano sul Temo, destinati dal Sette-cento alla concia delle pelli, vero e propriorelitto di archeologia industriale. Il com-plesso, in attività ancora nell’immediatosecondo dopoguerra, è stato classificatonel 1989 come monumento nazionale esottoposto a tutela. Si tratta di un insiemedi edifici per complessivi circa 4000 m2 di
superficie coperta, con un volume di cir-ca 27 000 m3, attualmente in condizioni digrave degrado, che però caratterizzanofortemente l’aspetto della riva sinistra delfiume con la loro architettura modulare eripetitiva a timpani affiancati.
S. Pietro* (C3, f.p.). La costruzione del-l’antica cattedrale della diocesi di Bosa fuavviata tra il 1062 ed il 1073; un’iscrizioneall’interno, sulla pila dell’acquasanta, ri-corda anche il nome del vescovo che feceedificare la chiesa, Costantino de Castra.L’edificio è il risultato di un lungo proces-so svoltosi in almeno tre diversi momen-ti: al 1062-73 risale il corpo centrale, di gu-sto romanico-lombardo; nel secondo de-cennio del XII sec. vennero eretti l’abside,con le due campate contigue, e il robustocampanile; la terza fase, riferita all’ultimo
10 La Nurra e il Paese di Villanova
156
decennio del XIII sec., comprende il pro-spetto e parte della fiancata nord-occi-dentale, elementi decisamente orientativerso le forme gotiche francesi, importa-te dai Cistercensi.La facciata, attribuita ad Anselmo da Co-mo, costruttore del S. Pietro di Zuri, èconclusa da un’edicoletta con colonninesulla cuspide; spiccano nel prospetto itre rosoni quadrilobati, molto rimaneg-giati, e i tre archi a sesto acuto con i sim-boli dei quattro evangelisti. Sull’architra-ve in calcare sono raffigurate le arcaichefigure di S. Pietro e S. Paolo, della Madon-
na col Bambino e di S. Co-stantino imperatore.Nell’abside sono murateiscrizioni pagane, prove-nienti dalla vicina necro-poli romana, e medievalidi grande interesse storico.L’interno è a tre navate contetto centrale a capriate.
La strada costiera Bosa-Alghero*Lungo la litoranea, gli alticontrafforti sulla destraimpediscono allo sguardodi arrivare ai centri e allecampagne conosciuti nel-l’ultima parte del viaggio.L’interesse è tutto attrattodal mare più sotto, verdescuro. Nell’aria, altissimi,
i grifoni, altro suggestivo endemismo ani-male della Sardegna, che nidificano fraqueste scogliere e in quelle di capo Cacciae punta Cristallo appena più a nord. La roc-cia sulla destra, dove la strada è stata ri-cavata faticosamente, incombe maesto-sa con ciuffi di vegetazione. Verso Alghe-ro questo paesaggio solitario si addolciscein insolite spiagge dalla sabbia rosso-az-zurrina come nell’ampio semicerchio del-la Speranza, a 8 km dal centro ‘catalano’.Dopo un breve pianoro verdeggiante di oli-veti il territorio diventa di nuovo scabro,con rilievi collinari e profonde insenaturenella costa dai nomi cupi o augurali: laCala de l’Omma molt (dell’Uomo morto),per esempio, oppure Calabona. A qual-che chilometro da Alghero la costa è dinuovo alta e deserta, e le onde, se tira ilvento, bianche a merlettare gli scogli.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Profilo dell’areaL’Anglona e il Logudoro sono nell’insieme come un corridoioche dalla costa settentrionale conduce verso il cuore dell’isola,così che la loro civiltà fonde gli influssi che sono di volta in vol-ta venuti dal mare con le manifestazioni più tipicamente lo-cali. Sono d’altra parte terre che per il clima dolce, la fertilitàdei terreni e la moderata disponibilità di acqua (il Coghìnas, il primo tratto del Tirso) han-no sempre reso relativamente facili le condizioni di vita. Dominano ovunque le colline,arrotondate dagli agenti atmosferici e dal lavoro degli agricoltori; soltanto all’interno, neimonti di Alà (Pattada è il paese più alto della provincia di Sassari), in quelli del Gocèa-no e del Màrghine si levano piccole catene che vanno oltre i 1000 metri.La fascia affacciata sul mare – che è poi quello del golfo dell’Asinara – è anche più ric-ca di tratti pianeggianti ed è rimasta fedele all’agricoltura. Una strada costiera ha favoritolo sviluppo del turismo balneare: i punti di maggiore attrazione sono la rocca di Ca-stelsardo e le grandi spiagge che si stendono a oriente e a occidente.
Da qui è facile dirigersi verso l’interno. Col-pisce, se lo si fa nel tempo delle vacanze esti-ve, il passaggio rapido dalla congestione deivillaggi della costa a zone di solitudine e si-lenzio, dove i terreni coltivati si riduconoper lasciare spazio ai pascoli, alternati aqualche zona di macchia e bosco. Le campagne sono disabitate, la popola-zione si concentra nei villaggi, ben distantiuno dall’altro, la maggior parte tra i 1000 ei 3000 abitanti, ideali per la conservazionedello spirito comunitario che è parte cosìimportante della loro natura. Il relativobenessere che li ha raggiunti, il naturale at-taccamento alle eredità del passato e in-sieme l’idea di poter attirare i flussi turisticidella costa li inducono a rinnovare le tra-dizioni, mantenere le feste, mettere in lucemonumenti sovente di qualità. Campeggia così, al centro del territorio, ilgrande nuraghe di Santu Antine, accom-
pagnato nel vicino paese di Torralba da un piccolo ma attivissimo museo; sulla collinavicina si leva la chiesa romanica di San Pietro di Sorres, e altre, una più suggestiva del-l’altra, si allineano da Sassari a Ozieri. Tra le feste tradizionali cui si può assistere rimanel’imbarazzo della scelta: a Nulvi e a Ploaghe, a Ozieri, Òsilo, Bono ecc. Altre suggestio-ni vengono dalla gastronomia, che offre una larga varietà di formaggi – a Thiesi, Nulvie Pèrfugas soprattutto – e i vini robusti che servono per accompagnare gli arrosti e al-tri piatti della tradizione. Ancora una volta il soggiorno avrà buona riuscita se alternerài passatempi del mare con frequenti “puntate” verso l’interno.
11.1 Da Sassari a CastelsardoItinerario circolare da e per Sassari, litoraneo e poi collinare, km 85 (carta a pag. 158)
157
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
11 L’Anglona e il Logudoro
Una corsa veloce da Sassari al ‘suo’ mare,Platamona, poi una passeggiata lungo l’ar-co del golfo dell’Asinara sino al centro piùcaratteristico, Castelsardo. Da questa zo-na sempre molto frequentata, soprattuttonella buona stagione, si va da lu Bagnu a
Tergu, con la sua bella chiesa, e si continuaverso l’interno, in direzione di Nulvi; dopo7.5 km una strada sulla destra conduce in14 km, attraverso una zona alta e movi-mentata di colline a macchia con qualcheresiduo di bosco, alla fertile vallata del

fiume Silis, coltivata a orti e frutteti; da quiuna salita a tornanti porta a Sènnori, chefa ormai tutt’uno con la vicina Sorso; infi-ne rientro a Sassari attraverso una diste-sa ondulata di oliveti.
Da Sassari a PlatamonaSi esce dalla città lungo via Pascoli, e po-co dopo si prende a sinistra la provincia-le detta di Buddi Buddi, che in leggera di-scesa conduce al litorale attraverso unazona di oliveti e frutteti punteggiati di abi-tazioni. Si rivela, qui, l’antica vocazioneagricola della città, quasi un verde ba-stione che la lambisce da nord.A 9 km, verso la fine della discesa che of-fre per prima la vista del mare, una svoltaa gomito sulla destra, senza segnali, con-duce, dopo un centinaio di metri, alla chie-sa di S. Michele di Plaiano*, romanica, tut-ta in blocchi calcarei, una delle più antichedel Capo di Sopra. Esisteva già nel 1082,
158
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

poi divenne sede centrale dei Vallombro-sani di Sardegna, ma in seguito conobbesecoli di abbandono; di recente è statarestaurata, ma ora è nuovamente chiusa.La facciata è armoniosa, segnata da tregrandi arcate che racchiudono nella par-te alta altrettante formelle intarsiate. Ripresa la strada, un breve percorso con-duce alla litoranea Porto Torres-Castel-sardo, che a sinistra, attraverso una zonarimboschita a pineta e densa di insedia-menti balneari, porta al primitivo nucleodi Platamona (m 7): fu creato a partire dal1951 per iniziativa di un intraprendentesindaco sassarese che voleva dare allacittà un suo sbocco al mare alternativo aquelli tradizionali di Alghero e Porto Tor-res. Sulla sinistra si allunga uno stagnocostiero di una novantina d’ettari, che haintorno begli esemplari di ginepro e ospi-ta folaghe, germani reali e altri volatili.
Da Platamona a CastelsardoDa Platamona la litoranea verso Castel-sardo corre rettilinea tra i pini; i villaggi tu-ristici si fanno meno fitti; sulla sinistra ditanto in tanto un breve tratto d’asfaltoconduce a un parcheggio al bordo dellaspiaggia. Ci si immette sulla statale 200 equando la costa si fa alta e rocciosa, si en-tra in un percorso a curve che offre pia-cevoli scorci del litorale. Si giunge al di-sordinato insediamento balneare di lu Ba-gnu e infine, dopo una salita e una curva,si ha di fronte l’abitato di Castelsardo, av-volto al suo monte sporto sul mare.
11.1 Da Sassari a Castelsardo
Castelsardo*Fondato forse nel 1102 dai Doria, il borgofortificato (m 114, ab. 5314), quasi im-prendibile per la sua posizione, fu poi usa-to a lungo dai dominatori di turno per ilcontrollo di quel tratto di costa e del re-troterra. Importante quindi dal punto di vi-sta militare, poté godere a periodi di formedi autonomia comunale; l’economia, fon-data tradizionalmente su pesca e agricol-tura, poggia oggi sul turismo, che ha de-terminato la creazione di molteplici strut-ture ricettive, e sulla rivalutazione del-l’artigianato locale.Lasciata la parte bassa dell’abitato, Pia-nedda, si sale sulla rocca per raggiungerela più antica, Casteddu; questa si visita –a piedi – per stradette scoscese sulle qua-li si affacciano alcuni pregevoli edifici.Precise indicazioni conducono al pano-ramico Castello medievale che ospita ilMuseo dell’intreccio mediterraneo, sem-pre aperto con orario ampio, amplissimonella buona stagione. Vi sono espostiesempi di cestini realizzati con accurata la-vorazione a mano in questo centro e al-trove; e poi altri esempi di intreccio: nas-se per la pesca, borse, e persino un’im-barcazione in materiale palustre – il “fas-soni” – ancora in uso nell’Oristanese. Igiovani della cooperativa che gestisce lastruttura possono dare indicazioni sulletecniche e sui materiali impiegati, utili
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

prima di accostarsi ad acquistare nei nu-merosi negozi d’artigianato o dalle donneche sulla porta di casa confezionano evendono i loro cestini. Scendendo dal Ca-stello nel caratteristico centro storico si ar-riva, passando dalla Casa comunale conporticato gotico, all’originale chiesa di S.Maria, senza facciata, dove è conservatolu Criltu Nieddu* (il Cristo Nero), uno deipiù antichi in Sardegna. Da qui ha inizio equi si conclude, il Lunedì Santo, la più im-portante manifestazione tradizionale lo-cale: è la processione del Lunissanti*, cheal mattino raggiunge Tergu e a sera inol-trata si svolge tra le vie del borgo illumi-nate soltanto da fiaccole: a sfilare sono imembri della confraternita di S. Croce di-visi in tre cori di quattro voci ciascuno.Ancora più in basso, affacciata sul marecol suo campanile aragonese, è la catte-
drale di S. Antonio Abate, del XVI sec.; al-l’interno, il coro, alcuni altari in legno e losplendido retablo* dell’ignoto artista delQuattrocento designato con il nome diMaestro di Castelsardo.
TerguIl piccolo villaggio (m 280, ab. 589) è si-tuato in una conca fertile, abitata sin dal-le epoche più antiche: ha un piccolo nu-
11 L’Anglona e il Logudoro
160
cleo centrale e le altre abitazioni sparsenella campagna circostante. Le occupa-zioni principali sono l’agricoltura e l’alle-vamento; ultimamente sono state avviatealcune iniziative agrituristiche, e i cestiniche vi si intrecciano non sono inferiori aquelli di Castelsardo.Continuando lungo il rettilineo centrale sigiunge alla bella chiesa romanica nota co-me Nostra Signora di Tergu*. Il tempio,con intorno i resti dell’antico monasterobenedettino che gli era unito, risale al XIIIsec. ed è di stile romanico pisano. Ben te-nuta e utilizzata come parrocchiale, hasul fianco un tozzo campanile quadrato.Leggiadra la facciata: realizzata alternan-do armonicamente blocchi di trachite ros-sa e di calcare chiaro, è segnata da una se-rie di arcate, un rosone a quattro lobi e pre-gevoli formelle intarsiate.
Sènnori e SorsoAll’arrivo la strada immette nella partealta di Sènnori (m 277, ab. 7390), colloca-ta ad anfiteatro a ridosso di alcuni rilievicalcarei e vicinissima a Sorso (m 136, ab.14 126), distesa sul declivio che confinacon la piana costiera.Curioso il rapporto tra queste due grosseborgate, divise da profonde diversità eun tempo da reciproca avversione; orache lo sviluppo edilizio le sta unendo,vanno a integrarsi a vicenda: mentre Sèn-nori, che parla logudorese, ha la vocazio-ne del commercio ed è più legata alle tra-dizioni, Sorso, che usa un dialetto simile alsassarese, è tutta dedita alla coltivazionedelle sue fertilissime campagne.A Sènnori si può fare un giro nelle stradettedel centro storico e raggiungere, nella par-te alta, la parrocchiale di S. Basilio, checonserva un’Incoronazione della Verginedel Cinquecento. Nelle feste (per S. Basilio,il 14 giugno; per S. Giovanni Battista, l’ul-tima domenica di giugno, nella chiesacampestre a 2 km dal paese) si possonoammirare i costumi tradizionali femmini-li, tra i più belli e preziosi dell’isola.Entrando a Sorso e prendendo al primo se-maforo a destra si imbocca la via Fioren-tina per raggiungere la parrocchiale di S.Pantaleo, con grande cupola, della primametà dell’Ottocento; e in un vicino avval-lamento la fontana della Billèllara, dalla cuiacqua deriverebbe, secondo la tradizionepopolare, l’estroso carattere degli abi-tanti. Qua e là per il paese si possonocomprare direttamente dagli agricoltori,che li tengono esposti sulla porta di casa,i prodotti dei campi attorno.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

11.2 I colli dell’AnglonaItinerario lineare da Sassari a Ploaghe, km 139 (carta a pag. 158)
161
Salvo una piccola puntata al mare in ter-ritorio di Valledoria, il percorso si snodatutto nella parte interna dell’Anglona.Dapprima lungo la statale 127, che proce-de tortuosissima in un’area di colline cal-caree offrendo la vista di campagne a trat-ti coltivate, a tratti a pascolo brado, a trat-ti ancora coperte di macchie, con qualcheresto di bosco e nelle parti alte punte e pa-reti rocciose inaspettatamente erte.Subito dopo Laerru si devia a sinistra sul-la statale 134 che si dirige verso la costa;giunti alla roccia dell’Elefante si prende adestra verso Codaruìna; quindi, raggiuntala valle del Coghìnas, si torna verso l’in-terno e, costeggiando da lontano la riva si-nistra del fiume, si oltrepassano alcuni ri-lievi per raggiungere la fertile piana diPèrfugas. Da qui il percorso, salvo qualchebreve tappa, segue la “direttissima” diTempio Pausania fino a Ploaghe. Del tuttoagevoli i 23 km per il rientro a Sassari.
ÒsiloTra i centri minori che fanno corona aSassari, Òsilo (m 615, ab. 3649) è quelloche ha saputo conservare meglio la pro-pria identità, forse perché appartato sullasommità di una collina. Le attività princi-pali sono l’allevamento e l’agricoltura, e siproducono ancora nei telai orizzontali fi-nissimi tappeti, arazzi e coperte d’anticatradizione; in occasione della festa mag-giore (Madonna degli Angeli, 2 agosto), sipossono vedere, e ammirare, i preziosicostumi tradizionali.All’uscita del paese una strada a tornanticonduce alla parte più alta dell’abitato e,per strette viuzze da fare a piedi, alla som-
mità del colle dove si trovano i resti del ca-stello Malaspina (XIII sec.), restaurati, conuna bella torre quadrata; un punto dalquale la vista spazia su buona parte dellaSardegna settentrionale.
NulviIl paese (m 478, ab. 3016) è collocato ai pie-di del piccolo altopiano calcareo del mon-te S. Lorenzo popolato già in antico, comedimostra l’alta densità di torri nuragiche:da questa deriverebbe l’antico nome Nu-gulbi, “Città dei nuraghi”. Col calo delle at-tività agricole, qui da secoli imperniatesulla cerealicoltura, è cresciuto l’alleva-mento; rinomati i formaggi della coope-rativa San Pasquale.Nelle strade del centro alcune ragguarde-voli dimore padronali dell’Ottocento e laParrocchiale settecentesca, con armonio-sa facciata in conci calcarei e campanile ot-tagonale; all’interno pulpito in legno conputtini e due leoni in marmo di stile goti-co. A fianco è la barocca chiesa del Rosa-rio, con graziosa facciata del 1630.Poco dietro è l’oratorio di S. Filippo, dovesono custoditi i tre grandi candelieri chevengono portati in processione il 14 ago-sto: alti ben 9 m, non sono a forma cilin-drica, come quelli di Sassari, ma di taber-nacolo, con una grande superficie sullaquale sono applicati i simulacri dei santi.Tra le chiese campestri, frequentatissimoin occasione della festa, l’8 settembre, ilsantuario della Madonna sul monte Alma,un alto “tacco” calcareo (496 m) collegatocon la statale: 2.5 km dopo il paese si svol-ta a sinistra su strada asfaltata che lo rag-giunge dopo altri 2 chilometri.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Se si continua sulla statale e si prende a de-stra al segnale, si può vedere un bel pozzosacro – presso il nuraghe Irru – messo in lu-ce di recente: tutto in pietra calcarea bian-ca, ha ancora oggi l’acqua che affiora spon-taneamente, e perciò il pozzo vero e pro-prio non è praticabile.
MartisAll’uscita dall’abitato (m 300, ab. 663)svoltando a destra all’altezza della picco-la statua della Madonna, si arriva alla piaz-za con la monumentale Fontana Nuova e,subito fuori l’abitato, all’ex parrocchiale diS. Pantaleo, del XIV sec.; in parte diruta,conserva la bella facciata con rosone po-licromo e un robusto campanile quadratorifatto nella parte alta.Ripresa la statale si volta subito dopo a de-stra: con una discesa asfaltata di 1 km sigiunge nella valle dove, ammucchiati in un
campo, sono alcuni dei tronchi che, pro-venienti dalla grande foresta di Carucanapietrificatasi nel Miocene, si trovano oggisparsi, relitti di ere lontane, in diversi luo-ghi dell’Anglona.
S. Pietro delle Immagini*Oltrepassato Laerru (m 177, ab. 1062; al-l’uscita una grande pipa segnala che TomSpanu costruisce gioielli per fumatori in ra-dica, olivastro e ginepro noti nel mondo),si prende a sinistra la statale 134 per Ca-stelsardo; dopo 2 km, sulla destra, è lastradetta che conduce (200 m) alla chiesadi S. Pietro delle Immagini, o di Simbranos,già dei Benedettini di Montecassino. Lafacciata, a fasce alterne di pietra chiara escura, è movimentata da serie di archiparte romanici parte gotici disposti su trelivelli. La visita all’interno (sempre aperto)consente di leggere il succedersi delle
11 L’Anglona e il Logudoro
162
due fasi costruttive: la prima agli inizi delXII sec., la seconda un secolo dopo. Vi sitrovava un tempo una Deposizione di sta-tue di legno colorate del XIII sec., che ora ènella piccola settecentesca parrocchiale diBulzi, 4 km più avanti.
Da questo abitato una strada a fondo naturaleche costeggia il campo sportivo conduce (km1.5, meglio se con mezzo fuoristrada) alla valledel rio Silanis dove, immerse nel verde a pocadistanza dal corso d’acqua, sono le suggestiverovine della chiesa di S. Nicola, XII sec., a suotempo costruzione romanica di pregio.Subito dopo è Sèdini (m 306, ab.1503); all’in-gresso, segnalate, sono le famose domus de ja-nas, tombe preistoriche adibite per lungo tem-po a prigione e poi, sino a pochi anni fa, ad abi-tazione. Aperte in un enorme masso calcareo,sono disposte su più piani e comprendono nu-merosi vani collegati tra loro.
Roccia dell’ElefanteDopo Sèdini la statale prosegue versonord, fino a offrire la vista del mare. Al ter-mine di una lunga discesa fermata d’ob-bligo alla roccia dell’Elefante: sul ciglio del-la strada il grande masso trachitico, cheprende il nome dalla sua forma bizzarra,ospita anch’esso, nella parte bassa, alcu-ne domus de janas; nel vano a destra si ve-dono, scolpite su pareti contrapposte,due coppie di corna taurine, simboli di unadivinità maschile cui veniva attribuita lavirtù di rigenerare dopo la morte. La zonaera fittamente abitata nel periodo nuragi-co: rimane tra gli altri il nuraghe Paddaggiu(e non Su Tesoro, come indicato sui car-telli), al bordo della vecchia strada per Co-daruìna che si imbocca subito dopo sulladestra (al segnale Terme di Casteldoria).In parte interrato, il nuraghe conservamolte delle strutture originarie.
Proseguendo ci si immette nella superstradaper Santa Teresa Gallura, ma la si lascia subitoin direzione della costa; toccata la Muddizza sitrova sulla sinistra, dopo un piccolo cimitero dicampagna, il bivio per S. Pietro a Mare. Attra-verso un bosco di eucalipti si raggiunge subitoil piazzale della chiesetta dal quale si ha la vistadell’estuario del fiume Coghìnas, che prima digettarsi in mare corre per lungo tratto quasi pa-rallelo alla costa: si è creata così una zona disabbie e di vegetazione di un certo interesse na-turalistico, frequentata in particolare da aironi,folaghe e gallinelle d’acqua.
Valledoria e Santa Maria CoghìnasRipresa la strada si attraversa Codaruìna(m 16), centro maggiore del comune diValledoria (ab. 3745) che unisce alla vo-cazione agricola una certa attività turisti-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

ca. Qui si piega a destra e ci si dirige a San-ta Maria Coghìnas (m 21, ab. 1455), attra-verso una fertile piana: bonificata nel do-poguerra e irrigata, è famosa per la pro-duzione dei carciofi. Alla fine del lungoattraversamento dell’abitato si giunge al-la piccola chiesa di S. Maria con bella fac-ciata gotica del XIV sec. Da qui si può fareuna breve deviazione alle terme di Castel-doria (a 2 km), ora chiuse per lavori, che,in un edificio ai margini del fiume, utiliz-zano acque salso-bromo-iodiche. Siamoa brevissima distanza da Viddalba (m 30,ab. 1745), altro centro agricolo nel qualeun piccolo ordinato Museo raccoglie te-stimonianze del passato, in particolareuna notevole raccolta di stele in arena-ria, incise, provenienti da una necropolid’epoca romana. Da Santa Maria Coghìnas ha inizio la pro-vinciale per Pèrfugas; dopo 2 km di salitasi giunge in vista della torre del castello deiDoria, edificato nel XII sec. per controllarequesto passaggio e la regione sottostante.
PèrfugasIl paese (m 92, ab. 2544) è affacciato su unazona pianeggiante di depositi alluvionali elacustri, molto fertile, che accolse l’uo-mo sin dai primordi: nel letto del rio Alta-na sono stati trovati attrezzi in pietra ri-salenti al Paleolitico inferiore. Questi re-perti (raschiatoi, punte, bulini) sono rac-colti in una sala del locale Museo archeo-logico e paleobotanico, a destra della viaprincipale, segnalato. In altre sale notevoliuna statuina di Dea madre in marna delNeolitico e, del periodo nuragico, due pe-si da telaio in selce; in una sezione paleo-botanica sono esposti infine esemplari difossili vegetali dal-la foresta pietrifi-cata dell’Anglona(v. pag. 162).Più avanti a sini-stra, anch’esso se-gnalato, è un note-vole pozzo sacronuragico, che si puòvedere attraversola recinzione.
A brevissima distan-za dal pozzo si leva laparrocchiale di San-ta Maria degli Angeli,al cui interno è con-servato il retablo diSan Giorgio* (untempo nella chiesaomonima, edificata
11.2 I colli dell’Anglona
163
in pregevoli linee gotico-aragonesi tra il XV e ilXVI secolo, a 2.5 km dal paese): opera di un nonmeglio identificato Maestro di Perfugas del Cin-quecento, ha al centro un’originale statua delsanto e tutt’intorno scene della vita di Cristo, ipadri della Chiesa, e (incorniciati da piccolipannelli) martiri e santi.
ChiaramontiA metà strada tra Pèrfugas e Ploaghe, ilpaese (m 430, ab. 1923) è raggiungibiledalla “direttissima” per Tempio Pausaniacon 3 km di salita panoramica. Poco primadi svoltare si può visitare il nuraghe Ruju,a pochi metri dalla strada (munirsi di tor-cia): all’ingresso una garitta e, a sinistra, ilcunicolo che porta al vano superiore, se-midistrutto; davanti la sala maggiore, cheè rimasta intatta.Salendo attraverso l’abitato si arriva allasommità del colle di S. Matteo, con le ro-vine del castello dei Doria*, XII sec.; perquanto non molto alto (464 m), il puntoconsente alla vista di spaziare fino al Lim-bara e alle pendici del monte Sassu.
PloagheAl centro del paese (m 425, ab. 4835) è laparrocchiale di S. Pietro a tre navate, inbuona parte barocca, che ha al fianco il belcampanile con sommità a punta. Nella vi-cina canonica è la Pinacoteca lasciata daGiovanni Spano, archeologo e linguista(1803-78), che comprende soprattutto ope-re di pittori sardi. Adiacente alla parroc-chiale è il vecchio cimitero, celebre per lelapidi in lingua sarda dettate anch’esseda Giovanni Spano.A fianco, nella chiesa di S. Croce, sonocustoditi i due candelieri votivi che, a so-miglianza di quelli di Sassari, vengono cu-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

con la tecnica a pibiones, a grani, e dei fi-nissimi arazzi a mustra de agu, a ricamo,sempre su telaio orizzontale.
Nei pressi dell’incrocio con la statale 597 perSassari è la chiesa di S. Michele di Salvènero e,3 km più avanti, la basilica di Saccargia, per lequali si rimanda al successivo itinerario.
11.3 Il Logudoro: Montacuto, Gocèano e MeiloguItinerario lineare da Sassari a Mores attraverso un lembo del Nuorese, km 186 (carta a pag. 158)
Da Sassari a OzieriIn uscita dalla città si imbocca la statale131 in direzione di Cagliari e dopo 10 km sidevia sulla 597 per Olbia, che si inoltra inun pianoro ondulato tra colline. Subitodopo appare, affacciata sulla strada, labasilica della SS. Trinità di Saccargia**,uno degli esempi più rilevanti del roma-nico in Sardegna. Edificata nel XII sec. al-ternando, col sistema introdotto dallemaestranze pisane, fasce di calcare chia-ro e di basalto scuro, ha una facciata altae mossa, con grande portico ad archi e inalto due serie di arcatelle con rombi e ro-soni in pietra e ceramica. Al fianco uncampanile quadrangolare a punta di oltre40 m; intorno sono i resti di un grandemonastero camaldolese. All’interno, a na-vata unica con capriate in legno, l’absideè affrescata con figure di santi e scene del-
rati dalle due principali categorie di lavo-ratori tradizionali, contadini e pastori;escono in processione il 14 agosto, all’ot-tava e al Corpus Domini.Il paese è rinomato per l’abilità delle suetessitrici, che sanno innovare con gusto imoduli tradizionali dei tappeti, realizzati
11 L’Anglona e il Logudoro
Il percorso si dirige subito, su strade ret-tilinee e veloci, al cuore del Logudoro finoa toccarne il centro principale, Ozieri. Daqui si inoltra poi, lungo la statale 128 bis,in zone movimentate da colline. Da Patta-da si torna indietro per prendere la bellaprovinciale che, attraverso la parte set-tentrionale della catena del Gocèano, ri-conduce nei pressi di Bultei sulla 128 bis;la si segue attraversando quella che i sar-di chiamano “Sa Costera”, la costa mon-tana affacciata sulla valle del Tirso, fino aimboccare la statale 129 verso Macomèr.Subito dopo si svolta a destra per attra-versare Bolòtana e inerpicarsi poi sulla ca-tena del Màrghine, in un territorio di mon-ti, boschi e suggestivi panorami. Si rag-giunge l’altopiano di Campeda e ci si im-mette sulla statale 131, che si segue poi fi-no alla svolta per Mores.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

11.3 Da Sassari a Ozieri
165
la vita di Cristo di autore del Duecentonon identificato.Ripresa la strada si incontra una lungasalita: al termine, dopo circa 3 km, im-boccando una carrareccia senza segnalisulla destra si giunge alla vicina chiesa diS. Michele di Salvènero, edificata dai Val-lombrosani nel XII secolo.Percorsi altri 7 km un bivio a destra porta(5 km) a un altro affascinante monumentomedievale: la basilica di S. Maria del Re-gno**, alle porte di Àrdara (m 296, ab.857), antica capitale del giudicato di Torres.Considerata la più ‘sarda’ delle chiese ro-maniche, fu edificata alla fine dell’XIsec. con facciata in pietra lavicascura segnata da modanatureverticali e una bifora e, ar-retrato su un fianco, ilcampanile a vela. All’in-terno, a tre navate concolonne sormontate dacapitelli di vari stili, sipossono ammirare unbel pulpito in legno fine-mente intagliato e il gran-de retablo di cui una par-te fu dipinta nel 1515 daGiovanni Muru.
Ripresa la 597 la si segue per 6 km, inol-trandosi nella fertile piana nota comeCampo di Ozieri, quindi si svolta a sinistraper Martis: subito appare alla vista la mo-le imponente della basilica di S. Antioco diBisarcio*, che domina da uno speroneroccioso. Un tempo sede vescovile, fu co-struita a più riprese a partire dall’XI sec. im-piegando trachite locale e fondendo ar-monicamente influssi romanico-pisani efrancesi. Splendida la facciata dell’avan-corpo nel quale si apre un porticato fine-mente decorato; nella parte posterioresono una grande abside e un robusto cam-
panile quadrato, mozzato da un ful-mine. L’interno, illuminato da
monofore, ha navata centralee due laterali sensibilmente
più piccole.Si torna indietro sulla 597fino al bivio per Ozieri.Dopo 5 km si sfiora Chi-livani (m 226), nodo fer-roviario e zona indu-striale che comprendeanche l’ippodromo Deo-
dato Meloni, uno degli‘anelli’ più frequentati del-
l’isola. Sede dell’Istituto sar-do per l’incremento ippico,
Ozieri è la capitale del cavalloisolano, in particolare dello splen-
dido anglo-arabo-sardo.
OzieriLa cittadina (m 390, ab. 11 615) sorge inuna conca riparata e ricca di acque po-polata sin dalle epoche più antiche: dai re-perti ritrovati nelle grotte di S. Michele (vi-cine al campo sportivo) prende il nome la‘cultura’ sviluppatasi in Sardegna fra i 3 ei 2000 anni a.C. Grazie a una florida eco-nomia agricola e zootecnica Ozieri ha co-nosciuto in passato periodi di benessere;elevata a città da Carlo Alberto nel 1836, ècapitale della subregione del Montacuto emaggior centro del Logudoro; vanta una vi-va tradizione culturale, specie per la poe-sia e il canto in lingua sarda.Dalla centrale piazza Garibaldi si raggiungesubito, anche a piedi, il complesso di S.Francesco: su una piazza si affacciano lachiesa e l’antico convento.Nella chiesa di S. Francesco da vedere ilgrande altare barocco in legno: in altoun’aquila bicipite, raro segno della brevedominazione austriaca in Sardegna, ai pri-mi del Settecento. Nel vicino convento, re-staurato per ricavarne un centro poliva-lente di cultura, si trova il Museo archeo-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

logico*: una prima sala raccoglie i materialidelle culture prenuragiche, tra le quali haovviamente maggiore spazio quella di SanMichele (o di Ozieri); la seconda quelli delperiodo nuragico, tra i quali modellini dinuraghe in pietra, armi, utensili e alcunibronzetti; la terza, la quarta e la quintasono dedicate al periodo romano, a quel-lo medievale e alla numismatica.Accanto è possibile ammirare un bel pa-lazzo a due altane, una sulla facciata el’altra in alto, su un lato: sono elegantiterrazze coperte, in parte neoclassiche, ti-piche dei più rilevanti edifici della città.Attraversato il centro storico si imbocca,oltre la piazza Carlo Alberto, o Cantareddu(Fontanella), la via Vittorio Emanuele III: siincontra dapprima la monumentale fon-tana Grixoni, dal nome del ricco oziereseche la edificò nel 1881; quindi, prose-guendo sulla sinistra in via Grixoni, la cat-tedrale dell’Immacolata, con facciata neo-classica. L’interno, barocco, custodisceun polittico* del Maestro di Ozieri, delCinquecento: sette tavole sulla vita di Cri-sto e della Madonna hanno al centro ilTrasporto da Nazareth a Loreto.Ozieri è rinomata anche per la produzioneartigianale di dolci tradizionali, tra i qua-li i sospiri, paste di mandorla avvolte inuna ‘cappa’ di zucchero o di cioccolato. Lasagra della Madonna del Rimedio, ultimadomenica di settembre, comprende ma-nifestazioni animate da canti sardi e pro-cessioni con costumi di tutta l’isola.
PattadaPaese di alta collina, il più elevato dellaprovincia di Sassari (m 778, ab. 3646), hafama di centro climatico: ha sviluppatoalcune strutture ricettive per il turismomontano e una bella pineta confina con l’a-bitato. A breve distanza, raggiungibile in
166
auto, la zona del monteLerno (m 1094), con un’an-tica foresta che compren-de esemplari di leccio, tas-so e agrifoglio.Il paese è noto per la pro-duzione del tipico coltelloa serramanico in uso tra ipastori e i contadini, dettoanche “pattadesa”. Sonoancora in attività alcunebotteghe artigiane specia-lizzate che alla produzionedei modelli usuali affian-cano quella di ricercatiesemplari da collezione.
Da Pattada a BonoDa Pattada si torna verso Ozieri per 4 km,si svolta sulla sinistra e subito dopo a de-stra, seguendo le indicazioni per Bultei.Dopo una lunga salita la moderna stradaprovinciale raggiunge il sommo della ca-tena del Gocèano e prosegue a quota 1000in un altopiano leggermente ondulato, conampie distese a pascolo brado e qua e làpunteggiato da gruppi di alberi.Si raggiunge la strada proveniente da Ozie-ri e la si segue sino a Bultei, dove si ritor-na sulla 128 bis. Questa continua in dire-zione sud con percorso tortuoso che toc-ca i centri abitati procedendo a mezza co-sta: a destra la catena del Gocèano, a si-nistra la valle del Tirso.
A Bultei (m 509, ab. 1265) si prende a sinistra, siattraversa l’abitato e subito dopo si svolta per
11 L’Anglona e il Logudoro
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Benetutti e Nule. Dopo 6 km è la zona termaleche prende il nome dalla piccola medievalechiesa di S. Saturnino, dalle sobrie linee in tra-chite rossa. Le acque, che hanno natura solfo-rosa e cloruro-bicarbonato-sodica e tempera-tura di oltre 30°, erano conosciute già dai ro-mani («Aquae Lesitanae»); oggi sono sfruttate indue stabilimenti.Benetutti (m 406, ab. 2246), paese di contadini epastori 6 km più avanti, conserva nella Parroc-chiale parte di un retablo* del Cinquecento, ope-ra del Maestro di Ozieri, che racconta il ritrova-mento della Croce da parte di S. Elena. Conti-nuando in salita si arriva subito dopo a Nule (m650, ab. 1630), noto per l’opera delle tessitrici: trai tappeti lisci, prodotti su telai verticali, sono piùnoti quelli a “framas”, di colori vivaci. Si può ve-derli nei laboratori privati, nel centro di lavora-zione promosso dall’Isola (Istituto Sardo Orga-nizzazione Lavoro Artigiano) e, nell’ultima de-cade di agosto, nella fiera annuale del tappeto.
BonoCentro maggiore della zona (m 540, ab.3922), ha dato i natali a Giovanni Maria An-gioy, che fu il capo dei moti antifeudali difine Settecento. È viva nel paese la me-moria di un episodio glorioso di quel pe-riodo, quando i bonesi riuscirono a re-spingere l’attacco delle forze della rea-zione: viene rievocato in forma originale inoccasione della festa di S. Raimondo, 31agosto, portando in processione una gran-de zucca. Dal vasto spiazzo delle Scuoleelementari una breve salita conduce alla
11.3 Da Ozieri a Bono
167
chiesa di S. Raimondo, che conserva un’an-tica statua di S. Francesco e offre la vista ditutto il paese. Procedendo nella stradacentrale si vede sulla destra, dopo aver ol-trepassato il busto di Angioy, la parroc-chiale di S. Michele, che ha una bella fac-ciata in stile romanico pisano.
Dalle Scuole elementari ha inizio la strada perSassari che, offrendo grandi scorci panoramici,si inerpica fino al passo Uccàidu (m 1042) econtinua poi, tra boschi e pascoli, per Forestadi Burgos (m 725; 18 km da Bono), dove l’Istitutosardo per l’incremento ippico, con sede a Ozie-ri, promuove l’allevamento di cavalli della pre-giata razza anglo-arabo-sarda.
Castello del Gocèano*Da Bono si continua ancora a mezza costalungo la statale 128 bis fino a giungere inprossimità del castello del Gocèano o diBurgos, in caratteristica posizione al cul-mine di una collina conica. Lo si può rag-giungere svoltando a destra a Bottidda e
L’altopiano di Alà e le montagne di Bud-dusò, nella parte nord-orientale dell’iso-la, sono il regno della sughera (v. foto inbasso). Ogni nove anni un esercito dioperai di altissima specializzazione libe-ra l’albero dalla sua scorza: il sughero èora pronto per essere lavorato.A dire la verità, da questo momento inpoi il regno del sughero si sposta di un cen-tinaio di chilometri più a nord, in Gallura.L’industria sarda del sughero, infatti, ènata verso la metà dell’Ottocento a Tem-pio, pare avviata da imprenditori francesie maestranze catalane, e a metà del No-vecento si è trasferita in gran parte a Ca-langiànus, una decina di chilometri a est diTempio. Oggi Calangiànus è la capitaleitaliana della lavorazione del sughero. Il prodotto principale è ancora il tappo.Tutti i tentativi che sono stati fatti per so-stituirlo (per esempio, con la plastica) so-no malamente falliti: solo il sughero per-
mette al vino di respirare quel tanto cheoccorre per conservare profumo e gusto. A Calangiànus tutto ruota intorno al su-ghero. Accanto alle grandi ditte che so-no costrette addirittura a importare lamateria prima (dalla Spagna, dal Porto-gallo) per far fronte alle richieste, cen-tinaia di artigiani lavorano nei banchet-ti di casa. Così il reddito si distribuisceun po’ su tutti: alcuni anni fa Calangiànusfu segnalato dalle statistiche come unodei cento comuni italiani a più alto red-dito pro-capite. Il sughero è leggero, mail suo peso, nell’economia gallurese, èben robusto.
L’intramontabile sughero
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

attraversando, dopo 4 km, Burgos (m 561,ab. 1089). Restano una torre e imponentimuraglioni di un grande complesso mili-tare, costruito dai giudici di Torres nel XIIsec. e legato alle loro vicende prima, aquelle dei giudici d’Arborèa più tardi. Nelpaese, lungo la strada che conduce al ca-stello, la Pro Loco gestisce un piccolo mu-seo con tavole che illustrano la sua storiae la vita che vi si svolgeva.
Verso BolòtanaSi giunge al bivio per Illorai, quindi a un an-tico ponte sul Tirso, con due arcate mino-ri e una più ampia e ardita: pare sia statocostruito dai pisani nel XII secolo. Subitodopo si sbuca sulla statale 129 Nùoro-Ma-comèr e la si imbocca verso quest’ultimocentro per una veloce puntata nella pro-vincia di Nùoro: dopo 8 km si svolta perBolòtana (a km 3.5), grosso centro (m 472,ab. 3400) disposto ad anfiteatro alle pen-dici della catena del Màrghine. Si può farsosta alla chiesa di S. Bachisio, a destra delpercorso nei pressi del cimitero: edificatain trachite rossa nel Duecento e rimaneg-giata più tardi, ha nella facciata un rosone,due nicchie e un bel portale con piccoli ori-ginali bassorilievi.In alcuni laboratori artigiani si tramandal’arte della tessitura antica: si produconoraffinati e tipici tappeti in lana e cotone neiquali vengono riportati motivi geometriciripresi da antichi mosaici.
168
La catena del MàrghineAttraversato il paese si esce sulla sinistra,in direzione della statale 131, e si inizia ainerpicarsi sulla catena del Màrghine, in unpercorso a tornanti tra boschi di lecci e ro-verelle che offre la vista della piana di Ot-tana e di monti lontani. Più avanti si in-contra ai bordi della strada – segnalato – ilparco di Ortachis, con prati e una bella ca-scata, che confina con un fitto bosco.
Subito dopo, invece di continuare sulla stradaprincipale, si può seguire sulla sinistra quellaquasi parallela, asfaltata solo in parte, che attra-versa la regione di Badde Sàlighes con i resti,oggi rivalutati turisticamente, della grande te-nuta con parco e villa creata nell’800 dall’ingleseBenjamin Piercy, costruttore delle ferrovie sarde.
BonorvaRaggiunta la statale 131 (che procede ver-so Sassari tagliando l’altopiano di Cam-peda), dopo 7 km, lungo la veloce discesadi Cadréas, un bivio a destra conduce (1km) a Bonorva (m 508, ab. 4257), borgataagricola molto attaccata alle tradizioni,patria di «Paulicu» Mossa, poeta in sardo(1818-92), e di Antonio Sanna e AngeloDettori (scomparsi entrambi nel 1981),che della lingua sarda sono stati studiosie propagatori assidui.Ancora molto viva – unitamente alle mani-festazioni folcloristiche – la tradizione del-la tessitura con telaio orizzontale: utiliz-
11 L’Anglona e il Logudoro
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

zando la tecnica “a punta de agu”, ossia a ri-camo, si ottengono tappeti e coperte dai di-segni molto elaborati ispirati al broccato.In una breve sosta nella piazza centrale sipuò vedere la piacevole facciata della Par-rocchiale, datata 1606; e, di fronte, un’a-bitazione del Cinquecento con colonnetortili nel portale, stemma e doccioni disembianze animalesche. Nel convento an-nesso alla chiesa di S. Antonio da Padova,del XVII secolo, è stato aperto di recente ilMuseo civico archeologico: raccoglie re-perti delle età prenuragiche e nuragica;una sezione è riservata ai miliari dellastrada romana da Cagliari a Olbia, chepassava nei pressi del paese.
Si continua in discesa verso il Campo di S. Luciae dopo 7 km si prende a destra per raggiunge-re, dopo altri 2 km, la chiesa campestre di S. Lu-cia e, subito dopo, le grandiose domus de janasdi S. Andrea Priu**. Scavate in un’alta paretedi trachite, utilizzate come tombe tra i 2 e i3000 anni a.C. e come chiesa rupestre nel primocristianesimo, si compongono di una serie dicomplessi ipogeici con vani per le sepolture eluoghi di culto; maggiore tra tutte la tomba delCapo, che ha ben 18 ambienti. Nel pianoro al disopra sono altre piccole domus e una tozzascultura che rappresenta forse un toro.
La Valle dei Nuraghi*Ripresa da Bonorva la statale 131 la si se-gue per 11 km, quindi si svolta a destra, en-trando nella cosiddetta Valle dei Nuraghisu cui campeggia, vicinissimo, il com-plesso della reggia nuragica di Santu An-tine**, uno dei più grandi dell’isola. Al tor-rione centrale che, nonostante progressi-ve demolizioni, supera ancora i 17 m, si af-fiancano altre tre torri minori, collegate dauna serie di lunghi corridoi e cammina-menti con feritoie tra i quali è ricavatoanche un grande cortile con pozzo. Pas-saggi, scale e vani minori completano lastruttura: nella parete del vano principa-le, che ha la consueta volta a tholos, concerchi di pietre sempre più stretti, oltre al-la scala, che porta ai vani superiori, è ri-cavato un corridoio circolare a piano ter-ra. Il complesso, costruito in varie fasi, eraancora in uso in epoca romana.Tornando indietro si passa sotto la statale131 e si continua a destra, sul vecchio trac-ciato, sino a (4 km) Torralba (m 430, ab.1063), dove è il Museo della Valle dei Nura-ghi del Logudoro-Meilogu. Ha una sezione ar-cheologica che nella sala Santu Antine con-serva materiali rinvenuti nel nuraghe, proiet-
11.3 Da Bonorva a Mores
169
tili in pietra, pinze da fonditore, fornelli e lu-cerne; e una sezione etnografica nella qua-le vengono allestite mostre tematiche.
S. Pietro di Sorres*Da Torralba si continua per Bonnànaro(m 405, ab. 1162; rinomato per le ciliegie eper il vino), lo si attraversa e, subito dopoBorutta (m 471, ab. 331), si raggiunge la ba-silica di S. Pietro di Sorres, monumentoisolato su un colle che domina la regione.Edificata in più tempi, a partire dall’XI sec.,in stile romanico pisano, già sede vesco-vile, ha larga facciata in pietra a due colo-ri segnata da archi e lesene disposti su trepiani orizzontali. L’uso della pietra di duecolori torna anche nelle colonne e negli ar-chi dell’interno, a tre navate, con volte acrociera in trachite nera.È l’unico complesso religioso extraurbanoad aver riavuto vita: nei locali adiacentiuna comunità di Benedettini cura un cen-tro di restauro del libro e organizza in-contri e soggiorni per quanti amano col-tivare la spiritualità.
MoresPaese di allevatori e contadini (m 366, ab.2112), vanta un campanile sottile ed ele-gante (ritenuto il più alto nell’isola: 48 m),edificato in stile neoclassico tra il 1850 e il1871 dall’architetto locale Salvatore Calvia.Tra i monumenti archeologici del suo ter-ritorio, suggestivo il dolmen Sa Covecca-da*, monumento sepolcrale del secondo-terzo millennio a.C.: in ciclopici massi tra-chitici dal bel colore caldo, ha la forma diuna casetta, coperta (coveccada) da unagrossa lastra orizzontale. Per raggiunger-lo si imbocca dopo Mores la provincialeper Bono; dopo 4 km si prende una stradasterrata che si dirama a destra passati ilponte sul rio Mannu e la ferrovia. Da qui sidevia al primo cancello a sinistra, che bi-sogna poi richiudere; e così, aprendo echiudendo altri due cancelli, si arriva do-po 2 km al monumento.
Si può continuare sulla stessa provinciale e,prendendo a sinistra al primo bivio, si arriva aIttireddu (m 313, ab. 583) dove si trova, annessoalla Casa comunale, un piccolo moderno Museocivico archeologico ed etnografico* diviso indue sezioni: quella archeologica, più ampia,raccoglie in cinque sale i materiali rinvenuti inmonumenti dell’epoca prenuragica, nuragica eromana, tra i quali vasi, tegami e fornelli; quel-la etnografica conserva strumenti che si riferi-scono alle attività tradizionali.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

12 La Gallura: il granito nel vento
Profilo dell’areaCol nome Gallura (forse, come nell’ebraico “galil”, Paesedelle alture) si indica la regione nord-orientale della Sarde-gna. La delimitano verso l’interno dell’isola, a ovest il fiumeCoghìnas e a sud una linea ideale che congiunge il monte Lim-bara con il piccolo centro di San Teodoro, sulla costa tirre-nica. Bellissima, la Gallura è fatta di mare, pianura, collina, montagna, zone coltivate, lan-de deserte. Gli appassionati di archeologia possono trovare in questa diversità ambientaletestimonianze delle civiltà prenuragica, nuragica, punica, romana, medievale. Ma ciò chepiù di ogni altro elemento caratterizza il paesaggio della Gallura sono le rocce di granito,che, ‘lavorate’ dal vento e dalla pioggia, assumono la forma di montagne in miniaturae di straordinarie sculture naturali. Altro carattere fondamentale della Gallura è la pre-senza di foreste di querce da cui si estrae il sughero, il cosiddetto “oro morbido”. La la-vorazione del granito e del sughero, a livello artigianale e industriale, è il cuore dell’e-conomia locale. Altra nota peculiare della Gallura è l’insediamento rurale sparso costituitodagli “stazzi”, aziende agro-pastorali in genere cellule abitative unifamiliari autosufficienticreate in origine da pastori, molti dei quali venuti dalla vicina Corsica, tra Sei e Sette-cento. Lo stazzo, costituito da una casa con intorno ovile, vaccile, porcilaia, orto e vi-gna, sorge al centro di un appezzamento di terreno più o meno vasto, parte del qualeviene riservata per la coltivazione dei cereali e parte destinata al pascolo brado.Numerosi (circa 2200) e fiorentissimi fino a qualche decennio fa, molti stazzi sono sta-ti abbandonati per il fenomeno dell’urbanesimo. La Gallura, spesso lontana dalla gran-de storia, durante il periodo dei giudicati era molto florida e influente.Ancora oggi in agro di Luogosanto esistono i resti di due castelli (di Balaiana e di S. Ste-fano o di Baldo) che pare siano appartenuti ai Visconti di Pisa. La leggenda vuole chenel primo fosse ospitato addirittura Dante Alighieri. Fra i suoi ruderi si può ammirareuna chiesetta (probabilmente la cappella del castello), tutta in granito nudo, dedicataa san Leonardo, espressivo esempio di architettura sacra del medioevo isolano. Il per-corso più suggestivo per accedervi è una ripida scala, scavata in parte nel granito del-la montagna, di ben 484 gradini. Chi, partendo da Olbia, percorre la statale 125 e svol-ta ad Arzachena per Luogosanto, trova il piede della gradinata sulla destra, a 3 km dalpaese. Al castello di S. Stefano, che pure costituisce una significativa testimonianza del-la storia medievale sarda, si arriva comodamente anche in macchina.
170
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Situata in un tratto di pianura litoranea de-clinante verso il fondo del suo golfo, do-minato dalla possente mole dell’isola di Ta-volara, Olbia (m 15, ab. 42 832), già im-portante scalo in età antica, ha riafferma-to la sua tradizionale funzione di raccordotra la Sardegna e la Penisola in quest’ulti-mo trentennio, dopo il decollo dell’indu-stria turistica: vivace centro marittimo,scalo aeroportuale e portuale, è il primo inItalia per movimento dei passeggeri. An-che a queste nuove funzioni è legato l’im-petuoso sviluppo urbanistico che ha com-promesso gli antichi equilibri urbani. La conca di Olbia fu densamente popolatain età prenuragica e nuragica, come atte-stano decine di nuraghi, tombe di giganti,fortificazioni megalitiche e numerosi poz-zi sacri. La città ha le sue radici su un ter-razzo a forma di quadrilatero leggermenterilevato sul mare: su questo spazio la tra-ma urbana si definì dal momento della suafondazione, quasi sicuramente cartagine-se (sec. V-IV a.C). A partire dall’epoca ro-
171
mana la crescita di Olbia corrispose a quel-la del porto: fu a lungo, infatti, città floridae importante, con un entroterra intensa-mente coltivato e disseminato di centriagricoli. La stessa Atte, l’influente concu-bina di Nerone, vi possedeva terreni, villee una fabbrica di mattoni.Dopo il crollo dell’impero, con le invasio-ni vandaliche, Olbia conobbe il destinodi distruzione e di rovina di tutti i centri co-stieri sardi. Nei pochi, oscuri, documentialtomedievali compare col nome di Fau-siana. Nuove acquisizioni sulla storia di Ol-bia in quei secoli stanno arrivando da uneccezionale ritrovamento archeologicodurante i lavori per la costruzione di untunnel nell’area del porto, dove sono af-fiorati i relitti di una decina di navi roma-ne e di un’imbarcazione di età giudicale. Fu nell’XI sec., sotto il dominio dei pisani,saldamente insediati in Gallura fino al XIIIsec., che il centro venne ricostruito nel-l’antico sito della città punica. Le sue ri-nate fortune, col nome di Terranova (che
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
12.1 Olbia e il suo golfoItinerario urbano, pedonale (pianta qui sotto), con escursioni automobilistiche finali (carta apag. 175)

rimase in uso sino al 1939), sono docu-mentate dalla ritrovata frequenza dei traf-fici marittimi e dallo sviluppo dell’agri-coltura nella piana. Capitale di curatoria esede vescovile, Terranova vide sorgerediversi edifici tra cui la bella chiesa ro-manica di S. Simplicio, costruita tra XI e XIIsec., in posizione topografica eccentrica ri-spetto al centro cittadino.La successiva lunghissima stagnazioneeconomica, demografica, edilizia – cuicontribuirono, unitamente all’inerzia e almalgoverno aragonese e spagnolo, care-stie, epidemie e malaria – si protrasse finoall’Ottocento. La costruzione della stradadi collegamento alla Carlo Felice (la statale131) e, quindi, l’apertura della ferrovia e lacanalizzazione dei torrenti diretti al maredeterminarono la nuova struttura dellacittà, il cui sviluppo si accompagnò alla ri-nascita della funzione portuale. L’impian-to di diversi caseifici e, poi, lo sviluppo del-l’industria mitilicola negli anni venti, mo-dificarono la base economica della cittàcon fenomeni d’immigrazione dalle regio-ni centro-meridionali della Penisola. Nel-l’ultimo trentennio del XX sec. l’impetuososviluppo demografico ha fatto balzare Ol-bia al quarto posto nella gerarchia urbanadella Sardegna, conferendole, anche, unaparticolare, composita fisionomia etnico-culturale.L’itinerario scelto consente una percezio-ne completa del primitivo impianto topo-grafico della città e della successiva evo-luzione. Ma Olbia, dotata di un porticcio-lo turistico e di uno Yacht Club (nei pres-si del porto vecchio) e circondata da mol-te belle spiagge a sud e a nord, può rap-presentare la base di partenza anche perescursioni nei rinomati centri turistici del-la costa nord-orientale (Golfo Aran-ci: km 18) e sud-orientale fino al-la Caletta in territorio di Si-niscola (km 54.5).Verso sud, particolarmenteconsigliata per l’ecce-zionale interes-se paesaggi-stico è l’escur-sione all’isola diTavolara rag-giungibile conbarconi (tra-versata 20 mi-nuti) da PortoSan Paolo, chesi trova a 15chilometri didistanza.
12 La Gallura: il granito nel vento
172
I monumenti della cittàCostruito nel 1930, attraverso l’amplia-mento della superficie degli isolotti IsolaFiorita e Isola Bianca, lo scalo di Olbia Ma-rittima (B3, f.p.) serve i collegamenti con iporti della Penisola e Àrbatax. È collegatoalla terraferma da una diga di 1400 m sul-la quale passa la linea ferroviaria da Ca-gliari e da Sassari-Porto Torres. Il viale Iso-la Bianca (B3) porta all’alberato viale Vit-torio Emanuele. Nell’abitato si segnalano ilMunicipio liberty (B2-3) e la chiesa di S. Pao-lo (1747; B2) in conci di granito a vistacon cupola maiolicata del secondo dopo-guerra. Notevole è anche il tessuto urbanointorno a corso Umberto (B2), ove gli edifi-ci recano gli architravi originali in granito.Alla confluenza fra il corso e via delle Ter-me è il palazzetto umbertino restaurato direcente che ospita la biblioteca comunale“Simpliciana” e una raccolta di repertid’età nuragica. In piazza Regina Margheri-ta (B2) in seguito a scavi è stata riportataalla luce una delle cisterne puniche. Al termine del corso, oltre il passaggio a li-vello, sulla destra, si arriva alla chiesa di S.Simplicio* (B1-2), tra i più interessantiesempi di romanico dell’isola. È stata co-struita in fasi successive tra XI e XII sec. suun’area cimiteriale cristiana. Interamente inconci di granito, più semplice di altre gran-di chiese romaniche della Sardegna, rivela,in particolare nella facciata, la fusione di ele-menti toscani e lombardi. L’interno è scan-dito da pilastri e colonne che sostengono iltetto a capriate e le volte delle navate late-rali. Vi si trova un’interessante raccolta diiscrizioni funerarie provenienti dalle vicinenecropoli e pietre miliari romane.
Su percorso carrozzabile di 5 km si può rag-giungere il complesso nuragico di Cabu Abbas
che, scarsamente signifi-cativo per l’occhio
inesperto, è fonted’interesse per lo
specialista. Dacorso Umberto siprende via D’An-nunzio (tratto ur-bano della stata-le 125), che do-po due ponti silascia per im-boccare a d. uncavalcavia fer-roviario; al ter-mine di questoparte a sin. lavia Mincio,primo trattodella strada
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

vicinale per Cabu Abbas; l’ultima parte del per-corso, che sale sulla cresta granitica (m 246), sisvolge a piedi. In alto, dominante il golfo di Ol-bia, si trova una torre a camera circolare condue nicchie contrapposte e pozzo centrale,rinforzata da muratura di rifascio; al momentodello scavo (1937) il pozzo fu trovato colmo diresti di sacrifici, quali ossa bruciate e ceneri mi-ste a frammenti ceramici.
Pozzo sacro Sa Testa*Si trova a pochi metri dalla strada pano-ramica per Golfo Aranci, a 5 km da Olbia(cartello indicatore). Considerato tra i piùinteressanti monumenti del genere in Sar-degna, è ascrivibile al periodo nuragicomedio (sec. VIII-VI a.C.). Dal vasto recintocircolare lastricato, presumibile luogo disosta dei fedeli durante i riti sacri, si ac-cede al vestibolo dotato di sedili e postoa un piano inferiore. Vi si apre l’imboccodella scala a 17 gradini, coperta da archi-travi, che porta alla camera a tholos dal cuipavimento sgorga l’acqua di vena.
Golfo AranciGià minuscolo borgo di pescatori ponzesi,il centro (ab. 2105)si è sviluppato in fun-zione del suo porto, divenuto capolineadei servizi marittimi con la Penisola già nel1888. All’ampliamento delle opere por-tuali si è accompagnata una disordinatacrescita edilizia a cui ha contribuito losviluppo degli insediamenti turistici lungol’arco costiero. Animatissimo durante lastagione estiva, il paese è situato in un’in-cantevole posizione in vista del suggesti-vo isolotto di Figarolo, fitto di macchiamediterranea e rifugio di una colonia dimufloni. A monte del paese, nei pressi
173
della stazione ferroviaria si trova l’impor-tante pozzo sacro nuragico di Milis.
Isola di Tavolara*Chiamata «Hermaea Insula» nelle antichecarte nautiche, Tavolara è un immensotavolato calcareo che emerge dal marecome un enorme bastione. Di forma tra-pezoidale, è alta in media 555 m, lunga 6km e larga uno. Agli estremi orientale e oc-cidentale ha due appendici: Spalmatore diFuori, montuosa e ripida, e Spalmatore diTerra, quasi totalmente pianeggiante. Quisi trova un minuscolo insediamento di al-cune case, due ristoranti, un piccolo sug-gestivo cimitero e un porticciolo. L’isola,mèta nei mesi estivi di un flusso continuodi visitatori, conserva il suo paesaggionaturale grazie al divieto di edificabilità im-posto dal comune di Olbia. Ospita un’ab-bondante fauna alata come l’uccello delletempeste e il falco pellegrino, e conservaanche alcune importanti specie botani-che divenute ormai rarissime.
PosadaAggrappato a un isolato sperone calca-reo del Nuorese nord-orientale e corona-to da un antico castello, è certo il più sce-
12.1 I dintorni di Olbia
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

12.2 Verso Tempio PausaniaItinerario circolare a ovest di Olbia, nella bassa Gallura, km 151 (carta a pag. 175)
I 28 distensivi km che portano da Olbia adArzachena per la statale 125 sono i primidi un itinerario che, quasi tutto su stradestatali, ha come meta l’interno della Gal-lura dove la lontananza dal mare ha con-servato quasi intatta la vita degli abitantie la stessa natura. La strada si snoda in unpaesaggio disseminato di stazzi e di roccetafonate di granito grigio; paesaggio chenon cambia neanche dopo Arzachena finoa Sant’Antonio di Gallura (18 km), Luras(17 km) e Tempio Pausania, a 10 km da Lu-ras. Cambia invece dopo Tempio e pertutti i 32 km che lo separano da Òschiri at-traverso le profonde valli, i forti tornantie i boschi di pini e di querce dei versantioccidentali del monte Limbara. E cambiaancora da Òschiri a Olbia (46 km): la sta-
nografico fra i paesi della zona (m 22,ab.2289). È costituito da due nuclei: uno diorigine medievale e uno sviluppatosi aipiedi del colle.Il borgo vecchio, un tempo interamentecinto da mura, si dispone a gradoni lungole pendici della rupe ed è caratterizzato dapiccole case bianche di calce che si af-facciano su erte scalinate e pittorescheviuzze. Nella parte più alta sorge la par-rocchiale di S. Antonio Abate, risalente al1324 ma ricostruita nel ’600. Ancora più inalto è il castello della Fava: costruito dai pi-sani poco prima del 1200, fu baluardo dei‘giudici’ di Arborèa e sede, a partire dal-l’epoca aragonese, dei baroni che gover-navano il vasto feudo della Baronìa. Della
174
struttura si conservano oggi alcuni trattimurari, le cisterne e una torre alta circa 20metri (dagli spalti, vista panoramica).
La CalettaSi trova nei pressi di Siniscola (da cui dista6.4 km) ed è diventata uno dei più fre-quentati insediamenti turistici della co-sta a sud di Olbia.Già centro balneare dei nuoresi negli annicinquanta, ha conosciuto un tumultuososviluppo edilizio che ha in parte compro-messo le qualità dell’ambiente naturale.Nota per le sue belle dune di bianca sab-bia che continuano ininterrottamente finoa Posada, è dotata di un porticciolo turi-stico-commerciale.
tale 597 attraversa terre collinari coltiva-te digradanti dolcemente verso il mare.
ArzachenaAdagiato su un costone roccioso, il paese(m 85, ab. 10 406) sarebbe sorto sopral’insediamento romano di Turibulum Mi-nor, e sino alla fine dell’Ottocento era sol-tanto un gruppo di case raccolte intorno al-la già campestre chiesa di S. Maria (ora re-staurata rispettando la vecchia struttu-ra), dedicata alla Madonna della Neve efondata nel 1776.A partire dalla seconda metà del xx sec. Ar-zachena ha sviluppato la frenetica attivitàdel suo nuovo ruolo di ‘capitale’ della Co-sta Smeralda; ha rapidamente aumentatole case e moltiplicato le attività commer-
12 La Gallura: il granito nel vento
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

12.2 Le tombe di giganti di Arzachena
175
ciali, dell’edilizia, del terziario e dei servi-zi. È un centro che vive, si potrebbe dire,con un occhio rivolto al futuro e l’altro a unlontanissimo passato. Il territorio di Ar-zachena è infatti letteralmente gremito dimonumenti archeologici, alcuni dei qualidi grande interesse.
Uscendo da Arzachena sulla strada per Sant’An-tonio, ma deviando dopo meno di 2 km al bivioper Luogosanto, si trova subito la tomba di gi-ganti di Lu Coddhu ’Ecchju** (o di Capichera),quasi sul bordo della strada: il vasto fronte del-la tomba è dominato dalla stele di granito altaoltre 4 m; lunga quasi 14 m, la tomba poteva ac-cogliere decine di defunti. Nei pressi, l’interes-sante nuraghe di La Prisgiona, oggetto in questomomento di scavi importanti. Dopo circa 1 km il segnale turistico indica la ne-cropoli di Li Muri*; e 500 m prima di arrivare ad
essa, una deviazione di poche decine di metriporta alla tomba di giganti di Li Lolghi* (le duetombe – vanto del patrimonio archeologico diArzachena – sono fra le più grandi, le più bellee le meglio conservate dell’isola).La necropoli di Li Muri, scavata a partire dal1940, è costituita da cinque grandi ciste dol-meniche, tombe costruite su lastre di pietracircondate da brevi circoli di pietre fitte. Qui gliarcheologi hanno individuato la testimonianzadi una cultura originale denominata appunto diLi Muri o delle tombe a circolo, coeva della pri-missima civiltà nuragica.Altri due monumenti si trovano invece a 2 kmdal paese sulla strada per Olbia: l’imponente nu-raghe Albucciu e, a sinistra, attraverso un viot-tolo percorribile anche in macchina, il tempiet-to di Malchittu, piccola costruzione a mègaron,unica nel suo genere in tutta la Sardegna in gra-nito. Gli archeologi la datano al periodo delBronzo medio (1500-1200 a.C.).
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

12 La Gallura: il granito nel vento
176
Le tombe di giganti sono la forma piùmonumentale delle sepolture nuragi-che. La voce popolare le ha chiamate co-sì perché le dimensioni della struttura ela grandiosità della fronte fecero pensareche soltanto un popolo di giganti, ap-punto, potesse mettere in opera pietrecosì grandi e un lavoro così impegnativo.Delle oltre trecento tombe disseminatenella Sardegna (soprattutto in quellanord-orientale), le più famose sono ledue che sorgono, a poca distanza unadall’altra, nelle campagne di Arzachena.Il paese che è diventato sinonimo dellamodernissima Costa Smeralda fu inrealtà abitato sin dall’antichità più lon-tana: il suo territorio è tutto un piccolomuseo all’aria aperta, con nuraghi, tem-pietti, peculiari tombe “a circolo”.Le due tombe di giganti, a pochi chilo-metri da Arzachena, sono tra i sepolcrid’età nuragica meglio conservati dell’i-sola. Si chiamano Coddhu ’Ecchju (collovecchio, ma anche altura antica) e Li Lol-ghi (è il nome degli anelli cui si legavanoi cavalli alle pareti esterne delle case).Sono composte di un’esedra, che co-stituisce la fronte della tomba, formatada grandi pietre piatte conficcate verti-calmente nel terreno (nella foto quelledi Coddhu ’Ecchju) con al centro unagrande stele centinata: ognuna delledue stele ha alla base un piccolo foro-portello che guarda su un lungo corri-doio, formato da pietre infitte vertical-mente e coperte da una serie di altre pie-tre disposte orizzontalmente (oltre 13metri a Coddhu ’Ecchju), che contene-va la tomba vera e propria.
Le tombe di giganti Prima di entrare nell’abitato di Sant’Antonio diGallura (m 355, ab. 1669) si trova il bivio, a de-stra, per il lago artificiale del Liscia distanteappena un paio di chilometri. È un invaso di 104milioni di m3, che viene utilizzato per l’irriga-zione dei comprensori agricoli di Arzachena edi Olbia e per i consumi civili della Costa Sme-ralda e di numerosi centri della Gallura. Il lago,che nei giorni di piena sommerge la chiesetta diS. Nicola di Carana, ha, quasi sulla riva, un oli-vastro gigantesco* (per cingerlo almeno diecipersone devono tenersi per mano) che, se-condo gli studiosi, è uno dei più vecchi alberid’Europa. Di recente è stato incluso nell’elencodelle piante da proteggere in Italia.
LurasDeviando sulla destra dalla 427 si arrivadopo 3 km a questo paese antico (m 508,ab. 2729) dalle belle case in granito, di-verso dagli altri della Gallura perché vi siparla il logudorese. Oggi i luresi, dediti alcommercio e alla lavorazione del sugheroe del granito, offrono anche capaci mae-stranze all’edilizia della Costa Smeralda.Tra i più significativi monumenti preisto-rici del suo territorio, quattro dolmen fu-nerari prenuragici risalenti al terzo mil-lennio a.C. Il più importante di questi è ilLadas*, a un paio di chilometri dal paese,sulla strada che porta alla statale 133 perPalau. Da visitare, al centro dell’abitato, an-che la settecentesca Parrocchiale. Da qual-che anno un cittadino di Luras, Pier Gia-como Pala, ha aperto all’interno di una bel-la casa padronale in granito, al centro delpaese, il Museo “Galluras. Frammenti dellaciviltà gallurese”, nel quale si possono ve-dere, oltre agli arredi e le suppellettili diun’abitazione tradizionale, gli strumentid’un tempo dei lavori di campagna e del-l’artigianato, compresi quelli per la lavo-razione del sughero.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

CalangiànusIl ricco centro gallurese (m 500, ab. 4770)sorge in un territorio abitato fin dalla prei-storia, come testimoniano significativi re-sti prenuragici. Nel 1698, con circa 1080abitanti, era, dopo Tempio, la secondacittà della “Incontrada de Gallura”. Oggi,con Tempio, la ‘capitale’ italiana del su-ghero. La lavorazione iniziò a Calangià-nus nel 1851, prima a livello artigianale epoi quasi subito a livello industriale. At-tualmente contribuisce per il 90% circa al-la produzione nazionale complessiva: ha3000 operai, 20 complessi industriali e180 botteghe artigianali. Dal 1978 vi si tie-ne un’importante Fiera internazionale delsughero. Merita una visita la chiesa di S. Ma-ria degli Angeli, che conserva un bel corosettecentesco, un tabernacolo ligneo e al-cuni quadri ottocenteschi del cagliaritanoGiovanni Marghinotti. La Parrocchiale èdel 1378 e conserva al transetto destroun’Assunzione di Andrea Lusso.
Tempio PausaniaLa città (m 566, ab. 13 979) sorge su un al-topiano granitico fitto di sughereti e di vi-gneti cui fanno da sfondo le cime a gugliedel maestoso massiccio del monte Limba-ra (m 1359). Importante centro sugherico-lo e vitivinicolo, è anche stazione di villeg-giatura collinare conosciuta per le qualitàterapeutiche delle acque oligominerali del-le rinomate fonti di Rinaggiu. È stata fin ol-tre la metà del ’900 la ‘capitale’ della Gallura.Il riflesso urbanistico di questo ruolo è leg-gibile nell’omogeneo tessuto di edilizia ci-vile e religiosa sette e ottocentesca che facorpo intorno alle piazze Gallura e S. Pietro.Il ridimensionamento delle sue funzioni ur-bane ha coinciso col processo di avvicina-mento delle popolazioni alle coste. Tempio è città di fondazione romana. L’in-sediamento si formò dalla riunificazione didue stazioni – Gemellae e Templum – lun-go la strada Olbia-Tìbula. Villaggio di mi-nuta consistenza demografica ed ediliziain epoca giudicale e pisana, vide crescerela sua importanza a partire dal Cinque-cento, cui seguì tra XVIII e XIX sec. un mo-vimento demografico di stabile accresci-mento dovuto anche a correnti immigra-torie dalla Corsica. Ad esso corrisposeun rapido sviluppo edilizio: a questo pe-riodo sono ascrivibili i più significativiedifici religiosi e civili eretti dalle più in-fluenti famiglie della città. È a metà dell’800 che mosse i suoi primipassi l’industria sugheriera: opifici indu-striali abbandonati ed edifici di servizio,
12.2 Da Luras a Tempio Pausania
177
‘monumenti’ dell’archeologia industriale,caratterizzano ancora diverse parti dellacittà. Oggi Tempio è sede di diocesi, cen-tro di servizi giudiziari e finanziari; è anchesede di attività di trasformazione delle ri-sorse locali (sughero e granito). Vi si tro-va pure una Cantina sociale da cui esconovini rinomati quali il Vermentino e il Mo-scato. Negli anni sessanta vi è sorta anchela Stazione sperimentale del sughero, isti-tuto scientifico di rinomanza europea.Tempio – dove il clima, il verde dei boschicircostanti, i giardini e i parchi, le acquesorgive rendono assai piacevole il sog-giorno - è nota in tutta la Sardegna per ilsuo Carnevale* straordinariamente par-tecipato: alla sfilata dei carri allegorici e al
processo al fantoccio del carnevale, detto“re Giorgio”, assistono, nella giornata diMartedì grasso, migliaia di persone che poiriempiono le sale da ballo aperte tutta lanotte e fino al successivo martedì.Via Roma è l’animato fulcro della vita cit-tadina; collega piazza Gallura e piazza d’I-talia lambendo il piccolo, scenografico,slargo di S. Pietro dove tra severi edifici ingranito sono raccolti gli episodi architet-tonici più interessanti, la Cattedrale e l’o-ratorio del Rosario. Dedicata a san Pietro, lamaestosa chiesa è stata ricostruita nel-l’Ottocento. Della preesistente fabbrica tar-doquattrocentesca rimangono il portale eil campanile absidato; all’interno, nella 3a e4a cappella sinistra, spiccano due altari li-gnei del ’700, finemente intagliati e dorati.Sulla Cattedrale prospetta l’elegante fac-ciata del settecentesco oratorio del Rosa-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Uscendo da Olbia si imbocca la statale125 che porta a Palau, ma lasciandola qua-si subito e svoltando a destra, si raggiun-ge, dopo 16 km, il lussuoso centro turisti-co-marinaro di Porto Rotondo. Qui la mac-chia mediterranea, punteggiata di ville e dirocce granitiche di bellezza non comune,è lussureggiante; il mare è di un tenero ver-de, davvero un verde smeraldo. Questopaesaggio accompagnerà il turista, percomode strade asfaltate, fino alla conclu-sione dell’itinerario, che permette di co-noscere quasi tutto il perimetro costierodella Gallura dirigendosi alla fine verso
l’interno e toccando note località turisti-che: oltre a Porto Rotondo, Cala di Volpe(24 km), Porto Cervo (3 km), Liscia di Vac-ca (4 km), Baia Sardinia (29 km), Palau(25 km), Porto Pozzo (13 km), Santa Tere-sa Gallura (5 km), Capo Testa (6 km), Vi-gnola (21 km), Portobello (10 km), CostaParadiso (17 km), Isola Rossa (8 km), Tri-nità d’Agultu (14 km), Àggius (23 km),Tempio Pausania (6 km).
Porto RotondoIl borgo (m 5) si affaccia su una baia ton-deggiante con costruzioni di misurata ele-
rio che mescola piacevolmente motivi sti-listici diversi. Suggestivo lo scorcio urba-no offerto da piazza Gallura.Al termine di via Garibaldi si accede al-l’ombroso parco delle Rimembranze, men-tre il viale della Fonte Nuova* – passeggia-ta estiva dei cittadini tempiesi – prende ilnome dalla fonte perenne di acque frescheche vi si trova. Più in alto si trovano le fon-ti di Rinaggiu*, inserite in un boschetto fit-to di alberi. Di recente vi è stato impianta-to uno stabilimento termale provvisto di pa-lestre, bagni turchi, saune, vasche idro-massaggio, sale per massaggi. Vi operanoanche strutture mediche specializzate nel-la cura di alcune malattie dei reni.
Usciti da Tempio, sulla statale 392 per Òschirisi incontra la deviazione per Vallicciola sulmonte Limbara. Si sale per 10 km ripidi ma dalfondo stradale buono attraverso fitti boschi dipini e querce fino allo spiazzo alberato dal qua-le si gode l’ampio panorama dell’intera Galluracon ‘l’azzurra visione’ della Corsica sullo sfon-do. Da Vallicciola la strada s’inerpica per altri 6km fino alle vette di punta Balistreri (m 1359) edi Ghjucantinu da dove lo sguardo spazia anchesul Logudoro e la Baronìa. Il massiccio del mon-te Limbara, vero paradiso degli escursionisti, èricchissimo di fonti, ruscelli, laghetti tanto ame-ni quanto facili da raggiungere.
Verso ÒschiriLa statale 392 si inoltra nella fitta vegeta-zione fra numerose fonti, tra le quali lapiù copiosa è quella di Fundu di Monti coni suoi cinque bocchettoni che versano l’ac-qua modicamente diuretica. Superato ilpasso del Limbara (676 m), si scende trasuggestive vallate boscose fino al lago ar-tificiale del Coghìnas e proprio dentro l’a-bitato ci si immette nella statale 597, la
12 La Gallura: il granito nel vento
178
“direttissima” Sassari-Olbia. Posto ai con-fini tra Gallura e Logudoro, Òschiri (m 202,ab. 3850) vive di agricoltura, pastorizia epesca. Ottimi e rinomati i suoi formaggi, maimpareggiabili le sue “panadas”, gustosis-simi involucri di pasta finissima, cucinati inforni speciali, con un ripieno d’anguilledel lago o di carne di maiale e vitella.
Non lontano, nella piana d’Ozieri, si eleva sulladestra, a 5 km da Òschiri, la chiesa di Nostra Si-gnora di Castro*, una costruzione romanica diderivazione lombarda, realizzata alla fine delsec. XII, che colpisce per la facciata in trachiterosa abbellita da un imponente campanile avela. Poco distanti, presso la sponda del lago,le rovine del medievale castello di Castro.
Si raggiunge il bivio per Berchidda (m 300, ab.3292), dopo 10 km sulla 597 per Olbia. L’abita-to è un florido centro agricolo-pastorale sullependici meridionali del massiccio del Limbara.Popolato fin dall’antichità, il territorio è co-sparso di resti archeologici che vanno dalledomus de janas e dai dolmen di Santa Caterinaai resti del castello di Montacuto di epoca giu-dicale. Attualmente è un paese agiato, con unamarcata attività cooperativistica e zootecnica.Anche l’imponente mole granitica del Limbararappresenta per Berchidda fonte di benessere conle sue acque, il suo legname, la sua selvaggina.
Di ritorno a OlbiaRitornati sulla statale 199 si raggiunge Ol-bia dopo 36 km di strada scorrevole che,attraverso terre ben coltivate e irrigateda più corsi d’acqua, scende dolcementeverso le piane costiere: nel tratto finale,sulla destra, i resti del medievale castelloPedreso*, in cima a una roccia, si con-trappongono alle moderne architetturedell’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
12.3 La Costa Smeralda e l’estremo NordItinerario prevalentemente costiero, da Olbia a Tempio Pausania, 224 km (carta a pag. 175)

12.3 La Costa Smeralda
179
ganza che gravitano sulla piccola piazza:da visitare la chiesa di S. Lorenzo*, operadi Andrea Cascella, con 20 statue sacre inlegno scolpite da Mario Ceroli. Per il suoporto turistico attrezzatissimo, è il più no-to tra gli insediamenti balneari sorti negliultimi due decenni a nord di Olbia.
Costa Smeralda**Lasciato Porto Rotondo, costeggiato il golfodi Cugnana, si entra nella Costa Smeraldache si allunga per 55 km nel tratto nord-orientale della Sardegna, tra Cala Razza diJuncu e l’insenatura di Poltu Quatu. Il nome,legato ai particolari colori del mare dalle tra-sparenze verdi e turchesi, fu coniato agli ini-zi degli anni sessanta da un gruppo di im-prenditori e finanzieri italiani e stranieriche investirono ingenti capitali su un com-prensorio territoriale di 5000 ettari, realiz-zando in una delle zone più deserte dell’i-sola il più esteso insediamento turistico-bal-neare del Mediterraneo.L’origine della Costa Smeralda è singolare:il principe Karim Aga Khan IV, viste per ca-so – si dice – queste bellissime coste gal-luresi popolate di pochi contadini e pa-stori, decise assieme a un gruppo di ami-ci e soci di realizzarvi una grande opera-zione turistico-immobiliare. Il compren-sorio della Costa Smeralda, quasi tutto incomune di Arzachena (e parte in comunedi Olbia), si presenta oggi come un auten-tico “paradiso per miliardari”: alcune de-cine di alberghi, centinaia di ville, un gran-de campo da golf, un porto turistico e uncentro nautico fra i più attrezzati e famo-
si del mondo. Ville e alberghi sono stati co-struiti in uno stile definito ‘neo-nuragico’,che però almeno in parte cerca di inserir-si nel paesaggio senza stravolgerne le lineee le caratteristiche. Il litorale è come in-tarsiato da piccole cale che penetrano findentro la fitta macchia creando una seriedi emozionanti contrasti cromatici.
Proseguendo verso Cala di Volpe si incontra akm 13.2 da Porto Rotondo il bivio per San Pan-taleo (m 166; a 5 km). Vale la pena di visitarequesto paesetto agricolo-pastorale incastona-to come un bianco cammeo in una colata sug-gestiva di alte rupi di granito.
Verso Porto CervoDopo Cala di Volpe si arriva alla spiaggia diCaprìccioli, chiusa al largo da una ridentecortina di isolette, e alla falcata distesasabbiosa di Liscia Ruia. Porto Cervo (m 8),il vero centro della Costa Smeralda, è ada-giato in una cala riparata e fornito di nu-merose strutture ricettive, negozi, locali diritrovo, campi da golf. L’abitato ruota in-torno alla famosa “piazzetta” e culminanella chiesa di Stella Maris* (B2, nella pian-ta alla pagina 180), opera dell’architettoMichele Busiri Vici. Il portale in bronzo abassorilievi rappresentanti l’Annuncia-zione si deve a Luciano Minguzzi; all’in-terno, una Mater Dolorosa impegnativa-mente attribuita a El Greco e un organo delSeicento. Il porto turistico (A-B1), fra i piùattrezzati, dispone di 500 posti barca di-slocati in sette pontili. Riprendendo la litoranea che serpeggiatra bianche rocce e macchie si supera
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Baia Sardinia, insediamento popolatissimodurante l’estate. Seguendo poi il contornomeridionale del golfo di Arzachena si pro-segue verso Palau.
PalauÈ il vivace centro (m 5, ab. 3355) di pas-saggio per La Maddalena. Un chilometroprima del paese, una strada asfaltata con-duce sulla sinistra a Porto Rafael, sofisti-cato borgo turistico raccolto intorno auna breve insenatura, e al promontorio diPunta Sardegna, animato da belle ville dis-seminate nel verde della macchia medi-terranea. Trasformatosi negli ultimi de-cenni dell’Ottocento da piccolo villaggio dicontadini-pescatori in un paese di una cer-ta importanza per la vicinanza di La Mad-dalena (con la sua grande base navale), Pa-lau ha oggi una sicura vocazione turistica.
Una delle bellezze naturali del territorio di Pa-lau è la famosa roccia di Capo d’Orso*, a 5 kmdal centro. Ai piedi di questa roccia di podero-sa bellezza che prende il nome dall’animale dicui la mole possente evoca l’immagine, si diceche Omero abbia localizzato il paese dei Le-strìgoni (ma lo si dice per molti altri posti delMediterraneo).
Da Palau a Santa Teresa GalluraAbbandonata, appena superato il pontesul Liscia, la 133 diretta a Tempio, si pro-
180
segue sulla 133 bis fino al bivio di San Pa-squale (m 139). Dopo questo paesello sor-to nel 1776, affacciato come da un aereopoggiolo sull’arcipelago maddalenino, me-rita sostare nel borgo marino di Porto Poz-zo (m 9), villaggio di contadini-pescatorisecondo un assetto sociale comune a tut-ti i piccoli paesi costieri.La 133 bis fra Porto Pozzo e Santa TeresaGallura corre per una zona pianeggiantericca di macchia mediterranea dove pri-meggiano le eriche nane e gli olivastri se-colari piegati dal vento. Dal lato destro del-la strada si staccano i vari svincoli che, do-po 4-5 km, portano alle frequentate localitàturistiche distribuite lungo la riva. Il maredi questo squarcio di costa è famoso perle acque di un incredibile verde-azzurro eper l’abbondante fauna marina, ricca dispecie rare e protette.
Santa Teresa Gallura*Il centro balneare (m 44, ab. 4157; e, da lu-glio a settembre, 40 000 ‘ospiti’) si affacciada un piccolo promontorio roccioso sulleBocche di Bonifacio. La caratteristica piùsignificativa di questa cittadina, la cuipianta di fondazione fu disegnata nel 1808di propria mano da Vittorio Emanuele I,che le diede il nome della regina, è la strut-tura regolare delle sue strade originarie. Èdi questi ultimi decenni la trasformazione
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

da borgo di ortolani-pescatori in sito tu-ristico di risonanza europea. Un fitto av-vicendarsi di spiagge e spiaggette dallasabbia finissima anima la costa da puntaFalcone alla penisoletta di Capo Testa;un’autentica sorpresa anche per i turistipiù vaccinati contro la magia di tante bel-lezze ambientali: mare, granito, sabbia emacchia dispiegano qui la straordinariagamma dei loro colori primigeni. Di fron-te alla cittadina si staglia oltre l’azzurro delmare l’ampia mole della Corsica (distanteappena 14 km), con i suoi bianchi bastio-ni calcarei della costa di Bonifacio. Dalporto, protetto da una profonda insena-tura che penetra nell’entroterra a fiancodell’abitato, partono i traghetti di lineaper Bonifacio (quotidiani, più numerosi du-rante l’estate: il viaggio dura circa un’ora).Quando i piemontesi costruirono SantaTeresa Gallura lì c’era solo la cilindrica tor-re di Longosardo, eretta nel XVI sec. da Fi-lippo II. E c’è ancora, alta sulla roccia.
Con una deviazione di appena5 km dall’abitato si arriva aCapo Testa**, promontoriodi granito collegato alla ter-raferma da uno stretto istmo.Nella parte nord-occidentalepresenta ancora tracce di ca-ve di granito sfruttate dai ro-mani. Anche i pisani nel me-dioevo ne usarono il granitoper i colonnati del Duomo diPisa. Sulla costa che fronteg-gia la penisoletta è sorto unvasto insediamento chiama-to Santa Reparata (m 22), dairesti di una chiesetta medie-vale che ha dato nome allabaia. All’estremità del pro-montorio c’è cala Spinosa conle sue acque verdi racchiuseda un anfiteatro di biancherocce di granito.
A Vignola MareDa Santa Teresa una lito-ranea porta fino a Castelsardo seguendoil mare o, a tratti, allontanandosene diqualche chilometro. Dopo il verde dossodi Rena Majore (dove gli antichi localiz-zavano le porte dell’inferno per il suo ma-re mugghiante nei giorni di forte mae-strale e oggi sorge un vasto complesso re-sidenziale), e dopo il lungo litorale albe-rato che fronteggia il promontorio grani-tico di Montirussu, s’incontra sulla destrail piccolo centro di Vignola Mare (m 6), vil-laggio di pescatori ora con posti di risto-ro e camping ben attrezzati.
12.3 Santa Teresa Gallura
181
A un chilometro da Vignola si trova sulla destrail bivio per (5 km di strada asfaltata) Portobel-lo di Gallura (m 50). Superato il rio Vignola si ar-riva a un mare felicemente sposato con la costarocciosa ricoperta di olivastri e lentischi piegatie pettinati dal vento quasi a continuare la di-stesa ondulata del mare. Fra alberi e rocce, unnucleo di ville sparse nel verde, acquattate sot-to il livello della macchia e alcune completa-mente nascoste da essa.
Proseguendo verso sud-ovest la stradacorre tra la macchia mediterranea costel-lata di stazzi: numerose rustiche insegneinvitano ad acquistare direttamente daiproduttori formaggi, latticini e vini localiin genere gustosi e di prezzo accettabile.Costa Paradiso (m 154), un altro insedia-mento turistico, è a destra sul mare. La siraggiunge con una deviazione di 5 km dalu Colbu. Porto Leccio e la baia di Tìnnaricon le sue rocce color corallo sono altridue punti sull’itinerario che vale la pena disegnalare al turista.
Isola RossaA 4 km dalla strada per Castelsardo, bian-co su suggestive rocce di porfido coloramaranto, s’incontra il piccolo paese (m23), 130 abitanti stanziali e 10-12 mila inestate, sorto con la vocazione per la pescae, in seguito, per il turismo.L’isoletta omonima, della stessa rosseg-giante pietra, ne delimita a nord-ovest ilporticciolo. Il borgo nacque agli inizi del’900 grazie a un gruppo di pescatori e con-tadini napoletani e galluresi che sfrutta-rono il mare antistante all’abitato soprat-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

12.4 L’Arcipelago della MaddalenaItinerario solo in parte pedonale sulle due isole maggiori; escursioni in battello per le altre(carta a pag. 183)
Posto all’estremità nord-orientale dellaSardegna (imbarchi da Palau), prende ilnome dell’isola principale. Formatosi pereffetto della sommersione provocata dal-l’innalzamento post-glaciale del livello delmare, è costituito da un gruppo di isolegranitiche per una superficie complessivadi 49.3 km2.Delle sette isole maggiori, quattro, SantoStefano, Spargi, Maddalena, Caprera, sitrovano vicino alle coste galluresi; le altretre, Budelli, Razzoli, Santa Maria, circon-date da uno sciame di isolotti e scogli, siaffacciano sulle Bocche di Bonifacio.Lo spettacolare paesaggio delle isole edei fondali marini, la fantasmagoria delle
forme e dei colori, la varietà delle specieornitologiche conferiscono a questo trat-to di costa – uno dei più suggestivi del-l’intero bacino del Mediterraneo – un ec-cezionale interesse paesaggistico e natu-ralistico. La necessità della tutela e dellavalorizzazione delle sue risorse naturali,ambientali e storico-culturali, hanno por-tato alla legge istitutiva del Parco nazionaledell’Arcipelago della Maddalena (1996).Destinato a rappresentare anche una par-te significativa dell’istituendo Parco marinointernazionale delle Bocche di Bonifacio,comprende una superficie superiore ai 20mila ettari – tra terra e mare – e ben 180chilometri di coste. Vi rientrano tutte le
tutto per la pesca dei mitili e dei crostacei.Vicino all’abitato, scura sulla roccia, an-cora imponente, si erge una torre cinque-centesca di difesa.
Trinità d’AgultuL’abitato (m 365, ab. 2033) si affaccia co-me da un belvedere sul Golfo dell’Asina-ra, l’Isola Rossa, Baia Trinità e PuntaCanneddhi. È un piccolo centro che vivedi un’attiva economia agricola. Vicine alpaese si trovano le antiche chiese di S.Antonio di Li Colti, di S. Pietro Martire, S.Orsola e S. Barbara, le ultime due pres-soché ridotte a ruderi.
182
Verso ÀggiusProseguendo in salita fra un’armoniosafuga di colline, al centro di un breve pia-noro si apre la cosiddetta Valle della Luna,o “Piana dei grandi sassi”; è una landad’aspetto desolato animata un tempo darocce granitiche scavate dall’erosione na-turale, molte con forme animali. Cavatorisenza scrupoli l’hanno ridotta quasi un de-serto; si è salvata soltanto la testa di Pla-tone (o del Frate Cappuccino), come vie-ne chiamata l’enorme roccia vicina allastrada, sulla destra.Àggius (m 514, ab. 1731), ridente e sugge-stivo, sorge sul versante sud-orientale delmonte della Croce (666 m) che assieme adaltre vette contigue è noto anche come “ilResegone sardo” per il suo aspetto se-ghettato. Nel territorio, resti preistorici im-ponenti: circoli megalitici nella zona di Pi-trischeddhu e tracce di villaggi prenuragicia li Pàrisi. Nell’Ottocento il paese fu tor-mentato da tremende faide: la più celebreraccontata nel “Muto di Gallura”, romanzodi Enrico Costa. Oggi Àggius è un florido etranquillo paese dove l’attività più inte-ressante, oltre a quelle legate alla lavora-zione del granito e del sughero, è la tessi-tura dei tappeti lavorati nel rispetto di unatradizione antichissima. Da luglio a set-tembre una Mostra del tappeto aggese* puòessere visitata tutti i giorni compresi quel-li festivi. Da vedere sono le quattro chiesedel centro storico: la parrocchiale di S. Vit-toria (1536), la Madonna d’Itria (1750) e glioratori del Rosario (1717) e di S. Croce(1709). Tempio Pausania (v. pag. 177), di-sta da Àggius meno di 7 chilometri.
12 La Gallura: il granito nel vento
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

12.4 L’Arcipelago della Maddalena
183
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
vata ricchezza di habitat e di specie, al-cune di rilevanza internazionale. Il rego-lamento provvisorio di salvaguardia am-bientale e la protezione con cavi tarozza-ti delle cale e delle spiagge più rinomatesono le prime misure dell’organismo digestione; mentre l’accesso al Parco di de-cine di migliaia di barche – che stavanomettendo a dura prova gli eccezionali va-lori ambientali – è ora regolamentato daprecise norme. La quasi totalità degli abitanti è concen-trata nel consistente nucleo urbano dellaMaddalena, sulla costa meridionale del-l’isola omonima. Le attività prevalenti so-no quelle della pesca, marinare e di ser-vizio collegate al turismo e alla presenzadel Comando della Marina militare. Nel-l’ultimo trentennio la vocazione turisticadel comprensorio ha ricevuto un forte im-pulso anche dalle attrezzature ricettivedislocate nelle isole come il Centro VelicoCaprera e i villaggi turistici del TCI (La
isole (e isolotti) appartenenti al territoriodel comune di La Maddalena, tra le quali– all’interno del Parco geo-marino, cheaspira a diventare un centro di eccellenzanel campo della tutela dell’ambiente, del-la ricerca e della didattica – è di particolareinteresse l’isola di Caprera, censita tra i si-ti di maggiore importanza per la conser-vazione della natura dall’Unione Europeae già Riserva orientata dal 1980. Nella fa-scia costiera le emergenze più suggestiveriguardano le forme dei litorali, di naturagranitica, che si caratterizzano per un an-damento frastagliato in un alternarsi difalesie e rias. Le principali formazioni ve-getali sono quelle tipiche della fascia co-stiera mediterranea.Tra l’avifauna di passaggio nelle isole sipossono ricordare alcune colonie nidifi-canti di specie rare: la berta maggiore, laberta minore, l’uccello delle tempeste e ilgabbiano corso. Per quanto riguarda gliaspetti marini è possibile rilevare un’ele-

12 La Gallura: il granito nel vento
184
druplicata rispetto a quello del 1881.Attualmente la cittadina è sede del Co-mando militare marittimo autonomo del-la Sardegna e della Scuola allievi sottuffi-ciali della Marina militare. Dagli anni set-tanta, nello stretto tra le isole Maddalenae Santo Stefano, ha sede una base USAper sommergibili atomici. I caratteri paesistici e naturalistici, la sel-vaggia, intatta bellezza dei luoghi e i valoriambientali non esauriscono i motivi di in-teresse della visita all’arcipelago madda-lenino. Muovendo dal centro della cittàdella Maddalena, si suggerisce il circuitodell’isola (km 20.6) lungo la “strada pa-noramica” e quindi la visita a Caprera (km5.3 più eventuali deviazioni) e al Museo ga-ribaldino, deposito di memorie risorgi-mentali. Per gli spostamenti è necessariol’uso di mezzi di trasporto. Con battelli ge-stiti da privati si possono effettuare ap-passionanti escursioni alle altre isole.
La MaddalenaCon i suoi 19.61 km2 e uno sviluppo co-stiero di 45 km è l’isola più grande del-l’arcipelago (ab. 11 715). Di forma trian-golare, si eleva al centro con un acciden-tato altopiano dall’altezza media di 100m con una cima – Guardia Vecchia – cheraggiunge i 156 m. È poverissima di suoli
utili alla coltivazione, datala forte prevalenza dei ter-reni granitici.Partendo dal lungomare,dove si trova l’attracco deitraghetti che collegano l’i-sola con Palau (traversata15 minuti), si giunge in bre-ve all’animata piazza Gari-baldi* dove prospettanoaffollati caffè ed edifici dirappresentanza come ilMunicipio. Nei pressi si di-stende il suggestivo centrostorico, piacevolmentemosso da scalinate e vico-li; vi si trova la parrocchia-le di S. Maria Maddalenache conserva due cande-labri e un Crocifisso d’ar-gento donati da Orazio Nel-son che, nella rada dellaMaddalena, stazionò conla squadra inglese primadella battaglia di Trafalgar.Lungo via Vittorio Emanue-le, si raggiunge il piccolo,incantevole porto pesche-reccio e turistico di Cala Ga-
Maddalena, vedi pag. 185) e del Club Mé-diterranée (Caprera).Già abitate in epoca preistorica, le isoledell’arcipelago acquistarono importanzain epoca romana come base di appoggiodelle navi sulle rotte del Tirreno. Abban-donate per un lungo periodo, furono fre-quentate nel XII sec. da pisani e genovesi,ma solo nel XVI le migrazioni temporaneedi pastori corsi, alla ricerca di pascoli perle loro mandrie, portarono alla nascita diun primo nucleo abitato alla Maddalena.Successivamente, col passaggio della Sar-degna al Piemonte, la resistenza della riot-tosa comunità corsa fu piegata, nel 1767,dall’occupazione dell’arcipelago con un di-staccamento militare. Cominciò così perLa Maddalena la prima fase di sviluppo le-gato alla presenza del porto militare del-la Marina sarda. Furono realizzate in que-sto periodo le principali strutture urbanea partire dal primitivo nucleo di Cala Ga-vetta. Nel 1887 il governo italiano scelsecome base strategica della Marina milita-re l’isola che è stata, fino alla fine della se-conda guerra mondiale, un’importantebase navale. La presenza della base e del-l’arsenale condizionò in maniera deter-minante lo sviluppo edilizio che accom-pagnò quello demografico. Al censimentodel 1901 la popolazione era più che qua-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

vetta, uno dei più affasci-nanti scorci urbani. Vi siapre piazza XXIII Febbraio1793 (giorno in cui le milizielocali riuscirono, durante laguerra tra Francia e Pie-monte, a respingere il ten-tativo di occupazione fran-cese). Tornati, attraverso
via Amendola, sul lungoma-re e superato il porto com-merciale, si raggiunge piaz-za Umberto I o piazza Co-mando, dominata dagli edi-fici del Comando della Ma-rina militare e panoramica-mente aperta sul mare e sul-le isole. Da qui si raggiungefacilmente il popolare sob-borgo di Moneta, che con-serva la parlata e il vivace carattere popo-laresco del primitivo nucleo d’insediamen-to. Superato il quartiere si arriva al ponte odiga (600 m, costruito nel 1891) che con-giunge La Maddalena con l’isola di Caprera.
La passeggiata, indicata a chi vuole godere delmagnifico panorama dell’arcipelago, si svolgelungo i 20.6 km della strada panoramica che fail giro dell’isola della Maddalena, costeggiandoil mare e toccando, a occidente e a oriente, al-cune delle opere difensive dell’epoca piemon-tese. Nel primo tratto della panoramica, meri-tano una visita le due sale del Museo archeo-logico navale Nino Lamboglia, dedicato al-l’archeologia sottomarina, inaugurato nel 1982.A nord, affacciato sulla bella cala di StagnoTorto, è invece il Villaggio del Touring Club Ita-liano, in felice situazione ambientale fra contortiginepri e macchioni di lentisco.
CapreraIndicata dai geografi come l’antica Phin-tonis di Tolomeo, si trova a est della Mad-dalena ed è la seconda tra le isole del-
12.4 L’Arcipelago della Maddalena
185
l’arcipelago quanto a superficie (15.75km2) e a sviluppo costiero (34 km). Gliaspri rilievi dell’accidentata costa orien-tale, dove si erge il monte Teialone (212m), lasciano il posto, in quella occidentale,a spazi pianeggianti occupati da pascoli epinete. L’isola – da sempre disabitata e fre-quentata solo in alcuni periodi dell’annoda pastori transumanti – fu in parte ac-quistata nel 1855 da Giuseppe Garibaldiche vi costruì una casa e alcuni edifici diservizio, che dal 1978 lo Stato ha orga-nizzato come Compendio garibaldino*.Il nucleo principale trova collocazionenella Casa Bianca. La costruzione occupail lato occidentale del cortile su cui do-mina, sovrastante a un abbeveratoio, il pi-no piantato in occasione della nascitadella figlia Clelia. Composta di diversi va-ni intercomunicanti, funzionali alla vita do-mestica e agli interessi di Garibaldi, èaperta verso l’esterno.L’allestimento museale segue nell’insiemela destinazione dei singoli ambienti dove
«L’unico luogo vero, l’unico luogo sacro del nostro Ri-sorgimento», ha scritto una volta di Caprera Mario Sol-dati. Qui - come poetò D’Annunzio - «dorme il Leone insepoltura», con un respiro «che solleva l’onda».A Caprera Garibaldi ci arrivò per caso, ma fu un amorea prima vista. Sbarcò a La Maddalena il 25 settembre
1849: dopo la caduta della Repubblica Ro-mana, andava in esilio. I suoi ospiti (Susini,Millelire, poi spesso compagni anche nelleavventure americane e nella spedizione deiMille) lo portarono a caccia a Caprera, l’iso-la delle capre. Alla fine del 1855, con una pic-cola eredità, ne comprò un pezzo: l’altro eradi certi signori inglesi, Collins. Con misterCollins, Garibaldi ebbe rapporti agitati, maquando restò vedova, nel 1860, la signoraCollins gli vendette il suo pezzo; Garibaldi lopagò con i soldi di una sottoscrizione aper-ta a Londra dal Times. Mentre gli costruiva-no la casa (nella foto, la camera con il lettodove morì il 2 giugno 1882), il generale abitòin strutture precarie come la “casa di ferro”,
una specie di prefabbricato che si vede ancora nelCompendio garibaldino. «Giuseppe Garibaldi, agricol-tore»: sono firmate così decine di documenti conservatiancora nell’archivio comunale della Maddalena. E a ra-gione. Garibaldi aveva trasformato quell’isola rocciosa,spazzata dalla furia del maestrale, in un’azienda dove c’e-rano vigna, orto, bosco, frutteto, una fattoria con (nel1866) 150 bovini, 214 capre, 400 polli, 50 maiali. Facevaun olio finissimo e un vino liquoroso profumatissimo: malui, a pranzo e a cena, beveva solo latte.
Garibaldi e Caprera
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

sono raccolti oggetti d’uso, arredi, quadrie numerosi cimeli come la cassa da cam-po e la rete metallica che l’eroe usò in tut-te le campagne di guerra. Nella cameradove Garibaldi morì è conservato il lettocircondato da una balaustra donata dal-la Società Reduci di Livorno. Tra i dipin-ti si segnala il ritratto di Giuseppe Garibaldieseguito da Saverio Altamura nel 1860.Sul retro della casa, all’uscita dall’ulti-mo vano, si possono vedere il forno e ilmulino a vento costruiti dallo stesso Ga-ribaldi. Su una roccia è collocato il bustorealizzato da Leonardo Bistolfi dopo lasua morte. Al termine del viale si trova latomba, un semplice sarcofago costituitoda un masso di granito affiancato da quel-li dei figli e della moglie.Caprera è famosa per l’intatta, smaglian-te bellezza del suo paesaggio. Sulle inac-cessibili pareti del versante orientale ni-dificano molte specie di uccelli come ilgabbiano reale, il gabbiano corso, il ma-rangone dal ciuffo e il falco pellegrino.Dichiarata riservanaturale orienta-ta nel 1980, l’isolaè stata liberatal’anno dopo dalleservitù militari.
186
Santo StefanoSi trova di fronte alla cittadinadi La Maddalena a metà per-corso della traversata da Pa-lau. È visibile dal traghetto ilforte di S. Giorgio (detto anchedi Napoleone) che fa parte delsistema di fortificazioni realiz-zato dal governo piemontesealla fine del ’700. Da qui, du-rante l’attacco francese del1793, Bonaparte, allora giova-nissimo luogotenente colonnel-lo della Guardia nazionale corsa,diresse il bombardamento con-tro la città della Maddalena (duegrandi palle di cannone sonoconservate nel palazzo munici-pale dell’isola maggiore).
SpargiDi forma tondeggiante e dall’aspro rilievo,raggiunge la massima elevazione col mon-te Guardia Preposti (155 m). Vi si trova unpiccolo insediamento di pastori e una bel-la e frequentata spiagga, Cala Corsara.
Budelli, Razzoli e Santa MariaBudelli**, conosciuta soprattutto per “laspiaggia rosa” (l’effetto cromatico è datoda minute particelle di corallo), si trova anord di Spargi ed è disabitata. La sua famaè legata alle inquadrature divulgate da unfilm di Michelangelo Antonioni. Nel 1992 oggetto di polemiche per un ven-tilato progetto di edilizia turistica, l’isola rap-presenta un unicum, ora protetto da unprovvedimento di tutela nell’ambito delParco geo-marino di La Maddalena. A nord-ovest e a nord-est, affacciate sulle Bocche diBonifacio e separate dal passo degli Asi-nelli, sono le isole di Razzoli e Santa Maria.La prima, disabitata, ha coste scoscese edè accessibile solo nella parte occidentale, al
fondo dell’insena-tura di Cala Lunga.La seconda, quasipianeggiante, ha al-cuni abitanti ed è inparte coltivata.
12 La Gallura: il granito nel vento
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Se si raggiunge la Sardegna lungo le rotte più frequentate, prendendo terra all’aeroportodi Olbia o al vicino porto dell’Isola Bianca, rimane l’incertezza se iniziare il periplo del-l’isola dirigendosi verso nord o muovendosi verso sud: sono 1897 chilometri di litora-le dall’incredibile varietà di forme nelle rocce e negli arenili, nel colore dell’acqua, neipaesaggi umani come in quelli floro-faunistici dei retroterra. Fra tante attrazioni, è pro-babile che sia la fama della Costa Smeralda a decidere la prima tappa. Il paesaggio della costa gallurese è dominato dal granito che prende le forme più stra-ne e pittoresche, combinandosi in modi sempre diversi con la macchia, la sabbia e l’ac-qua marina. Il litorale settentrionale ha invece le linee dolci del grande golfo dell’Asinara,che fa spazio a spiagge sempre più ampie sino a quella di Platamona; il granito continuaa comparire a Portobello, a Costa Paradiso, quindi cede il posto alla trachite di Castel-sardo per chiudere con gli schisti della punta occidentale, Stintino, e le falesie dell’Asinara.Ancora coste variegate e alte sino a capo Caccia, con le sue grotte, poi giù, per Alghe-ro e il successivo selvaggio tratto verso Bosa, dove si aprono una foce, un porto e alcunespiagge. Ancora un tratto di litorale alto, di basalto poi di calcare, che si fa nuovamen-te basso e sabbioso nel Sinis e nel golfo di Oristano, fino ai territori un tempo paludo-si di Arborèa. Più a sud le rocce e i tratti sabbiosi si alternano con le dune della CostaVerde; segue un lungo tratto desertico che lascia poi spazio alle rive delle zone un tem-po minerarie dell’Iglesiente, con la bellissima falesia di Masùa e Nèbida.Dopo capo Altano la costa si fa più bassa e monotona, ma ha di fronte le isole di San Pie-tro e Sant’Antìoco con le loro spiagge piccole e nascoste. Il cambio di direzione avvie-ne a capo Teulada, al termine di una penisola impervia: si apre poi un’insenatura, pre-ludio alle rocce scoscese, in parte granitiche, della Costa del Sud; quindi riprende il do-minio della sabbia che, con qualche interruzione, ci conduce sino a Cagliari col suo golfoe la sua spiaggia, il Poetto; il granito occupa tutta la parte sud-orientale, che ha al cen-tro Villasimìus con le sue belle spiagge.Nel risalire la costa orientale si trovano il tratto affollato di Costa Rei e quello di Mura-vera, rinomato per la purezza delle acque; quindi, dopo la parte desertica del Salto diQuirra, i litorali di Tertenìa, Cardedu e Bari Sardo, ancora poco conosciuti; più frequentatiquelli dell’Ogliastra, a sud e a nord del capo Bellavista e delle rocce rosse di Àrbatax.Un mondo a parte è il primo tratto del golfo di Orosei, dove poche spiagge di sogno siaprono in una falesia calcarea. Segue un tratto di rocce miste a spiagge; di tanto in tan-to ricompare il granito che da capo Comino ci accompagna sino al golfo di Olbia, sottol’impressionante mole dell’isola Tavolara.
187
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Itinerari tematici
La Sardegna delle spiagge (carta a pag. 189)

Pittulongu. È la grande spiaggia degli ol-biesi, adatta per chi vuole fare poca stradae disporre di comodità e servizi. Il lungo ar-co sabbioso è a breve distanza dalla stra-da per Golfo Aranci; gode ancora del ripa-ro di capo Figari a nord e di capo Ceraso asud; la vista arriva sino all’inconfondibilemassa calcarea di Tavolara, mentre le na-vi di linea sfilano all’orizzonte
Porto Rotondo. Nella parte terminale del-la penisola di monte Ladu, tra i golfi di Cu-gnana e di Marinella a nord di Olbia, siaprono due insenature di forma rotonda,riparate da promontori granitici. In una èstato costruito il porto, detto giustamen-te Rotondo come l’elegante villaggio che èsorto tutt’intorno; nell’altra, cala La Tazza,si apre la nota spiaggia di Ira (dedicata al-la principessa Fürstenberg), un semicer-chio di sabbia bianca – bagnato da acqualimpida e quasi sempre calma – che al-l’interno confina con un’area pianeggian-te dove le case hanno lasciato spazi alla ve-getazione spontanea. Altre spiagge, piùpiccole e sempre diverse, si aprono sia inquesto versante (Iscia Segata; della Volpe),sia nelle insenature che si dispongono aoriente (il grande arenile della Marinella)e a occidente (punta Asfodeli).
La Costa Smeralda. All’aprirsi del golfo diCugnana si stendono, sulla costa orienta-le, le spiagge di Portisco, movimentate daun isolotto con istmo sabbioso. Subitodopo una scritta su un masso di granito sulciglio della strada panoramica segna l’i-nizio della Costa Smeralda, dove il rispet-to per l’ambiente è stato più forte.Subito dopo partono diramazioni per leprime spiaggette: quella detta Rena Bian-ca e le cinque di cala Razza di Juncu; an-cora intatte, un’immagine di com’era que-sta zona prima della valorizzazione turi-stica: i profumi della macchia, le falci disabbia tra punte di granito e l’acqua calmadel mare, di un azzurro sempre diverso.La prima grande spiaggia è Liscia Ruja,affacciata più avanti nell’insenatura di Ca-la di Volpe, preceduta da quelle dette Pe-tra Niedda e Petra Bianca a seconda delletonalità del granito; è una delle più belledella Sardegna: un arenile ad arco, sepa-rato dalla strada d’accesso da addensa-menti di macchia, chiuso in fondo dal pro-montorio Monte dell’Isola.Da Cala di Volpe si raggiunge punta Ca-prìccioli: chi conosce le sue spiaggette sache, qualunque vento tiri, si può trovaresempre quella in cui il mare è calmissimo.
188
Seguono la spiaggia del Principe, divisa indue da un promontorio e bagnata da ac-que limpidissime, e la spiaggia del Ro-mazzino (rosmarino), al fondo di una baiasemicircolare presso l’albergo che porta lostesso nome.Da qui bisogna percorrere alcuni chilo-metri per raggiungere la ‘capitale’ di que-sto paese di vacanze, Porto Cervo: sull’i-tinerario una deviazione conduce allespiagge del Piccolo Pevero e del Pevero, cheha sul retro un piccolo stagno e oltre, sulpendio della collina, le propaggini del fa-moso campo da golf.La costa intorno a Porto Cervo è più po-vera di spiagge: quella vicina di cala Ro-mantica è tutta ciottoli, qualcuna meno fre-quentata si apre nella vicina penisola di ca-po Ferro; più oltre Liscia di Vacca, in un’a-rea verde con prati, alberi, vasche d’acquae cascatelle, e Pitrizza, col suo albergo instile ‘neo-nuragico’.
L’Arcipelago della Maddalena. Ancorauna volta un paesaggio dominato dal gra-nito che delimita gli arenili, dà luogo colsuo disfacimento alle sabbie, affiora dalleacque del mare e origina le alture dell’in-terno, contendendo lo spazio alla vegeta-zione spontanea e assumendo forme ori-ginali e fantasiose.Il periplo dell’isola maggiore (in senso an-tiorario lungo la strada panoramica) toc-ca prima, nella penisoletta di Giardinelli, al-cune piccole spiagge dominate da roccechiare; vengono poi quelle riparate di Ca-la Spalmatore, dalla sabbia rosata; seguo-no quelle di Monti di Rena, nell’insenaturaStagno Torto, di Bassa Trìnita, circondatada dune bianche, e quelle piccolissime diCala d’Inferno, così chiamata per le formeinsolite che assumono i graniti.A Caprera sono rinomate le piccole spiag-ge di Cala Coticcio, sul litorale orientale,raggiungibili più facilmente dal mare; po-co più a sud, anch’essa breve e solitaria,quella di Cala Brigantina; nella parte nord-occidentale la Cala Napoletana compren-de tre piccoli arenili dominati da erte roc-ce; altri se ne trovano a sud. Lungo la pun-ta Rossa infine, estrema propaggine me-ridionale, si stende quella di Cala Andrea-na, dove il colore chiaro della sabbia de-termina una tonalità particolare, e piace-volissima, dell’acqua.Altre spiagge, tutte piccole e nascoste,paradiso di chi va per mare, si trovano nel-le isole minori dell’arcipelago, da SantoStefano a Spargi, da Santa Maria a Razzo-li. Tra queste, celeberrima la spiaggia rosa
Itinerari tematici
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

189
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

di Budelli, unica nel suo genere, colorata diframmenti di granito, di coralli e di con-chiglie; la recente istituzione del parcoha finalmente frenato l’insensato vezzodei turisti di portarne via manciate con-siderate quali souvenir.
Porto Pollo . Anche Palau ha tutta una se-rie di spiagge, sia nel tratto di costa versoest, dove si leva il grande ‘Orso’ di grani-to, sia a nord-ovest, nella tozza penisolache termina con punta Sardegna. Verso oc-cidente, subito prima della foce del Li-scia, si trova l’isola dei Gabbiani, o Isu-ledda, collegata all’isola maggiore da unastriscia di sabbia che offre una doppiaspiaggia dove si può osservare lo spetta-colo degli atleti del windsurf, richiamatiqui dalla felice combinazione dei venti.
Santa Teresa Gallura. Santa Teresa hauna sua spiaggia, ormai quasi inglobatanell’abitato: occupa una delle due inse-nature che delimitano il promontorio su
cui sorge il paese. Nonostante l’affolla-mento estivo, conserva la bella sabbiache le ha dato il nome: Rena Bianca; l’ac-qua è limpida e, grazie anche alla quinta diun isolotto di granito, quasi sempre calma. Intorno a punta Falcone, che segna il limitenord della Sardegna, le spiaggette di PortoQuadro, delimitate da rocce e da macchieche giungono sino alla sabbia e, più oltre,estesa al centro di un’insenatura, la Mar-morata, che conserva la sua bellezza no-nostante l’eccesso di cementificazione. Oltre Santa Teresa, le spiagge di Capo Te-sta, collegato alla Sardegna da una linguadi sabbia: le prime due sono lungo questoistmo; a breve distanza quella di SantaReparata, nel punto dove attraccavano lenavi romane e poi pisane.
Itinerari tematici
190
La Gallura di nord-ovest. Da Santa Tere-sa parte la litoranea che raggiunge Ca-stelsardo e prosegue poi per Porto Torres.Il paesaggio è ora meno tormentato e il li-torale si snoda per linee più regolari. Il pri-mo arenile è Rena Majore, al di là di una pi-neta. Si stende al fondo di un’insenatura,ma talvolta le burrasche delle Bocche diBonifacio lo raggiungono, con insistitofrastuono di risacca.Ancora pochi chilometri e un’altra devia-zione porta alla spiaggia di Vignola, che sistende in due anse: quella di destra sichiude con una massa di granito rossastro,quella di sinistra con una penisoletta ri-coperta di macchia e dominata da unapanoramica torre spagnola.Molto più piccola, e raggiungibile soltan-to con una passeggiata di mezzo chilo-metro, la spiaggia di Li Cossi (i còrsi), al ter-mine di una vallata scavata da un torren-te lungo il tratto di Costa Paradiso, alto sulmare con formazioni di graniti dalle sfu-mature rosate. Analoga l’origine della
spiaggia Tìnnari, formatapoco più avanti, con ciot-toli di porfido, dal rio Pi-rastu. Siamo ormai viciniinfatti alle formazioni roc-ciose di Isola Rossa. Quiuna spiaggia si apre neipressi dell’abitato, men-tre un’altra si stende alfondo dell’insenatura de-limitata dalla punta LiCanneddi. Subito dopo lerocce lasciano spazio allungo arco sabbioso incorrispondenza della fo-ce del Coghìnas.
Il golfo dell’Asinara. Ol-tre il Coghìnas cessa il dominio del grani-to, si succedono depositi alluvionali e,nella zona di Castelsardo, formazioni ditrachite. Il litorale qui si mantiene alto, la-sciando spazio a pochi angusti arenili, do-po di che si apre una delle spiagge piùgrandi della Sardegna, territorio comuna-le di Sorso e solo in piccola parte di Sas-sari: in quest’ultima sorse negli anni cin-quanta il lido di Platamona, che ha finitoper dare il nome a tutta l’area, caratteriz-zata da villaggi seminascosti nella vicinapineta e da discese a mare frequentateanche dagli abitanti del retroterra.
Stintino. Dire Stintino significa dire La Pe-losa, la spiaggia che si apre vicino aglistretti passaggi tra capo Falcone, l’isola
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Piana e l’Asinara; grazie a questa specialeposizione gode di un’acqua limpidissimache, unita ai colori della sabbia e dellamacchia litoranea, ne fa un luogo di gran-de bellezza, nonostante il premere di in-sediamenti eccessivi.Più a sud, nella zona ex mineraria dell’Ar-gentiera, alcune spiagge, tra le quali PortoPalmas, si aprono tra le rocce di una costaprevalentemente alta.
Alghero. La città ha una sua spiaggia, il Li-do, riparata all’interno della rada e dal-l’acqua discretamente limpida, ma il po-polo dei villeggianti ama disperdersi neinumerosi punti che la costa offre a mag-giore distanza. A nord la sabbia del Lidotrova continuazione in quella di San Gio-vanni, protetta da un boschetto di pini. Ol-tre Fertilia i giovani si concentrano alleBombarde, tanto che non è facile trovarviposto. Altre spiagge si aprono più avanti,soprattutto al fondo dell’insenatura di Por-to Conte. A sud della città la costa si fa al-ta; unica spiaggia, a 8 km seguendo la stra-da per Bosa, è quella della Speranza.
Bosa . La spiaggia di Bosa è a Bosa Marina,il sito balneare sorto nel punto in cui il fiu-me Temo si getta a mare. Ha di fronte unbell’arco sabbioso che gode di un tratto dimare quasi sempre calmo perché ben ri-parato. La sabbia è di colore scuro perchéderivata dal disfacimento di rocce vulca-niche: per questo trattiene il calore del so-le ed è adatta alle sabbiature.
Il Sinis. La penisola del Sinis, a nord-ove-st di Oristano, interessante dal punto di vi-sta archeologico – basti pensare alle rovinedi Tharros – e naturalistico, si affaccia sulmare con alcune belle spiagge: notevolequella di Is Arutas, con arenile formato dagrani di quarzo chiaro.
La Costa Verde. Al termine di questo trat-to di litorale, poco frequentato per la dif-ficile accessibilità a ridosso dell’anticazona mineraria di Montevecchio e Ingur-tosu, è la notevole spiaggia di Piscinas: lacaratterizzano la foce del rio omonimo e lapresenza nel retroterra di dune di sabbiafinissima, parte ricoperte di vegetazioneparte ancora in movimento sotto il consi-stente effetto dei venti.
Il Fluminese e l’Iglesiente. Molto estesa esempre poco frequentata è la spiaggia diPortixeddu, a sud di capo Pecora, tagliatanella parte settentrionale dalle acque del
La Sardegna delle spiagge
191
rio Mannu; ancora più a sud si apre tra i ri-lievi impervi della costa il bell’arenile di Ca-la Domestica, nei pressi del quale restanole strutture usate un tempo per il tra-sporto e l’imbarco dei minerali. Spiagge piuttosto grandi sono ancora piùa sud: tra queste Plag ’e Mesu (spiaggia dimezzo), in territorio di Gonnesa, ampioarenile d’acqua cristallina alternato a qual-che sporgenza rocciosa.
San Pietro e Sant’Antìoco. Le due isolehanno coste generalmente alte e rocciose,con spiagge da scoprire, nascoste e ripa-rate come sono, ma anche diverse a se-conda delle rocce e degli spazi che vi siaprono. A San Pietro si trova, a sud diCarloforte, la spiaggia Bobba, a breve di-stanza dalle celeberrime Colonne; piùgrande, sul versante opposto, la Caletta, alfondo di un’insenatura, ben esposta al so-le e di acqua limpida. A Sant’Antìoco il lido più frequentato èquello di Maladroxia, sulla costa orienta-le, al termine di un anfiteatro dominato daun nuraghe e da un villaggio. Sulla costaoccidentale piccoli suggestivi arenili a Ca-la Lunga e capo Sperone.
Da Teulada a Cagliari. Nel primo tratto diquesto litorale, denominato Costa del Sude percorso da una strada panoramica, siaprono la spiaggia di Teulada, nei pressidella torre Budello, e quella di Porto Tra-matzu, entrambe di sabbia fine e bianca,molto riparate. Lungo il successivo per-corso si incontrano quella di Tuerredda, di-visa da una punta sabbiosa che si spingenell’acqua, e altre due ai lati della torre diChia: a ponente quella di Su Giudeu, a le-vante quella di Chia, un semicerchio per-fetto. L’ampia e rettilinea spiaggia di San-ta Margherita, frequentata soprattutto dacagliaritani, e dotata di numerose strutturericettive, ha anche una bella pineta.
Il Poetto. All’interno del golfo di Cagliari siapre quello minore di Quartu che ha al fon-do, subito a est del caratteristico capoSant’Elia, un vasto arco sabbioso allun-gato tra l’acqua marina e quella di unostagno. Vicina alla città e ai centri circo-stanti, è la spiaggia per eccellenza dei ca-gliaritani, frequentatissima anche comeluogo di ritrovo e divertimento e dotata diservizi di qualsiasi genere.
Villasimìus e Costa Rei. In questa puntasud-orientale dell’isola riprende il dominiodel granito: annunciate da alcune spiagge
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

allineate lungo la strada costiera che par-te da Cagliari, si aprono quelle di Villa-simìus, tutte note e frequentate, valoriz-zate ora dalla creazione di un parco mari-no; a cominciare da quella del Riso, nelgolfo di Carbonara, così detta perché co-stituita da granelli di sabbia leggermentepiù grossi del solito. A breve distanza dalpaese anche quelle di Simìus e Porto Giun-co, mentre quella di Punta Molentis si aprenel sito in cui la costa, fattasi alta, piegaverso nord; si mantiene poi ancora roc-ciosa, dando luogo alle belle spiagge diCala Pira e Cala Sinzias; quindi, tornatabassa, lascia spazio alla lunga striscia disabbia di Costa Rei, molto frequentata perla presenza di villaggi turistici.
Muravera. La spiaggia più nota e fre-quentata del Sàrrabus è quella di San Gio-vanni, poco a sud di Muravera: si disten-de ampia nel tratto di pianura costieracreata dal tratto finale del Flumendosa.Un’altra striscia sabbiosa si stende a nord,mentre a sud si trovano quella delle Saline,ai piedi di una torre costiera; e quella di Co-lostrai, a ridosso di un altro stagno.
Tertenìa. Il territorio di Tertenìa si affacciasul mare con una conca chiusa da una seriedi colline che ne fanno un mondo a parte.Tra le spiagge, che si stendono vicino a nu-raghi, torri costiere e villaggi minerari di-smessi, la maggiore e più frequentata èquella di Foxi Manna.A nord del capo Sferracavallo si stendel’insolita spiaggia di Coccorrocci, tutta diciottoli (i coccorrocci): inpietra scura di origine vul-canica, sono stati levigatidall’azione delle onde. Chipreferisce la sabbia trovapoco a nord le spiagge diSu Sirboni (il cinghiale), a ri-dosso di un promontorioroccioso, e di Marina di Gài-ro, lunga e rettilinea.
L’Ogliastra. Dall’OrientaleSarda si accede facilmentealle belle spiagge di Bari Sar-do: quella dominata dallatorre di Barì e quelle confi-nanti a nord, dette di Cea ede Is Iscoglius Arrubius (gliscogli rossi di porfido cheaffiorano dall’acqua). Si en-tra così nel territorio di Tor-tolì che offre, ancora più anord, il lido di Orrì; segue
Itinerari tematici
192
quello di Lotzorai, nell’arcuata insenaturastesa oltre capo Bellavista.
Cala Luna e le altre. Subito a nord di Lot-zorai ha inizio la massa calcarea dei Su-pramontes, ricoperta di boschi e di desertisassosi, che si affaccia sul mare con una fa-lesia alta e impenetrabile sin oltre Dorga-li. È aperta da una serie di piccole spiaggedifficilmente raggiungibili via terra; in esta-te sono perciò toccate dalle barche per tu-risti che partono da Cala Gonone e daSanta Maria Navarrese. Le più celebri so-no Cala Luna, che ha al fianco alcuni “grot-toni” e nel retro una bellissima distesa dioleandri, Cala Sisine e Cala Mariolu.
Da Marina di Orosei a Siniscola. La costatorna a farsi bassa e sabbiosa a Orosei, do-ve le acque del Cedrino accompagnanoinsieme a una distesa di pini una lunghis-sima striscia di sabbia. Più a nord si apro-no, in una costa nuovamente mossa e altadove torna a comparire il granito, le spiag-ge frequentate dai nuoresi: Cala Liberotto,con alcuni lidi che hanno a ridosso unesteso villaggio di vacanze; Bèrchida, inuna zona di notevole valore naturalistico;Capo Comino, dove le rocce rossastre si al-ternano a tratti di arenile e dune dissemi-nate di ginepri; Santa Lucia e la Caletta, conarchi sabbiosi a ridosso di una pineta.
La costa di Budoni e San Teodoro. Quel-la di Sant’Anna è la spiaggia più ampia e fre-quentata di Budoni: vicinissima al paese,è orlata da una pineta. La spiaggia più no-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

ta di San Teodoro è invece la Cinta; e anchela più frequentata perché vicina al paese:un arco sabbioso di oltre 3 km, dominatoin lontananza dalla massa dell’isola di Ta-volara. Si collega a sud con quella di Calad’Ambra, mentre a nord, a ridosso del ca-po Coda Cavallo, si aprono lu Impostu eBrandinchi, entrambe a semicerchio e dal-le acque cristalline ben riparate.
Tavolara, Molara e dintorni. Nella partesettentrionale del capo Coda Cavallo siaprono diverse spiagge. La più ampia e fre-quentata è quella di Cala Coda Cavallo; lim-pidissime le sue acque, dalle quali si levaa poca distanza l’isoletta Proratora; più ol-tre la massa granitica dell’isola di Molarae quella calcarea di Tavolara.
La Sardegna delle spiagge
193
La costa continua granitica sino a Olbia,dando spazio a numerose spiagge note efrequentate, tra le quali: Porto Taverna,al fondo dell’insenatura omonima; PortoSan Paolo, nei pressi del paese dallo stes-so nome; e Porto Ìstana, magnifico arenileaperto contornato da un fitto villaggio diseconde case.Sull’isola di Tavolara, che si raggiunge coibarconi che partono da Porto San Paolo,alcune spiagge si trovano lungo lo Spal-matore di Terra, che si protende verso laSardegna. Per raggiungere Molara biso-gna invece disporre di barca propria: trale rocce che digradano sul mare, dissemi-nate di arbusti e olivastri, si aprono le ca-le Spagnola e, nei pressi di una distesa dirovine medievali, di Chiesa.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
La Sardegna delle montagne (carta a pag. 189)
I viaggiatori che arrivano dalla Corsica – che è una vera e propria “montagna in mezzoal mare” – e dal Nord Italia finiscono presto per rendersi conto che, per quanto le alti-tudini non siano notevoli, i rilievi della Sardegna (e alle volte neppure i maggiori) svol-gono le stesse funzioni che i monti rivestono in giro per il mondo: di cesura tra una re-gione e l’altra, in primo luogo, ma poi anche di riserva di materie prime come il legnoe l’acqua, e ancora di polmoni verdi e, a seconda dei periodi e delle circostanze, di ri-fugio per i ribelli all’autorità costituita.Il Limbara, ad esempio, dal quale ha inizio questo ‘giro’ tematico nell’orografia sarda,ha svolto un ruolo essenziale nel delimitare lo spopolamento, tra medioevo ed età mo-derna, della regione a nord; e poi, al momento del ripopolamento, nel fermare i coloniche arrivavano dalla Corsica: quasi una barriera tra modi di vita e di lavoro, etnie e lin-gue diversi. Il ‘giro’ non è, né vuol essere, un inventario dei sistemi montuosi della Sar-degna. È piuttosto un excursus che, segnalando i caratteri, le peculiarità e i modi per lavisita dei più significativi di questi sistemi, intende soprattutto ricordare come le bel-lezze naturalistiche e il grande fascino ambientale della seconda isola del Mediterraneonon risiedano soltanto nella sua pur affascinante fascia costiera.
Il LimbaraAnche se supera di poco i 1300 m, il mon-te che chiude a sud la Gallura appare im-ponente, specie se visto dalle pendici me-ridionali, che appartengono a Òschiri eBerchidda; più accessibile è nel versanteopposto, perché i centri di Tempio Pau-sania e Calangiànus giacciono su un alto-piano che ne è propaggine.L’asprezza del suo profilo e di parte dei ver-santi è dovuta alla natura delle rocce: tut-ti graniti che, per quanto lavorati per mil-lenni dagli agenti atmosferici, hanno as-sunto solo in parte profili morbidi e arro-tondati; per il resto le trasformazioni han-no accentuato l’inasprirsi delle forme, si-no a dar luogo ai profili bizzarri e fantasiosiche sono la gioia del visitatore. La monta-gna occupa un’area di 270 km2, delimitatapiù nettamente nella parte meridionaledal solco vallivo percorso dalla super-
strada Sassari-Olbia, mentre a ovest la se-parazione è segnata dal fiume Coghìnas. Nella parte bassa i versanti ospitano am-pi sughereti che contribuiscono non pocoall’economia locale: Calangiànus è la ca-pitale italiana dell’industria del sughero; aquesta altitudine compare anche il leccioche poi, nelle vallate, occupa le altitudinisuperiori, insieme a macchie di fillirea ebiancospino, viburno e corbezzolo.In alcune delle parti alte denudate dal di-sboscamento e dagli incendi sono state im-piantate migliaia di pini, a volte associatia lecci ma in ogni caso destinati a conso-lidare le superfici e a favorire il ritorno del-la vegetazione spontanea. Allo stesso modo sono stati reintrodotti,nella foresta demaniale a monte di Ber-chidda, i daini e i mufloni – ormai scom-parsi da anni – con l’intento, una volta ri-stabilite le giuste condizioni ecologiche, di

lasciarli liberi sulle pendici del monte. Trale specie animali che sono riuscite a so-pravvivere sono numerosi i cinghiali, i co-nigli e le lepri, né mancano martore, riccie donnole; tra i volatili i gheppi, gli spar-vieri e le poiane, e sembra che stia ri-prendendo a nidificare l’aquila.Le fontane che scaturiscono in tutti i ver-santi sono famose per la bontà delle ac-que. La più frequentata è quella di Fundudi Monti, che sgorga da cinque bocche aimargini della strada Tempio-Òschiri.
I percorsi. Il Limbara è tagliato da nu-merose strade che, partendo da Calan-giànus, da Berchidda e dalla strada Tem-pio-Òschiri giungono a Vallicciola, a 1053m di altitudine. Il più agevole dei percor-si è l’ultimo, tutto asfaltato. Dalla caser-ma della Forestale un sentiero conduce
nella valletta scavata dal rio Pisciaroni.Una volta che lo si raggiunge bisogna at-traversarlo e risalirlo lungo la riva de-stra, mentre la valle si apre di tanto in tan-to offrendo visioni delle zone sottostan-ti, sino a Tempio. L’acqua scorre tra for-mazioni di granito, alternando cascatellea laghetti. Di tanto in tanto qualche per-corso laterale consente di inoltrarsi tra lavegetazione circostante, ricca di lecci esugheri, agrifogli e filliree.Una volta ripreso il percorso lungo l’a-sfalto e guadagnato l’ameno pianoro diVallicciola si potrà raggiungere la punta Ba-listreri (m 1359), la maggiore del massiccio,o inoltrarsi nei percorsi che dagli altriversanti convergono in questo punto.
Itinerari tematici
194
Dai monti di Alà al monte FerruLa Sardegna non ha una vera e propria ca-tena di monti. La formazione che più vi siavvicina è questo allineamento da nord-esta sud-ovest di altipiani e massicci di naturadiversa, che nelle parti maggiori superanodi poco i 1000 m; ma l’effetto di cesuraesercitato sul territorio è superiore a quel-lo che ci si aspetterebbe: nella sua partemeridionale questa ‘sequenza’ di alturesegna il confine tra i Campidani e il Logu-doro, ovvero tra il Capo di Sotto e quellodi Sopra della Sardegna. A nord ha inizio con i monti di Alà. Più chedi monti si tratta in realtà, come nei territoripiù meridionali di Buddusò e di Bitti, di al-tipiani che oscillano dai 500 agli 800 m e daiquali emergono di tanto in tanto delle cre-ste che superano di poco i 1000: il rilievomaggiore nei pressi di Alà dei Sardi è la pun-
ta Senalonga (m 1076), men-tre a sud-ovest si leva ilmonte Lerno (m 1094). Lanatura del territorio è tuttagranitica, le superfici sonoin parte ricoperte di boschi– soprattutto lecci e sughe-ri – e macchia, in parte de-nudate a causa dello sfrut-tamento antropico e degliincendi. Alle falde della Se-nalonga ha origine il rio Po-sada, mentre sull’altopianodi Buddusò si trova la sor-gente del Tirso, il fiumemaggiore dell’isola.Seguono, sempre in dire-zione sud-ovest e parallelial corso del Tirso, i montidel Gocèano, lungo i quali ilgranito lascia spazio agliscisti e alle trachiti; il pa-trimonio boschivo com-
prende sugheri e roverelle ma anche tas-si, agrifogli e, tra le specie di nuova intro-duzione, i castagni (fa capo ai comuni diBultei, Anela, Bono); a Burgos appartieneil compendio di Foresta di Burgos, utiliz-zato anche per l’allevamento dei cavallidella varietà anglo-arabo-sarda. Qui lapunta maggiore è il monte Rasu (m 1259),subito sopra Bono. Analoga la conformazione dei monti delMàrghine, che si raccordano a nord conl’altopiano di Campeda e hanno la puntapiù elevata nel monte Santo Padre (m 1026).Dal punto di vista botanico ha interesse lazona di Badde Sàlighes, agro di Bolòtana,dove Benjamin Piercy, ingegnere inglesecostruttore delle ferrovie sarde, eresse
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

una villa e introdusse poi varietà pregiate. Il monte Ferru occupa la sede del vulcanoche ha dato origine ai tavolati basaltici ver-so Abbasanta e intorno a Bosa. Anche quile parti alte (punta maggiore il monte Urtigum 1050), prive di vegetazione, vengonosottoposte a vasti lavori di forestazione.Sono stati reintrodotti il grifone e il mu-flone, per il resto la fauna annovera le va-rietà presenti in tutta la catena: dominanoi cinghiali, le volpi e le lepri, i falchi, glisparvieri, le poiane, i picchi e i merli.
I percorsi. Per raggiungere la punta Se-nalonga si imbocca da Alà dei Sardi lastrada per la chiesa campestre di SanFrancesco. La si segue in direzione nord,man mano che sale, e si parcheggia ai pie-di del roccione Madonna della Neve; sicontinua verso nord-est, salendo tra un al-ternarsi di graniti e di macchie di lentisco,erica e corbezzolo; si lascia sulla sinistrala punta Giammaria Cocco (m 1036) e siraggiunge facilmente la mèta, che offreun’ampia vista sulla regione. Scendendosul versante sud si può visitare il com-plesso nuragico di Sos Nurattòlos.Anche il monte Rasu offre una mèta che èallo stesso tempo naturalistica e religiosa.Quando dalla piana di Torralba si procedeverso il passo Uccàidu, che immette nelladiscesa su Bono, si trova sulla destra, incorrispondenza di una valletta, la devia-zione che, procedendo sul fianco del mon-te, conduce alla fattoria Giannasi (m 935),nella quale è inglobato il convento france-scano fondato dal beato Giovanni Parentinel Duecento. La strada di accesso offre va-sti scorci panoramici.
Il monte AlboÈ un bastione calcareo lungo una ventinadi chilometri, orientato da nord-est a sud-ovest; da un lato guarda verso l’altopianodi Buddusò, dall’altro si affaccia con mol-ta maggiore imponenza sulla regione co-stiera attraversata dal Cedrino, la Baronìa;qui ha ai piedi la superstrada Nùoro-Olbia,all’altro versante una secondaria che, cor-rendo vicina alle vette, unisce i centri po-sti ai suoi due estremi, Lula e Siniscola.Si conservano nelle pendici, soprattutto amonte Creia – dove si stende una forestademaniale – tratti delle leccete origina-rie; nelle parti alte si alternano punte roc-ciose, pietraie, tratti a macchia e zone dirimboschimento. La fauna comprende cin-ghiali, mufloni e numerosi rapaci. Le cimemaggiori, Catirina e Turuddò, sono en-trambe nella parte meridionale (m 1127).
La Sardegna delle montagne
195
I percorsi. Per raggiungere le due cime bi-sogna toccare Lula e continuare per lachiesa di Nostra Signora del Miracolo; siprosegue ancora per 2 km, sino a un’areadi parcheggio dove un segnale blu su unmasso indica l’inizio del sentiero. Si pro-cede in un bosco di lecci misti a corbezzolie ginepri e si raggiunge in breve la cresta:le due cime Turuddò e Catirina sorgono abreve distanza, una a destra e una a sini-stra, ma si può anche continuare sul sen-tiero che, tagliando il fianco opposto, offrebellissime vedute della Baronìa.
Il GennargentuIl Gennargentu è veramente, come ha scrit-to Alberto La Marmora – al quale è dedi-cata la punta più alta, m 1834 – il «sardo co-losso»: non tanto per l’altitudine quantoper l’estensione, con propaggini – dallequali distinguiamo qui di seguito i Supra-montes – che arrivano sin quasi a Nùoro anord, alla vallata del Flumendosa a sud;mentre in direzione est-ovest vanno dalTirreno al Tirso. Si aggiunga la presenza dipareti erte e fratture profonde e si spiegaancora meglio il significato antropologicoe storico di questo territorio, tradizionalerifugio delle popolazioni che si volevanosottrarre alla minaccia delle invasioni e perquesto punteggiato dai paesi maggior-mente ‘conservativi’ della civiltà sardaoriginaria. Le strade che li collegano sonosul lato orientale la statale 389 che unisceNùoro all’Ogliastra, a ovest la tortuosa295 che conduce da nord verso il Sarci-dano e a sud la 198 Sarcidano-Ogliastra.La natura delle rocce è mista di filladi,marmi e micascisti, ma nelle parti perife-riche compaiono i calcari, specie quelliestesi dei Supramontes, e i graniti. Alle fal-de meridionali ha origine il Flumendosa,mentre da quelle occidentali nascono idue maggiori affluenti del Tirso, il Taloroe il Mannu; sul Taloro e sul Flumendosa èstata creata una serie di invasi per l’irri-gazione e l’approvvigionamento idricodelle popolazioni a valle. Tra le numerosesorgenti è da citare almeno quella di Don-nortei, tra Fonni e il monte Spada, moltofrequentata per i pregi della sua acquaoligominerale.La vegetazione comprende grandi distesedi lecci ma anche roverelle, tassi e agrifo-gli; castagneti e noccioleti nei pressi dei vil-laggi hanno un ruolo nell’economia loca-le. Trovano largo spazio i pascoli: il Gen-nargentu è il “cuore pastorale” della Sar-degna. La fauna annovera il muflone e la le-pre, il cinghiale e la volpe, mentre nelle zo-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

ne più alte nidificano l’aquila reale, il grifo-ne e altri rapaci.Non meno interessante l’ambiente umanodi questa parte della Sardegna: nel corsodelle escursioni si trovano anche numerosinuraghi e, di tanto in tanto, le capanne deipastori, costruite da secoli con muretti asecco e coperture di rami e strame. Alle fal-de del Bruncu Spina, cui si accede da Fon-ni, entra in funzione in tempo di neve l’u-nico impianto di risalita dell’isola.
Lungo la cresta. Una delle escursioni me-no faticose verso la vetta del Gennargen-tu inizia dalla stazione sciistica sul BruncuSpina, che si raggiunge in auto da Fonni.Dalla sciovia si prende verso destra e si sa-le muovendosi a serpentina sul fianco del
monte, sino alla cresta, a 1740 m; la si se-gue poi sino alla vetta del Bruncu Spina (m1829), quindi le punte Paulinu e Su Sciusciue infine la maggiore, intitolata al La Mar-mora (2 ore e mezza dal parcheggio).Possibilità di incontrare branchi di muflonie grandiosa vista panoramica a 360 gradisu ogni parte dell’isola, sino al mare.
I SupramontesPer Supramontes si intende un altopianocalcareo che si erge a delimitare, con altefalesie, il golfo di Orosei e si spinge poi al-l’interno fino a confinare col massicciodel Gennargentu. Si distinguono i Supra-montes di Baunei, di Urzulei, di Dorgali, diOliena e di Orgòsolo ma l’area, che siestende per circa 500 km2, ha caratteri-stiche omogenee.In primo luogo la natura del suolo, calcarie dolomie del Giurassico che nel tempo sisono aperti e frammentati, facendo spa-zio a fratture, vallate incassate dette “co-
Itinerari tematici
196
dule” (che arrivando al mare danno luogoa spiagge di straordinaria bellezza) e corsid’acqua sotterranei, con fenomeni carsicitra i quali alcune grandi risorgive (celebrefra tutte Su Gologone, in territorio di Oliena)e numerose grotte, tra le quali quella delBue Marino, aperta sul mare, e quella apozzo di Ispinigoli, presso Dorgali; da grot-te crollate derivano il grande avvallamentodi Su Suercone, in agro di Orgòsolo, e la do-lina di Tìscali, che ospita un villaggio nu-ragico al confine tra Oliena e Dorgali.L’altitudine della parte sommitale variadai 500 agli 800 m, solo qualche puntatocca i 1000; la vegetazione e la fauna so-no abbondanti nei versanti e nei tratti val-livi mentre le parti alte sono pietraie de-sertiche, veri paesaggi lunari.
Su Gorropu. Scorrendo all’interno della co-sta tra Dorgali e Baunei, il rio Fluminedduha scavato questa profondissima spacca-tura tra i monti Oddeu e Cucuttos. Per ve-derla bisogna scendere dalla statale 125nella vallata e raggiungere il corso d’acquaal ponte Sa Barva, dove si parcheggia. Daqui ha inizio un sentiero agevole che inun’ora e mezza conduce in vista dell’orri-do. Con molta prudenza ci si può inoltraretra rocce e oleandri fino a un laghetto.
Il LinasTra i monti della Sardegna il Linas è quel-lo che si leva più erto e imponente, ancheperché a nord e a est ha la pianura cam-pidanese, mentre a sud corre la vallatadel Cixerri. Di natura granitica nella partecentrale, è circondato da una regione discisti, né mancano i calcari: tutti terreni neiquali, specie sul versante occidentale, so-no state aperte nei secoli numerose mi-niere, ora tutte abbandonate. La punta
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

maggiore, Perda de Sa Mesa (m 1236), sor-ge a ridosso di Gonnosfanàdiga, ma le suepropaggini si estendono a est, sino a do-minare Villacidro; a nord, nelle regioni mi-nerarie di Àrbus e Gùspini; a ovest, nei ter-ritori di Fluminimaggiore; e a sud, in quel-li di Iglesias e Domusnovas.Il bosco, che si alterna alla macchia e atratti sassosi, è soprattutto di lecci, men-tre la fauna annovera anche qui cinghiali,volpi e lepri e specie pregiate di rapaci,quali l’aquila e il falco pellegrino.Tra i luoghi interessanti il vasto parco co-munale Perda de Pibera a Gonnosfanàdiga;la grotta di S. Giovanni, presso Domusno-vas, una delle poche al mondo attraver-sate da una strada; e le cascate: più fa-mosa la Spèndula, presso Villacidro, mavale la pena di raggiungere quella sul rioMuru Mannu, la maggiore dell’isola, conun salto di 70 metri.
Alla cascata del Muru Mannu. Da Villaci-dro si raggiunge e oltrepassa la caserma fo-restale di Montimannu sino a parcheggia-re presso la Cantina Ferraris. Da qui si se-gue il percorso segnato col numero 109: siaffronta un dislivello moderato e si attra-versano belle distese di lecci; in due ore emezza, superati alcuni guadi, si giunge al-la conca dove precipita l’acqua, circondatada alte pareti; ai piedi un laghetto delimi-tato da lecci e agrifogli.
I monti del SulcisSono una variegata distesa di rilievi – col-linari più che montani, a stare alle altitudini– che occupano quasi tutta la sporgenzasud-ovest dell’isola a sud della valle delCixerri. Un’area molto vasta la cui naturageologica – mista di graniti e arenarie, sci-sti e calcari – ha favorito in passato losfruttamento minerario, oggi quasi com-pletamente cessato. Le parti più elevateculminano con le punte Is Caravius (m
197
1116) e Maxia (m 1017). La fascia meri-dionale è ricoperta dalla più vasta forestaisolana: formata principalmente da lecci,cui si alterna la macchia di lentisco e cor-bezzolo, si estende per circa 350 km2.La parte meglio protetta e attrezzata per lavisita è la Riserva di Monte Arcosu, costi-tuita nel 1985 dal WWF Italia: occupa 3600ettari a ovest di Cagliari e ha come scopoprincipale la salvaguardia del cervo sardo.
Dentro la Riserva. Una delle passeggiatepiù agevoli all’interno della Riserva di Mon-te Arcosu è quella che in un’ora circa con-duce dall’ingresso alla Rocca Lada. Perraggiungere l’area protetta bisogna pas-sare per la chiesa campestre di Santa Lucia,cui si arriva dalla zona industriale di Mac-chiareddu o da Capoterra, e continuareseguendo i segnali. Una volta arrivati siinizia il percorso lungo il sentiero A4 checosteggia il rio Sa Canna. Sui lati le roccegranitiche che delimitano la valle, dallequali si levano numerosi i rapaci, mentre iversanti sono ricoperti, così come le rivedel corso d’acqua, da una densa vegeta-zione. Con un po’ di fortuna, e procedendocon cautela, si può vedere qualche cervo.
Il Sette FratelliIl monte Sette Fratelli – così chiamato per-ché culmina in una cresta che annoverasette e più punte (la maggiore di 1023 m)– è la parte più interessante dei rilievi del-l’isola a sud del Flumendosa; ne costitui-sce la parte più meridionale, separata dal-la restante dalla vallata dei rii Cannas e Pi-cocca, percorsa da un tratto pittorescodell’Orientale Sarda. Un territorio quasitutto granitico, ricoperto nelle parti più al-te da fitte formazioni di bosco e macchiadominate dal leccio.Anche qui, come nei monti del Sulcis, lapresenza di maggior rilievo dal punto di vi-sta faunistico è quella del cervo sardo (sene calcolano oltre 200 esemplari), tantoche la caserma della Forestale UmbertoNoci ospita, nei pressi del passo Arcu ’e Ti-du lungo l’Orientale, un museo che ne rac-coglie reperti e memorie.
Verso la cima. Dalla caserma Noci ci sispinge lungo il corso del rio Maidopis, ric-co di cascatelle, che si risale sul versantesinistro: una densa vegetazione cresce sul-le rive e nell’area circostante. Dopo un’orae mezza si raggiunge il punto dominantedal quale si vede la serie di rilievi che dà ilnome al Sette Fratelli, compreso il mag-giore, punta Sa Ceraxa (m 1023).
La Sardegna delle montagne
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

La grande stagione del romanico
198
Sono due i periodi della storia sarda chehanno prodotto le architetture più originalidell’isola: da una parte la lunga età nura-gica, che ha disseminato delle sue 7 milatorri il paesaggio sardo, dall’altra il perio-do ‘giudicale’, che ha visto sorgere nell’i-sola le grandi chiese romaniche. Il periodo‘giudicale’ è chiamato così perché nell’ar-co temporale compreso fra l’anno Mille el’inizio del Trecento la Sardegna, ormaiseparata dal lontano potere di Bisanzio, sitrovò divisa in quattro territori sostan-zialmente autonomi (se non addiritturaindipendenti) rispetto a forme di domi-nio esterne, governata da signori che ve-nivano indicati col nome di iudikes.Sebbene in rapporto con potentati ‘con-tinentali’, in par-
ticolare con le repubbliche di Pisa e di Ge-nova (soprattutto a partire dal 1016, quan-do le due potenze marinare armarono unaflotta che allontanò dall’isola la minacciadell’invasione araba), e variamente legati,attraverso matrimoni e alleanze, con in-fluenti famiglie della Penisola, i ‘giudici’appaiono, lungo questi tre secoli, come i ca-pi di quattro dinastie capaci di ammini-strare l’intero territorio isolano. Proprio adessi, del resto, si dovette l’imponente af-flusso nell’isola di ordini religiosi impor-tanti e attivi, che si insediarono in diversiluoghi della Sardegna e nelle terre loroconcesse costruirono alcune delle più bel-le chiese medievali della Sardegna.Qualcuna si trova all’interno delle cittàmaggiori o in centri periferici: come quel-la sorta di capostipite dei monumenti ro-manici del nord dell’isola che è la grandebasilica di S. Gavino di Porto Torres, ca-
ratteristica non soltanto per l’imponenzadelle dimensioni ma anche per il fatto dinon avere una fronte bensì due absidicontrapposte: all’interno colonne e capi-telli provengono in gran parte dalla cittàromana di Turris Libisonis, e nella suacripta sono venerati i tre martiri turritani(Gavino, Proto e Gianuario), patroni nonsolo di Turris ma anche di Sassari, sua“figlia”; oppure S. Simplicio di Olbia, nelnord-est, dalla facciata in cui è leggibilel’accostamento di motivi lombardi a formepiù proprie dell’architettura pisana. Ma l’impronta maggiore al paesaggio èquella data da una serie di chiese co-
struite nelle campagne dove monacicoraggiosi, in particolare i Bene-
dettini di Montecassino e di Ca-maldoli, pregavano, bonifica-vano le terre tutt’intorno, am-ministravano poderi e servi,diffondevano elementi es-senziali di cultura. Alte sullospazio circostante, immersenel silenzio di spazi ormaispopolati, sono queste checolpiscono maggiormente ilvisitatore. Alcune di loro, delresto, sono fra gli esemplaripiù belli del romanico isolano.Nel nord-ovest dell’isola cin-que di questi capolavori sor-gono a pochi chilometri di di-stanza uno dall’altro, sicchéè possibile visitarli nel brevegiro di qualche ora. Si può
partire dalla basilica della SS. Trinità diSaccargia, che sorge a breve distanza daSassari. Costruita forse in due tempi damaestranze pisane prima tra la fine delsec. XI e il 1116, quindi a qualche decenniodi distanza a fianco di un preesistente con-vento di Camaldolesi, colpisce per l’armo-nia con cui si alternano, tanto sul corpoprincipale quanto nel campanile e quantoinfine nel portico anteriore, fasce di bian-chissime pietre calcaree e di scuri massi ba-saltici. Gli studiosi avvertono che la basili-ca, così come la vediamo oggi, è soprattuttoil frutto di un drastico restauro compiutotra la fine dell’Ottocento e i primi anni delNovecento: ma il visitatore resta affascinatodall’armonia dell’intera struttura, sottoli-neata proprio dalla doppia geometria deicolori. Nel severo interno è conservato unciclo di affreschi che è l’unico giunto inte-ro a noi dal medioevo romanico sardo.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

199
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Proseguendo in direzione di Olbia (e quin-di di S. Simplicio), si sfiora l’abside di S. Mi-chele di Salvènero, che i Vallombrosaniedificarono all’inizio del XII secolo, e sipuò quindi prendere a destra per Àrdara:qui la chiesa di S. Maria del Regno sorgeai bordi dell’abitato, che fu sede dei ‘giu-dici’ di Torres. E infatti la chiesa era, in ori-gine, la cappella palatina dei ‘giudici’: co-struita tutta in scura trachite, fu eretta pervolontà di Georgia, sorella di Gonnario-Comita ‘giudice’ di Torres e di Arborèa, econsacrata nel 1107. Al suo interno si tro-va uno dei più bei retabli dell’isola, una
grande tavola d’altare dipinta verso gliinizi del Cinquecento.Più avanti, sulla sinistra della statale 597,si ammira un altro capolavoro dell’archi-tettura romanica in Sardegna, S. Antiocodi Bisarcio, a lungo cattedrale di una dio-cesi poi trasferita a Ozieri. S. Antioco fu co-struito già prima del Mille, quando la chie-sa venne danneggiata da un grande in-cendio: la sua ricostruzione sarebbe stataprogettata secondo modi strutturali e de-corativi di ascendenza pisana, ma media-ti dall’esperienza ‘lombarda’ degli altrigrandi cantieri sardi (ad esempio, quellodi S. Giusta presso Oristano). Non molto distante da Àrdara, in territoriodi Borutta, sorge il quinto di questo grup-po di monumenti del romanico isolano, labasilica di S. Pietro di Sorres, anch’essa,come S. Antioco, a lungo sede della dioce-si omonima. Edificata in due tempi, primaverso la fine dell’XI secolo e poi verso la fi-ne del XII, ha alla base file di conci di bion-do calcare, mentre nella parte superiore ri-pete la suggestiva dicromia della Trinità diSaccargia. Alla basilica è stato aggiunto unconvento dove i Benedettini hanno oraattivato un importante laboratorio di re-stauro del libro. Alta su uno spuntone iso-lato di roccia calcarea, S. Pietro di Sorreschiude la serie delle grandi testimonianze
Itinerari tematici
200
romaniche nel nord dell’isola, alle quali an-drebbero tuttavia aggiunti almeno dueesemplari dell’architettura civile: il ca-stello di Burgos, nel Gocèano, edificatonella prima metà del XII secolo, e il castel-lo di Serravalle a Bosa, iniziato nello stes-so periodo ad opera dei Malaspina.Anche l’area centro-occidentale sarda,quella dell’antico giudicato di Arborèa,ha belle chiese romaniche. Fra queste si-curamente interessante è la piccola chie-sa di S. Pietro di Zuri, a pochi chilometrida Ghilarza. La chiesa, tutta in una trachi-te rosa che si accende di luce al tramonto,fu costruita intorno al 1291; conosciamo ilnome del committente, il ‘giudice’ d’Ar-borèa Mariano II, e conosciamo anche ilnome dell’architetto, un Anselmo da Co-mo, ormai «proiettato verso il gotico –scrive Roberto Coroneo (autore del volu-me Architettura romanica dalla metà delMille al primo ’300, dal quale sono trattenon poche indicazioni di questo brano) –eppure sensibile ai suggerimenti della tra-dizione romanica». La chiesetta sorgeva inuna sede diversa da quella attuale: fra il1923 e il 1925, quando si realizzò il grandeinvaso del lago Omodeo sul Tirso, fu smon-tata pietra su pietra e ricostruita a monte.Di interesse anche maggiore è, in prossi-mità di Oristano, la cattedrale di S. Giusta,magnifica chiesa ‘pisano-lombardo-sarda’edificata nella prima metà del XII secolo. Il sud dell’isola vanta anch’esso numero-si monumenti: ma qui le chiese sono in ge-nere di più modeste dimensioni – salvo im-ponenti eccezioni come la Cattedrale diIglesias, fatta edificare dal conte Ugolino,e quella di S. Pantaleo a Dolianova, co-struita fra il 1150 e il 1290 – e si trovano perlo più all’interno degli abitati. Eppure èproprio questa duplice caratteristica chele rende affascinanti: perché il visitatore re-sta sempre sorpreso di trovare, nel peri-metro di questi villaggi contadini, autenticigioielli di un’architettura per molti aspet-ti raffinata. Varrà la pena di indicare, comeesemplificazioni di questo discorso: S.Maria di Monserrato a Tratalìas, del 1213;S. Platano a Villa Speciosa, dovuta ai Vit-torini di Marsiglia che la eressero attornoal 1144; S. Maria di Uta, pure edificatadai Vittorini e di poco precedente; S. Ma-ria di Sibiola a Serdiana, sempre dellaprima metà del XII secolo.Il libro di Coroneo, che abbiamo citato, in-dica in 169 le chiese romaniche isolane, cuiaggiunge 9 castelli: tra questi, il castello diS. Michele, eretto dai pisani, nel XIII seco-lo, a dominio della città di Cagliari.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Sino a qualche decennio fa era ancorapossibile vedere, in Sardegna, il “costumesardo”. Cioè tipi di abbigliamento che,originatisi attraverso i secoli, si eranoconservati (e in parte evoluti) lungo ilcorso della vita sull’isola. Più di duemilaanni fa Cicerone chiamò i sardi mastruca-ti latrones, predoni (ribelli a Roma, natu-ralmente) vestiti della mastruca: un cap-potto di pelle di pecora o di capra senzamaniche, che i pastori portano anche og-gi, ora col vello di lana all’esterno, ora – ea seconda della stagione – all’interno. Lamastruca, che si può ancora vedere inqualche area interna, è così il più antico in-dumento sardo e insieme quello che hameglio resistito nei secoli.Ma per costume sardo si intende, in ge-nere, l’abbigliamento tradizionale: speciequello femminile e specie quello festivo.Ogni paese, in Sardegna, ha (aveva) il suocostume: anzi, i suoi costumi, perché le di-verse evenienze della vita (il matrimonio,la vedovanza) erano significate anche at-traverso questo o quel particolare tipo diabbigliamento. Il costume è scomparso dall’uso quoti-diano dei sardi nell’ultimo dopoguerra:fino agli anni sessanta era ancora possi-bile, per esempio, vedere a Dèsulo lostraordinario costume tutto giocato sucolori forti e brillanti (il giallo, il rossoscarlatto, l’azzurro). La pittura sarda delprimo Novecento ha immortalato questomondo più di quanto non abbiano fatto fo-
tografi ed etnografi.Oggi, le feste – di cui èricco l’anno isolano,in ispecie tra la pri-
201
mavera e l’estate – sono forse le occasio-ni migliori per vedere vivere quelle testi-monianze del folclore che diversamente bi-sognerebbe andare a cogliere in momen-ti speciali della vita dei piccoli centri, op-pure passare in rassegna in musei etno-grafici (come, in particolare, il documen-tatissimo Museo della Vita e delle Tradi-zioni popolari sarde, a Nùoro).In Sardegna ci sono feste popolari quasitutto l’anno: quasi tutte (ma non tutte) dicarattere religioso. Fra queste hanno fini-to per acquistare particolare risonanzaalcune manifestazioni cui più che ad altreè stato affidato il compito di rappresentare(anche agli occhi del turista o del visita-tore) la civiltà isolana. Sono una per cia-scuna delle quattro province isolane: laSartiglia a Oristano, la Sagra di Sant’Efisioa Cagliari, la Cavalcata sarda a Sassari, laFesta del Redentore a Nùoro.La prima, la Sartiglia, è una festa equestreche si celebra a Carnevale, con protago-nisti mascherati e cavalieri in costumesardo; ricollegata, forse, ad antichi ritipropiziatori di primavera, s’iscrive nellacategoria delle “corse all’anello” che il fol-clore conosce in tante altre regioni d’Italia.La cagliaritana Sagra di Sant’Efisio, il 1°maggio, e la nuorese Festa del Redentore,alla fine d’agosto, sono processioni reli-giose di antica tradizione, cui partecipanofedeli di centinaia di paesi dell’isola con icostumi tradizionali.Un’autentica sagra del costume è la Ca-valcata sarda di Sassari, la penultima do-menica di maggio: invenzione turisticanata nel 1951, è una corale rassegna digruppi di giovani, donne, vecchi a cavallo(ma anche su carri o, più ancora, a piedi)che indossano per l’occasione gli antichicostumi da festa, religiosamente conser-vati nelle cassepanche per il resto del-l’anno. Una festa ‘laica’, cui le migliaia dipartecipanti vanno però come a un ap-puntamento che consolida e insieme ce-lebra la civiltà regionale.Ma se si dovesse indicare la festa rimastapiù fedele alle proprie origini, e nella qua-le è possibile vedere più ‘da vicino’ l’animaregionale, sicuramente si dovrebbe direl’Àrdia di San Costantino, a Sèdilo. Collo-cato quasi al centro geografico della Sar-degna, sulle sponde del lago Omodeo, ilsantuario di San Costantino (dedicato al-l’imperatore che non è riconosciuto comesanto dalla Chiesa romana, ma fu varia-
Costumi e manifestazioni tradizionali
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

202
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

mente venerato come tale in quella bizan-tina) è il luogo sacro cui più s’appunta la de-vozione popolare dei sardi. Qui il 6-7 luglioil ‘santo’ è celebrato con una cavalcata(àrdia significherebbe guardia,e la festa – incentrata sullasfida, spesso violenta, fradue gruppi di cavalieri –vorrebbe ricordare la bat-taglia di Ponte Milvio, 313d.C., che segnò l’avventodella libertà religiosa per icristiani nel mondo roma-no) impressionante per l’a-gonismo dei contendenti, lagrande folla di spettatori, il pae-saggio in cui si svolge.In realtà ogni mese ha, in Sarde-gna, le sue feste. Salvatore Pirisinune ha messo a punto e pubblicato unsintetico ma esaustivoelenco significativa-mente intitolato Mille e più feste (Super-star/Edes, Sassari, 1999).Ogni mese la sua festa, ripetiamo. Sant’An-tonio Abate, conosciuto nell’isola comeSant’Antonio del fuoco, è festeggiato lanotte fra il 16 e il 17 gennaio con grandifalò, che in certi paesi specie della Sarde-gna centrale presentano particolare sug-gestione e spettacolarità.Febbraio è il mese dei grandi Carnevali.Da quello di Oristano a quelli pastorali diFonni, di Mamoiada (dove sfilano i famo-si mamuthones), Orotelli e Ottana (tutti inBarbàgia) e quello, ricco di risonanze pa-gane e di erotica malizia, di Bosa. Molto co-nosciuto è il Carnevale di Tempio, concortei di carri al modo di Viareggio.A marzo-aprile le cerimonie della Setti-mana Santa acquistano forma e forza divere e proprie sacre rappresentazioni nel-le cerimonie dette de S’Iscravamentu (let-
Costumi e manifestazioni tradizionali
203
teralmente, lo schiodamento, cioè il di-scendimento dalla Croce, il Venerdì Santo)e de S’Incontru (l’incontro fra la Madonna
e il Cristo risorto, la mattina del giornodi Pasqua). Processioni e ceri-
monie di particolare sugge-stività si svolgono ad Al-ghero, Cagliari, Castelsar-do, Galtellì, Iglesias, Nulvi,Oliena, Orosei, Santu Lus-surgiu, Sassari, Teulada.Maggio è il mese più ricco difeste: non solo per i due
grandi appuntamenti di Ca-gliari e di Sassari, ma anche
perché è in questo periodo cheiniziano, un po’ in tutta l’isola, le
animate feste intorno ai santuaricampestri. Alcune di queste dura-
no più giorni, e si svolgono pressoantiche chiese circonda-te da porticati e minu-
scole casette dette cumbessìas, edificateapposta per ospitare i pellegrini nei gior-ni della festa. La più importante festa pa-storale dell’isola si celebra a S. Francescodi Lula, dal 1° al 9 maggio (un’altra, sug-gestiva per il paesaggio solitario, pressol’Annunziata di Bitti, terza domenica delmese).A giugno la festa più importante è quella diS. Giovanni Battista (24 giugno): alla vigiliasi accendono un po’ dappertutto grandifalò, attraverso i quali i giovani saltano perdiventare “compari e comari”. A Fonni vie-ne portato in processione un grosso paneappositamente preparato, su cohone ’e fro-res (la focaccia fiorita).Luglio è il mese dell’Àrdia di Sèdilo; un’al-tra àrdia si corre negli stessi giorni a Poz-zomaggiore. Numerose le feste in onoredella Vergine.In agosto le feste più importanti sono
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Un’isola di specialità enogastronomiche
C’è una intelligente campagna pubblicita-ria promossa dalla Regione sarda (in par-ticolare da parte dell’Assessorato all’Agri-coltura) che dice molto energicamente:“Alimenti sardi, buoni per natura”. Non è solo un’invenzione pubblicitaria.Lo sviluppo dell’attività turistica ha mol-tiplicato in Sardegna le strutture ricettivee i luoghi della ristorazione. I calcoli uffi-ciali parlano di oltre 8 milioni di presenzesecondo i dati più recenti (6 milioni e 400mila di italiani, 1 milione 700 mila di stra-nieri); i dati ufficiosi – perché i primi ri-guardano soltanto gli esercizi ricettivi uf-ficialmente qualificati come tali, mentre inrealtà sono cresciute a dismisura le se-conde case e forme diverse di insedia-menti vacanzieri – arrivano, forse conqualche enfasi, sino a 20 milioni. Quantità raramente vuol dire qualità. Nelcaso della Sardegna, dove la quantità eraesigua, la rapida moltiplicazione ha an-che (e si sottolinea “anche”) incrementa-to la qualità. Quello che ha fatto, in parti-colare, lo sviluppo dell’industria turisticaè di aver dato vita a una cucina regionaleunificata. Nel senso che mentre in passa-to ogni zona (talvolta perfino il singolocentro) aveva un suo piatto tradizionale,che non veniva offerto in nessun altro cen-tro dell’isola, oggi esistono almeno dueideali menù tipici, uno per la cosiddetta “li-nea mare” e uno per la “linea terra”, che inqualche misura si possono trovare in qua-lunque ristorante di qualunque parte del-la Sardegna.Cucina di terra. In altre parole, una cuci-na sarda, in senso stretto, forse non esiste.E se esistesse sarebbe difficile avvicinarsiad alcuni cibi che appartengono a un pas-sato anche recente, ma che risulterebbe-ro poco gradevoli al palato non locale: l’e-
sempio non è solo quello del maialettocotto a carraxiu, cioè al coperto, su un let-to di brace e uno strato di erbe aromati-che, il tutto ‘coperto’, appunto, da unostrato di frasche e poi di terra (tanto da fa-re raccontare, a chi ci vuole credere, chelo facevano i pastori quando dovevanocuocere qualche porcetto rubato al vici-no). L’esempio è anche quello dei cibi pro-pri della cucina pastorale, che si possonogustare in occasione di particolari ricor-renze della vita dell’ovile: su tondinzu, ilgiorno della tosatura, è coronato sempre,quando è finita la fatica dei tosatori, dapranzi pantagruelici. Tra questi, la pecorain cappotto e su zurrette. La pecora in cap-potto è detta anche patate in cappotto: di-zione più giusta perché a essere in cap-potto sono le patate, messe a bollire nonsbucciate insieme a una gran quantità di
senz’altro la “discesa” dei Candelieri diSassari, alla vigilia di Ferragosto, in cui leantiche corporazioni sfilano nei costumispagnoleschi accompagnando 9 grandi ce-ri e, alla fine del mese, la già ricordata Sa-gra del Redentore, a Nùoro, che ora si ce-lebra con due diversi appuntamenti, uno‘laico’ e uno più specificamente religioso.In sardo settembre si dice Capidanni, per-ché era in questo mese che iniziava l’annoagrario. Il giorno 8 si celebrano in molti cen-tri dell’isola grandi feste in onore dellaVergine: per i pastori della Barbàgia l’ap-puntamento è sul santuario di Monte Go-
Itinerari tematici
204
nare, presso Sarule. Molti i fedeli anche indue santuari dedicati alla Madonna delRimedio, presso Orosei e Oristano. Sug-gestiva la festa di Nostra Signora di RegnosAltos, celebrata nel quartiere medievale diBosa la seconda domenica del mese.Con l’arrivo dei primi freddi e la ripresa deilavori agricoli finisce il periodo delle gran-di feste. Da ricordare, semmai, la Sagradelle Castagne, che si svolge ad Aritzo l’ul-tima domenica di ottobre, la festa della Ma-donna dello Schiavo a Carloforte (15 no-vembre) e i riti tradizionali che ovunqueaccompagnano il Natale.
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Un’isola di specialità enogastronomiche
205
cipolle; il brodo, convenientemente sgras-sato, è particolarmente gustoso, ma piùgustose – anche più della stessa carne – so-no le cipolle e soprattutto le patate. Su zur-rette è un sanguinaccio di pecora: in cui,però, il sangue di cui si riempie uno sto-maco di pecora è appena sbollentato econdito con uva passa, erbe aromatiche efrustoli di cervella.Il viaggiatore di palato più schizzinosopuò trovare altri cibi, anch’essi tenuti nor-malmente fuori dalla cucina turistica, nel-le grandi sagre che, fra maggio e settem-bre, si celebrano nei santuari della cam-pagna sarda. È uso, infatti, che in occa-sione della festa i “soprastanti”, cioè imembri del comitato che di anno in annosi fa carico dell’organizzazione, offranodi tasca loro il grande pranzo comunitarioa tutti i convenuti: e l’ospite che arriva nonè solo sacro, è anche gradito. In queste ri-correnze, nella Sardegna centrale, è pos-sibile ancora gustare su filindèu, una pastada minestra costruita come una rete sot-tile di fili delicatissimi, una vera e propria“trina”: ma da mangiare. In genere, peral-tro, il pranzo comunitario è fatto della ce-na della vigilia che ha al centro dei granpiatti di trippa, formaggio e frutta, e di undesinare del giorno dopo in cui si distri-buiscono minestra e bollito con patate. Evino, molto vino.Ma il menù che il visitatore può più facil-mente incontrare è, come si è detto, quel-lo standard. Che nella “linea terra” preve-de, oltre gli antipasti casalinghi (salsicce,olive, formaggio e creme piccanti di for-maggio, spesso anche fegatini e frattagliedi animali giovani), i piatti delle paste, frai quali primeggiano i ravioli, e secondi diarrosto, con netta preferenza per il por-cetto e il capretto.I ravioli sono di ricotta e/o formaggio, in-saporiti talvolta con qualche erba aroma-tica (il timo, in particolare).Si chiamano con le varian-ti del termine culurgione:siccome ogni zona ha lesue specialità, varrà la pe-na di indicare sos culorzo-nes ogliastrini (ma ora dif-fusi in tutta l’isola), a basedi patate e formaggio, alprofumo di menta, e li pu-lilgioni galluresi, in cui l’u-so della buccia di limone edello zucchero, tanto nelripieno quanto nelle salse,segnala la ‘diversità’ di cuii galluresi vanno fieri (ma il
dilagare della cucina turistica ha ristrettodi molto la produzione e il consumo, nel-la stessa Gallura, di questa variante tra-dizionale. Sicché talvolta è curioso senti-re chiedere o offrire i ravioli amari, intesisemplicemente come ravioli non dolci). Ilprimo piatto più tradizionale, in Gallura, èperò la suppa cuata (coperta, nascosta),qualcosa come un soufflé di pane, for-maggio, brodo, che in forno si ricopre d’u-na crosta splendente.Cucina di mare. La “linea mare” è, in pro-porzione, quella che è stata più frequen-tata con lo sviluppo del turismo. Così la cu-cina del pesce è uscita dalle città costiere(segnatamente Cagliari, Alghero e Car-loforte; a Oristano esisteva una bella tra-dizione di cucina delle peschiere lagunaricon ricette spesso inedite) per estender-si lungo l’intero periplo costiero e pene-trare anche verso l’interno. Il fatto è chemolto spesso si può mangiare, in Sarde-gna, del pesce fresco: anche se negli ulti-mi anni si vanno diffondendo gli alleva-menti e l’acquacoltura, laddove il pesce‘vero’ sembra essere solo quello prove-niente direttamente dalla barca del pe-scatore. Regina della cucina di mare è l’a-ragosta, che la Sardegna esportava sino aqualche decennio fa verso i porti dellaFrancia, e che ora – nella stagione estiva,anche in conseguenza di periodi di “fermobiologico” imposti dai responsabili regio-nali del settore – viene a volte importata:il buon conoscitore locale non solo di-stingue (forse perfino a occhio, dal coloree dalle dimensioni) l’aragosta sarda daquella ‘forestiera’, ma anche apprezza ledifferenze nell’aroma della polpa prodot-te dalle differenti pasture su cui le arago-ste sono cresciute. Santa Teresa, Castel-sardo, Alghero e Bosa sono i centri rino-mati per la pesca (e la cucina) dell’arago-sta: ma Carloforte, che vanta una solida cu-
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

cina del tonno e conserva piatti che ri-chiamano la lontana origine dei primi co-loni (dalla Liguria alla Tunisia, e di qui al-l’isola sarda di San Pietro), offre ricette ma-rinare di tutto rispetto.Il pane. È l’elemento essenziale dell’ali-mentazione sarda. Praticamente, quasiogni centro della Sardegna (e soprattuttodella Sardegna ‘minore’) ha un suo spe-ciale tipo di pane tradizionale (qualchestudioso ne ha contato sino a 400 tipi dif-ferenti), anche se in molti luoghi, come èfacile immaginare, è subentrata la panifi-cazione industriale. Ma in tutta l’isola, peresempio (e immancabilmente nei risto-ranti), si mangia il pane carasàu (indurito),l’antico pane dei pastori, sottoposto auna duplice cottura per farlo durare i lun-ghi giorni della transumanza: una sfogliacircolare, vasta ma sottilissima, che a ta-vola (del ristorante) si serve in genere ri-scaldata al forno (dunque reduce da unaterza cottura!) condita con sale e olio cal-do; questo pane si chiama guttiàu o istid-diàu (rispettivamente dal latino gutta estilla, appunto perché “gocciolato”).I pani da festa, poi, che venivano confezio-
206
nati in occasione di scadenze importantidella vita familiare (le nozze, in particolare),sono così lavorati da aver fatto parlare di“plastica effimera”: nel Padiglione dell’Ar-tigianato a Sassari o al Museo delle Tradi-zioni popolari a Nùoro alcuni esemplari diquesta straordinaria manifattura occupano,a ragione, un posto segnalato.Alla evoluzione dei pani appartengonomolte delle moltissime varietà di dolci lo-cali. Fra i quali si è rapidamente ‘regiona-
lizzata’ la sebada, così detta dal-la pasta violata con lo strutto:una piccola focaccia di pasta eformaggio fresco lasciato leg-germente inacidire, fritta e ser-vita col miele caldo.E con il pane, indimenticabili, icento formaggi.Il vino. La Sardegna è oggi fa-mosa anche per i suoi vini, cheproprio negli anni più recentihanno ricevuto importanti ri-conoscimenti in Italia e all’este-ro. I rossi non sono più forti eimperiosi come un tempo, maaccordati alle esigenze del be-vitore moderno; i bianchi trion-fano soprattutto d’estate con lacucina del mare. L’isola ha an-che, sin dai primi di novembre,una vasta produzione di novel-li: alla vendemmia del Duemilase ne sono contati 16 diversi.Quando arriva il “digestivo”l’antica, robusta acquavite det-ta filuferru e il profumato li-quore di mirto fanno la loro par-te di amabili padroni di casa.
Itinerari tematici
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

Alfonso IV, re d’Aragona e conte di Catalogna,1299-1336 – pag. 21, 30
Altamura Saverio, da Napoli (?), P., 1822-97 – pag. 186Altomonte Giacomo, da Roma, P., att. inizi sec. XVIII
– pag. 32, 45Angioy (o Angioj) Gian Maria, da Bono (Sassari), uo-
mo politico, 1751-1808 – pag. 23, 167Anselmo da Como, A. lombardo, att. 2a metà sec. XIII
– pag. 30, 104, 156Are Salvatore, da Bosa (Nùoro), A., c. 1776-1840 –
pag. 155Arieti Giovanni Battista, da Alghero (Sassari), A.,
not. 1721-33 – pag. 92Augusto Bartolomeo, da Genova, P., not. 1716-25 –
pag. 138
Barabino Carlo, da Genova, A., 1768-1835 – pag. 48Barisone I, giudice-re (1063-dopo1065) di Torres –
pag. 145Berlinguer Enrico, da Sassari, uomo politico, 1922-
84 – pag. 136Biasi Giuseppe, da Sassari, P., 1885-1944 – pag. 32Bilevelt Giovanni, P. di origine fiamminga, att. a Sas-
sari 1622-52 – pag. 139Biscarra Giovanni Battista, da Nizza (Francia), P.,
1790-1851 – pag. 141Bistolfi Leonardo, da Casale Monferrato (Alessan-
dria), S., 1859-1933 – pag. 186Bogino Gian Lorenzo, da Torino, statista, 1701-84 –
pag. 23, 136Braudel Fernand-Paul, da Lunéville (Francia), sto-
rico, 1902-85 – pag. 15Bruschi Domenico, da Perugia, P., 1840-1910 – pag.
32, 43Busiri Vici Michele, da Roma, A. e Ing., 1894-1981 –
pag. 179
Cambi Ulisse, da Firenze, S., 1807-95 – pag. 32, 93Cano Antonio, da Sassari, P., S. e A., 1775-1840 – pag.
32, 140Capula Giovanni, da Cagliari, A., not. 1305-1307 –
pag. 29, 154Carlo Alberto di Savoia, da Torino, re di Sardegna,
1798-1849 – pag. 23, 165Carlo Emanuele III di Savoia, da Torino, re di Sar-
degna, 1701-73– pag. 23, 62, 136Carlo Felice, da Torino, re di Sardegna, 1765-1831
– pag. 44, 46Carta Antonio Ignazio, A. sardo, not. 1781-86 – pag.
32, 84Casula Antioco, da Dèsulo (Nùoro), poeta, 1878-
1957 – pag. 130Casula Antioco, P., sardo, not. 1593 – pag. 43Cavaro Lorenzo, da Cagliari, P., not. 1500-1518 –
pag. 43
236
Cavaro Michele, da Cagliari, P., 1517/20-1584 –pag. 44, 83
Cavaro Pietro, da Cagliari, P., not. dal 1518, m. 1537– pag. 31, 44, 83, 84, 94
Cavedoni Giacomo, da Sassuolo (Modena), P., 1577-1660 – pag. 140
Cima Gaetano, da Cagliari, A., 1805-1878 – pag. 32,39, 42, 46, 47, 54, 83, 85, 86, 93
Ciusa Romagna Giovanni, da Nùoro, P., 1907-58 –pag. 113, 114
Cominotti Giuseppe, Ing. e Inc., not. 1826-30 – pag.32, 138
Cossiga Francesco, da Sassari, uomo politico, n.1928 – pag. 136
Crespi Giuseppe Maria, d. lo Spagnolo, da Bolo-gna, P., 1665-1747 – pag. 139
D’Annunzio Gabriele, da Pescara, scrittore, 1863-1938 – pag. 117, 185
David Gerard, da Oudewater (Belgio), P., 1460-1523 – pag. 43
Deffenu Attilio, da Nùoro, saggista e uomo politico,1890-1918 – pag. 112
Deledda Grazia, da Nùoro, scrittrice, 1871-1936 –pag. 112, 113, 114, 115
Delitala Mario, da Orani (Nùoro), P., 1887-1990 –pag. 32, 44, 113, 139, 141
Dessì Giuseppe, da Villacidro (Cagliari), scrittore,1909-77 – pag. 65
Dessy Stanislao, da Arzana (Nùoro), P. e Inc., 1900-86 – pag. 44, 139
De Vincenti Felice, da Torino, A., sec. XVII – pag. 32, 48
El Greco (Domìnikos Theotokòpoulos, d.), da Creta,P., c. 1541-1614 – pag. 179
Eleonora d’Arborèa, giudicessa d’Arborèa dal 1383al 1402 – pag. 20, 22, 84, 91, 94
Fancello Salvatore, da Dorgali ( Nùoro), S. e P.,1916-41 – pag. 120
Festa Felice, da Torino, S., not. dal 1800, m. 1826 –pag. 140
Figari Filippo, da Cagliari, P., 1885-1974 – pag. 32,43, 139
Floris Carmelo, da Bono (Sassari), P. e Inc., 1891-1960 – pag. 113, 114
Galassi Andrea, da Sassari, S., att. 1a metà sec. XIX– pag. 32, 44, 45, 46, 141
Garibaldi Giuseppe, da Nizza, generale e uomo po-litico, 1807-82– pag. 151, 185, 186
Gazzola Pietro, da Piacenza, A., 1908-1979 – pag. 43Giacomo II, re d’Aragona, c. 1264-1327 – pag. 21Giordano Luca, da Napoli, P., 1634-1705 – pag. 114Giulianotti Filippo, da Genova, S., 1852-1903 – pag. 138
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - MilanoTratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Indice dei nomi
L’indice è ordinato per lo più secondo il cognome; secondo il soprannome (o lo pseudonimo) se questoè più noto del cognome; in mancanza dell’uno e dell’altro viene indicato il nome seguito dal patronimi-co o dalla provenienza, oppure la denominazione convenzionalmente usata. Dopo le notizie biograficheè data l’indicazione delle pagine nelle quali si ricordano i personaggi storici citati e le opere dovute o at-tribuite a ciascun artista.
Abbreviazioni usate: A., architetto; att., attivo; c., circa; d., detto; Inc., incisore; Ing., ingegnere; Int., intagliatore;m., morto; n., nato; not., notizie; O., orafo; P., pittore; S., scultore; sec., secolo; v., vedi.

Gramsci Antonio, da Àles (Oristano), pensatore euomo politico, 1891-1937 – pag. 88, 105
Guarini Guarino da Modena, A., 1624-83 – pag. 32Guglielmo da Pisa, S., not. 1159-62 – pag. 42
Jerace Vincenzo, da Polìstena (Reggio di Calabria),S. e P., 1862-1947 – pag. 114
Juvarra (o Juvara) Filippo, da Messina, A. e Inc.,1676-1736 – pag. 32
La Marmora Alberto, da Torino, generale, 1789-1863 – pag. 72
Lai Maria, da Ulàssai (Nùoro), P. e S., n. 1919 – pag.78, 113
Lawrence David Herbert, da Eastwood (Gran Bre-tagna), scrittore, 1885-1930 – pag. 33, 38
Le Lannou Maurice, geografo francese, 1906-92 –pag. 14
Lilliu Giovanni, da Barùmini (Cagliari), archeologo,n. 1914 – pag. 18, 87
Lonis Giuseppe Antonio, da Senorbì (Cagliari), S.,1720-1805 – pag. 47, 83
Lusso Andrea, da Albagiara (Oristano), P., not.1593-1610 – pag. 177
Lussu Emilio, da Armungia (Cagliari), scrittore e uo-mo politico, 1890-1975 – pag. 25, 72, 77
Mabuse (Jan Gossaert, d.), P. olandese, c. 1478-1533/36 – pag. 139
Maestro di Castelsardo, P., att. fine sec. XV-inizi sec.XVI – pag. 30, 44, 86, 138
Maestro di Ozieri, P. att. sec. XVI – pag. 31, 139,166, 167
Mainas Antioco, da Cagliari, P., not. 1535-65 – pag.31, 44
Maino Carlo, A. piemontese, not. 1781-1802 – pag.32, 84
Maratta (o Maratti) Carlo, da Camerano (Ancona),P. e Inc., 1625-1713 – pag. 139
Margherita di Savoia, regina d’Italia, 1851-1926 –pag. 141
Marghinotti Giovanni, da Cagliari, P., 1798-1865 –pag. 32, 44, 84, 92, 138, 139, 177
Mariano II, giudice-re di Arborèa (1274-1299 c.) –pag. 104
Mariano IV, giudice-re di Arborèa, m. 1376 – pag. 30,91, 105
Marieschi Michele, da Venezia, P. e Inc., 1696-1734– pag. 139
Mates Joan, P. catalano, att. 2a metà sec. XV – pag. 30Minguzzi Luciano, da Bologna, S., n. 1911 – pag. 179Mura Antonio, da Aritzo (Cagliari), P. 1902-72 –
pag. 123Muru Giovanni, P. sassarese (Ploaghe?), not. 1515-
32 – pag. 138, 165
Nelson Orazio (Horatio), ammiraglio inglese, 1758-1805 – pag. 184
Nievo Ippolito, da Padova, scrittore, 1831-61 – pag. 115Nino Pisano, da Pisa, S. A. e O., not. dal 1349, m. c.
1368 – pag. 30, 92Nivola Costantino, da Orani (Nùoro), S. e P., 1911-
89 – pag. 32, 113, 131
Omodeo Angelo, Ing., ideatore del lago omonimo(1918-24) – pag. 104
Orlando Vittorio Emanuele, da Palermo, uomo po-litico e giurista, 1860-1952 – pag. 25
Palazzi Bernardino, da Nùoro, P., 1907-86 – pag. 98.Palearo o Paleari Giorgio, d. Fratino, A. svizzero,
sec. XVI – pag. 46
Indice dei nomi
237
Pallottino Massimo, da Roma, archeologo, 1909-94– pag. 146
Pelloux Luigi Girolamo, uomo politico, 1839-1924 –pag. 24
Pietro IV il Cerimonioso, re d’Aragona e Catalo-gna, 1319-87 – pag. 149, 152
Pinna Diego, da Sassari, P., not. 1626 – pag. 139Pinna Francesco, da Alghero (Sassari), not. 1594-
1619 – pag. 31Piovene Guido, da Vicenza, scrittore, 1907-74 –
pag. 38Pomodoro Gio, da Orciano di Pesaro (Pesaro e Ur-
bino), S., n. 1930 – pag. 89.
Rapous Vittorio Amedeo, da Torino, P., 1729-1800 –pag. 92, 140
Romero Baldassarre, da Cagliari, A. e Int., not. 1681– pag. 139
Sartorio Giuseppe, da Boccioleto (Vercelli), S., 1854-1922 – pag. 44, 69, 141
Satta Sebastiano, da Nùoro, poeta, 1867-1914 –pag. 112
Scano Dionigi, da Sanluri (Cagliari), Ing., 1867-1949– pag. 43
Sciola Pinuccio, da San Sperate (Cagliari), S., n.1942 – pag. 64, 65, 74, 127
Sciuti Giuseppe, da Zafferana Etnea (Catania), P.,1834-1911 – pag. 32, 44, 141
Segni Antonio, da Sassari, uomo politico, 1891-1972 – pag. 136
Sella Quintino, da Mosso Santa Maria (Biella), uo-mo politico, 1827-84 – pag. 69
Siqueiros David Alfaro, da Chihuahua (Messico), P.,1896-1974 – pag. 127
Soldati Mario, da Torino, scrittore e regista cine-matografico, 1906-99 – pag. 185
Spano Giovanni, da Ploaghe (Sassari), archeologoe linguista, 1803-78 – pag. 163
Susini Clemente, da Firenze, ceroplasta, 1757-1814– pag. 44
Sustermans Justus, da Anversa (Belgio), P., 1597-1681 – pag. 139
Tiarini Alessandro, da Bologna, P., 1577-1668 – pag.114
Tola Pasquale, da Sassari, storico e magistrato –pag. 138
Turchi Alessandro, d. l’Orbetto, da Verona, P., 1578-1649 – pag. 139
Ugone III, giudice-re di Arborèa, figlio di Mariano IV,c. 1335-1383 – pag. 91
Umberto I di Savoia, da Torino, re d’Italia, 1844-1900– pag. 141
Van der Weyden Roger, da Tournai (Belgio), P., c.1400-64 – pag. 43
Van Loo Charles-André, da Nizza (Francia), P., 1705-65 – pag. 140
Vela Vincenzo, da Ligornetto (Svizzera), S., 1820-91– pag. 44
Viana Giuseppe, A. piemontese, not. 1755-87 – pag.32, 48, 94
Vittorio Amedeo II di Savoia, da Torino, re di Sar-degna, 1666-1732 – pag. 39
Vittorio Amedeo III di Savoia, da Torino, re di Sar-degna, 1726-96 – pag. 23
Vittorio Emanuele I di Savoia, da Torino, re di Sar-degna, 1759-1824 – pag. 142, 180
Vivarini Bartolomeo, da Venezia, P., c. 1430-dopo1491 – pag. 139
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano

238
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - MilanoTratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Indice dei luoghi e delle cose
AAbbasanta, 105, 208Abbazia di S. Maria di Corte,
110Acqua Frida (sorgente), 89Àggius, 182, 208Àles, 88, 208Alghero, 149, 191, 208Altopiano di Abbasanta, 105Anglona, 161Àrbatax, 121, 209Arborèa, 100, 209Àrbus, 65Arcipelago della Maddalena,
182, 188Arco dell’Angelo, 75Àrdara, 165, 200Area archeologica di Aiodda,
87Area marina protetta di Capo
Carbonara, 74Argentiera, 147Aritzo, 125, 210Armungia, 76Arzachena, 174, 210Assèmini, 52, 210Atzara, 126, 211
BBadde Sàlighes, 168Baia Sardinia, 180, 211- di Tìnnari, 181Ballao, 79Barbàgia di Belvì, 125Barbàgia di Ollolai, 126Barbàgia di Seùlo, 124Baronìa, 132Barùmini, 85, 211Basilica di S. Antioco di
Bisarcio, 165, 200- di S. Pietro di Sorres, 169, 200- della SS. Trinità di Saccargia,
164, 198Baunei, 121, 211Belvì, 125, 212Benetutti, 167, 212Berchidda, 178, 212Bètili di Tamuli, 110Bithia (scavi), 56Bolòtana, 168, 212Bonàrcado, 111Bonnànaro, 169Bono, 167, 212Bonorva, 168, 212Borutta, 169Bosa, 153, 191, 212Buggerru, 66Bultei, 166Bulzi, 162Burcei, 75, 213Burgos, 168
CCabras, 94, 191, 213Cagliari, 38, 191, 213Cala Gonone, 120, 192, 215- Luna, 120, 192- Mezzaluna, 63Cala di Volpe, 179Calangiànus, 177, 215Calasetta, 62, 215Campo S.Anna, 100- di S. Lucia, 169Capo Caccia, 147- Carbonara, 74- Malfatano, 57- Sandalo, 63- Spartivento, 56 - Spinosa, 181- Testa, 181 Carbonia, 70, 215Carloforte, 62, 216Cascata del Muru Mannu, 197- di Sa Spèndula, 65, 197Caserma della Forestale di
Funtana Bona, 128- Umberto Noci, 75Castello di Acquafredda, 71- di Bonu Ighinu, 153- di Castro, 178- dei Doria, 163- di Gibas, 77- del Gocèano o di Burgos, 167- di Medusa, 89- di Montacuto, 178- Pedreso, 178- di Pontes, 133- di Quirra, 77Castelsardo, 159, 216Castiàdas, 74, 216Catena del Màrghine, 168, 194Centro di Educazione ambien-
tale “Laguna di Nora”, 55Chia, 56Chiaramonti, 163, 217Chiesa della Madonna del
Carmelo, 123- della Madonna di Interrìos,
153- Nostra Signora di Bonu
Ighinu, 153- Nostra Signora di Castro, 178- S. Antioco di Bisarcio
(basilica), 165, 200- S. Antonio, 78- S. Efisio, 54- S. Gemiliano, 103- S. Giovanni, 79- S. Lussorio, 103- S. Maria di Corte (abbazia), 110- S. Michele di Plaiano, 158- S. Michele di Salvènero, 165- S. Nicola (Bulzi), 162
Chiesa di S. Nicola(Villaputzu), 77
- S. Pietro delle Immagini o diSimbranos, 162
- S. Pietro di Sorres (basilica),169, 200
- S. Pietro di Zuri, 104, 200- S. Saturnino, 167- S. Serafino, 104- S. Sisinnio, 65- SS. Trinità di Saccargia
(basilica), 164, 198Chiesetta di Nostra Signora di
Montenero, 114Chilivani, 165Codaruìna, 162Compendio garibaldino
(Caprera), 185Complesso megalitico di Su
Mulinu, 83Complesso nuragico di Cabu
Abbas, 172- di Craddaxus, 89- di Santu Antine, 169Complesso prenuragico di
Monte d’Accoddi, 144Complesso termale di S. Maria
is Acquas, 84Cornus (scavi), 109Costa Paradiso, 181, 217- Smeralda, 179, 188- del Sud, 56, 191Cùglieri, 109, 217
DDèsulo, 130, 217Dolianova, 76, 217Dolmen Ladas, 176- Sa Coveccada, 169Domu de janas di Corongiu,
82Domus de janas di Filigosa, 110- di S. Andrea Priu, 169Domus de Maria, 56, 217Domusnovas, 71Dorgali, 119, 218
EEscalaplano, 79, 218Estuario del Coghìnas, 162
FFertilia, 148Fluminimaggiore, 66, 218Flussìo, 109, 218Fonni, 129, 218Fontana del Paradiso, 153Fordongiànus, 103Foresta di Burgos, 167Foresta di Carucana, 162- di Marganai-Oridda, 71- di Montarbu, 123
L’indice riporta le località, i nomi geografici, i monumenti isolati citati negli itinerari di visita; il nume-ro in corsivo indica la pagina della sezione «Gli altri luoghi» in cui la località compare. Sono in azzurrole località dotate di pianta.

Indice dei luoghi e delle cose
239
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Foresta di Montes, 128- di Seleni, 123- di Uatzo, 130Fortezza di Monte Sirai
(scavi), 69Fundu di Monti (fonte), 178Funtana Coberta, 79
GGadoni, 125Gàiro, 123Gallura, 170Galtellì, 133Gavoi, 131, 219Gennargentu (massiccio del),
129, 195Genoni, 86Gergei, 87, 219Gerrei, 76Gèsturi, 86Ghilarza, 105, 219Giara di Gèsturi, 86- di Serri, 87- di Siddi, 83Giardino montano di Linasia,
67Gocèano, 166, 194Gola di Gorropu, 121, 196Golfo Aranci, 173, 219Grotta del Bue Marino, 120- di Corbeddu, 118- Is Janas, 124- di Ispinigoli, 119- di Nettuno, 148- dei Ricami, 148- Sa Oche, 118- di S. Giovanni, 71, 197- Su Bentu, 118- di Su Mannàu, 66- Su Màrmuri, 78- Taquisara, 123Grotte Is Zuddas, 58Guasila, 83Gùspini, 65
IIglesias, 67, 220Iglesiente, 64, 191Ingurtosu (centro minerario
di), 66Is Bangius (scavi), 100Ìsili, 87, 220Isola dell’Asinara, 147- Budelli, 186, 188- Caprera, 185- La Maddalena, 184- Mal di Ventre, 98- dell’Ogliastra, 121- Piana, 63- Razzoli, 186, 188- San Pietro, 62, 191- Santa Maria, 186, 188- Sant’Antìoco, 59, 191- Santo Stefano, 186, 188- Spargi, 186, 188- Tavolara, 173, 193 Isola Rossa, 181Istmo di Sant’Antìoco, 59Ittireddu, 169, 220
JJerzu, 78, 220
LLa Caletta, 174, 192Làconi, 86, 220Laerru, 162Lago alto del Flumendosa, 124- di Baratz, 147- del Coghìnas, 178- di Gùsana, 131- del Liscia, 176- Mulàrgia, 79- Omodeo, 104- del Temo, 153La Maddalena, 184, 220Lanusei, 123, 221Las Plassas (collina di), 84Logudoro, 164Lu Bagnu, 159Luras, 176, 221
MMacomèr, 110, 221Mamoiada, 129Mandrolisai, 126Mara, 153Marceddì, 100Marmilla, 81Marrubiu, 100 Martis, 162Masùa, 69Meilogu, 153, 169Menhir di Perdas Fittas, 131Milis, 111Mògoro, 88, 221Montacuto, 165Monte Albo, 134, 195- Arci, 87- Bruncu Spina, 129, 196- Cardiga, 78- della Croce, 182- Ferru, 109, 195- Gonare, 131- Lerno, 166, 194- Limbara, 178, 193- Mungianeddu, 130- Novo S. Giovanni, 129- Ortobene, 114- Perda Liana 123- Sette Fratelli, 75, 197- Texile, 125- Tìscali, 118- Turuddò, 134Monteleone Rocca Doria, 153Montevecchio (miniera di), 65Montiferru, 108Mores, 169Morgongiori, 88, 221Muravera, 74, 192, 222Museo Nino Lamboglia (La
Maddalena), 185
NNèbida, 69Necropoli di Anghelu Ruju, 148- di Li Muri, 175- di Montessu, 58- di Pranu Mutteddu, 82- di S’Acqua Salida, 82- di S. Andrea Priu, 169- di Sas Concas, 132Nora (scavi), 55Nule, 167Nulvi, 161
Nùoro,112, 222Nurachi, 108Nuraghe Albucciu, 175- Ardasai, 123- Arrubiu, 79- Asoru, 74- Cuccurada, 88- La Prisgiona, 175- Losa, 105, 106-107- Paddaggiu, 162- Palmavera, 148- Ruggiu, 110- Ruju, 163- Santu Antine, 169- S. Barbara, 110- Su Concali, 78- Su Nuraxi, 85Nurallao, 87Nurra, 144
OOgliastra, 122Olbia, 171, 198, 222Olìa Speciosa, 74Oliena, 117, 223Olivastro sul lago del Liscia,
176Ollastra, 102Orani, 131Orgòsolo, 127, 223Oristano, 90, 224Orosei, 133, 192, 224Òschiri, 178, 224Òsilo, 161Ottana, 105, 225Ozieri, 165, 225
PPàdria, 153, 225Paese di Villanova, 153Palau, 180, 225Pan di Zucchero (faraglione),
69Parco della Giara di Gesturi, 86- di monte S. Antonio, 110- letterario Grazia Deledda, 115- naturale di Monte Arci, 88- nazionale dell’Arcipelago
della Maddalena, 182- nazionale dell’Asinara, 147Passo Arcu de Sàrrala, 78- di Genna Sìlana, 121- del Limbara, 178- Uccàidu, 167Pattada, 166, 225Pau, 89Paulilàtino, 108, 225Pedra Longa, 121Perdasdefogu, 78Pèrfugas, 163, 226Pimentèl, 82Pineta di Giuanni Corrias, 89- di Is Benas, 88Planargia, 109Platamona, 159, 190Ploaghe, 163, 226Portobello di Gallura, 181Porto Cervo, 179, 226Porto Conte, 147, 226Porto Corallo, 77Porto Pozzo, 180Porto Rafael, 180

Indice dei luoghi e delle cose
240
Tratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - MilanoTratto da Guida Verde d’Italia Sardegna del Touring Club Italiano - © 2001 Touring Editore Srl - Milano
Porto Rotondo, 178, 188, 227Porto Torres, 144, 198, 227Posada, 173Pozzo sacro Sa Testa, 173Pranu Sànguni, 76Pula, 54, 227Punta Balistreri, 178- Catirina, 134- Corrasi, 118- La Marmora, 129, 196- Serpeddì, 75
QQuartu Sant’Elena, 51, 228
RReggia nuragica di Santu
Antine, 169Rifugio S’Arena, 129Riserva di Monte Arcosu, 197Rocce rosse di Àrbatax, 122Roccia di Capo d’Orso, 180- dell’Elefante, 162
SSalto di Quirra, 78San Giovanni di Sinis, 95San Leonardo de Siete
Fuentes, 110Sanluri, 84, 228San Nicolò Gerrei, 76San Pantaleo, 179San Pasquale, 180San Priamo, 74San Salvatore, 98San Sperate, 64Santa Caterina di Pittinuri, 109,
228Santadi, 58, 228Santa Giusta, 99Santa Lucia, 134, 192Santa Maria Coghìnas, 163Santa Maria Navarrese, 121, 229Sant’Andrea Frìus, 76Sant’Antìoco, 59, 229Sant’Antonio di Gallura, 176Santa Reparata, 181Santa Teresa Gallura, 180, 190,
229Santuario della Madonna
(Nulvi), 161- di Nostra Signora di Gonare, 131- di S. Costantino, 105- di S. Francesco di Lula, 134- di S. Mauro, 126Santuario ipogeico di S.
Salvatore, 98Santuario nuragico di S.
Cristina, 108- di S. Vittoria, 87
Santu Lussurgiu, 111, 230San Vero Milis, 111, 230San Vito, 77S’Archittu, 109Sarcidano, 84Sàrdara, 83, 230Sàrrabus, 72Sassari, 135, 230Sa Trèbina (torrioni di), 88Scala Piccada, 153Sèdilo, 105Sèdini, 162Selàrgius, 51, 231Sènnori, 160, 231Senorbì, 82, 231Serri, 87Sestu, 52Settimo San Pietro, 51 Seùi, 124, 232Seùlo, 124Siddi, 83Silì, 102Siliqua, 71Simàxis, 102Sindìa, 110, 232Sinis, 94, 191Siniscola, 134, 232Sorgente di Su Gologone, 118,
196Sòrgono, 126, 232Sorso, 160, 232Spiaggia di Bèrchida, 134, 192- delle Bombarde, 148- di Caprìccioli, 179- di Costa Rei, 72, 192- di Piscinas, 66, 191- Rena Majore, 181, 190- di Santa Margherita , 56, 191- di Simìus, 74- della Speranza, 156Stagno di Cabras, 95- di Casaraccio, 146- di Colostrài, 74- di Marceddì, 100- di Molentàrgius, 50- di Sale Porcus, 98- di S’Ena Arrubia, 99- di Tortolì, 121Stintino, 146, 190, 232Strada del Flumendosa, 77Suelli, 82Sulcis, 53Suni, 153Su Nuraxi (complesso nuragi-
co), 85Supramonte di Oliena, 118
TTadasuni, 104, 233Tempietto di Malchittu, 175
Tempio di Àntas, 66Tempio Pausania, 177, 233Tergu, 160, 233Terme di Casteldoria, 163Terralba, 100, 233Tertenìa, 78, 192Teulada, 57, 233Tharros (area archeologica),
96Tomba di giganti Li Lolghi, 175- Lu Coddhu ’Ecchju, 175- S’Ena ’e Thomes, 133Tonara, 130, 233Torralba, 169, 234Torre del Bulo, 148- di Chia, 56- del Lazzaretto, 148- di Pittinuri, 109Torre Salinas, 74 Tortolì, 121, 234Tratalìas, 58Trexenta, 81Trinità d’Agultu, 182Tuìli, 85
UUlàssai, 78, 234Uta, 71
VValico di Arcu ’e Tidu, 75Valle di Lanaittu, 118- della Luna, 182- dei Nuraghi, 169- del Tirso, 102Valledoria, 162, 234Viddalba, 163Vigneti Sella e Mosca, 148Vignola Mare, 181, 190Villacidro, 65, 234Villaggio nuragico di Brunch’e
s’Omu, 89- di Genna Maria, 83- di Monte Tìscali, 118- di Serra Òrrios, 132- di Su Putzu, 79- Su Nuraxi, 85Villaggio del Touring Club
Italiano (La Maddalena), 185Villamar, 84Villanovaforru, 83, 235Villanovafranca, 83Villanova Monteleone, 153, 235Villanova Truschedu, 103Villaperuccio, 58 Villaputzu, 77, 235Villasimìus, 73, 191, 235Villasor, 65Villaurbana, 89Villa Verde, 89