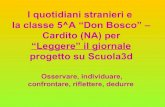Roccasalva CONFRONTARE LE SINTASSI DELLA RETE URBANA - … · Secondo un ordine crescente di...
-
Upload
truongnhan -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Roccasalva CONFRONTARE LE SINTASSI DELLA RETE URBANA - … · Secondo un ordine crescente di...
1
XXXIV CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI
CONFRONTARE LE SINTASSI DELLA RETE URBANA: UNA PROPOSTA APPLICATIVA
Giuseppe ROCCASALVA1,
SOMMARIO
Le analisi configurazionali dello spazio urbano (spatial configuration analyses)
possono essere usate per scelte che riguardano la progettazione, la conservazione o la
valorizzazione dei tessuti urbani delle città. Queste analisi permettono di studiare le modifiche
dello spazio urbano sia in termini diacronici sia sincronici, con particolare riferimento a quei
fattori economici e sociali che sono sensibili alle scelte di variazione della struttura dello
spazio urbano.
L’utilizzo di queste tecniche è da affinare soprattutto per quanto riguarda il modo di
comunicare e confrontare gli esiti. Attraverso un confronto tra due realtà territoriali
apparentemente differenti (AMT di Torino e Il Cairo), l’articolo descrive il ruolo e l’utilità
degli studi configurazionali. Inoltre propone un’iniziativa comune (Open Syntax Italy) volta a
condividere in modo univoco il sistema di letture sintattiche attraverso un protocollo di
georeferenziazione che sia consultabile da tutti. L’obiettivo è quello di favorire la
condivisione della conoscenza sulla struttura sintattica, rafforzando gli studi di un singolo
territorio e amplificandone le potenzialità attraverso un particolare confronto.
1 Politecnico di Torino LAQ/tip-SiTI (DAD-DIST), c/o SiTI via P.C. Boggio 61, 10138, Torino, e-mail: [email protected]
2
Introduzione
Negli ultimi trent’anni le analisi morfologico-configurazionali note come “Space
Syntax Analyses” hanno portato avanti – con approcci diversificati – una ricerca mirata a
comprendere meglio le proprietà e le possibilità connesse con la distribuzione della forma
delle città. Nonostante le doverose critiche, queste analisi hanno messo in evidenza delle
condizioni legate alla forma delle città che già erano intuitivamente note agli studi precedenti
sulla morfologia ma hanno aggiunto la possibilità di una misurazione oggettiva e
standardizzata.
La lettura della distribuzione della forma dello spazio attraverso un insieme
d’indicatori matematici ha permesso la trasposizione di considerazioni qualitative - anche non
nuove e presenti da anni in letteratura – in forme matematiche che possono subire una lettura
più sistematica, ripetibile e algebrica. Inoltre, una lettura della distribuzione della forma così
standardizzata ha reso possibile il dialogo tra la progettazione urbana e altri studi e discipline
che si occupano di città come l’ingegneria dei trasporti, le scienze cognitive, la progettazione
energetica etc...Sono rintracciabili studi nel campo della mobilità, della sicurezza urbana o
della valorizzazione economico-immobiliare che hanno tentato una relazione con gli
indicatori sulla sintassi dello spazio.
Sebbene le analisi sintattiche della forma siano soprattutto un supporto alla
progettazione, alcuni studi (B. Jiang, V. Cutini) stanno riflettendo su come questa lettura,
seppur parziale, possa rivelarci altre informazioni sull’origine ed sull’evoluzione insediativa.
In quest’ottica, quest’ articolo si domanda quale potrebbe essere il modo migliore per sfruttare
questa lettura tipizzata.
Gli studi sintattici sulla forma delle città presenti in letteratura, assumono tecniche di
analisi varie e la loro sistematizzazione non è stata mai tentata né forse ha motivo di essere
sperimentata. Invece, se si assume che le diverse metodologie di analisi morfologico-
configurazionale si distinguono nel modo di leggere la distribuzione della forma delle città,
sarebbe più opportuno concentrare un tentativo di sistematizzazione sugli esiti che sono forse
il punto comune a tutti e quello che potrebbe avere maggiori affinità. Da questa
considerazione nasce l’esigenza di capire come e se il confronto degli esiti può aprire un
nuovo capitolo di approfondimento su questo metodo.
La Configurazione
E’ opportuno introdurre brevemente il concetto di configurazione per poterne
discuterne i possibili impieghi analitici e le potenzialità che quest’ articolo intende mettere in
evidenza.
3
Le analisi configurazionali tentano di leggere la struttura e la qualità delle connessioni
in un sistema dato. Le connessioni possono essere di diverso tipo a seconda della disciplina
che le esamina (fisica, grammatica, estetica-arte, morfologia etc...). In Fisica della materia, la
configurazione elettronica (posizione reciproca degli elettroni) permette di studiare i legami di
un atomo e di definirne le ragioni della stabilità dell’atomo e della conformazione della
materia al variare di questi legami. Nella Linguistica la configurazione è la sintassi, ovvero le
relazioni che esistono tra le parole o le lettere nella lettura. Similmente, in ambito urbano, le
analisi configurazionali delle città tentano di leggere la struttura della forma di una città, a
partire dai legami tra le forme in un sistema di spazi, ovvero la conformazione della città o
delle forme abitate. Ogni spazio tra gli edifici viene interpretato e messo in relazione con gli
spazi contermini e con tutti il sistema (la rete) di spazi della città o della porzione di città che
si vuole studiare.
In termini generali, per descrivere quanto il concetto di configurazione sia connaturato
al modo di ragionare e apprendere dell’essere umano basta pensare ad una frase in cui le
parole siano composte solo da alcune lettere, quelle iniziali e finali e solo alcune centrali; in
questo caso riusciremmo comunque a leggere la frase. Inoltre se invertissimo l’ordine di
alcune lettere nelle parole, riusciremmo comunque a non avere grandi difficoltà di lettura. Ad
esempio, è possibile leggere le seguenti parole e frasi incomplete:
GR_MM_T_ _A
UN_VE_S_TÁ
S_GN_FI_AT_
Secondo un ordine crescente di difficoltà, dovrebbe essere possibile leggere e capire le
parole precedenti. La mente umana colma automaticamente le lacune grazie ai legami che
crea tra informazioni presenti e conoscenze disponibili.
“Uno stduio ha rileavto che la mente umana legge le parole non per inetro, nel senso
che se si scamibassero di posto le lettere al cetnro di una paorla senza muvoere le prime due e
le ultime due, si leggreebbe beinsismo”.
Non importa l’ordine delle lettere di una parola se la prima e l’ultima sono al loro
posto. Questo accade perché la mente non legge ogni lettera singolarmente ma la parola per
intero, lasciando quindi alla mente assemblare le lettere ed interpretare la parola
correttamente.
I precedenti giochi di parole e frasi sono alcuni tra i tanti che fanno intuire le
peculiarità del rapporto che esiste tra configurazione e apprendimento. Se trasponiamo questo
rapporto in un esempio di tipo grafico simile al gioco di lettere, possiamo ugualmente
verificarne il valore. Ad esempio, prendiamo due schemi con la stessa configurazione ma
4
composti da elementi di forma diversa; la mente intuisce che sono simili nonostante la
differenza dei componenti.
Figura 1 Due serie di configurazioni grafiche di cui si percepisce la somiglianza nonostante siano composte da elementi
differenti. (fonte : Hillier 1996)
Il riconoscimento della configurazione di un’immagine, di una forma o di uno spazio è
una capacità che la mente umana possiede in modo intuitivo e non analitico. Come spiega
Hillier (1996), fondatore delle analisi configurazionali dello spazio urbano, abitualmente ma
non consciamente facciamo associazioni configurazionali senza pensarci e senza saperne
descrivere i meccanismi e i pesi. Nel linguaggio possiamo distinguere concetti di cui abbiamo
un’idea (le parole e ciò che significano) e i concetti con cui ci formiamo un’opinione (le
regole sintattiche e semantiche con cui organizziamo le parole per creare un significato). I
primi sono consapevoli mentre i secondi rappresentano una struttura nascosta, come le regole
configurazionali, appena sotto il livello di coscienza. Sempre Hillier ricorda che questa
“inconscia configurazionalità” è presente ovunque, anche nei nostri comportamenti sociali più
comuni, in cui seguiamo un sistema di regole a volte senza rendercene conto (sedersi a tavola,
seguire una lezione, riunirsi in cerchi per dialogare etc..).
Comprendere come la configurazione di uno spazio influenzi il nostro modo di fare
esperienza della città è un tema molto frequentato nella letteratura sulla morfologia urbana ma
queste analisi si propongono anche come un metodo standardizzato che tenta di offrire un
supporto “non discorsivo” ed evidente alle scelte.
5
Classificare per confrontare: il ruolo delle analisi
Numerosi studi professionali in tutto il mondo forniscono specifiche consulenze
sull’efficienza della forma in termini estetici, energetici, funzionali, ambientali paesaggistici,
urbanistici etc… Le analisi configurazionali affiancano molte di queste attività, generando
negli ultimi dieci anni una rete di centri di consulenza (pubblici e privati). Alfiere di questa
diffusione fu forse l’Arch. Norman Foster che affidò dal 1992 allo studio londinese di Hillier
una serie di consulenze sui suoi progetti per poter supportare alcune scelte o testare gli effetti
delle sue proposte sia in ambito architettonico sia alla scala del progetto urbano. Come questo
esempio di efficace intesa professionale si possono contare, dall’Australia alla Svezia, più di
dieci situazioni nel mondo in cui esiste una consolidata comunione tra lo sviluppo scientifico
dell’analisi dello spazio urbano e le numerose realizzazioni che hanno incluso le letture
configurazionali nelle scelte progettuali.
Le analisi configurazionali dello spazio sono sistematiche ma hanno un ruolo specifico
a seconda del tipo di analisi adottate, che a loro volta dipende dagli interessi o dalla scala
dell’indagine che si deve affrontare. Una classificazione delle tipologie applicative è
necessaria per poter avviare una condivisione della conoscenza tra la comunità di esperti che
studiano e usano queste analisi.
Sia per i progetti che ricadono nel settore privato sia per quelle che sono guidate dal
pubblico, le applicazioni delle analisi configurazionali si occupano principalmente dei modelli
di movimento che permettono di capire i problemi relativi al sistema degli spostamenti in una
città. In questi casi, le analisi configurazionali hanno prevalentemente un ruolo di confronto
delle alternative di sviluppo e di gerarchizzazione delle scelte. Si possono contare analisi
configurazionali alla scala globale di una città che tentano di individuare la migliore
localizzazione di un edificio monofunzionale (ad esempio un ospedale, un centro
commerciale e un ufficio) o analisi che ordinano l’efficienza distributiva di settori specifici di
una città.
Se consideriamo il progetto degli spazi aperti di una città, si possono contare progetti
che sono solitamente affidati alla cura e manutenzione del settore pubblico; questi spazi della
città sono analizzati mettendo in relazione l’efficienza spaziale con i possibili movimenti. Le
analisi configurazionali stimano ad esempio, la continuità tra gli spazi aperti o la visibilità
locale, che concorrono ad anticipare alcuni modi in cui gli spazi verranno percepiti e usati dai
fruitori finali.
6
Nell’ambito degli studi sulla mobilità, l’analisi della configurazione urbana sembra
competere con le simulazioni trasportistiche ma in realtà rileva tutt’altro ordine previsionale.
Dal progetto di una nuova infrastruttura urbana alla modifica del funzionamento degli incroci
stradali, la lettura della sintassi dello spazio propone di valutare l’impatto sociale, economico
e ambientale di strategie alternative di movimento pedonale, ciclabile e veicolare. In questo
caso, spesso le analisi sono affiancate da più tradizionali tecniche di osservazione che
contribuiscono a calibrare le simulazioni sui flussi di movimento e a migliorare la consistenza
degli studi sintattici. Sebbene la teoria della sintassi dello spazio sia spesso riferita al
movimento pedonale, essa considera l’ordine e la distribuzione delle varie componenti della
mobilità (trasporto pubblico e privato, carrabile e ciclabile).
Nell’ambito degli studi sul mix funzionale e sulla diversità delle destinazioni d’uso di
una città, le analisi configurazionali sono prevalentemente dedite allo studio del rapporto fra
movimento e attività. Il concetto di economia dei flussi (movement economy), discusso da
Hillier, propone di interpretare lo sviluppo economico sulla base dell’intensità di probabile
utilizzo dello spazio analizzato. Lo spazio è la “macchina” che può innescare uno sviluppo
economico-sociale, mantenerlo in vita o scoraggiarlo. Sia la piccola sia la grande
distribuzione hanno dei quadri esigenziali con specifiche necessità o propedeuticità
localizzative. Basti pensare alla specificità dei “corner shop” non soltanto da un punto di vista
merceologico ma soprattutto localizzativo. Nell’ambito del geo-marketing sono state
sviluppate delle regole di posizionamento che contemplano regole formali che coincidono in
parte con quelle che possono essere lette dalle analisi configurazionali (posizionamento
globale, visibilità relativa e di facciata). Combinando studi di osservazione diretta dello spazio
pubblico (Gehl 1970) con modelli di flusso dei passanti (White 1060), si producono schemi di
distribuzione che sono utili per capire e ottimizzare i modelli di frequentazione e di passaggio.
Trascurando l’elencazione delle applicazioni che si possono contare nell’ambito della
progettazione di edifici (pubblici o privati), è interessante inserire in questa breve
classificazione anche quelle analisi configurazionali che si distinguono per il modo in cui
sono usate all’interno del processo di valutazione delle scelte progettuali. Se inizialmente le
analisi configurazionali erano usate come strumento di verifica della validità dei progetti,
permettendo di apporre modifiche ancora nel corso del ragionamento progettuale, in seguito
sono diventate anche uno strumento di misurazione, soprattutto quando le analisi vengono
effettuate in una fase già matura del processo. In quest’ultimo caso, gli indicatori misurati
dalle analisi configurazionali servono come riferimento per un confronto non con delle
alternative ma con dei modelli o con lo stato di fatto.
7
Infine possiamo dire che tutti gli ambiti di questa classificazione non offrono soluzioni
standard ma sono accomunati dall’adozione di un approccio di lavoro standardardizzato, in
grado di supportare il processo di valutazione delle scelte progettuali. Nei diversi ambiti
d’indagine si contraddistingue un certa omogeneità di applicazione che utilizza inoltre una
logica tran-scalare in cui il confronto attraverso gli indicatori è sempre visto alla scala globale
e locale del progetto urbano.
Syntattic open data: il confronto come metodo
Figura 2 : Portale internet “Open Syntax Italy” (fonte : produzione dell’autore)
Sfruttando il processo sistematico che è alla base delle analisi configurazionali, questo
articolo propone di avviare un modo di condivisione degli esiti su base geografica attraverso
un sito internet dedicato. Si ritiene che la costruzione condivisa della conoscenza
configurazionale del territorio sia un processo più preciso e più consistente di quelle che
potrebbe fare un singolo strumento di simulazione. Quest’opinione è motivata dal modo in cui
lo spazio urbano è trasformato in una mappa utile alle analisi configurazionali. Questo
passaggio comporta una conoscenza del territorio che non può totalmente essere sostituita
dalla macchina ma che è essa stessa “motore” principale degli studi sulla configurazione dello
spazio urbano. In poche parole, la traduzione degli spazi aperti in struttura configurazionale
comprende la conoscenza locale dei luoghi che non può che essere affidata alle esperienze di
ciascuno.
Per facilitare il processo di acquisizione e condivisione della conoscenza
configurazionale del territorio si è impostato un particolare sito internet. Questo portale sfrutta
il concetto di “crowd mapping” cioè di mappe partecipate, in cui ognuno contribuisce alla
costruzione di una conoscenza collettiva e condivisa del territorio a partire dalla propria
8
esperienza scientifica. Il sito, denominato Open Syntax Italy, intende raccogliere le analisi
configurazionali dei vari esperti che in giro per l’Italia studiano il territorio attraverso le
letture e le dimensioni configurazionali. Oltre alla condivisione, si ritiene che l’apertura dei
dati pubblicati (open data) possa generare un servizio aggiuntivo anche a chi non è
propriamente cosciente del modo in cui si analizza la struttura sintattica di un territorio ma
capisce o intuisce induttivamente le potenzialità che una misura configurazionale può avere
rispetto ad altri interessi e caratteristiche sociali, ambientali ed economiche che sono sensibili
alla trasformazione dello spazio urbano.
Il sito internet, come un geoportale, raccoglie le analisi configurazionali mostrando su
base geografica il mosaico dei vari studi sul territorio italiano.
Per capire quali dati sono quelli che più di tutti possono essere facilmente pubblicabili
e condivisibili sul portale Open Syntax Italy, è necessario stabilire alcuni sistemi di
riferimento e di misurazione comuni.
All’inizio la lettura della sintassi dello spazio si basava su indicatori semplici e
riconducibili all’accessibilità della forma, come ad esempio la profondità totale o media e
l’integrazione, oggi ci sono numerose misure più raffinate che permettono specifiche analisi.
In generale, le dimensioni delle analisi configurazionali sono il frutto della combinazione di
quattro categorie che riguardano la tipologia di calcolo (algoritmo o calcolo della scelta uno,
due), la distanza (topologica, angolare o metrica), il raggio (topologico, angolare o metrico) e
il peso (basato sulle lunghezze dei segmenti di uno spazio convesso o sulle loro dimensioni
topologiche o sulla loro riduzione a nodi etc…).
I calcoli che si possono sperimentare sono diversi ma soprattutto è importante valutare
quali coefficienti di calibrazione adottare di volta in volta, nei vari contesti di forma, alle varie
scale e in rapporto all’obbiettivo dell’indagine.
Ad esempio, le distanze fanno variare l’informazione che la misura descrive. Tuttavia
la distanza topologica è prevalentemente utile per i confronti configurazionali. Questo tipo di
distanza non considerando le dimensioni euclidee dello spazio permette di misurare
l’organizzazione (sistema di relazioni) di diverse porzioni di territorio anche distanti tra loro.
La distanza angolare è un affinamento di quella topologica e tenta di includere le
informazioni tipiche di una distanza euclidea alle caratteristiche sintattiche dello spazio. La
distanza angolare è particolarmente utile per semplificare le opzioni in contesti morfologici
particolarmente contorti o in ambienti architettonici che hanno bisogno di essere analizzati
non soltanto in relazione ai movimenti potenziali ma anche in funzioni di fattori come la
sicurezza, la permeabilità etc… Infine, la distanza metrica è utile per confrontare il dettaglio
delle superfici di progetto in un contesto topologico al fine di cercare delle ricorrenze tra gli
indicatori (ad esempio un confronto più specifico con gli standard urbanistico, ovvero
quantità di superficie lorda di pavimento rispetto alla quantità di spazi aperti di relazione di
9
pari-visibilità). Inoltre le distanze metriche sono utili in fase sperimentale nell’ambito delle
calibrazione con le altre due distanze.
Alcune di queste combinazioni danno dei risultati già consolidati da numerose
esperienze applicative mentre altri accostamenti non sono stati ancora testati, pubblicati
ufficialmente o non danno dei risultati particolarmente significativi.
In generale, ogni indicatore può avere una o più analisi di riferimento ma la migliore
lettura ed interpretazione di uno spazio ha spesso solo una (o più opportuna) modalità
applicativa.
Il portale Open Syntax Italy propone agli utenti due semplici funzioni di condivisione
che permettono, al netto di tutti i possibili ragionamenti sui vari contesti urbani, una
condivisione basata su informazioni comuni e confrontabili.
La prima funzione riguarda la condivisione delle mappe assiali del contesto studiato.
Gli utenti possono caricare sulla geografica di base un livello (axial map) che trasmette il
valore di integrazione o di scelta globale di un territorio. Questo valoro è una misura
normalizzata e globale per cui ammette il confronto diretto tra contesti territoriali differenti.
Oltre a verificare lo stato di efficienza del sistema degli spazi di una porzione di territorio si
potrà anche in futuro monitorare lo stato di miglioramento o peggioramento dei valori globali
di accessibilità e interazione di una città al variare della sua morfologia.
La seconda funzione permette agli utenti di inserire le banche dati delle analisi
configurazionali svolte. Questa funzione non è visualizzabile su mappa ma solo attraverso
grafici a rete (spider gram) che permettono una tra le più interessanti e utili forme di
confronto di tipo quantitativo. Questi confronti numerici implicano una misurazione diretta e
precisa dei valori su diversi territori o di valori differenti sullo stesso territorio.
La “correlazione” e la “tran-scalabilità” sono tra le principali forme di misurazione e
confronto numerico che prevede il portale.
Nella lettura delle analisi configurazionali ma in generale nel tentativo di cercare delle
relazioni tra variabili differenti, è importante comprendere il significato di termini come
correlazione e regressione da un punto di vista matematico e rispetto al modo in cui vengono
esaminate nelle analisi legate alla struttura dello spazio.
In generale, date due o più variabili è possibile esprimere la relazione eventualmente
esistente tra di esse attraverso le analisi di correlazione o di regressione. La correlazione è una
misura di relazione tra due o più variabili. La scala di misura adoperata deve essere un
intervallo, ovvero i coefficienti di correlazione possono assumere valori da -1,00 a +1,00. Il
valore di -1,00 rappresenta una perfetta correlazione negativa, mentre un valore di +1,00
rappresenta una perfetta correlazione positiva. Un valore di 0,00 rappresenta una mancanza di
correlazione. Il tipo di correlazione adoperato più frequentemente è la r di Pearson, detto
anche coefficiente di correlazione lineare. Questa correlazione misura la “proporzionalità” di
due variabili ed è indifferente all’unità di misura o grandezza di ciascuna variabile. La
10
condizione di proporzionalità è elevata se può essere schematizzata da una linea retta
(inclinata positivamente o negativamente).
La linea retta che si usa nei grafici di correlazione è chiamata retta di regressione o
retta ai minimi quadrati, perché è determinata in modo tale che la somma delle distanze al
quadrato di tutti i punti da corrispondenti punti della retta sia la minore possibile. Il concetto
di distanze al quadrato ha un’importante conseguenza funzionale su come il valore del
coefficiente di correlazione reagisce al variare dell’organizzazione dei dati.
La retta di regressione può essere descritta dalla
y = a + bx
dove y = variabile dipendente
x = variabile indipendente
a = costante
b = coefficiente di regressione
La significatività di un coefficiente di correlazione cambia con la dimensione del
campione da cui è stato calcolato. Il test di significatività si basa sull’assunto che la
distribuzione dei residui (cioè le deviazioni dalla retta di regressione) per la variabile
dipendente y segua quella di una normale e che la variabilità degli stessi residui sia la stessa
per tutti i possibili valori della variabile indipendente x2. Quando si ha un basso livello di
significatività il coefficiente r di correlazione e quello b di regressione risultano
numericamente piccoli, mentre il grafico è caratterizzato da due rette (y = a + bx ; x = a + by)
che sottendono un angolo ampio. Nel caso opposto (angolo piccolo tra le rette di regressione)
la relazione tra le variabili è più forte e il coefficiente di correlazione è elevato (prossimo a
+1,00 oppure -1,00).
Le correlazioni sono state utilizzate anche nello studio dinamico della variazione di un
fattore. L’osservazione di un fenomeno nel tempo e nello spazio da origine a forme di lettura
che usano il calcolo di correlazione. Ad esempio, in biologia si chiama allometria3 lo studio
dell’evoluzioni delle relazioni di forma al variare della scala. In molte discipline c’è la
convinzione che esistano delle regole nella relazione tra le geometrie di funzionamento degli
elementi osservabili e fenomeni sociali, economici o naturali. Per dimostrare questo principio,
in molti ambiti disciplinari si sono effettuati studi di correlazione tra variabili alle diverse
scale e nel tempo. Le correlazioni economico-sociali sulle città sono tra le più note (PIL e il
consumo energetico o la crescita del numero di stazioni di rifornimento, il costo della benzina
e la dimensioni-densità delle città). Ogni correlazione confronta la scalabilità delle relazioni
tra due condizioni (ad esempio la popolazione e il consumo del suolo o le scelte di mobilità).
2 Borra, S., et al 2008 3 In biologia è lo studio dell’evoluzione di una o più parti di un organismo che presentano caratteristiche diverse dagli altri. Definita in modo accurato prima da Otto Snell (1892) e poi da Julian Huxley (1932), l’allometria è il principio secondo cui si possono ritrovare delle correlazioni tran-scalari nelle forme naturali
11
Ad esempio, in ambito energetico, la discontinuità nella dimensione degli edifici e nella loro
densità altera significativamente l’impronta energetica. Per cui il rapporto tra forma e densità
del tessuto urbano possiede una regola che ricorre alle diverse scale, influendo sul valore di
consumo energetico. Quindi esiste una relazione misurabile tra scala globale e forma locale.
Figura 3: Energia contro densità: Se guardiamo due città simili per clima e popolazione come Detroit e Copenaghen notiamo
come la dimensione della densità influenzi fortemente i modelli di mobilità delle persone. Monaco e Hong Kong sono
relativamente molto dense e trafficate ma presentano dei modelli di consumo molto più sostenibili.(fonte Newman e
Kenworthy 1989)
Caso pilota: confronto sintattico tra Il Cairo e Torino
Questo caso prende spunto da quella parte di studi configurazionali che sono dedicati a
capire le regolarità morfologiche dei tessuti urbani alternativi o differenti. L'obiettivo è quello
di costruire un metodo di confronto tra un tessuto come quello torinese e altri contesti. Ciò é
possibile mettendo a confronto le stesse relazioni tra la rete degli spazi locali in tessuti urbani
che sono differenti per caratteristiche sociali, culturali o economiche. In particolare è stata
scelta la città del Cairo poiché quest'ultima è profondamente diversa dalle città europee e da
Torino in particolare. Il Cairo ha una popolazione di circa 11 milioni di abitanti (nella sola
città) e un trend di crescita di 1,6% annuo, con una costante e rapida modifica morfologica. La
dinamicità di Torino invece mostra un trend di crescita della popolazione di 0,3% annuo e
concentrate trasformazioni territoriali il cui iter d'implementazione é decisamente più lento.
12
Figura 4 (sinistra)Trend di crescita della popolazione. La città del Cairo ha un trend di crescita conforme a quello nazionale
mentre Torino presenta un 0,3% a fronte di 3,4% nazionale. Simili sono anche i trend di crescita nell’ambito rurale o anche
nelle altre città egiziane. (fonte the guardian). (destra) Elaborazione GIS delle principali destinazioni d’uso ed infrastrutture.
Sono messe in evidenza le strade principali (in nero) e quelle ad alto scorrimento come la tangenziale e le strade regionali (in
rosso). Inoltre la mappa ha campito in rosso gli edifici residenziali, in giallo il commercio, in grigio e nero gli edifici
pubblici-religiosi.
Originariamente la struttura urbana principale della città del Cairo era concentra ad est
del Nilo anche per la presenza delle ramificazioni del trasporto ferroviario. Oggi, pur
mantenendo una forte concentrazione nell’area centrale, la gran parte degli insediamenti si
trova all’interno di anelli concentrici ma discontinui di strade che terminano con il raccordo
principale lontano dal centro. La città possiede due linee di metropolitana che s’intersecano
nell’area centrale e servono principalmente quattro aree insediative a nord e nord est, a sud e
sud ovest. Le attività commerciali sono maggiormente concentrate nell’area centrale mentre
gli edifici pubblici e religiosi sono diffusi e spesso costituiscono una pluralità di centri sempre
all’interno del principale anello di raccordo stradale.
Il confronto tra il caso torinese e quello egiziano è dimensionalmente possibile se si
pensa che entrambe le principali superfici urbane possano quasi interamente essere racchiuse
in un rettangolo di 20 km di lato. Nonostante il sistema geografico sia quasi della stessa
dimensione, è importante sottolineare che negli stessi spazi la città del Cairo possiede dieci
volte la popolazione di Torino.
13
Figura 5 Confronto dimensionale tra le città del Cairo e di Torino (i lati neri misurano 20 km ciascuno).(a sinistra) Foto aeree
delle due città. (a destra) Composizione del’insieme delle circoscrizioni di Torino e delle aree amministrative della città del
Cairo (in quest’ultima l’area sottolineata da una linea bianca è la superficie dei quartieri che sono stati indagati). (fonte:
elaborazione dell’autore)
La città del Cairo si è sviluppata in modo incrementale e con alcuni specifici sviluppi
insediativi, ognuno con una forma e un carattere differente. Ciò ha prodotto una città fatta di
quartieri molto ben definiti e di “aree di transizione” che li mettono in relazione. Tra i
quartieri ben definiti sono state messe in evidenza le caratteristiche dell’area centrale (city
centre), di Shobra, di Heliopolis, di Nasr e di Mohandeseen.
L’area centrale (city center o garden city) è stata pianificata nella seconda metà
dell’ottocento con l’intento di imitare la morfologia di Parigi. Si tratta di una struttura radiale
che ha mantenuto limiti ben definiti come il Nilo a est, una strada di scorrimento a nord e la
città antica (Fatimid) a ovest. L’area di Shobra è stata progettata negli anni novanta per
collegare il Palazzo Reale al centro attraverso un asse stradale. Quest’ultimo, insieme con i
margini dei lotti agricoli sono diventati i segni generatrici del nuovo sviluppo insediativo
dell’area. Anche quest’area ha mantenuto fino ad oggi dei confini definiti dall’acqua, dalle
infrastrutture primarie e dalla ferrovia. L’area di Heliopolis (letteralmente la città del Dio Sole
o della luce) è una classica città satellite per il Cairo, nata intorno al 1910. Il principale
collegamento è dato da una nuova linea della metropolitana. La struttura urbana è
caratterizzata da assi stradali posti radialmente al cui incrocio sono spesso collocate degli
14
spazi autonomi. La cittadella di Heliopolis è una centralità non solo residenziale ma con
diversi servizi ed è solo parzialmente circoscritta dalle aree dell’aeroporto e da quelle militari
(ancora più ad est). L’area di Mohandeseen (appena fuori dall’area amministrativa del Cairo e
in cui sorgono le famose piramidi) nasce intorno al 1950 ed è il primo ampliamento progettato
ad ovest del Nilo. Rispetto alle trasformazioni precedenti dell’area nord-est, questo sviluppo
si è protratto negli anni e non ha mai raggiunto una densità ed omogeneità del tessuto urbano
ma è fatto di parti piuttosto differenti tra loro. La città di Nasr, la più recente (1960), è l’unica
progettata secondo una struttura rigidamente ortogonale con sottoaree e relativi centri. L’area
è circondata per gran parte dalle aree militari comuni anche al margine sud di Heliopolis.
Queste aree sono tra le principali e più caratteristiche del tessuto progettato del Cairo.
Dopo aver interpretato i principali settori del tessuto del Cairo ed averne definito l'epoca di
sviluppo, si è passati alla costruzione del modello configurazionale della morfologia
consolidata degli spazi progettati per una superficie totale che circonda e connette questi
cinque settori. Si tratta di una “finestra d’indagine” che potrebbe equivalere all’Area
Metropolitana della Città del Cairo e che è circoscritta dal principale collegamento anulare
della città (tipo tangenziale). La costruzione della mappa delle assialità è stata basata sulle
informazioni cartografiche “aperte” dell’Agenzia delle Entrate Egiziana, su mappe aeree del
2007, attraverso confronti con professionisti locali e infine con un sopralluogo nell'inverno
2012.
In termini generali, la lettura configurazionale mette in evidenza attraverso le misure
globali, i principali assi di collegamento e distribuzione del sistema osservato.
15
Figura 6 Mappa della configurazione della Città del Cairo (gli assi con colori più caldi hanno valori maggiori mentre
l’azzurro e il blu mostrano le aree più segregate). (sinistra) Secondo momento morfologico (post 1995): scelta globale e
(destra) scelta locale.
Nonostante i quattro insediamenti siano le aree più dense di assi, la configurazione
mostra che al loro interno vi sia una prevalenza di aree segregate. Ciò è dovuto alla natura
stessa delle scelte insediative di queste aree, nate velocemente per un’esigenza abitativa e
collegate in modo puntuale con il contesto globale della città. Inoltre porzioni interne sono ate
con forme autonome e introverse rispetto al contesto.
Se si osserva la centralità dell’integrazione (area di aggregazione dei valori più alti-
caldi) si nota che non è concentrata in nessuna delle aree insediative principali ma è
parzialmente a ridosso del “cuore” storico della città. In particolare, nell’area a nord dell’area
centrale (City Centre-Garden city) ma soprattutto adiacente alla città antica (Fatimid).
Nonostante la città antica non sia leggibile nella sua interezza per via della sua
rappresentazione cartografica compatta, ha mantenuto negli anni la vicinanza ai principali
spostamenti che interessano l’intera distribuzione della città.
Un secondo livello di assi più integrati si “diffonde” radialmente dal centro verso gli
insediamenti a nord est e est (Heliopolis e Nasr). Questi spazi rappresentano gli assi che
originariamente diedero avvio allo sviluppo degli insediamenti e che hanno mantenuto il loro
ruolo nel tempo. Sono invece più frammentati i percorsi che conducono agli insediamenti ad
ovest (Mohandeseen e Shobra). Si osservano anche in questo secondo livello d’integrazione,
raccordi anulari di strade che permettono alcuni collegamenti tra le aree (Shobra-Heliopolis-
Nasr). Questi collegamenti sono deboli ma molto importanti perché liberano le aree
insediative dalla dipendenza con il centro della città.
Se osserviamo la scala locale delle misure configurazionali, notiamo che ogni
insediamento ha uno o più assi di distribuzione posizionati in modo baricentrale al sistema di
assi (tranne l’area di Nasr che è adiacente all’asse principale di collegamento con l’aeroporto).
Questo è ancora più evidente se si osserva la mappa dell’integrazione con un raggio
d’indagine di 2000 metri. In questo dettaglio si mettono in evidenza le centralità locali e gli
spazi meglio serviti di ogni insediamento. Gli insediamenti con uno schema radiale hanno una
pluralità di centri mentre Heliopolis e Nars mostrano delle deboli prevalenze d’integrazione
locale. Ciò è dovuto alla struttura regolare del tessuto ma soprattutto al fatto che quest’ultimi
sono meglio connessi con il centro a discapito della formazione di centri locali di attrattività.
Infine alla scala locale non è evidente un sistema di centralità sull’area a ridosso della città
vecchia dato che invece emergeva alla scala globale. Ciò è dovuto alla rarefazione
d’informazioni configurazionali locali sulla forma, ovvero al fatto che questi spazi sono
caratterizzati da tessuti “informali” o non ben definiti.
16
E’ importante sottolineare che la ricostruzione del tessuto globale della città del Cairo
ha tenuto conto delle aree consolidate e del tessuto di spazi così come definito dai sistemi
informativi (GIS). Questi tessuti urbani sono importanti soprattutto per quanto riguarda i loro
confini che devono essere considerati come limiti nella lettura configurazionale. I margini
possono essere labili ma è molto importante che si riconosca nelle letture morfologiche la
differenza tra tessuti spontanei o informali e quelli consolidati così da poterne dare
un’opportuna rappresentazione e quindi comprensione. Gli esiti delle analisi configurazionali
hanno comunque attribuito a queste aree alti livelli d’integrazione nonostante le informazioni
deducibili dallo spazio siano solo parziali.
17
Figura 7 (in alto) Margini tra il tessuto spontaneo antico e tessuto degli spazi progettati (linea blu in pianta e bianca
nell’immagine aerea non zenitale) (fonte: elaborazione dell’autore). I margini sono in continua evoluzione, l’uno contamina
l’altro man mano che gli spazi delle strade e i percorsi sono ufficializzati e regolarizzati. (in basso) due immagini
rappresentativi della struttura urbana organizzata di Giza (destra) e della città antica (Fatimid) in cui non sono tracciate strade
ma è si compone di un intricato sistema di vicoli.
Alcune riflessioni sui confronti
Oltre al confronto diacronico e sincronico tra gli spazi urbani della stessa città,
un’ulteriore analisi può essere fatta attraverso l’accostamento delle misure sintattiche di
diversi casi studio. In questo paragrafo sono messe brevemente in evidenza le modalità con
cui è possibile approfondire la lettura dei dati osservati e misurati dalle mappe assiali del caso
studio di Torino e del Cairo, attraverso i grafici di regressione.
In particolare, sono state messe in relazione alcune misure (integrazione e connettività)
che mostrano la distribuzione dell’indicatore d’intellegibilità e di sinergia. Questi confronti
permettono di formulare delle ipotesi sulle caratteristiche della forma dello spazio considerato
ed eventualmente metterla in relazione con altri tessuti urbani.
L’intellegibilità permette di comprendere la semplicità con cui la forma di una città si
mostra all’osservatore, ovvero il modo in cui un sistema di spazi può essere più o meno facile
da osservare, percorrere e capire. L’intelligibilità è un indicatore di secondo livello ed è
rilevante nella formazione di nuovi tessuti urbani in quanto propedeutica alla formazione del
senso di appartenenza e dell’identità da parte degli utilizzatori finali.
La sinergia invece definisce il grado di relazione che le parti hanno con il tutto, ovvero
il legame che esiste tra le scelte locali e globali. La sinergia è rilevante per stabilire il peso o
l’influenza che una scelta globale ha in rapporto al sistema degli spazi locali e viceversa per
una trasformazione locale.
18
0.201583 1.77404
0
121 R² = 0.139678
Integration [HH]
Connectivity
0.210897 5.18236
0.201583
1.77404 R² = 0.598442
Integration [HH] R3
Integration [HH]
Figura 8 Grafici dell’indicatore di Intellegibilità (sinistra) e di Sinergia (destra), Torino 2010. Ogni punto equivale ad uno
spazio del sistema considerato e i colori caldi trasmetto i valori più alti della misura considerata mentre quelli freddi la più
bassa. (fonte: elaborazioni dell’autore)
Osservando i grafici dell’intellegibilità, si nota come la maggior parte degli spazi
(puntini del grafico) ha una distribuzione compatta che segue la linea detta di regressione. Ciò
significa che buona parte degli spazi del tessuto urbano dell’AMT torinese ha un buon livello
d’intellegibilità, con la maggior parte degli spazi che misurano tra un minimo di 0,2 e un
massimo di 1,2 (picco) d’intellegibilità. Questo tipo di distribuzione, omogenea è piuttosto
indifferente alla localizzazione di una funzione piuttosto che un uso. Nella progettazione di
nuove realtà, un tessuto come quello di Torino rende più difficile far emergere delle
specificità locali a causa della monotona omogeneità del suo tessuto. La formazione di nuove
e future centralità deve confrontarsi con i valori di picco del grafico per poter pesare ed
influenzare il sistema integrato torinese.
La sinergia invece mostra dei rapporti costanti tra le misure locali e globali del sistema
con una dispersione (ovvero una minore relazione) per quegli spazi (puntini blu tra 0,2 e 1,98)
che rappresentano il tessuto periurbano e distante del sistema (collina ma anche le aree
segregate di alcuni comuni di cintura). Tuttavia la pendenza della retta indica che le relazioni
tra le scelte che si fanno sulla quasi totalità dell’AMT o anche sugli interventi locali di una
sola circoscrizione, possono avere un reciproco effetto sul resto del sistema.
0.163669 2.97293
0
44 R² = 0.0425175
Integration [HH]
Connectivity
0.210897 4.21721
0.163669
2.97293 R² = 0.192663
Integration [HH] R3
Integration [HH]
Figura 9 Grafici dell’indicatore di Intellegibilità (sinistra) e di Sinergia (destra), Città del Cairo 2007. Ogni punto equivale ad
uno spazio del sistema considerato e i colori caldi trasmetto i valori più alti della misura considerata mentre quelli freddi la
più bassa. (fonte: elaborazioni dell’autore)
19
Passando alla lettura dei grafici dell’intellegibilità e della sinergia del sistema di spazi
della città del Cairo, si possono notare specifiche caratteristiche, in parte vicine alle letture sul
caso studio di Torino, nonostante la differenza di forma, sviluppo e uso delle due città. In
generale, l’indicatore d’intellegibilità del Cairo ha un andamento simile al tessuto urbano
torinese. Si nota, infatti, una concentrazione della maggior parte degli spazi in un intervallo
d’integrazione che misura da 0,16 fino 0,85. Ciò indica che gli spazi che si collocano in
questo insieme o nella vicinanza di questi valori sono difficili da percorrere, da capire e
spesso non favoriscono l’uso sociale degli spazi. In queste aree si concentrano solitamente le
zone residenziali. In questo caso, il tessuto non è indifferente alle funzioni presenti o che
possono insediarsi.
Tuttavia, i livelli di correlazione totali tra le misure dell’intellegibilità sono inferiori al
caso torinese (0,04 contro 0,13 dove 1 è il livello massimo) ma non come ci si potrebbe
aspettare da un tessuto contorto, privo di maglie ortogonali di distribuzione come quello
egiziano. Ciò significa, ad esempio, che Torino è più semplice da capire e percorre per un
turista rispetto al Cairo ma non in modo così significativo.
L’indicatore di sinergia degli spazi del tessuto del Cairo mostra un andamento simile a
quello di Torino ma senza interruzioni. Questo indica una migliore relazione tra globale e
locale del sistema di spazi del Cairo rispetto a Torino. Infatti, la correlazione tra i valori della
sinergia sono migliori nella lettura del Cairo che non in Torino (0,19 contro 0,59 dove 1 è il
valore migliore). Ciò, oltre ad essere alquanto sorprendente, è giustificato dal fatto che il
Cairo ha un sistema di spazi locali (gli insediamenti) strettamente dipendente dal nodo
centrale. Pertanto le modifiche (globali e locali) sono sensibili a questa dipendenza più che in
Torino. Il grafico della sinergia mostra, infatti, un ottimo livello di relazione tra i valori locali
e globali, con la quasi totalità dei valori con un andamento a rapporto costante.
Questi confronti tentano di contribuire a trovare le relazioni tra locale e globale anche
in contesti in cui la densità, la cultura e la storia sono così apparentemente differenti.
Conclusioni
Le riflessioni presentate in quest’ articolo sono frutto di un ragionamento ancora
iniziale ma che ha mostrato delle intenzioni determinate e un metodo di lavoro certo per il
futuro. Le misure delle analisi configurazionali stanno diventando un’analisi concreta e
riconosciuta e spesso nascono in studi settoriali ben definiti e ampiamente pubblicati. In
particolare, si ricorda lo studio sulle capacità sociali della forma urbana4, lo studio
sull’impatto della pedonalizzazione di uno spazio urbano5, lo studio sull’influenza della
4 Marcus, L., Spatial Capital and How to measure it: an outline of an analytical theory of the social performativity of urban form, 2007 5 Peponis J., Ozbil A., Bafna S. The Effects of Street Configuration on Transit Ridership, 2007
20
centralità nelle decentralizzazioni6, lo studio sulle dinamiche della congestione del traffico7 o
sulla frammentazione urbana negli insediamenti informali8. Inoltre, nella redazione di alcuni
complessi protocolli di valutazione urbana (ad esempio quello recente del Leed Neighborhood
Italia) sono inclusi caratteri e dimensioni riconducibili alle teorie della Sintassi dello Spazio
(Space Syntax).
La convinzione di fondo è che la condivisione degli studi sulla configurazione urbana
conduca ad una migliore interpretazione dell’indipendenza tran-scalare dei dati e della
correlazione delle dimensioni sintattiche con altri possibili impatti sulla città (economiche,
sociali ed ambientali). Il metodo di condivisione proposto amplifica la comprensione della
"morfologia sociale" passando attraverso una valutazione collettiva, costantemente
aggiornata. Con il tempo, il sedimentarsi di varie esperienze di analisi renderà forse possibile
arrivare a definire delle “misure limite” di configurazione che potranno magari essere una
guida per il monitoraggio e tutela delle trasformazioni territoriali al pari di altri fattori
sull’inquinamento o sull’efficientamento energetico.
Riconoscimenti
Lavoro svolto con il contributo economico del Centro SiTI (Istituto Superiore sui
Sistemi Territoriali per l’Innovazione).
Bibliografia
Hillier B., Space is the machine, a configurational theory of architecture, Cambridge
University Press, Cambridge (Capitolo II)1996.
Borra, S., Di Ciaccio, A., Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali, Milano,
McGraw-Hill, 2008
6 Ortiz-Chao C., Hiller B., In search of pattern of land –use in Mexico city. Logistic regression at the plot level. 2007 7 Nagel K., Schreckenberg M., A cellular automaton model for freeway traffic. Journal de Physique I 2 (12), 1992 8 Sobreira F. & Gomes M. City of Slums: self-organisation across scales, (CASA working paper) anche in proceeding International Conference on Complex Systems (ICCS2002), Nashua, NH, USA, June 9-14, 2002; vedi anche The logic of diversity: complexity and dynamic in spontaneous settlements Tesi di Dottorato Federal University of Pernanbuco.
21
ABSTRACT
Spatatial cofigurational analyses can be used to support decision affecting the design,
conservation or improvement of the urban city fabric. These analytic method allows to study
urban space transformation both diachronically and synchronically. Particularly, configuration
analyses focus on the relation between economic and social factors that are sensitive to
configuration choices of urban space.
The output of these analytic method must be easier to share and disseminate. This is
possible by means of crowd mapping syntactic data and share with all. The article describes
how to start this process through a pilot project. The goal is to encourage to share
configuration knowledge by clustering syntactic studies of a single territory and by
amplifying the potential of single analytic experience.