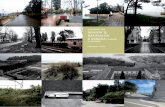Rassegna stampa 21 ottobre 2015 - WebDiocesi · della dignità e della purezza del ministero...
Transcript of Rassegna stampa 21 ottobre 2015 - WebDiocesi · della dignità e della purezza del ministero...
RASSEGNA STAMPA di mercoledì 21 ottobre 2015
SOMMARIO
La diffusione di notizie infondate è gravemente irresponsabile e non è degna di attenzione. Così il portavoce vaticano padre Federico Lombardi in risposta alla
notizia pubblicata e ripresa da diversi organi di stampa di una presunta patologia che avrebbe colpito Papa Francesco. Il Pontefice – sottolinea padre Lombardi - sta
svolgendo come sempre la sua attività intensissima.
L’Osservatore Romano pubblica oggi una riflessione di Pierangelo Sequeri sulla preghiera di intercessione di Mosè (cap. 32 dell’Esodo): “La grandezza del gesto di intercessione di Mosè sta nel rifiuto del privilegio che Dio gli accorda, al prezzo della
separazione del suo destino da quello della sua gente. Ammonisce duramente il popolo per la sua infedeltà a Dio, però, nello stesso tempo espone se stesso, di fronte a Dio, per la vita del popolo. Penso che si riveli qui una dimensione dell’intercessione
che deve sempre di nuovo istruire anche noi, figli della nuova alleanza. L’intercessione non oscura il giudizio di Dio sul peccato. Nondimeno, invoca la misericordia divina sul peccatore senza separare la propria vita dalla sua: non è enorme - anche religiosamente - questa esposizione solidale allo sguardo di Dio?
L’intercessione non innalza la sua preghiera dal luogo di una purezza separata, ma piuttosto da quello di un’affezione solidale. La preghiera di Mosè è il contrario di quella che ascoltiamo dal fariseo nella parabola di Gesù sul fariseo e il pubblicano. L’identificazione di fronte a Dio con il destino del popolo, come qualità essenziale della dignità e della purezza del ministero ecclesiastico - e dell’intero ministero evangelico della Chiesa - mi appare molto debole nella coscienza e nello stile
cristiano. I pastori devono esprimere nel modo più semplice e diretto la loro richiesta a Dio di non voler essere separati dal destino del popolo: nella buona e nella cattiva
sorte, in questa vita, e nell’accesso al regno in cui si compie la promessa della salvezza. Devono proclamare apertamente di non voler essere salvati senza di loro. Non hanno accettato, dalla vocazione, soltanto la gioia del ministero della salvezza, ma anche i suoi rischi. Il rischio di dover affrontare momenti di regressione e di oscuramento della fede: senza arrendersi, ma anche senza esasperare il proprio risentimento fino ad abbandonare il popolo al suo destino. Il rischio di dove
condividere lunghi periodi di smarrimento e di indifferenza nei confronti delle virtù elementari della convivenza: la passione per la giustizia, la custodia dei più deboli, la cura del bene comune. Il rischio - proprio a motivo della compassione nei confronti del popolo di Dio, che rimane destinatario delle promesse - di essere confusi con i
peccatori, indicati come complici del peccato, sospettati di cedimento all’incredulità e di tradimento della giustizia divina. Gesù, dopo essere stato rinchiuso nel
fraintendimento della sua mediazione solidale, fu inchiodato alla pretesa evidenza della sua condizione di bestemmiatore della giustizia divina e di complice della trasgressione della legge sacra. La fede cristiana proclama che egli portò questo scandalo fino in fondo, per amore di tutti gli uomini, senza scendere dalla croce e senza separarsi da noi, peccatori, che non abbiamo altra speranza se non questa. E cioè, la speranza che il Figlio stesso decida liberamente di sopportare anche questa estrema conseguenza dell’amore misericordioso di Dio: l’esperienza di sentirsi
giudicato, da coloro che si lasciano ispirare dalle potenze stesse del peccato, come un peccatore imperdonabile. Fino a patire in se stesso l’esperienza della lontananza di Dio. «Si è addossato i nostri dolori e noi l’abbiamo giudicato castigato» (Isaia, 53, 1-12: 4). La legge è capace di mediazione, ma non di intercessione. L’attitudine a congiungere direttamente la mediazione religiosa del sacro e l’esposizione di sé nell’intercessione per l’altro, è una questione di formazione e di stile cristiano
inconsapevolmente - ma gravemente - oscurata. L’interesse della sua riabilitazione, quale evidenza primaria dell’annuncio evangelico, non interessa esclusivamente la
trasparenza della testimonianza ecclesiale. Nell’odierno orizzonte della cultura e della società secolare, questa attitudine deve rappresentare anche una provocazione
importante per l’èthos civile. La domanda radicale sul potere («cosa giustifica il potere di un uomo su altri?») è avvolta, nell’epoca recente, da un generale
atteggiamento di sospetto e di critica. Il potere è certamente una figura di relazione molto complessa, che abita nel modo più diretto la sua affinità con le radici del divino, del sacro, della religione. Le democrazie moderne hanno sviluppato un
rapporto circolare fra il potere di rappresentanza e il potere di governo, nell’intento di trovare il punto di mediazione necessario a garantire l’autorità indispensabile al potere correggendone la deriva verso l’autogiustificazione. La problematica attuale del sistema, a fronte dello sviluppo di una società degli individui - per molti aspetti
coerente con la cultura della persona e della libertà - mostra i segni di un indebolimento della mediazione del potere nei confronti del legame sociale. La soluzione meramente procedurale - giuridica - di questa mediazione appare sotto molti aspetti inefficace e inadeguata. L’esempio di Mosè che abbiamo ricordato è
anche l’esempio di ciò che ultimamente giustifica la rappresentanza e l’esercizio del potere. La mediazione senza intercessione, il richiamo alla legge senza condivisione del rischio, la riserva di una via d’uscita privilegiata e parallela a quella dei fallimenti
che toccano il popolo, appaiono sempre più come un modo di legittimazione del potere destinato a produrre corruzione e a suscitare scandalo. Vale certamente per la comunità religiosa, vale anche - sempre più - per la comunità civile. L’intercessione
come atteggiamento mentale e pratico dell’accettazione di un destino comune comporta l’umiltà di riconoscersi, in ogni caso, come soggetti a un’istanza di giustizia e di giudizio che affonda le sue radici nel sacro, e da ogni lato ci supera. E impedisce alla mediazione di sostituirsi al fondamento, di farsi autoreferenziale, di perseguire
l’unico obiettivo di garantire se stessa. Una dimensione religiosa che ricupera fortemente questo tratto qualificante, che la rivelazione cristiana colloca nella mente e nel grembo stesso di Dio, introduce analoga umiltà e analogo spirito di dedizione nell’èthos delle politiche della convivenza civile. Sotto questo profilo, la rivoluzione
della tenerezza di Papa Francesco perde ogni ambigua connotazione retorica e sentimentale, per assumere il progetto di una vera e propria trasformazione del rapporto fra potere e rappresentanza nel senso più ampio possibile. Un uomo che dice: «Se non vuoi salvare questi, cancella anche me dal tuo libro della vita», non è semplicemente un uomo generoso, è un vero capo. «I grandi uomini e donne di Dio
sono stati grandi intercessori». È presto per dire in che modo questa ispirazione potrà produrre la svolta che ci è necessaria, nella Chiesa e nell’umana convivenza. Di certo, siamo già piuttosto in ritardo, quanto allo slancio costruttivo che le dovremo dedicare:
in primo luogo a vantaggio delle generazioni in arrivo” (a.p.)
2 – DIOCESI / PARROCCHIE IL GAZZETTINO Pag 17 Giubileo, a San Marco corsa ai restauri di Paolo Navarro Dina La Procuratoria impegnata a liberare dalle impalcature la facciata sulla piazza e a creare nuovi percorsi IL GAZZETTINO DI VENEZIA Pag XII Halloween, il parroco vieta la festa in patronato di Giorgia Pradolin Venezia, struttura negata a una mamma in cerca di uno spazio per ospitare trenta bambini 3 – VITA DELLA CHIESA L’OSSERVATORE ROMANO Pag 5 Il no di Mosè di Pierangelo Sequeri A Vienna il convegno su Papa Francesco e la rivoluzione della tenerezza / 1
Pag 5 Dal basso di Carlos Maria Galli A Vienna il convegno su Papa Francesco e la rivoluzione della tenerezza / 2 Pag 8 Il nome della suora Messa a Santa Marta CORRIERE DELLA SERA Pag 21 Le confessioni di Madre Teresa di Aldo Cazzullo Il missionario che fu padre spirituale della santa in India: “Anche lei tremava all’idea di morire” LA REPUBBLICA Pag 22 Carmelitani e gigolò, scontro in Vaticano: “Alla sbarra i religiosi” di Lorenzo D’Albergo e Orazio La Rocca Roma, il cardinale De Paolis contro Vallini: non basta allontanare i sacerdoti, serve un processo canonico. Il racconto dell’escort: “I miei incontri di sesso e droga con il superiore dell’Ordine” LA NAZIONE Pag 1 Il dovere di scriverlo di Andrea Cangini
Pagg 2 – 3 Il Papa è malato: un tumore curabile di Tommaso Strambi Francesco De Victoriis Piccola macchia scura nel cervello. È seguito dal professor Fukushima, della clinica San Rossore a Pisa IL FOGLIO Pag III Giù le mani da Paolo VI di Stephan Kampowski e David Crawford Studiosi giovanpaolini spiegano che archiviare l’Humanae vitae (come qualcuno chiede al Sinodo) implica che il Magistero papale si può cambiare. Rendendolo non vero WWW.CHIESA.ESPRESSONLINE.IT Napier, la voce della verità sulla lettera dei tredici cardinali di Sandro Magister C'è voluto questo arcivescovo sudafricano per chiarire pubblicamente le vere ragioni della lettera, di cui è uno dei firmatari. Tutto nasce nel sinodo del 2014 e nelle manovre di alcuni per forzarne gli esiti. Ecco testuali le sue parole 5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO AVVENIRE Pag 1 Il più umano dei diritti di Carlo Cardia IL GAZZETTINO Pag 23 Convivenze di fatto e unioni civili: la soluzione in legislazioni diverse di Ennio Fortuna 7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA CORRIERE DEL VENETO Pagg 2 – 4 “Figlie mie, non saremo un peso”. A 95 anni uccide la moglie e si spara di Davide Tamiello, Alice D’Este, Andrea Priante e Jacopo Lodde Ernesto e la sua Loredana, costruttori e benefattori: “Ci diedero centomila euro per fare un centro anziani”. Tre colpi tra la folla dell’ospedale: le grida, la paura, i pazienti in fuga. Il lucido gesto di menti stanche, un’eutanasia emotiva Pag 6 Mose di Alberto Zorzi Dall’inchiesta emerge che i cassoni venivano pagati il doppio del costo e oltre al guadagno veniva fatta pure la “cresta” per creare fondi neri
LA NUOVA Pag 1 Il sistema mazzette di Mazzacurati di Renzo Mazzaro Pag 4 “Un grande benefattore dei Centri Don Vecchi” di Giacomo Costa La tragedia di Mestre: don Armando Trevisiol ricorda le difficoltà e la generosità dell’ingegnere IL GAZZETTINO DI VENEZIA Pagg VI – VIII “Era malato, ma ci aiutava” di Fulvio Fenzo Don Armando Trevisiol ricorda Cecchinato. I famigliari: “Ernesto, un filantropo che era stanco di lottare” 8 – VENETO / NORDEST CORRIERE DEL VENETO Pag 1 Il Nordest corre con il digitale di Sandro Mangiaterra Competitività, la nuova sfida … ed inoltre oggi segnaliamo… CORRIERE DELLA SERA Pag 1 Il partito che Renzi non ha di Ernesto Galli della Loggia Il Pd e il governo Pag 33 Tre considerazioni contro la guerra in Medio Oriente di Carlo Rovelli Dubbi morali e politici LA REPUBBLICA Pag 1 La strada corta di Salvini di Stefano Folli AVVENIRE Pag 3 Figli e consumi degli altri, la crisi del modello tedesco di Massimo Calvi Volkswagen, export, demografia: perché Berlino trema LA NUOVA Pag 13 La corsa del premier equilibrista di Fabio Bordignon Pag 14 Erri De Luca e la libertà di opinione di Giovanni Palombarini
Torna al sommario 2 – DIOCESI / PARROCCHIE IL GAZZETTINO Pag 17 Giubileo, a San Marco corsa ai restauri di Paolo Navarro Dina La Procuratoria impegnata a liberare dalle impalcature la facciata sulla piazza e a creare nuovi percorsi Il conto alla rovescia è già iniziato. L’appuntamento è fissato per il 13 dicembre quando si aprirà la Porta Santa. E da allora, quasi a sette giorni dall’apertura di quella romana a San Pietro, anche Venezia darà il proprio contributo al Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. E per arrivare a quella data, la Procuratoria di San Marco, l’ente che sovraintende all’edificio della Basilica sta facendo i salti mortali. Uno sforzo impegnativo con più obiettivi: riuscire quanto prima a liberare la facciata sulla Piazza impegnata da molti anni dalla "solite" impalcature, ma soprattutto garantire l’accoglienza nel Tempio marciano. Tutto questo contando sulle proprie forze e sui propri denari. Perché la Basilica "costa" ben 4 milioni di euro di manutenzione all’anno. Tanto per lanciare un
segnale ulteriore al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi sulla specificità di Venezia. «Già, quattro milioni tondi tondi - spiega il Procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin - per tutelare un bene straordinario come la Basilica. La Procuratoria inoltre dà lavoro ad un’ottantina di persone. Avremmo potuto rivelarlo anche a Renzi...». Nonostante il "peso" del bilancio, l’attività ferve soprattutto nell’organizzazione del Giubileo. «Seguendo le linee del Patriarca Moraglia - sottolinea Tesserin - abbiamo messo a punto una serie di operazioni di restauro e abbellimento. Innanzitutto cominceremo dalle millenarie Porto d’accesso alla Basilica. Verranno restaurate e ripulite. Poi è stato scelto il percorso di ingresso. Si entrerà dalla Porta di San Clemente, con un nuovo percorso verso il Battistero e la Fonte battesimale, ma quello che più emergerà sarà il Cristo Pantocratore e gli Evangelisti, nella Cupola. Qui è prevista un’operazione di pulizia per far risaltare ancor più questo capolavoro in mosaico». Altre operazioni in vista dell’Anno Santo riguarderanno la Croce Centrale sotto la grande Cupola e la Lampada Votiva. Entrambe verranno restaurate, ripulite e rimesse in ordine. «Inoltre - aggiunge Tesserin - stiamo realizzando un nuovo percorso interno che consentirà di valorizzare al culto l’icona bizantina della "Madonna del Bacio" molto cara alla tradizione e ai fedeli veneziani. In questo frangente stiamo anche risistemando l’antico pavimento che porta al Tesoro di San Marco. Contiamo di concludere questa delicata operazione entro il prossimo giugno». Ma non è tutto. Ci saranno novità anche per le facciate fin troppo spesso occupate da impalcature e restauri. «Contiamo di liberare la facciata principale quanto prima come ci ha chiesto anche il Patriarca - sottolinea il Procuratore - Ma allo stesso tempo la nostra operazione di salvaguardia continuerà. Daremo il via ai restauri delle facciate Sud e Ovest della Basilica con un importo che si aggirerà sul milione di euro tenuto conto anche dei costi dell’Iva. Uno sforzo notevole, ma indispensabile per difendere un edificio fin troppo aggredito dalle acque alte e anche dal turismo di massa»». Infine a completamento del progetto "Anno Santo" arriverà il decimo Quaderno di San Marco a cura di Irene Favaretto, interamente dedicato al Ciborio bizantino. «Come dire - sorride Tesserin - Una ciliegina sulla torta». IL GAZZETTINO DI VENEZIA Pag XII Halloween, il parroco vieta la festa in patronato di Giorgia Pradolin Venezia, struttura negata a una mamma in cerca di uno spazio per ospitare trenta bambini Trenta bambini di Cannaregio cercano una saletta per la festina del 31 ottobre. Impossibile rivolgersi a parrocchie e patronati, troppo chiasso e i vicini si lamentano, senza contare che Halloween è una festa pagana e quindi, permesso completamente negato dal parroco. Il motivo? Troppo rumore e in più Halloween è una festa diseducativa. Si riaccende dunque il dibattito su questa festa importata dai Paesi anglosassoni e considerata "pagana" se paragonata alla ricorrenza cristiana dei defunti. «Ci lamentiamo che Venezia si sta spopolando e diventa una città per soli vecchi - spiega una mamma, Giulia Todaro - ma se i piccoli non possono più giocare nemmeno in patronato, o fare le festine al pomeriggio, dove possono andare?». I fatti. Una settimana fa alcune famiglie hanno iniziato la ricerca di una saletta per organizzare la festicciola dei bimbi nel pomeriggio di sabato 31 ottobre tra addobbi, dolcetti, un po’ di musica e forse qualche costume. I genitori si sono subito rivolti alle parrocchie del sestiere che però hanno rifiutato. «Abbiamo provato a chiedere alla parrocchia di San'Alvise, Madonna dell'Orto e San Marcuola - spiega la mamma - tutte ci hanno dato la stessa risposta: troppo rumore e i vicini si lamentano, qualcuno in passato ha sporto anche querela. Festine vietate anche a Villa Groggia e, da quando se ne sono andate le suore Canossiane, anche lo spazio del convento di Sant'Alvise è stato chiuso ai veneziani». Il parroco di Sant'Alvise e San Marcuola, don Stefano Costantini, conferma. «Il problema è che i vicini del patronato di San Marcuola si sono lamentati per le feste precedenti e abbiamo dovuto interromperle. Il patronato di Sant'Alvise si trova nella stessa situazione, perché è circondato dalle abitazioni. In ogni caso - aggiunge il parroco - se mi avessero detto che si trattava di una festa di Halloween non l'avrei comunque autorizzata perché per noi è diseducativa, contraria ai valori cristiani: pone l'accento sulla morte vista in maniera irrisoria e distoglie dal vero significato di quel giorno, la festa di tutti i Santi e la commemorazione dei defunti». Niente Halloween a prescindere
quindi, discorso diverso per i compleanni dei bimbi: «Parleremo con i parrocchiani - aggiunge don Stefano - per capire cosa è possibile fare». Al momento, le trenta famiglie lanciano un appello: «Oramai - afferma Todaro - al 31 ottobre mancano pochi giorni e non sappiamo dove rivolgerci per poter trascorrere un pomeriggio di festa con i nostri bimbi che ci sperano molto, e resteranno delusi. L'unica sala solitamente disponibile nel sestiere, quella a Santa Lucia, era già stata prenotata. Se qualcuno ha un luogo da proporci ci contatti via Facebook». Torna al sommario 3 – VITA DELLA CHIESA L’OSSERVATORE ROMANO Pag 5 Il no di Mosè di Pierangelo Sequeri A Vienna il convegno su Papa Francesco e la rivoluzione della tenerezza / 1 Si è svolto dal 15 al 17 ottobre presso l’università di Vienna il congresso internazionale sul tema «Papa Francesco e la rivoluzione della tenerezza dell’amore». I lavori sono stati introdotti da un messaggio inviato dal cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo metropolita di Vienna (impegnato al sinodo), il quale ha sottolineato come «con l’esortazione apostolica Evangelii gaudium Papa Francesco ha presentato il documento programmatico della riforma della Chiesa che si propone di realizzare». Questo documento - ha aggiunto il cardinale - «ha sullo sfondo il concilio Vaticano II, con uno sguardo sul presente» ed è caratterizzato «da una visione teologica che permea anche l’intero pontificato. Ciò è emerso dai primi passi verso la riforma della Curia e continua a valere dinanzi alle grandi sfide. In questo dà buoni risultati il valido atteggiamento gesuita di consultarsi a lungo e poi decidere con chiarezza». Pubblichiamo stralci dagli interventi di Pierangelo Sequeri, preside della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, e di Carlos María Galli, decano della facoltà di teologia di Buenos Aires, pubblicati integralmente sul sito dell’Osservatore Romano. Nel libro biblico dell’Esodo si trova una pagina di impressionante bellezza, che non posso leggere senza provare ogni volta una forte emozione. L’episodio che racconta è connesso con il momento drammatico del ritorno dell’idolatria nell’esperienza del popolo dell’alleanza in cammino verso la terra promessa. Dio stesso annuncia a Mosè il tradimento del popolo: mentre egli riceveva le tavole della legge che doveva sigillare l’alleanza con Dio, il popolo convinceva Aronne a consentire la costruzione di un idolo da adorare. «Lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece, farò una grande nazione», dice Dio a Mosé (Esodo, 32, 10; cfr. Deuteronomio, 9, 13-14). La risposta di Mosè è semplice, abile, grandiosa. «Perché dovranno dire gli Egiziani: con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra?» (Esodo, 32, 12a). E poi, il Dio che ha promesso ai Padri una lunga discendenza, verrà forse meno alla sua parola? In ogni caso, ribadisce Mosè, è vero che il popolo ha commesso un grave peccato: però, se non puoi perdonarli, «cancella anche me dal tuo libro». Il risultato - come sappiamo - sarà un lungo passaggio attraverso le prove della storia, che lo stesso Mosè dovrà condividere: ma il popolo non verrà distrutto. La grandezza del gesto di intercessione di Mosè sta nel rifiuto del privilegio che Dio gli accorda, al prezzo della separazione del suo destino da quello della sua gente. Ammonisce duramente il popolo per la sua infedeltà a Dio, però, nello stesso tempo espone se stesso, di fronte a Dio, per la vita del popolo. Penso che si riveli qui una dimensione dell’intercessione che deve sempre di nuovo istruire anche noi, figli della nuova alleanza. L’intercessione non oscura il giudizio di Dio sul peccato. Nondimeno, invoca la misericordia divina sul peccatore senza separare la propria vita dalla sua: non è enorme - anche religiosamente - questa esposizione solidale allo sguardo di Dio? L’intercessione non innalza la sua preghiera dal luogo di una purezza separata, ma piuttosto da quello di un’affezione solidale. La preghiera di Mosè è il contrario di quella che ascoltiamo dal fariseo nella parabola di Gesù sul fariseo e il pubblicano. L’identificazione di fronte a Dio con il destino del popolo, come qualità essenziale della dignità e della purezza del ministero ecclesiastico - e dell’intero ministero evangelico
della Chiesa - mi appare molto debole nella coscienza e nello stile cristiano. I pastori devono esprimere nel modo più semplice e diretto la loro richiesta a Dio di non voler essere separati dal destino del popolo: nella buona e nella cattiva sorte, in questa vita, e nell’accesso al regno in cui si compie la promessa della salvezza. Devono proclamare apertamente di non voler essere salvati senza di loro. Non hanno accettato, dalla vocazione, soltanto la gioia del ministero della salvezza, ma anche i suoi rischi. Il rischio di dover affrontare momenti di regressione e di oscuramento della fede: senza arrendersi, ma anche senza esasperare il proprio risentimento fino ad abbandonare il popolo al suo destino. Il rischio di dove condividere lunghi periodi di smarrimento e di indifferenza nei confronti delle virtù elementari della convivenza: la passione per la giustizia, la custodia dei più deboli, la cura del bene comune. Il rischio - proprio a motivo della compassione nei confronti del popolo di Dio, che rimane destinatario delle promesse - di essere confusi con i peccatori, indicati come complici del peccato, sospettati di cedimento all’incredulità e di tradimento della giustizia divina. Gesù, dopo essere stato rinchiuso nel fraintendimento della sua mediazione solidale, fu inchiodato alla pretesa evidenza della sua condizione di bestemmiatore della giustizia divina e di complice della trasgressione della legge sacra. La fede cristiana proclama che egli portò questo scandalo fino in fondo, per amore di tutti gli uomini, senza scendere dalla croce e senza separarsi da noi, peccatori, che non abbiamo altra speranza se non questa. E cioè, la speranza che il Figlio stesso decida liberamente di sopportare anche questa estrema conseguenza dell’amore misericordioso di Dio: l’esperienza di sentirsi giudicato, da coloro che si lasciano ispirare dalle potenze stesse del peccato, come un peccatore imperdonabile. Fino a patire in se stesso l’esperienza della lontananza di Dio. «Si è addossato i nostri dolori e noi l’abbiamo giudicato castigato» (Isaia, 53, 1-12: 4). La legge è capace di mediazione, ma non di intercessione. L’attitudine a congiungere direttamente la mediazione religiosa del sacro e l’esposizione di sé nell’intercessione per l’altro, è una questione di formazione e di stile cristiano inconsapevolmente - ma gravemente - oscurata. L’interesse della sua riabilitazione, quale evidenza primaria dell’annuncio evangelico, non interessa esclusivamente la trasparenza della testimonianza ecclesiale. Nell’odierno orizzonte della cultura e della società secolare, questa attitudine deve rappresentare anche una provocazione importante per l’èthos civile. La domanda radicale sul potere («cosa giustifica il potere di un uomo su altri?») è avvolta, nell’epoca recente, da un generale atteggiamento di sospetto e di critica. Il potere è certamente una figura di relazione molto complessa, che abita nel modo più diretto la sua affinità con le radici del divino, del sacro, della religione. Le democrazie moderne hanno sviluppato un rapporto circolare fra il potere di rappresentanza e il potere di governo, nell’intento di trovare il punto di mediazione necessario a garantire l’autorità indispensabile al potere correggendone la deriva verso l’autogiustificazione. La problematica attuale del sistema, a fronte dello sviluppo di una società degli individui - per molti aspetti coerente con la cultura della persona e della libertà - mostra i segni di un indebolimento della mediazione del potere nei confronti del legame sociale. La soluzione meramente procedurale - giuridica - di questa mediazione appare sotto molti aspetti inefficace e inadeguata. L’esempio di Mosè che abbiamo ricordato è anche l’esempio di ciò che ultimamente giustifica la rappresentanza e l’esercizio del potere. La mediazione senza intercessione, il richiamo alla legge senza condivisione del rischio, la riserva di una via d’uscita privilegiata e parallela a quella dei fallimenti che toccano il popolo, appaiono sempre più come un modo di legittimazione del potere destinato a produrre corruzione e a suscitare scandalo. Vale certamente per la comunità religiosa, vale anche - sempre più - per la comunità civile. L’intercessione come atteggiamento mentale e pratico dell’accettazione di un destino comune comporta l’umiltà di riconoscersi, in ogni caso, come soggetti a un’istanza di giustizia e di giudizio che affonda le sue radici nel sacro, e da ogni lato ci supera. E impedisce alla mediazione di sostituirsi al fondamento, di farsi autoreferenziale, di perseguire l’unico obiettivo di garantire se stessa. Una dimensione religiosa che ricupera fortemente questo tratto qualificante, che la rivelazione cristiana colloca nella mente e nel grembo stesso di Dio, introduce analoga umiltà e analogo spirito di dedizione nell’èthos delle politiche della convivenza civile. Sotto questo profilo, la rivoluzione della tenerezza di Papa Francesco perde ogni ambigua connotazione retorica e sentimentale, per assumere il progetto di una vera e propria trasformazione del rapporto fra potere e rappresentanza nel senso
più ampio possibile. Un uomo che dice: «Se non vuoi salvare questi, cancella anche me dal tuo libro della vita», non è semplicemente un uomo generoso, è un vero capo. «I grandi uomini e donne di Dio sono stati grandi intercessori» (Evangelii gaudium, 283). È presto per dire in che modo questa ispirazione potrà produrre la svolta che ci è necessaria, nella Chiesa e nell’umana convivenza. Di certo, siamo già piuttosto in ritardo, quanto allo slancio costruttivo che le dovremo dedicare: in primo luogo a vantaggio delle generazioni in arrivo. Pag 5 Dal basso di Carlos Maria Galli A Vienna il convegno su Papa Francesco e la rivoluzione della tenerezza / 2 Nella Lumen gentium il concilio Vaticano II esprime una nuova coscienza ecclesiologica. L’unità dinamica dei due primi capitoli, articolati con la struttura di un dittico, risponde alle macro-categorie Mistero e Popolo. Francesco ha manifestato la sua preferenza per questa categoria, come ha confermato nell’Evangelii gaudium. Con Francesco avviene un duplice ritorno del Popolo di Dio che irrompe in modo nuovo sulla scena, come si osserva a Piazza San Pietro e nei viaggi apostolici. Tale legittimità dal basso, a partire dall’affetto del popolo credente, si aggiunge alla legittimità dall’alto data per opera dello Spirito nell’elezione e nella guida del suo ministero. La Chiesa con volto latinoamericano vive un kairòs singolare. Lo Spirito Santo «soffia dove vuole» (Giovanni, 3, 8) e ha soffiato come «una forte raffica di vento» (Atti degli apostoli, 2, 2). Il nuovo Papa è stato eletto quando le periferie del mondo (orbi) sono apparse nel cuore della città (urbs). Francesco rappresenta l’arrivo del global south nel cuore della Chiesa e anche del mondo, come abbiamo visto nella sua visita all’Onu. La Chiesa cresce nel sud del mondo. Negli ultimi cento anni si è verificata un’inversione nella composizione del cattolicesimo. Nel 1910 il 70 per cento dei battezzati cattolici viveva nel nord e il 30 nel sud. Nel 2010 il 32 per cento viveva nel nord (24 in Europa, 8 in Nord America) e il 68 nei continenti del sud: 39 in America Latina, 16 in Africa, 12 in Asia, 1 in Oceania. Dopo un primo millennio segnato dalle Chiese orientali e un secondo diretto dalla Chiesa occidentale si intravede un terzo millennio rivitalizzato dalle Chiese del sud in una cattolicità interculturale incentrata teologalmente nella Chiesa di Roma e con una dinamica policentrica. Il ritorno del Popolo di Dio comprende il ritorno di varie questioni ecclesiali conciliari: il sensus fidei di tutti i credenti; le iniziative delle Chiese locali; le strutture collegiali e sinodali; il dialogo ecumenico e interreligioso; la missione permanente in tutte le periferie; il posto dei poveri nella Chiesa; uno sguardo rinnovato sulla famiglia come Chiesa domestica; la chiamata ai teologi a essere figli del loro popolo, credenti e profeti, a pensare pregando e pregare pensando, insieme con un rapporto istituzionale più rispettoso verso di loro; la lotta contro il clericalismo e il centralismo; i legami fraterni dei ministri ordinati con tutti i fedeli - uomini e donne perché «i laici sono, semplicemente, l’immensa maggioranza del Popolo di Dio. Al loro servizio c’è una minoranza: i ministri ordinati» (Evangelii gaudium, 102). La teologia argentina ha compreso il mondo del quale parla il Concilio attraverso le realtà del popolo e della sua cultura. Ha pensato al popolo come un soggetto storico collettivo e come un luogo ermeneutico per leggere i segni dei tempi. Nella visita del Papa agli Stati Uniti e ad altri Paesi abbiamo visto che lui entra nel cuore della cultura popolare. La nostra teologia ha nutrito ciò che è popolare con un concetto teologico che proveniva dall’ecclesiologia del Vaticano II. La Facoltà di Teologia di Buenos Aires, che compie cento anni, è stata pioniera nel commentare la Lumen gentium nel 1965. La corrente argentina non è stata conosciuta. Il grande pubblico europeo ha conosciuto solo le opere dei teologi latinoamericani più famosi. Un’eccezione è stata il riconoscimento da parte dei grandi teologi tedeschi. Noi cogliamo dalla Lumen gentium il Popolo di Dio come colui che cammina con i popoli nella storia. Su questa strada la nostra teologia si è dedicata a pensare le relazioni tra il Popolo di Dio e le culture dei popoli. Per Francesco «questo Popolo di Dio si incarna nei popoli della terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura» (Evangelii gaudium, 115). La sezione «un popolo dai molti volti» (115-118) sviluppa l’immagine del volto in senso ecclesiologico per fondare l’inculturazione interculturale della Chiesa. «Nei diversi popoli che sperimentano il dono di Dio secondo la propria cultura, la Chiesa esprime la sua autentica cattolicità e mostra “la bellezza di questo volto pluriforme”» (116). La storia mostra che il Cristianesimo, costituito secondo la logica dell’incarnazione del Figlio di
Dio, acquisisce diversi volti culturali. «Non farebbe giustizia alla logica dell’incarnazione pensare in un Cristianesimo monoculturale e monocorde» (117). Ogni processo di inculturazione genera nuove espressioni di fede e di Chiesa secondo la tradizione di ogni popolo. La Chiesa cresce per «i diversi popoli nei quali si è inculturato il Vangelo» (122). Francesco è un nuovo inizio della riforma promossa dal Concilio. La ricezione del Vaticano II e la riforma della Chiesa sono entrate in una nuova fase. Al Papa interessa la continuità della riforma. Egli sostiene che il Concilio abbia operato una rilettura del Vangelo alla luce della cultura contemporanea e tale dinamica sia assolutamente irreversibile. Francesco invita alla riforma a partire dalla «freschezza originale del Vangelo» (11). Dice che «il concilio Vaticano II ha presentato la conversione ecclesiale come l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo» (26). La riforma della Chiesa nasce dalla sua radice evangelica per essere più fedele a Cristo. Francesco unifica l’interpretazione dell’ecclesiologia conciliare accomunando Lumen gentium, Gaudium et spes e Ad gentes perché non si possono separare il Popolo di Dio e la sua missione nel mondo. Dice: «Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo» (Evangelii gaudium, 111-134). E riprende la formula «tutti siamo discepoli missionari» (119-121), formulato nella Conferenza di Aparecida, dove ho collaborato con lui come perito teologico. La riforma è la conversione missionaria di tutto il Popolo di Dio e di tutti nel Popolo di Dio. Francesco vuole «la riforma della Chiesa in uscita missionaria» (17), una «pastorale in conversione» (25-33), una «conversione missionaria» (30). E sottolinea: «Spero che tutte le comunità cerchino di usare i mezzi necessari per avanzare nel cammino della conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno» (25). L’azione missionaria è il paradigma di tutta la Chiesa. «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa (...). La riforma delle strutture che esige la conversione pastorale si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie» (Evangelii gaudium, 27). Chiama a riformare le strutture ecclesiali «affinché diventino più missionarie» (27), includendo la conversione del Papato e del governo centrale della Chiesa (32). Questa dinamica dovrà impregnare la forma storica della Chiesa. Si può constatare quindi l’importanza del progetto della Conferenza di Aparecida (2007) perché il Papa prende alcune delle sue linee e le rilancia in un modo strategico nel suo programma riformatore. Ma egli non intende esportare un modello latinoamericano ma vuole che ogni Chiesa assuma la missione in modo inculturato nel proprio tempo e nel proprio luogo. Con Francesco la dinamica della conversione missionaria della periferia latinoamericana dà il suo contributo alla riforma dell’intera Chiesa. Pag 8 Il nome della suora Messa a Santa Marta Non abbiamo «un Dio meschino» e neppure «un Dio fermo». Il nostro è «un Dio che esce» per «cercare ognuno di noi». E quando ci trova, «ci abbraccia, ci bacia», perché è «un Dio che fa festa» e in cielo si fa «più festa per un peccatore che si converte» che «per un centinaio che rimangono giusti». Su questo amore «senza misura» del Padre il Pontefice è tornato nell’omelia della messa celebrata a Santa Marta martedì mattina, 20 ottobre. Come di consueto Francesco ha preso spunto dalle letture della liturgia, in particolare dal brano della lettera ai Romani (5,12.15.17-19.20-21) nel quale san Paolo ricorda che «come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti». Si tratta - ha fatto notare il Papa - di «un riassunto della storia della salvezza», nel quale l’apostolo «ci dice come salva Dio, come ci ha salvati, come ci salva: come dà la salvezza che è l’amicizia fra noi e lui». Il Pontefice ha collegato questo passo a quello della liturgia del giorno precedente, nel quale - ha rammentato - «abbiamo parlato dell’elemosina, abbiamo detto che Dio dà senza misura: dà se stesso, il suo Figlio». Anche stavolta il discorso verte su «questa idea: come dà Dio, in questo caso l’amicizia, la salvezza tutta nostra?». La risposta del Pontefice è che Dio «dà come dice che darà a noi quando facciamo un’opera buona: ci darà una misura buona, pigiata, colma, traboccante». Una generosità che richiama alla mente il concetto di «abbondanza». E non a caso, ha osservato Francesco, «questa
parola “abbondanza” in questo brano viene ripetuta tre volte». Dunque «Dio dà nell’abbondanza». Tant’è vero che Paolo, a mo’ di «riassunto finale» del suo discorso, afferma: «Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia». Ecco com’è «l’amore di Dio: senza misura. Tutto se stesso». Egli infatti, ha ricordato il Papa, «inviò suo Figlio, si abbassò per farsi compagno di strada, per camminare con noi: lui stesso camminò con noi, dall’inizio con il suo popolo». Cosa significa allora «questa sovrabbondanza di darsi che è l’amore di Dio»?. Significa che «Dio non è un Dio meschino: lui non conosce la meschinità, lui dà tutto». Significa ancora che «Dio non è un Dio fermo: egli guarda, aspetta che noi ci convertiamo». In sostanza, ha sottolineato il Pontefice, «Dio è un Dio che esce: esce a cercare, a cercare ognuno di noi». Ogni giorno «lui ci cerca, ci sta cercando», come fa il pastore con la «pecora smarrita» o la donna con la «moneta perduta». Dio «cerca: sempre e così. Dio aspetta attivamente. Mai si stanca di aspettarci». Il suo atteggiamento è quello del «padre vecchio» che «ha visto venire, rientrare il figlio da lontano» e subito gli è andato incontro «ad abbracciarlo». Anche «Dio ci aspetta: sempre, con le porte aperte». Perché il suo cuore «non è chiuso: è sempre aperto». E «quando noi arriviamo come quel figlio, ci abbraccia, ci bacia: un Dio che fa festa». Gesù «lo dice esplicitamente parlando della giustificazione, cioè dei peccati perdonati: ci sarà più festa in cielo per un peccatore che si converte che per un centinaio che rimangono giusti». Questo «è l’amore di Dio; Dio ci ama così, senza misura». Certo, ha riconosciuto Francesco, «non è facile, con i nostri criteri umani - siamo piccoli, noi, limitati - capire l’amore di Dio. Possiamo capire in questi gesti del Signore questa sovrabbondanza, ma capire tutto non è facile». In proposito il Papa ha rievocato la figura di una religiosa conosciuta durante il suo ministero a Buenos Aires. Era «una suora anziana, molto anziana, che tutta la vita aveva lavorato in un reparto dell’ospedale, e ancora lavorava lì» Aveva «più di 84 anni» ma lavorava «sempre con il sorriso. Aveva sicuramente l’esperienza dell’amore di Dio, perché parlava sempre dell’amore di Dio e faceva sentire questo amore». Per questo «le avevano dato un soprannome»: la chiamavano «la suora amore-di-Dio». Ed è «una grazia», ha commentato il Pontefice, «trovare questa gente, questi santi, a cui il Signore ha dato il dono di capire questo mistero, questa sovrabbondanza del suo amore». Resta il fatto che «noi sempre abbiamo l’abitudine di misurare le situazioni, le cose con le misure che noi abbiamo: e le nostre misure sono piccole». Per questo - ha raccomandato Francesco - «ci farà bene chiedere allo Spirito Santo la grazia, pregare lo Spirito Santo, la grazia di avvicinarci almeno un po’ per capire questo amore e avere la voglia di essere abbracciati, baciati con quella misura senza limiti». San Paolo, in realtà, «aveva capito quanto brutto fosse il peccato, ma quanto grande fosse la sovrabbondanza dell’amore di Dio. A tal punto che si sente piccolo e in un momento, mosso dallo Spirito Santo, chiama Dio “papà”». Abitualmente «parla del Padre, il Padre», ma «in un momento dice: papà». Dunque, ha ribadito il Papa, «grazie allo Spirito posso dirgli “papà”». Da qui l’invito conclusivo: «Chiediamo la grazia di sentire questo amore, che è un amore di papà, un grande amore, senza limiti». CORRIERE DELLA SERA Pag 21 Le confessioni di Madre Teresa di Aldo Cazzullo Il missionario che fu padre spirituale della santa in India: “Anche lei tremava all’idea di morire” Calcutta. Ma quali peccati aveva mai da confessare madre Teresa? «Siamo tutti peccatori. Don Bosco, padre di noi salesiani, che era un santo potentissimo, capace di guarire i moribondi e - se avesse voluto - di far morire i sani, si confessava ogni settimana. Madre Teresa avvertiva questa necessità più di rado, e mi confidava cose che ovviamente conosce e conoscerà solo il Signore. Parlavamo in inglese, perché lei non ha mai imparato l’italiano. Posso raccontare questo: quando madre Teresa si sentì prossima alla fine, e l’arcivescovo di Calcutta mi mandò a chiamare perché le impartissi l’estrema unzione, anche lei aveva timore di morire. E tremava. La morte è terribile per tutti. Anche lei che era una santa, che aveva visto morire migliaia di derelitti, che era certa della vita ultraterrena così come era certa che il sole sorge e tramonta, anche lei aveva timore. Non paura; trepidazione, ecco. Trepidazione di presentarsi davanti a Dio. Il bello fu che quella volta non morì…». In un Paese un po’ più consapevole di se stesso di
quanto non sia l’Italia di oggi, padre Rosario Stroscio sarebbe un eroe nazionale. L’ultimo, o uno degli ultimi, missionari cattolici ancora vivi e attivi in India, che da tempo ai missionari ha chiuso le frontiere. Le suore ne parlano come di un santo. Anche l’erede di madre Teresa, Mechthild Pierick, tedesca di Munster che qui a Calcutta ha assunto il nome indiano di Prema, Amata, dice che dobbiamo assolutamente andare a trovarlo, finché siamo in tempo: «Ha quasi 94 anni, e una storia straordinaria da raccontare. Abita qui vicino, nella chiesa che lui stesso ha costruito, dopo aver prosciugato una palude». Padre Rosario Stroscio è un siciliano di Furnari, alle pendici dell’Etna. E’ quasi cieco da un occhio ma non ha perso un capello. Ha un abbraccio vigoroso e uno spiccato senso dell’umorismo. Oltre alla chiesa ha fatto erigere due statue ai santi della sua vita: don Bosco e madre Teresa, di cui è stato amico e confessore per oltre mezzo secolo. Ha anche costruito un campo da calcio, l’unico del quartiere dove i bambini giocano a piedi nudi sull’erba anziché sui sassi. «Sono arrivato in India nel 1939, a 17 anni. In Sicilia vidi i missionari che avevano portato il vangelo nelle terre degli infedeli, sulle orme di san Tommaso: storie di malattie tropicali, conversioni, persecuzioni. I missionari erano gli eroi della mia giovinezza. Decisi che sarei stato uno di loro. Mia madre capì che non mi avrebbe più rivisto, e si disperò: stava per perdere un altro figlio maschio; il primogenito, Giuseppe, era morto, e dopo erano nate quattro bambine. Salpammo da Napoli sul Conte Biancamano, che in dieci giorni ci portò a Bombay attraverso il canale di Suez, il Mar Rosso e l’oceano. Eravamo poverissimi e allegri». «Gli inglesi tenevano l’India con poche migliaia di soldati, quasi tutti indiani. Un capolavoro politico. Siccome convertire gli indù era difficile, ci mettemmo in cammino per i villaggi degli Adivasi, le popolazioni tribali animiste. Bisognava fare attenzione a uscire la sera perché c’erano ancora le tigri». Il cristianesimo è una religione complessa: la trinità, la resurrezione della carne… come la spiegava agli indigeni? «Il cristianesimo è difficile solo per quelli che hanno studiato troppo. E poi la resurrezione, l’immortalità dell’anima, la presenza stessa di Dio, che a noi appaiono così ostiche, qui sono considerate ovvietà. Il primo mese in venti chiesero il battesimo. Risposi che a Gesù si arriva poco per volta». «Il 10 giugno 1940 il duce dichiarò guerra agli inglesi. Il giorno stesso mi portarono in campo di prigionia, vicino a Darjeeling. Il 4 dicembre 1942 fummo trasferiti presso Deoli, in Rajastan. Ci trattarono sempre con molto rispetto, ma a marzo nel deserto del Rajastan ci sono già quasi 50 gradi, e quando i prigionieri cominciarono a morire ci spostarono a Dehradun, ai piedi dell’Himalaya. Ci liberarono solo alla fine del novembre 1944, e potemmo riprendere la nostra missione. Ricordo la notte del ferragosto 1947: l’indipendenza, la divisione tra India e Pakistan, i massacri tra indù e musulmani; la gente festeggiava e intanto scorreva il sangue. Ricordo quando arrivò la notizia della morte di Gandhi. Il Paese fu travolto da un’ondata di dolore. Devo dire però che madre Teresa non aveva il mito di Gandhi; del resto non fu lui a liberare l’India, furono gli inglesi ad andarsene. Non dico che lo considerasse un fachiro seminudo, come lo definiva Churchill; ma lei non si interessava di politica». «La vidi per la prima volta nella cattedrale di Calcutta, nel 1948. Aveva ottenuto di lasciare il convento per trasferirsi tra le baracche. Il suo direttore spirituale, il gesuita belga Van Exem, quel giorno la trattò quasi con disprezzo, e lei con umiltà non si ribellò. Andavo a predicare per le suore. Madre Teresa era molto intelligente, aveva un grande dono per le lingue. Ma era anche molto semplice. E poi aveva un bellissimo sorriso. Eravamo un’anima e un cuore solo: lei capì che io l’avevo capita; e io capii che lei aveva capito me. Andavo a trovarla nella sua celletta: una branda, un tavolo, una panca, e crocefissi dappertutto. Cercava il volto di Gesù negli altri, e lo trovava nei morenti, negli handicappati, negli orfani, nelle donne rese folli dal carcere o dalle violenze. Sulla sua tomba ha voluto che fosse scritto, con i petali dei fiori: “Io non faccio nulla, fa tutto Lui”». «Fu attaccata per la sua condanna dell’aborto. In molti la criticavano; ma era impossibile restare indifferenti di fronte a lei. Una volta venne a intervistarla una giornalista americana, prevenuta, altera. Rifiutò di mettersi a piedi nudi. Il suono dei suoi tacchi a spillo risuonava per il convento. Madre Teresa la ricevette mentre toglieva i vermi dal corpo di un moribondo, raccolto all’angolo della strada. Alzò lo sguardo, la vide, le disse: “Abbia pazienza, alla mia età non vedo più bene. Mi aiuterebbe?”. La giornalista si buttò ai suoi piedi in lacrime. Madre Teresa le aveva toccato il cuore. Era davvero una santa». «Ora per noi cattolici è sempre più dura. Da molto tempo non arriva nessun confratello, e devo farmi rinnovare il permesso ogni anno. Indira Gandhi, che ho incontrato, era autoritaria ma tollerante. Sua nuora Sonia
ha tentato di far dimenticare di essere italiana. Ora il premier, Modi, è un induista radicale, e ci detesta». Cosa prevede per il futuro? «Nulla di buono. Come ha detto la Madonna, il mondo oggi è peggio che ai tempi di Noè e del diluvio, è peggio di Sodoma e Gomorra». Ma abbiamo Papa Francesco. «Non mi convince del tutto. Ha passato la vita in Argentina, una terra che conosco: dopo il mio addio mia madre ebbe un altro figlio, lo chiamò Giuseppe come quello che aveva perduto, e lui si trasferì in Argentina, dove andai a trovarlo. Il Paese è quasi sempre stato governato dalla massoneria. E il dio della massoneria è Lucifero». Sa cosa dice Wikipedia di lei, padre? «Wiky che?». Un’enciclopedia digitale sostiene che lei è un esorcista. E che quando l’arcivescovo la mandò a chiamare lei forse praticò un esorcismo su madre Teresa, che come altre sante poteva essere visitata dal demonio… «Io le ho impartito l’estrema unzione, e ho pregato con lei, per lei. Erano le 6 di sera. Madre Teresa si sentì un po’ meglio, e prodigiosamente si ristabilì. Era il 1997, aveva già 87 anni. Morì pochi mesi dopo. Quella volta non feci in tempo a giungere al suo capezzale». «Raccogliemmo 133 testimonianze per la causa di beatificazione. Non fu difficile trovare il miracolo: almeno cinque donne sostenevano, confermate dai medici, di essere state guarite da lei in una sola notte». Ogni tanto padre Rosario preferisce esprimersi in inglese: «Ormai non parlo più italiano con nessuno. Solo con il mio angelo custode, che però non mi risponde… In Italia non tornerò più. Ci sono stato l’ultima volta nel 2003, per la beatificazione di madre Teresa. E’ diventata una terra senza moralità. Accogliere tutti questi maomettani mi pare poco lungimirante: verrà il giorno in cui abbevereranno i loro cavalli a San Pietro. Ma sa cosa mi ha colpito di più? Vedere tante donne girare con il gatto in braccio, come se fossero figli. La Sicilia in cui sono cresciuto era di una povertà medievale, però le donne avevano molti figli. Un Paese che ha sostituito i bambini con i gatti è un Paese senza domani. Ma io il domani non lo vedrò, e questo mi conforta. Sono felice di aver alimentato la fiamma della fede in queste terre lontane. Presto lascerò il mio corpo e vedrò Dio. Lo vedrò faccia a faccia». LA REPUBBLICA Pag 22 Carmelitani e gigolò, scontro in Vaticano: “Alla sbarra i religiosi” di Lorenzo D’Albergo e Orazio La Rocca Roma, il cardinale De Paolis contro Vallini: non basta allontanare i sacerdoti, serve un processo canonico. Il racconto dell’escort: “I miei incontri di sesso e droga con il superiore dell’Ordine” Roma. Prima gli incontri gay negli anfratti di Villa Borghese, poi quelli entro le mura della curia dei Carmelitani scalzi. Giorno dopo giorno lo scandalo dei rapporti omosessuali che ha sconvolto l'Ordine si arricchisce di dettagli. Tutti elencati nel dossier che inquieta il Vaticano e certificati dalle deposizioni di Sergio, un "marchettaro" che si concedeva ai preti per 50 euro, e di Sebastiano, che prima di essere allontanato dalla parrocchia di Santa Teresa d' Avila ha avuto una relazione di un anno con un alto esponenti della congregazione. Una liaison a dir poco travagliata: superalcolici, sniffate di popper (la droga che prolunga il piacere) e un misterioso pestaggio, dopo le prime denunce datate 2006. Il report, inviato a metà luglio al cardinale vicario Agostino Vallini, al segretario di Stato Paolo Parolin e a Papa Bergoglio, rischia di stravolgere gli equilibri della curia generalizia dei Carmelitani nel cinquecentenario della fondazione. E, ne sono sicuri i fedeli, è il documento che ha spinto il Santo Padre a esporsi il 14 ottobre, all'udienza del mercoledì: «Chiedo perdono a tutti per gli scandali di Roma e del Vaticano». Immoralità su cui il preposito generale dell'Ordine dei Carmelitani, Saverio Cannistrà, avrebbe preferito chiudere un occhio, mettendo a sopire le chiacchiere dei fedeli con il trasferimento di quattro padri della curia e tre religiosi della parrocchia. Mandando lontano da Roma "rei" e innocenti (padre Angelo, il parroco, don Alessandro, vice e favorito dai parrocchiani, e l'ausiliario Ferdinando). Ma ora interviene il cardinale Velasio De Paolis. Presidente emerito della Prefettura per gli affari economici e, prima, segretario del Tribunale della Signatura Apostolica, la Cassazione della Santa Sede, il giurista accende il dibattito e detta la linea al Vicariato su un caso da affrontare «senza perdite di tempo. Non basta aver inviato al preposito generale dei Carmelitani il dossier sui frati accusati di aver partecipato a incontri gay a pagamento. Non è nemmeno sufficiente che i religiosi incriminati siano stati allontanati. Se le accuse sono vere
occorre sanzionare i colpevoli, anche con l'espulsione dall'Ordine e la riduzione allo stato laicale». Una possibile sentenza neanche ipotizzabile senza la mobilitazione dei parrocchiani. Quando i fedeli hanno capito che il dossier rischiava di finire nel dimenticatoio, in 110 hanno preso carta e penna e spedito una lettera a Francesco per difendere i religiosi innocenti finiti loro malgrado nel repulisti. I primi rapporti omosessuali riportati nel dossier risalgono al 2002. È invece di pochi giorni fa una scoperta che ha fatto inorridire i parrocchiani. Indagando, i fedeli hanno individuato l'entrata secondaria di via Aniene da cui sarebbero stati fatti entrare i "marchettari" che venivano invitati nelle stanze dell'edificio sacro di corso Italia per soddisfare i preti alla ricerca di una compagnia notturna. «È una vicenda dolorosa, complicata, nonché vergognosa - commenta De Paolis - e Vallini ha fatto bene a coinvolgere subito i responsabili della Curia generalizia. Ma non basta. Se le accuse sono vere, è bene agire con tempestività per punire i colpevoli dopo un processo canonico». Un iter a cui di sicuro non sarà sottoposto il giovane parroco che quattro anni fa ha deciso di rinunciare all'Ordine e a 30 si è ritrovato a fare il gelataio. Qualcuno tra i fedeli assicura abbia subito violenze in parrocchia. Voci, mormorii. «Chi ha tradito a Roma la promessa di castità - conclude il cardinale De Paolis - potrebbe farlo altrove. Per questo serve il processo». Roma. «Ho fatto la strada, sono uno intelligente io». Sebastiano F. è uno degli uomini con cui almeno un alto esponente della curia dei Carmelitani Scalzi avrebbe avuto rapporti sessuali. In stazione, sta per salire su un treno che lo porterà lontano da Roma e dalla parrocchia di corso Italia in cui ora non è più il benvenuto. «Lavoravo con un monsignore, andavo a benedire le case dei fedeli, e ora ho perso tutto. Sono costretto ad andarmene in Austria. Nessuno mi ha aiutato e Vallini ha torto». Sebastiano, a cosa si riferisce? «Il 18 giugno sono andato in Vicariato per presentare al cardinale Vallini e al vescovo Di Tora la mia deposizione. Ma al loro posto è venuto don Nicola, il segretario. Con me c' era anche padre Alessandro. Eravamo stati convocati alle 10.30 del mattino». A quel punto cosa ha fatto? «Ero lì per firmare il documento, una deposizione molto importante, esclusivamente davanti al cardinale. Allora, quando è arrivato il segretario, mi sono opposto. Ho detto che avrei atteso Vallini. Ma dopo due ore mi hanno detto che non mi avrebbe ricevuto. Perché? Me lo sono chiesto tante volte. Ma lui quella volta non si è fatto proprio vedere. E io mica stavo lì a vendere i peperoni. Me ne sono andato e poi ho mandato la lettera a tutti, anche al Santo Padre. Altrimenti quella deposizione firmata sarebbe finita nel cassetto e dimenticata». Cosa c' era scritto in quella deposizione? «Tutto quello che avevo da denunciare su quegli incontri. Dall' inizio alla fine, dal 2005 in poi». Perché? Cosa succede nel 2005? «Ho conosciuto il superiore dei Carmelitani, fumava una sigaretta a Villa Borghese e me ne offrì una. L' ho conosciuto così. Poi ci sono stati dei rapporti, la maggior parte erano a pagamento ». La storia poi è nota. Don Alessandro le chiese se conoscesse il superiore. Lei come rispose? «Che lo conoscevo. Me ne sono accorto quando l' ho visto con i paramenti sacri a un funerale dell' Ordine. Prima non sapevo fosse un prete. Ora, dopo dieci anni, è venuto tutto a galla e io sono costretto ad andarmene e a perdere tutto. Pensi che mi hanno contattato anche diverse tv, ma mi hanno solo preso in giro». Ma torniamo a Roma, in corso Italia. Frequentava la parrocchia? «Per un periodo ho vissuto in una piccola stanza in parrocchia. Vivevo con i Carmelitani. Facevo il servizio per i poveri, servivo i pasti alla mensa della Caritas». E i rapporti sessuali? Avvenivano anche in chiesa? «No, non con me. Non voglio che mi siano attribuite parole che non ho detto. Non mi fido più di nessuno. Io ho avuto degli incontri, ma solo a Villa Borghese. Quel prete, don Silvano, mi faceva sniffare anche il popper. Gli incontri si sono interrotti dopo un anno, dopo che mi sono confidato con padre Alessandro. Ma non sono un
"marchettaro". Nessuno mi ha mai pagato. E quando ho saputo che era un prete mi è venuto il vomito». Qualcuno in curia sapeva? «Don Agostino lo sapeva, a quei tempi era il parroco. A padre Gabriele mi sono confidato in confessionale. Lo sapeva anche don Giuseppe, allora parroco di San Nicola di Bari, una parrocchia in via dei Prefetti. Andavamo a fare il ritiro spirituale a Palestrina. Poi mi hanno messo fuori dalla parrocchia, dicendo che ero un poco di buono. Ero andato a vivere a Villa Borghese. Lì mi hanno pestato: era l' 11 settembre del 2006. Non racconto frottole: anche padre Alessandro ha visto il religioso con cui avevo rapporti uscire nel cuore della notte. E lì si è convinto anche lui». LA NAZIONE Pag 1 Il dovere di scriverlo di Andrea Cangini Naturalmente, ci siamo posti il problema. Scriviamo oggi, sulla base di fonti certe, che papa Francesco ha un tumore al cervello e fino a ieri ci siamo domandati se fosse lecito violare in maniera così evidente la privacy di un uomo. Un uomo che a dicembre compirà 78 anni. Abbiamo ritenuto che in questo caso il diritto alla riservatezza contasse un po' meno del diritto dell'opinione pubblica ad essere informata. Quel che vale per i capi di Stato e di governo vale a nostro avviso anche per il capo della Chiesa cattolica: in casi del genere, la malattia cessa d'essere una faccenda privata per divenire una questione di pubblico interesse in ragione dell' enorme responsabilità che grava su malati così straordinari. Si è lungamente parlato, negli scorsi anni, del tumore alla prostata di Silvio Berlusconi così come della malattia che affliggeva papa Wojtyla e, dopo di lui, delle patologie di Benedetto XVI. In nessuno di questi tre casi la notizia del corpo malato ha minato la credibilità del "leader"; in tutti e tre questi casi l'immagine dell'uomo ne è uscita rafforzata. Francois Mitterrand negò fino all'ultimo di avere un cancro, ritenendo che l'ammissione avrebbe leso la maestà della Presidenza francese, Ronald Reagan toccò il culmine della propria popolarità negli Stati Uniti e nel mondo rivelando d'avere l'Alzheimer. Ci sono precedenti di tutti i generi, a riguardo. Ma la costante è che quando il malato svolge una funzione così rilevante per l'interesse generale pubblicare la notizia della malattia è un dovere per chi la scova. Le dimissioni di Joseph Ratzinger e lo stile informale di papa Francesco hanno smitizzato la sacralità del pontificato, umanizzandolo: mai come oggi il Papa appare un uomo tra gli uomini. Un uomo malato, nella fattispecie, ma di un male assolutamente curabile. Un uomo come tanti. Siamo certi che Jorge Mario Bergoglio, a cui vanno i nostri auguri più sinceri, saprà trasformare un elemento di debolezza in un fattore di forza. Pagg 2 – 3 Il Papa è malato: un tumore curabile di Tommaso Strambi Francesco De Victoriis Piccola macchia scura nel cervello. È seguito dal professor Fukushima, della clinica San Rossore a Pisa Pisa. «Non dovrebbe essere necessario alcun tipo di intervento chirurgico». L'infermiera è sollevata. Quando ha letto il nome del paziente quasi non ci voleva credere. E, oggi che gli esami avrebbero evidenziato che «quella macchia, un piccolo tumore al cervello, si può curare senza portare il paziente in sala operatoria», è entrata nella piccola cappella della Casa di Cura San Rossore ad accendere un cero alla Madonna. «Sono anni che lo non facevo più», confida. Quel paziente non è un suo familiare e neanche un conoscente. Ma è come se lo fosse. Sicuramente è una persona speciale. Il suo nome è Jorge Mario Bergoglio. Sì, proprio lui, il Papa venuto «dall'altra parte del mondo». Tutto è nato qualche mese fa. Una mattina come tante, quando all'improvviso nel cielo sopra Barbaricina, alle porte di Pisa, è sbucato un elicottero. Chi lo ha visto racconta di aver notato le insegne giallo-bianche sulla fiancata mentre volava radente sopra le ville della zona. Così si è subito sparsa la voce che ci fosse «il Papa a San Rossore». «In fondo come fa le telefonate, a sorpresa, - racconta uno degli abitanti - poteva anche essere arrivato per visitare la piazza del Duomo e la Torre Pendente». Ma perché non usare l'aeroporto militare, sede della 46ª Aerobrigata, utilizzato normalmente dal rigido protocollo dei servizi di sicurezza, nel caso di visite ufficiali, che dista da San Rossore
solo cinque minuti? Semplicemente perché su quell'elicottero non c'era Papa Bergoglio. L'elicottero, infatti, è atterrato nella piazzola dell'elisoccorso della Casa di cura San Rossore con il solo equipaggio. Perché? Secondo alcuni testimoni oculari pochi minuti dopo l'atterraggio, dalla clinica (nota per aver avuto tra i suoi pazienti Indro Montanelli, Sandra Mondaini e Pippo Baudo) sarebbero usciti il professor Takanori Fukushima e alcuni operatori della sua équipe. E questo ha ulteriormente alimentato i misteri legati all'arrivo dell'elicottero. Già, perché il professor Fukushima è conosciuto a livello mondiale per la sua ricerca e il trattamento dei tumori al cervello, aneurismi e neuralgie trigeminali. Perché, dunque, l'elicottero? Nella casa di cura le bocche sono rigorosamente cucite, in rispetto alla policy aziendale. Quel che è certo è che l'elicottero dopo aver prelevato l'équipe del professor Fukushima, docente di Neurochirurgia al Duke University Medical Center e alla West Virginia University Medical Center, è ripartito alla volta di Roma per atterrare oltre le mura Leonine. E qui, nonostante la riservatezza sia la cifra dello Stato più piccolo del mondo da secoli, qualcosa tra il Colonnato del Bernini è filtrato. Se qualcuno ha chiamato a consulto il professor Fukushima dev'essere per una persona della stretta cerchia della 'famiglia papale'. Qualcuno ha anche pensato a Benedetto XVI. In fondo, quando Ratzinger si dimise una delle ipotesi che circolò era proprio quella di una malattia che non gli consentiva di portare avanti il proprio pontificato. Ma, ormai, sono passati più di due anni da quel passo indietro e il Papa emerito, nelle pochissime uscite pubbliche, è apparso in salute. E allora sono riemerse le voci sulla salute del Papa e la confidenza, fatta da un alto prelato nei mesi scorsi, secondo cui Francesco potrebbe anche lui presto stupire il mondo rinunciando, come il suo predecessore, al soglio di Pietro. Ma ora che il professor Fukushima avrebbe escluso la necessità di qualsiasi operazione chirurgica, confermando la possibilità di curare il suo paziente più famoso al mondo, è chiaro che non sarà quella «piccola macchia» a influenzare le decisioni del Santo Padre. IL FOGLIO Pag III Giù le mani da Paolo VI di Stephan Kampowski e David Crawford Studiosi giovanpaolini spiegano che archiviare l’Humanae vitae (come qualcuno chiede al Sinodo) implica che il Magistero papale si può cambiare. Rendendolo non vero I padri sinodali, attualmente riuniti a Roma per discutere sulla "vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo", si chiedono come trovare uno slancio nuovo per la pastorale familiare. A questo scopo è importante individuare con precisione le sfide cui la famiglia cristiana si trova di fronte nelle società di oggi. La più grande di queste sfide, almeno secondo alcuni sociologi, è quella rappresentata dalla rivoluzione sessuale (cfr. M. Eberstadt, "The New Intolerance", First Things, marzo 2015), la cui caratteristica principale è l'avere scisso la sessualità dalla procreazione. Per noi che viviamo ormai nell'epoca post-rivoluzionaria, spesso è difficile capire fino in fondo quanto sia stata radicale quella rivoluzione e fino a che punto stia influendo sul modo di vivere la sessualità, il matrimonio e la famiglia nel mondo odierno. Il documento magisteriale che propone con più forza un'alternativa alla rivoluzione sessuale è l'enciclica Humanae vitae del Beato Paolo VI. Nell'Instrumentum laboris di quest'anno, che serve da base ai padri sinodali per le loro deliberazioni, troviamo due atteggiamenti diversi nei confronti di quel documento. Nel n. 137 si vede un approccio pragmatico che prende il suo orientamento dal mondo di oggi. Mentre elogia la sapienza di Humanae vitae, non riesce a riassumere il suo contenuto e con una casistica pre-conciliare lo svuota del suo valore normativo (cfr. D. Crawford -S. Kampowski, "An Appeal", First Things, 9 settembre 2015). Nel precedente n. 49 invece si legge che Paolo VI "con la enciclica Humanae vitae, ha messo in luce l'intimo legame tra amore coniugale e generazione della vita". Quello, difatti, si potrà dire l'argomento principale del documento, che vale la pena di approfondire, come faremo in seguito. L'amore coniugale: la base della norma Nel n. 14, Humanae vitae esprime una norma contro gli atti sessuali deliberatamente resi sterili (è ciò che il documento intende con il termine "contraccezione"), chiamandoli intrinsecamente non onesti. Come il "perché" di questa norma viene indicata la seguente tesi: un atto sessuale contraccettivo non si può mai qualificare come atto di amore coniugale. E' questo il significato essenziale del cosiddetto "principio d'inseparabilità" proposto dall'enciclica, secondo cui vi è un nesso
inscindibile fra il significato unitivo dell'atto coniugale e il suo significato procreativo (HV 12). Se questa tesi è vera, allora risulta evidente che i rapporti sessuali contraccettivi violano il sesto comandamento, la cui affermazione principale è che i rapporti sessuali sono ordinati all'amore coniugale. In altri termini, l'argomento è che, nei rapporti sessuali contraccettivi, l'uomo compie un atto sessuale con la moglie senza trattarla come moglie, e la donna compie un atto sessuale con il marito senza rapportarsi a lui come marito: insomma, comunque si voglia chiamare ciò che stanno facendo, i due non compiono un vero atto di amore coniugale. Orbene, su che cosa si basa questa tesi? Per capirlo dobbiamo domandarci che cosa occorra affinché un atto sessuale sia un atto di amore coniugale. Vi sono alcuni requisiti da soddisfare. In primo luogo, ovviamente, occorre che sia un atto sessuale compiuto da coniugi, cioè da un uomo e una donna che hanno unito le loro vite per mezzo di una promessa pubblica di reciproca fedeltà, esclusività sessuale e apertura alla generazione e all'educazione della prole. Assumendo questo impegno i due si uniscono in matrimonio. Quest' ultimo è l'istituzione dell' amore coniugale, che a sua volta è un amore con una missione: "l'altissima vocazione dell'uomo alla paternità" (cfr. HV 10). Questa missione di generare ed educare la prole è ciò che distingue l'amicizia coniugale da altri generi di amicizia. Come afferma il Concilio Vaticano II, "per la sua stessa natura l'istituto del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e all' educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento" (GS 48). L'amore proprio del marito e della moglie, quindi, è un amore che ha una missione particolare e, con essa, anche la caratteristica specifica di abbracciare tutta la loro vita. Come non vi è unione che due persone possano realizzare in terra più grande dell'essere padre e madre dei figli dell'uno e dell'altra, così difficilmente potrà esservi un'espressione di amore più grande che dire all'altra persona: "Voglio che tu sia la madre / il padre dei miei figli". In questo senso, essere il marito di una donna significa essere il padre potenziale dei figli di lei, ed essere la moglie di un uomo significa essere la madre potenziale dei figli di lui. Il fatto che l'uomo e la donna si guardino reciprocamente in questo modo non implica che si stiano strumentalizzando reciprocamente in vista di generare prole. Significa soltanto che l'amore coniugale è ordinato a formare una famiglia, e questo è l'aspetto che rende l'amicizia coniugale specificamente diversa da ogni altro genere d'amicizia. Un secondo requisito che un atto sessuale deve soddisfare per essere un atto di amore coniugale è l'essere di per sé idoneo alla procreazione (cfr. HV 11). Deve cioè essere scelto come un atto di tipo generativo. Nella misura in cui un atto coniugale consuma e riassume il senso ultimo dell'amore coniugale, esso stesso deve avere le caratteristiche dell'amore coniugale. Orbene, l'amore coniugale è umano, totale, fedele, esclusivo e fecondo (cfr. HV 9). Affinché un atto sessuale sia un atto coniugale, i coniugi devono rapportarsi l'uno all'altra come marito e moglie, cioè come il potenziale padre e la potenziale madre dei loro figli. E' evidente che l'atto sessuale contraccettivo è carente sotto questo profilo: nella misura in cui i coniugi, intervenendo sui propri corpi, rendono deliberatamente sterili se stessi e il loro atto, chiaramente scelgono un tipo di atto sessuale intrinsecamente sterile. Questo è l'aspetto sotto il quale l'atto è scelto. Potrà essere fecondo accidentalmente, a causa del fallimento del contraccettivo, ma la possibilità di "incidenti" non cambia il fatto che, tentando di rendere sterili se stessi e il loro atto, i coniugi scelgono atti sessuali sterili tanto quanto sono sterili i rapporti anali od orali. Indipendentemente dal metodo di contraccezione impiegato - sia esso un metodo "barriera" o chimico - un atto sessuale contraccettivo non si può definire un atto di amore coniugale perché, sul piano delle loro scelte, i coniugi non si rapportano fra loro come sposi, cioè come il potenziale padre e la potenziale madre della loro prole comune. La loro potenziale paternità e maternità è proprio ciò che hanno deliberatamente escluso. Essi compiono un atto sessuale senza rapportarsi l'uno all'altra come coniugi. In questo senso l'atto non può consumare o riassumere il senso ultimo dell'amore coniugale. Pertanto il rapporto sessuale contraccettivo non si può mai definire un atto di amore coniugale, anche se compiuto da coniugi. Esso ricade quindi sotto l'interdetto del sesto comandamento: "Non commettere adulterio", o in altre parole: "Il sesso è per l'amore coniugale". Ne consegue che come norma morale negativa contenuta nei Dieci Comandamenti, la norma formulata dalla Humanae vitae esprime una verità sul nostro essere, sul nostro bene e sul nostro amore, la quale è valida sempre e ovunque. Esprime cioè un assoluto morale che non ammette eccezioni. Pertanto Paolo VI, in riferimento
all'atto sessuale reso volutamente infecondo, parla di un atto "intrinsecamente non onesto" [intrinsece inhonestum] (HV 14). E' vero, talvolta la fedeltà a questo amore è difficile, comporta sacrifici e richiede la maturità delle virtù. Ma l'amore sacrificale è al cuore del Vangelo. se le sue proposte non saranno ascoltate. La diffusione delle pratiche contraccettive aprirebbe una "via larga e facile [...] all'infedeltà coniugale e all'abbassamento generale della moralità". L'uomo potrebbe finire "per perdere il rispetto della donna e, senza più curarsi del suo equilibrio fisico e psicologico, arrivare a considerarla come semplice strumento di godimento egoistico". Infine, il Papa immagina che i governi civili possano essere tentati di imporre ai loro popoli misure di controllo demografico. Ebbene, tutto ciò si è avverato. Ecco una triste constatazione, che milita a favore dell'insegnamento dell'enciclica, e che dovrebbe incoraggiare la Chiesa a riscoprire la sua verità e bellezza e a proclamarla con maggiore convinzione. Inoltre, l'ideologia del gender - denunciata da Papa Francesco come "colonialismo ideologico" (Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno dalle Filippine, 19 gennaio 2015) e come "espressione di una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa" (Udienza generale del 15 aprile 2015; cfr. anche Laudato si', 155) - può sorgere soltanto in una cultura che ha dimenticato il nesso fra sessualità e procreazione. Se l'attività sessuale è scissa da ogni idea di procreazione, allora la differenza sessuale perde il suo significato. Soltanto in una cultura che ha completamente scisso l'esercizio delle facoltà sessuali da qualsiasi considerazione per la procreazione, l'orientamento sessuale può diventare più importante della differenza sessuale, il che apre la via anche alla questione del "matrimonio" fra persone dello stesso sesso. Se gli atti sessuali non sono pensati come atti di tipo generativo, allora - come vedeva già la filosofa inglese e discepola di Ludwig Wittgenstein, G.E.M. Anscombe nei primi anni Settanta - non vi è più ragione perché essi dovrebbero essere compiuti da un uomo e da una donna, e non da due uomini o due donne (cfr. il suo Contraception and Chastity), ovvero, aggiungiamo noi, da tre uomini e/o quattro donne. Dobbiamo tenere a mente che con i loro atti di amore coniugale, uomo e donna fanno qualcosa che va al di là di entrambi. Si inseriscono nella grande corrente delle generazioni umane. Ricordano la loro origine e si proiettano verso il futuro. Nella misura in cui tali atti sono potenzialmente fecondi, gli sposi superano l'isolamento della coppia e si trascendono verso un terzo, verso un progetto di vita comune che è il potenziale Contraccezione e pastorale della famiglia In questa parte vogliamo sottolineare che la proposta della Humanae vitae, che ribadisce l'insegnamento costante della Chiesa secondo cui, per essere buono e gradito a Dio, ogni atto sessuale deve essere un atto di amore coniugale, è tutt'altro che un tema secondario nell' immenso mare di sfide che affronta oggi la pastorale della famiglia. Il rifiuto, a tutti gli effetti, della Humanae vitae da parte della cultura secolare e di un gran numero dei pastori e dei fedeli della Chiesa è all'origine di una cospicua porzione delle sfide odierne, e la Chiesa non può affrontarle adeguatamente se non trova la forza, il coraggio e la parresìa evangelica per riproporre nella loro pienezza, per quanto possano essere impegnativi, gli insegnamenti di questo documento. Al paragrafo 17 della Humanae vitae, il Beato Paolo VI pronostica ciò che avverrà figlio. Ciò rimane vero anche se non intendono direttamente procreare un figlio, o se sanno che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non sono in grado di concepire. Essi conservano la loro "apertura intenzionale" verso la procreazione finché scelgono un tipo di atto generativo. Per far ciò non occorre null'altro che usare gli organi adeguati e non manipolare se stessi né l'atto. Un esercizio degli organi sessuali che sia intrinsecamente sterile (masturbazione reciproca, rapporto anale od orale), o che sia stato deliberatamente reso sterile (contraccezione, sterilizzazione), non possiede questa dimensione trascendente: e in ciò risiede la sua manchevolezza, il suo male. A parte le questioni delle unioni fra persone dello stesso sesso e della teoria del gender, anche tutti i problemi morali e pastorali legati alle tecnologie riproduttive artificiali (dalla questione della moralità delle procedure in sé alle questioni collegate, come la maternità surrogata o la sorte dei cosiddetti embrioni "soprannumerari") sono legati al rifiuto della Humanae vitae: se si possono avere rapporti sessuali senza avere figli, ovviamente si possono avere figli senza avere rapporti sessuali. Appello finale Le Sacre Scritture ci consentono di pensare la Chiesa come un corpo, il Corpo di Cristo (cfr. Ef 1, 22-23), un organismo vivente che si estende attraverso lo spazio e il tempo. Ciò che essa ha definito vero e buono ieri non può certo
diventare falso e gravoso oggi. Per quasi duemila anni, fra i cristiani vi fu un consenso pressoché universale circa l'immoralità delle pratiche contraccettive (cfr. J.T.Noonan, Contraception). Fu soltanto con la Conferenza di Lambeth del 1930 che, per la prima volta nella storia, una confessione cristiana mise pubblicamente in discussione tale concezione. Da allora in poi, a partire dall' enciclica di Pio XI Casti connubii di quello stesso anno, il magistero della Chiesa cattolica affermò esplicitamente l'immoralità della contraccezione. Quella posizione fu poi ribadita da Pio XII, il quale definì immorale "ogni attentato dei coniugi nel compimento dell' atto coniugale o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, attentato avente per scopo di privarlo della forza a esso inerente e di impedire la procreazione di una nuova vita" (Discorso alle ostetriche del 19 ottobre 1951). Pio XII aggiunse nella stessa allocuzione che "nessuna 'indicazione' o necessità può mutare un'azione intrinsecamente immorale in un atto morale e lecito", sottolineando con parole ben chiare che "questa prescrizione è in pieno vigore oggi come ieri, e tale sarà anche domani e sempre, perché non è un semplice precetto di diritto umano, ma l'espressione di una legge naturale e divina". Orbene, Paolo VI non promulgò la Humanae vitae perché pensava che le forti affermazioni dei suoi predecessori lasciassero adito a dubbi. A occasionare l'enciclica fu piuttosto l'invenzione della pillola ormonale (cfr. GS 51, n. 14). La questione originaria non era se la contraccezione potesse in fin dei conti essere moralmente lecita, ma semplicemente se l'uso della pillola potesse qualificarsi come contraccezione, considerato che non rientrava nella definizione che Pio XII aveva dato di quella pratica. Nel decidere della questione della pillola, con una lieve modifica della definizione di contraccezione data in precedenza da Pio XII, Paolo VI ribadì anche gli insegnamenti dei suoi predecessori (cfr. HV 14), che a loro volta sono stati costantemente sottoscritti e difesi dai suoi successori. Così, con parole chiare, San Giovanni Paolo II, parlando dell' insegnamento della Humanae vitae, ha precisato: "Non si tratta, infatti, di una dottrina inventata dall'uomo: essa è stata inscritta dalla mano creatrice di Dio nella stessa natura della persona umana ed è stata da lui confermata nella rivelazione. Metterla in discussione, pertanto, equivale a rifiutare a Dio stesso l'obbedienza della nostra intelligenza" (Discorso ai partecipanti al II Congresso Internazionale di Teologia Morale, 12 novembre 1988). Ora, effettivamente il paragrafo 137 dell'Instrumentum laboris implica che l'insegnamento esplicito e incessante del magistero papale di più pontefici possa essere cambiato, il che a sua volta significa che tale insegnamento non era oggettivamente vero. Orbene, se il magistero papale non trae la sua autorità dall'essere un ministero al servizio della verità, il suo esercizio può basarsi soltanto sul potere. In altre parole, il testo in discussione propone che l'autorità papale ed ecclesiale si basi sulla volontà, anziché sulla ragione e sulla verità. Naturalmente ciò segnerebbe la fine dell'autorità papale, la quale, per esistere, deve basarsi sulla verità e non sul potere (cfr. J. H. Newman, Lettera al Duca di Norfolk). Considerato tutto quanto si è detto fino a questo punto, per il bene della famiglia, della Chiesa e della società, facciamo energicamente appello al Sinodo affinché rifletta più approfonditamente sul significato della differenza sessuale con il suo nesso con la fecondità, e riconosca e promuova l'insegnamento della Humanae vitae malgrado tutti gli ostacoli e contro tutte le ideologie che vogliono distruggere la famiglia e in ultima analisi la stessa Chiesa di Dio. Supplichiamo i Padri Sinodali di seguire l'esempio di Nostro Signore e a riferirsi al "principio", cioè al piano originale di Dio per la famiglia fin dal momento della Creazione (cfr. Mt 19, 8): un piano iscritto nella natura stessa della persona umana e che è il solo a corrispondere al nostro vero e autentico bene. Infine, imploriamo il Sinodo di ribadire ed esporre gli insegnamenti di San Giovanni Paolo II, che Papa Francesco ha innalzato all'onore degli altari conferendogli l'appellativo di "Papa della famiglia" (Omelia, 27 aprile 2014). WWW.CHIESA.ESPRESSONLINE.IT Napier, la voce della verità sulla lettera dei tredici cardinali di Sandro Magister C'è voluto questo arcivescovo sudafricano per chiarire pubblicamente le vere ragioni della lettera, di cui è uno dei firmatari. Tutto nasce nel sinodo del 2014 e nelle manovre di alcuni per forzarne gli esiti. Ecco testuali le sue parole Già quattro giorni prima che la lettera dei tredici cardinali a Francesco diventasse di dominio pubblico, veniva additato tra i "cospiratori" che volevano sabotare il sinodo e
colpire lo stesso papa. E dopo la pubblicazione della lettera, l'aggressione contro di lui e gli altri firmatari è continuata con ancor più virulenza, con il fattivo sostegno dei gestori vaticani dell'informazione sinodale. Finché è venuto il giorno, ieri, martedì 20 ottobre, in cui il cardinale Wilfrid Fox Napier, arcivescovo di Durban, Sudafrica, ha finalmente potuto dire la sua verità, sul sinodo e sulla lettera dei tredici al papa, nella cornice ufficiale della quotidiana conferenza stampa moderata da padre Federico Lombardi. Alla conferenza stampa Napier è intervenuto in qualità di copresidente delegato del sinodo. Una presenza obbligata. Ed era la prima volta che uno dei tredici firmatari della lettera compariva nella sala stampa vaticana, dopo l'esplosione del caso. Una domanda "ad hoc" per lui non poteva mancare. E infatti è arrivata, puntuale e polemica, ad opera di un giornalista di punta del cattolicesimo "liberal" americano, Robert Mickens, fondatore e direttore di "Global Pulse Magazine". La domanda di Mickens e la risposta del cardinale Napier, entrambe pronunciate in inglese, sono integralmente trascritte e tradotte più sotto. Ma per meglio capirle occorre premettere qualche annotazione. Il libro che Mickens sospetta sia stato ispirato dal cardinale Napier è "The Rigging of a Vatican Synod?", del vaticanista Edward Pentin del "National Catholic Register", edito la scorsa estate in forma di E-Book da Ignatius Press: una ricostruzione dettagliata della "manipolazione" del sinodo del 2014. E infatti, nella sua risposta, per spiegare i moventi della lettera dei tredici cardinali, Napier parte proprio dalle manovre che lui stesso scoperse e smascherò pubblicamente nel sinodo dello scorso anno. Di quelle manovre, Napier ricorda la dinamica essenziale. Si svilupparono in particolare nella scrittura e nella pubblicazione della "Relatio" di metà sinodo e poi ancora nella redazione della "Relatio" finale. La commissione incaricata di redigere le due "Relatio", tutta nominata da papa Francesco, era allora composta dai seguenti padri sinodali: - Cardinale Péter Erdõ, relatore generale del sinodo; - Cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale; - Bruno Forte, segretario speciale; - Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del pontificio consiglio per la cultura; - Cardinale Donald W. Wuerl, arcivescovo di Washington; - Victor Manuel Fernández, Argentina; - Carlos Aguiar Retes, Messico; - Peter Kang U-Il, Corea; - Adolfo Nicolás Pachón, preposito generale dei gesuiti. Forte, Wuerl e Fernández furono i più attivi e spregiudicati nello spingere avanti la loro "agenda", come Napier la chiama oggi. Ma le reazioni dell'aula sinodale furono talmente forti da indurre Francesco a includere lo stesso Napier e un vescovo australiano, Denis J. Hart, nella commissione, nella fase finale del sinodo. Anche quest'anno la commissione per la stesura della "Relatio" finale è stata tutta nominata da Francesco, che vi ha ricollocato di nuovo i tre suddetti, uno dei quali, Wuerl, è stato anche, nei giorni scorsi, il più offensivo nell'attaccare pubblicamente i tredici firmatari della lettera al papa, Napier compreso. Non sorprende, quindi, che Napier riconduca proprio agli avvenimenti dell'ottobre 2014 le "preoccupazioni" sottoposte quest'anno all'attenzione del papa nella lettera dei tredici cardinali, perché le forzature di allora non si ripetano oggi. Napier giudica positiva la risposta ottenuta da Francesco, già il giorno dopo la consegna della lettera. Ma fa anche capire che proprio l'aver risvegliato l'attenzione del sinodo sui rischi esposti nella lettera ha giocato a favore di un più corretto svolgimento dei lavori, dato il conseguente maggiore controllo esercitato da tutti sulla commissione che ha il compito di scrivere la "Relatio". Ma lasciamo la parola al botta e risposta tra Mickens e Napier. MICKENS – Cardinale Napier, lei ha raccomandato un libro scritto da uno dei nostri colleghi, al quale suppongo che lei abbia collaborato, che in sostanza accusa la segreteria del sinodo e altri di aver manipolato il sinodo. Tredici cardinali hanno scritto una lettera al papa all'inizio di questa assemblea esprimendo preoccupazioni riguardo a irregolarità nella procedura. Lei se ne è dissociato? O forse può chiarire se ha collaborato anche a questa lettera? Oggi ci ha appena detto che la procedura le piace. Che cosa è cambiato dall'ultima assemblea a questa? È bastato che il papa abbia garantito che va bene? Oppure ha qualche altro motivo? Perché non sembra che le procedure siano cambiate drasticamente. Ci può almeno spiegare che cosa è cambiato nella sua testa, al punto che ora può dirsi soddisfatto rispetto all'ultima assemblea? Grazie.
NAPIER – Penso che la prima cosa da dire è che nel precedente sinodo c’erano alcuni singoli elementi che erano motivo di preoccupazione. E uno in particolare è stato il presentare la relazione intermedia come se fosse venuta dal sinodo, come se facesse parte della deliberazione del sinodo. E questo non era vero, perché noi abbiamo ricevuto il documento circa un'ora dopo che voi dei media l’avevate ricevuto. E solo allora abbiamo cominciato a leggerlo. E quel documento già diceva delle cose che io sapevo erano state dette nell’aula da due o tre persone al massimo. Ma era presentato come se quelle fossero la riflessione del sinodo. Ora questo certamente dava l'impressione che il sinodo fosse spinto in una certa direzione. Ho anche fatto parte della commissione che ha redatto il documento finale. E ci sono state anche lì alcune materie che ancora una volta venivano spinte in una certa direzione. Quindi, in questo senso una particolare ideologia, o agenda, o come la si vuole chiamare, sembrava essere all’opera. E la lettera alla quale lei fa riferimento era una lettera privata di cardinali e vescovi al papa ed è stata anch'essa scritta nello spirito di ciò che papa Francesco aveva detto all'inizio del sinodo dello scorso anno, quando disse: "Per favore parlate apertamente e onestamente, ma ascoltate con umiltà". Ed era rivolta a lui in questo spirito. Papa Francesco ha subito risposto con il discorso che ha fatto il giorno dopo, penso, che aveva ricevuto la lettera. E questo ha poi fatto una differenza enorme nel grado di sicurezza e di fiducia, perché le preoccupazioni sono state prese in considerazione, se ne è preso cura, e quindi da lì in poi tutti siamo andati avanti a lavorare nel sinodo a tutto vapore. E penso che questo è ciò che ho sperimentato, ed è il motivo per cui ritengo che questo sinodo riprende da dove quella prima settimana del sinodo precedente l'aveva lasciato, quando eravamo tutti ottimisti e impazienti di lavorare davvero sulle questioni, insieme, come una squadra, con quella sinodalità – il papa è così appassionato di usare questa parola –: collegialità e sinodalità, lavorando insieme come colleghi nella direzione di ciò che è meglio per la Chiesa. Torna al sommario 5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO AVVENIRE Pag 1 Il più umano dei diritti di Carlo Cardia Il contrasto politico sulle 'unioni civili' suggerisce una riflessione di ampio respiro, che sappia distinguere le grandi questioni di merito da quelle dei tempi e procedure. Con una premessa necessaria, perché è un errore considerare le divergenze più recenti alla stregua di piccole schermaglie regolamentari per accelerare o ritardare l’iter di proposte di legge, che ancora non convincono e che investono scelte cruciali per la vita collettiva. Queste schermaglie sono la spia di divisioni profonde, tra chi vuole una legge chiara e rispettosa dei diritti fondamentali della donna e dei minori, e chi intende introdurre – pur sotto la bandiera di un qualche progressismo – svolte regressive con formule ambigue, manipolabili in sede giurisprudenziale, e con silenzi normativi che altri poi possono riempire a piacimento. Non è la prima volta che le Carte internazionali dei diritti umani, che nel Novecento hanno suscitato speranze e attese in tutto il mondo, sono utilizzate per far prevalere i diritti dei più forti su quelli dei più deboli, avviando una parabola in cui si mischiano promesse non mantenute, impegni traditi, silenzi clamorosi. Così avviene in tanti Paesi nei quali il diritto di libertà religiosa è negato, violato con il ripetersi di eccidi, persecuzioni violente e sconvolgenti, cui assistiamo spesso con incredulità e impotenza, nel silenzio assordante delle istituzioni internazionali. In Occidente, anche le più solenni dichiarazioni sono insidiate dalla cultura del relativismo assoluto, quando sostiene che i diritti umani non sono universali, ma frutto di una civiltà estranea ad altri popoli e società, aprendo così la strada a un 'multiculturalismo' che legittima pratiche e usi che vengono da secoli bui della storia umana. Più di recente, questa forma di relativismo si è data come obiettivo strategico quello di stravolgere la cultura e la tradizione che s’è plasmata in Europa su matrimonio, tutela della famiglia e della maternità, recepita nelle Convenzioni internazionali, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 in poi. L’Italia vive oggi un segmento di questa parabola, e deve valutare progetti che investono la il matrimonio e le nuove generazioni, col rischio di
assimilare modelli fatti propri da altri Paesi, non di rado su pressione d’istituzioni sovranazionali del tutto incompetenti in materia, o per decisioni giurisprudenziali che contraddicono le leggi votate da Parlamenti sovrani, altre volte per scelte legislative ambigue e reticenti. Basterà ricordare che la Corte di Strasburgo, di fronte al chiaro dettato dell’art. 12 della Convenzione dei diritti dell’uomo del 1950, che parla del matrimonio tra uomo e donna, s’è più volte contraddetta nello spazio di pochi anni: prima affermando nel 2001 che il matrimonio non è istituto che riguarda gli omosessuali, poi nel 2010 che il matrimonio gay non può essere imposto ai singoli Stati, ma è legittimato da un altro articolo che tutelerebbe la vita privata dei singoli, infine sollecitando ambiguamente gli Stati ad adottare una legislazione che lo introduca di fatto. Anche un recente documento del Parlamento europeo, pur privo d’ogni valore cogente, ha spinto in questa direzione gli Stati membri della Ue perché favoriscano le 'teorie del gender', anche introducendo una nuova forma di matrimonio. La stessa Corte Suprema degli Usa ha nei mesi scorsi scavalcato gli Stati membri, divisi sull’argomento, e con una contestata sentenza, ha deciso che il matrimonio gay va introdotto in ogni legislazione territoriale. Perfino il drammatico crinale dell’adozione di minori da parte di coppie non eterosessuali è stato superato spesso per mera conseguenza logica del riconoscimento del matrimonio gay, o per intervento giurisprudenziale, come è avvenuto in Germania nel 2013, nonostante la legge del 2001 lo escludesse. Infine, si registra un deprimente silenzio di istituzioni nazionali e sovranazionali sulla questione della maternità surrogata che si lega di fatto alle situazioni citate: l’adozione per coppie omosessuali maschili può realizzarsi mediante il ricorso all’uso servile del corpo di una donna per ottenere così il risultato della filiazione altrimenti impraticabile. Di tutto ciò, e del merito delle scelte da compiere, ancora adesso in Italia si cerca di non discutere, mentre ci si appella di continuo a una generica crescita dei diritti individuali, come se i diritti dei minori, e quello della donna a non essere sfruttata, non fossero a fondamento dell’intero edificio dei diritti umani. Nel nostro Paese la situazione potrebbe essere diversa per più ragioni. Per un’opinione pubblica da sempre sensibile e attenta ai valori della famiglia, e alla tutela della maternità; e perché un confronto sincero favorirebbe un accordo su due punti essenziali: distinguere, in armonia con la Costituzione, la tutela della famiglia fondata sul matrimonio dal riconoscimento dei diritti individuali anche nelle relazioni interpersonali; confermare il diritto primario dei minori ad avere entrambe i genitori, escludendo l’adozione da pare di coppie non eterosessuali. Il diritto alla doppia genitorialità madrepadre non è una concessione da fare a una parte politica, né può essere contrattata per avere qualcosa in cambio. È il primo, e in certo senso il più umano, dei diritti umani, che va riconosciuto a chi nasce perché su esso si fonda, e si sviluppa, tutta la sua vita futura. E l’impegno contro la servitù del corpo femminile dovrebbe essere un momento alto di concordia politica, per riaffermare la dignità della donna contro nuove forme di asservimento. Queste colonne d’Ercole segnano il confine tra una concezione dei diritti umani che rispetti le esigenze dei più deboli, e un’altra che apre all’egoismo del più forte, a forme inedite di servitù e sfruttamento. Come tali, non possono essere aggirate con silenzi ipocriti (sulla maternità surrogata), compromessi lessicali (che non parlano di matrimonio, ma dicono la stessa cosa), con inganni linguistici. E il punto è proprio questo. La storia degli ultimi anni, in Europa e in Occidente, è piena di trappole, ambiguità, pressioni indebite, per conseguire risultati che certamente non sono presenti in atti normativi, ma che poi, in modo ingannevole, si ottengono senza che il Parlamento li abbia approvati. Il diritto dei minori ad avere un papà e una mamma, come tutti i bambini del mondo, il diritto delle donne più sole, soprattutto nei Paesi poveri, a non essere spinte verso umilianti servitù, come avviene nella maternità surrogata, restano obiettivi strategici di una politica che non intende utilizzare le Carte internazionali dei diritti umani per legittimare l’affermazione del più forte sul più debole. IL GAZZETTINO Pag 23 Convivenze di fatto e unioni civili: la soluzione in legislazioni diverse di Ennio Fortuna Era piuttosto evidente che il disegno di legge in corso di esame al Senato sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto non sarebbe piaciuto ai più e che sarebbe stato
vivacemente contestato. Dai tradizionalisti perché avrebbero trovato che il rapporto destinato a tradursi in unione civile riconosciuta somiglia troppo al matrimonio vero e proprio ,pur rimanendo questo riservato esclusivamente alle coppie eterosessuali, ma anche dai progressisti perché difficilmente avrebbero ammesso che il matrimonio è definitivamente interdetto agli omosessuali. In sostanza era facile prevedere un percorso agitato e contrastato, né si poteva e tanto meno si può ora escludere che alla fine tutto si risolverà in un giro di parole e in vivaci scambi di opinioni senza che la legge veda la luce, almeno in tempi ragionevoli. Personalmente trovo che il progetto sulle unioni civili sia esageratamente ricalcato sul rapporto matrimoniale vero e proprio, al punto che in molti chiederanno le opportune modifiche proprio per salvaguardare le caratteristiche e l’esclusività del matrimonio. Sostanzialmente, così come raffigurato nel disegno di legge, adottato come base di discussione, tutto ciò che è presente nel matrimonio civile si rinviene anche nell’unione omosessuale, specie quanto a diritti e doveri dei componenti della coppia. Evidentemente i presentatori, a corto di fantasia oppure di proposito, hanno adottato come modello esclusivo il codice civile nel capitolo del matrimonio, e lo hanno tradotto in proposta per le unioni omosessuali, in pratica ricreandone la struttura quasi perfettamente. Manca, certo, la proclamazione del vincolo matrimoniale da parte dell’ufficiale di stato civile, ma tutto il resto è presente, quasi negli stessi termini, cosicché i componenti della coppia in linea di massima godono dei diritti e sono gravati dai doveri degli sposi senza però essere sposati. Ciò che non può piacere ai tradizionalisti, ma che non piacerà neppure ai progressisti che non mancheranno di denunciare la presunta discriminazione. Ora la polemica si incentra soprattutto sull’adottabilità del figlio del partner Secondo l’ultimo testo del disegno di legge aperta solo al figlio naturale. Troppo poco per i progressisti, decisamente troppo per i tradizionalisti. Le cose vanno meglio con la convivenza di fatto laddove si regolamenta finalmente una situazione che da troppo tempo esigeva di essere disciplinata in modo civile. Qui basta un rapporto stabile e duraturo per dare luce a diritti e a doveri, anche in mancanza di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato. Mi sembra logico prevedere meno contrasti e minori problemi, anche se difficilmente il disegno di legge andrà in porto in tempi ragionevoli, le difficoltà dipendendo soprattutto dal fatto che contemporaneamente si discute delle unioni civili, come ho detto, problema ben più contrastato. Forse una soluzione potrebbe essere rinvenuta nella scissione del disegno di legge, un lato le unioni civili, dall’altro le convivenze di fatto. Ma difficilmente ciò accadrà, vista l’impostazione fortemente ideologizzata che investe il progetto complessivo. Un aspetto positivo va comunque segnalato e apprezzato: da troppo tempo in Italia c’era polemica forte e vivace sulla sorte delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Praticamente era l’unico paese d’Europa ancora privo di qualunque regolamentazione. Il fatto che finalmente il Parlamento si accinge ad affrontare il problema (indipendentemente dalla concreta soluzione dei tanti problemi) non può non essere annotato e apprezzato positivamente. Torna al sommario 7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA CORRIERE DEL VENETO Pagg 2 – 4 “Figlie mie, non saremo un peso”. A 95 anni uccide la moglie e si spara di Davide Tamiello, Alice D’Este, Andrea Priante e Jacopo Lodde Ernesto e la sua Loredana, costruttori e benefattori: “Ci diedero centomila euro per fare un centro anziani”. Tre colpi tra la folla dell’ospedale: le grida, la paura, i pazienti in fuga. Il lucido gesto di menti stanche, un’eutanasia emotiva Mestre. L’avevano deciso insieme. Dopo tutti questi anni, avrebbero chiuso il sipario sulle loro vite mano nella mano. Hanno scritto una lettera per le figlie, hanno chiamato un taxi per farsi portare all’ospedale dell’Angelo a Mestre, la loro città. Qui, nel cortile interno, davanti a tutti, Ernesto Cecchinato, 95 anni, ha estratto la sua Beretta. Due colpi al petto alla moglie, Loredana Pedrocco, 90 anni, e un colpo per se stesso, diretto alla tempia. Un atto estremamente lucido. Un omicidio e un (tentato) suicidio concordato, quello tra i due coniugi mestrini che ieri mattina, intorno alle 10, ha
scatenato il panico all’interno dell’ospedale. Cecchinato è un ingegnere in pensione, famoso in città soprattutto per aver realizzato da costruttore l’intero viale don Sturzo, nella Mestre degli anni ‘70. I due, mestrini doc, dall’inizio del 2014 si erano trasferiti all’Hotel Venezia di Abano Terme. Non avevano prenotato nessuna visita medica a Mestre. Secondo i medici, Cecchinato sarebbe stato operato anni fa per l’installazione di un bypass. La moglie, invece, non avrebbe avuto patologie particolari se non quelle legate all’età avanzata. «I due anziani però sentivano che stava arrivando la fine della loro vita terrena e non volevano creare fastidi alle loro figlie», ha spiegato commosso il dirigente del commissariato di Mestre, Eugenio Vomiero, dopo aver letto la lettera firmata dai due anziani e indirizzata a Carla, 65 anni, che vive a Conegliano, e Nadia, 61 anni, che abita a Mestre. Lettera che Loredana Pedrocco aveva infilato nella sua borsa, prima di chiamare il taxi che li portasse da Abano a Mestre. Una volta dentro all’ospedale, si sono mescolati alle decine e decine di persone presenti nel salone d’ingresso in attesa delle visite, per fare una prenotazione o per salire ai reparti. I due si sono seduti su una panchina nell’area di riposo vicino a delle grandi piante verdi. Poi i tre colpi. La donna è morta all’istante, l’uomo, invece, è stato portato in terapia intensiva. La sua vita, al momento, è appesa a un filo. Sul posto, per le indagini, la squadra mobile di Venezia. Nella lettera, i due coniugi avevano spiegato chiaramente i motivi del gesto: la malattia, la vecchiaia, la paura di diventare un peso per le figlie. La pistola utilizzata, una calibro 6, era stata regolarmente acquistata e detenuta dal 95enne. La scena, choccante, è avvenuta sotto gli occhi dei tanti utenti dell’ospedale mestrino. «Ho sentito i primi colpi, sembravano quelli di una pistola giocattolo - spiegano gli impiegati seduti al di là del vetro - poi ho alzato la testa e ho visto un anziano, seduto accanto ad una donna con la testa riversa che si puntava la pistola alla tempia. È stato un secondo, e poi ha fatto fuoco». Il colpo non ha ucciso Ernesto Cecchinato. Inspiegabilmente. La pallottola lo ha attraversato lasciandolo ancora vivo. L’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente e trasportato in Rianimazione dove è rimasto tutto il giorno. I familiari hanno aspettato in una saletta riservata. Lontani da sguardi indiscreti. «Non l’abbiamo ancora operato – hanno spiegato i medici nel pomeriggio - è anziano e per il momento va stabilizzato. L’operazione poi potrebbe essere molto rischiosa». I problemi sostanziali al vaglio dei medici dell’ospedale dell’Angelo sono due: l’età e la difficoltà dell’intervento che avrebbe dovuto preservare le funzionalità corporee in un fisico già molto provato. E così, in serata Ernesto Cecchinato è stato messo in coma farmacologico. La prognosi rimane riservata. Chi ha assistito alla scena si è precipitato fuori dagli uffici, ha chiesto aiuto. Uno dei primi è stato un signore anziano che stava passando per di là per prenotare un esame: «Ero arrivato da poco, stavo per mettermi in coda - racconta – quando ho sentito gli spari. Sono corso subito verso le panchine. Sono arrivato mentre l’uomo stava premendo il grilletto». L’uomo è stato interrogato a lungo dalle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. «Io non ho avuto il coraggio – dice Virna Pesce della pasticceria – ho sentito gli spari ma non sapevo cosa stesse accadendo». Accanto agli anziani, subito dopo, è arrivato anche il tassista che li aveva accompagnati nel loro ultimo viaggio. L’uomo, come tutti gli altri testimoni della vicenda, è stato interrogato dalla polizia. Mestre. Quando Giovanni Zanetti ha conosciuto l’ingegner Ernesto Cecchinato era ancora molto giovane. All’epoca aveva 18 anni e aveva appena cominciato a muovere i primi passi da architetto. Insieme a lui ha lavorato fianco a fianco a diversi progetti, che hanno cambiato il volto di Mestre. «Abbiamo lavorato uno accanto all’altro fino agli anni ‘80, in particolare nella zona di viale don Sturzo. E’ un uomo capace e molto sensibile - spiega Zanetti - di fronte al suicidio di un conoscente comune mi aveva detto: ha avuto il coraggio che io non ho. Ma erano parole a caldo, dette molti anni fa, non ci ho fatto caso. Da quando si era ritirato dal lavoro negli ultimi anni ci incontravamo più di rado. Mi ha raccontato della sua passione per la pittura. Aveva realizzato diversi dipinti, alcuni molto belli e li aveva esposti al Centro don Vecchi. Persone come Ernesto hanno sempre creduto nelle regole della vera e semplice società. forse si è sentito troppo solo e non ce l’ha fatta a gestire quest’ultimo passo». Ernesto Cecchinato ha scritto un pezzetto dello sviluppo di Mestre. Sentiva sua questa città, perché ci era nato e cresciuto e perché una parte l’aveva anche costruita. Ingegnere libero professionista, socio di un’impresa, ha legato il suo nome soprattutto alla realizzazione del quartiere don Sturzo, a nord di
Carpenedo. L’ingegnere, in società con altri, acquistò i terreni, li bonificò e cominciò il lungo braccio di ferro con l’amministrazione, piena di dubbi su quel nuovo pezzo di città, per riuscire ad avere il via libera. Erano gli anni ‘70, il pieno del boom edilizio di Mestre. «Era arrivato quasi all’esaurimento nervoso all’epoca - racconta don Armando Trevisiol, ex parroco di Carpenedo - mi aveva confidato che proprio in quel periodo, per risollevarsi, aveva incominciato a dipingere». Don Armando lo sapeva bene, tanto che Cecchinato, un giorno, si presentò in parrocchia per regalargli le sue opere e 5 milioni di lire. «Sapevo da sempre che questo professionista mestrino, assieme ad un certo “faccendiere” di Carpenedo, aveva bonificato le cave che soprattutto un altro paesano di Carpenedo, il signor Casarin, aveva scavato per cuocere i mattoni nella sua fornace - aggiunge don Armando -. L’ingegner Cecchinato progettò e realizzò tutti quei fabbricati del viale che ora ha, ai bordi, due magnifici ed imponenti filari di pini marittimi». Cecchinato fece molto di più. Il «costruttore benefico», come lo chiamava don Armando, nel 2013 donò 100mila euro alla fondazione Carpinetum per la costruzione del «Don Vecchi 5», dedicato agli anziani non autosufficienti. Lo fece senza proclami, cercando anzi di mantenere l’anonimato. Don Armando lo riconobbe solo dal bonifico: «Non era particolarmente credente, ma apprezzava quello che facevo. Ci sentivamo spesso. Mesi fa mi aveva detto di essere malato, stanco e di sentire di essere arrivato alla fine». Mestrino doc, in città era stato un’istituzione. «Il rione don Sturzo l’ha progettato praticamente tutto lui - racconta don Rinaldo, ex parroco di San Pietro Orseolo - quando da queste parti c’era solo la mia Chiesa ha pensato di costruire un quartiere. Abbiamo lavorato fianco a fianco per anni. Era una persona corretta, simpatica, attenta e generosa e aveva una sensibilità particolare per le persone. Ha dato lui, insieme a me, l’anima e l’idea del rione don Sturzo. Prima al bordo di via Vallon c’era solo una casa. Lui ha fatto la strada e i palazzoni, pensando di svilupparli in altezza per lasciare spazio al verde. Ci siamo visti anche dopo la fine dell’attività, dopo la costruzione». Ma i ricordi di lui sono intensi anche tra i colleghi. «Un bravo costruttore - lo ricorda l’architetto mestrino Ruggero Artico - mio padre lo conosceva bene. Era uno dei pochi con cui gli architetti riuscivano ad andare d’accordo sul lavoro». «Una persona retta, onesta, un ingegnere della vecchia scuola», per il collega Pietro Franceschin. E Loredana Pedrocco? Una donna di casa e di famiglia. Nell’appartamento di via Fucini i vicini li ricordano sempre insieme. «Non uscivano mai separati - racconta una vicina - li vedevo passare a braccetto». Da tempo però in quella casa, un condominio a due piani interamente di proprietà dei Cecchinato, i due anziani non c’erano più. Vivevano all’hotel Venezia di Abano Terme. «Non li vediamo più da tempo - spiegano nella farmacia vicina - erano clienti ma non venivano spesso». «Era rimasta solo la figlia - conferma il barbiere che ha aperto un piccolo negozio nella via - vedendo l’alloggio libero le avevo chiesto di affittarmelo. Lei ha risposto che i genitori preferivano tenerlo così com’era, per ogni evenienza». Abano terme (Padova) All’Hotel Venezia si brinda. Nel giardino un gruppetto di signori anziani scherza e alza i calici: uno di loro compie ottant’anni e gli amici hanno improvvisato una festicciola sui tavolini bianchi della struttura che li ospita. Scherzano, si divertono, qualcuno parla al telefono a voce alta. Un applauso, strette di mano ed è già tempo di rientrare: ci sono i fanghi da fare, poi il massaggio tibetano, la fontana di acqua termale, il bagno all’ozono sensoriale e un passaggio nella grotta ai vapori. La vita scorre lenta e – almeno all’apparenza - piacevole, nelle 110 stanze di questo grande hotel a 4 Stelle che sorge nel cuore di Abano. Gli ospiti arrivano, si incontrano, fanno amicizia, ma sono rapporti a termine. A vacanza finita si torna a casa e le amicizie appena instaurate si interrompono, sospese fino alla prossima settimana di relax. Ci si rivede tra un anno: stesso periodo, stesso albergo, stessi trattamenti. Ma per Loredana Pedrocco e suo marito Ernesto Cecchinato le cose stavano diversamente: l’Hotel Venezia era la loro casa e il personale una seconda famiglia. I coniugi erano arrivati all’inizio del 2014 e non se n’erano più andati, forse proprio perché - con l’avanzare dell’età e gli acciacchi che si facevano sentire - non volevano gravare sulle figlie. Vivevano in quella stanza che ieri la polizia ha passato al setaccio cercando prove, tracce, dettagli utili a ricostruire cosa li abbia spinti a chiamare un taxi e farsi portare all’ospedale di Mestre, sulla panchina dove lui ha sparato alla moglie e poi ha cercato di farla finita. Francesco Pelizza è il tassista che li ha accompagnati in quell’ultimo viaggio verso la morte. È
rimasto al loro fianco, da quando sono usciti dall’hotel al momento in cui Cecchinato si è puntato la pistola alla testa. «Era una pistola piccola. Credo che per tutto il tempo l’abbia tenuta nascosta sotto all’impermeabile», racconta. Partiamo dall’inizio… «Avevano prenotato la corsa per le 8.30 del mattino. Li conoscevo: spesso si muovevano in taxi, sempre insieme, anche se di solito li accompagnava un mio collega. Questa volta però lui era occupato e quindi sono andato io a prenderli, di fronte all’hotel. Era un piacere averli come clienti: due persone gentili, molto educate. Lui si è presentato con l’impermeabile, il cappello e il giornale sotto al braccio. Aveva una busta in mano». Di cosa hanno parlato lungo il tragitto? «Mi ha spiegato di dover fare una visita cardiologica, e poi ha ricevuto la telefonata di un familiare. Per il resto parlavano tra loro. Erano una coppia innamoratissima, piena di attenzioni l’uno per l’altra, inseparabili. Era bello osservarli, scoprire che a novant’anni marito e moglie possono ancora chiamarsi “amore”...». Nulla che facesse presagire l’intenzione di farla finita? «Nulla, si sono comportati normalmente. Mi sono fatto l’idea che lei non sapesse del piano di suo marito. Oppure, se anche lo conosceva e avevano concordato di farla finita insieme, magari non aveva idea del giorno esatto in cui lui avrebbe agito». Nella borsa della donna hanno trovato una lettera di addio... «L’ho sentito dire, ma per quanto ne sappiamo potrebbe essere stato lui a infilarla nella borsetta» Quando siete arrivati all’ospedale di Mestre cos’è accaduto? «L’anziano, lucidissimo come sempre, ha tirato fuori il tesserino per i disabili e l’ha posato sul cruscotto del taxi. Mi ha indicato che strada seguire e dove parcheggiare. Credevo di doverli accompagnare al secondo piano e invece mi ha fermato, dicendo che lui e la moglie avrebbero aspettato all’ingresso, in quella specie di giardino che si trova all’interno all’ospedale di Mestre. “Vai pure via - mi ha detto Cecchinato - intorno alle 10 verrà a prendermi Greta, l’assistente della dottoressa, per accompagnarmi al reparto”. Ho risposto che li avrei aspettati volentieri ma lui ha insistito e a quel punto gli ho lasciato il mio numero di cellulare. Ci siamo accordati: mi avrebbe telefonato non appena fossero stati pronti a tornare all’hotel». A quel punto li ha lasciati soli? «Sono andato in bagno e quando sono uscito li ho notati seduti su una panchina. Lei era alla sua sinistra, gli aveva tolto il cappello e lo teneva tra le mani. Mi sono voltato per andare via e in quel momento si è sentito il primo colpo di pistola. Ho capito subito che il botto proveniva dalla zona in cui si trovavano loro. Li ho guardati, lei era accasciata sulla panchina: il marito le aveva sparato al petto. A quel punto mi sono avvicinato, non sapevo cosa fare... Poi, l’ho visto puntarsi la pistola alla testa e premere il grilletto». È finita così... «Sono rimasti su quella panchina, seduti l’uno accanto all’altra come due fidanzati. Poi, lentamente, l’uomo è scivolato sul pavimento e sono arrivati gli infermieri che l’hanno portato via». Le persone presenti nella hall dell’ospedale erano sconvolte. «Il sangue continuava ad uscire, è stato orribile. In pochi minuti sono arrivati i poliziotti con il giubbotto antiproiettile, convinti fosse in corso una sparatoria. Io ero ancora intontito, mi hanno chiesto da che parte fosse fuggito l’uomo che aveva sparato. Ho risposto che era troppo tardi: non c’era più nessuno da inseguire...». Mestre. Tre colpi. Un silenzio irreale e poi il caos: grida, la security con i giubbotti anti proiettile, medici, infermieri, pazienti, tutti affacciati dai piani verso la hall. Il primo pensiero di tutti è stata una sparatoria, un omicidio con l’assassino in fuga. Sono stati i primi testimoni a bloccare la «caccia» all’uomo, dicendo che non c’era nessun fuggiasco armato, ma solo quella coppia a terra, nel sangue. Quando Ernesto Cecchinato, seduto sulla panchina tra il verde con la moglie Loredana Pedrocco, ha esploso i due colpi contro di lei e ha rivolto l’arma contro se stesso, tutti i negozi erano aperti. «Ero in cassa – spiega la commerciante dell’edicola – ho sentito i due colpi ma all’inizio ho pensato ad un’arma giocattolo. Poi ho visto tutti accorrere verso il centro della hall e allora sono uscita. Ho visto il corpo di lei, riverso sulla panchina». «Ho pensato a una sparatoria – racconta una ragazza del bar – o una rapina, sono rimasta dentro aspettando che
passasse». Racconta lo stesso anche l’addetta all’accoglienza dell’associazione non udenti: «Sono rimasta immobile dietro al bancone – dice – non riuscivo più a muovermi dal terrore». «Stavo per prendere l’ascensore per andare a trovare un’amica. Ho sentito due colpi, mi sono girata e ho visto quell’uomo seduto che si puntava la pistola alla tempia». Valeria, 75 anni di Mestre, è ancora sotto choc. All’Angelo ieri mattina era andata per fare visita a un’amica ricoverata. «Pochi attimi e si è scatenato il caos – racconta – sono arrivati medici, infermieri. La signora era sulla sedia, la testa rivolta indietro e tutto il sangue davanti. Lui era a terra, immobile, ho pensato che fosse morto. Tutti stavano intorno alla signora, pensavo stessero tentando di salvarla. Una scena sconvolgente, ho preso l’ascensore per non vedere altro». E’ stato un uomo, per primo, a prendere tra le braccia il corpo di Cecchinato. Gli uomini del servizio di vigilanza dell’ospedale sono stati i primi a intervenire, lanciandosi alla ricerca dei presunti assassini. In quel primo momento non si erano ancora resi conto che, in realtà, i colpi erano partiti solo tra quei due anziani. In pochi minuti, l’ospedale è stato invaso dalle forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di Mestre, gli investigatori della squadra mobile e gli uomini della scientifica. La prassi dei rilievi: in realtà, il caso è chiuso e c’è ben poco da indagare. In supporto agli agenti di polizia, anche i carabinieri della compagnia di Mestre. Durante le operazioni, è stato recintato con il nastro rosso tutto il cortiletto dell’ospedale, per permettere di fare i rilievi senza che nessuno alterasse la scena del delitto. Fino a quando, cioè, il carro funebre non è arrivato per portar via il corpo della donna. Allora sono state alzate delle barriere per recintare l’intera zona e metterla al riparo da sguardi indiscreti. L’area è stata riaperta poco prima delle 13.30. Per tutto il tempo, pazienti e utenti dell’ospedale, hanno osservato le operazioni a occhi sgranati tra le telecamere e i flash dei fotografi. Sono in pochi quelli a tirare dritto, senza accorgersi o ignorando volutamente quel viavai di uomini in divisa. «Scusi, dove posso prenotare una visita?», chiede una signora senza indugiare troppo sulle transenne. Di fatto tutti i servizi, comunque, sono rimasti aperti. Il personale si è mosso velocemente per evitare che la situazione rendesse l’ospedale inaccessibile: «Di fronte a questa tragedia esprimo tutto il mio cordoglio – ha detto Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’Usl 12 – un plauso va anche al personale dell’ospedale che ha dato la sua piena disponibilità per le ore più concitate per evitare disagio agli utenti». Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Luigi Brugnaro: «Di fronte alla tragedia solo il silenzio – ha detto - questi episodi dettati dalla disperazione dovrebbero farci riflettere sul valore e sul significato della vita». In un momento di grande clamore mediatico sommersi dalle mille ipotesi che girano e gireranno attorno alle motivazioni che hanno portato i coniugi Cecchinato all’insano gesto mi viene spontaneo ragionare sulla vicenda umana ed ai significati del suo epilogo. In queste situazioni ci si affanna spesso nel chiedere risposte alla psicologia ragionando in termini di causa ed effetto; si cercano diagnosi rassicuranti che mettano una cornice all’evento e portino al senso comune risposte chiare e incontrovertibili che si è trattato di un gesto folle o conseguente a qualche patologia. Si va a frugare nelle pieghe della vita di questi due fieri anziani, esempio fulgido della conquistata longevità della nostra epoca che probabilmente con la stessa dignità con la quale avevano vissuto più di novant’anni di vita, hanno deciso di farla finita. Quale esperto del decadimento cognitivo e della gestione del familiare e del paziente che soffre della sindrome di Alzheimer potrei dilungarmi ad elencare segni e sintomi che caratterizzano la malattia e rispolverare l’immancabile depressione a giustificare il tutto… ma non lo farò. Dai primi elementi riportati dalla cronaca odierna e dalle indagini emerge un lucido e discreto disegno di dipartita dalla vita sostenuto dal messaggio di richiesta di comprensione per i familiari e una sequenza di azioni e scelte aventi la finalità di andarsene in punta di piedi. La scelta di vivere in albergo negli ultimi mesi, le scuse della lettera trovata nella borsetta della signora Loredana e la scelta dell’ospedale come scenario dell’epilogo della loro storia, testimoniano una lucida determinazione a porre fine alle loro vite, poco intossicata da tratti patologici e più orientata verso una consapevole fine delle loro vicende umane. In una sorta di accudimento reciproco queste due persone hanno deciso, per loro stessa mano, di porre fine alla loro apparente felice esistenza senza dare la possibilità che qualsivoglia malattia andasse a logorare ulteriormente i loro corpi consunti e vecchi. Psicologicamente credo si possa parlare di eutanasia emotiva di una o forse due menti
stanche e ancora lucide per poter compiere un gesto di libertà. Certo meno roboante degli episodi da ascrivere al club dei 27, il tentativo di farla finita dei coniugi Cecchinato rappresenta probabilmente una semplice storia d’amore conclusasi in uno stato alterato di coscienza indotto dalla stanchezza di una vita e non dalle nevrosi dell’esistenza quotidiana. Pag 6 Mose di Alberto Zorzi Dall’inchiesta emerge che i cassoni venivano pagati il doppio del costo e oltre al guadagno veniva fatta pure la “cresta” per creare fondi neri Venezia. Delle tre bocche è quella più piccolina, più lontana da Venezia. Ma quando si trattava di tirare fuori i soldi per i politici, la bocca di porto di Chioggia non temeva confronti, anche perché Stefano Tomarelli, l’uomo di Condotte, e Pio Savioli, consulente del Coveco, si erano inventati uno stratagemma niente male: fare la «cresta» sui cassoni per creare i fondi neri e gonfiare le tasche di amici e superiori, nonché le proprie. E’ lo stesso Savioli – interrogato dai finanzieri il 14 luglio 2014, in un verbale ora agli atti del processo – a spiegare il sistema. Da contratto era previsto che gli 8 cassoni fossero pagati circa 16,5 milioni l’uno dal Magistrato alle Acque al Consorzio Venezia Nuova, che poi avrebbe dovuto «comprarli» dalla Clodia. Secondo il racconto del consulente del Coveco, in realtà il costo vivo del cassone era stato stimato in circa la metà – 7,6 milioni di euro – e già da questo si può capire come ci fosse un enorme margine «regolare». A quel punto però si decise di «gonfiare» il costo di ognuno dei cassoni di 500 mila euro, da dividere a metà con una retrocessione «in nero»: 250 mila andavano alle imprese esecutrici (le coop Clea e San Martino) per il «disturbo», 250 mila se li spartivano Tomarelli e Savioli. Il primo, come confessa lui stesso nell’interrogatorio del 24 giugno 2014, se ne prendeva 160 mila, di cui 30-35 mila erano suoi e il resto li avrebbe versati all’ingegner Paolo Bruno, all’epoca presidente di Condotte (poi deceduto). «Diciamo che sugli otto cassoni doveva arrivare a un milione», spiega Tomarelli. La pista più interessante è però quella dei 90 mila euro che finivano nelle tasche di Pio Savioli. Lui stesso ha fatto uno schemino precisissimo di fronte ai finanzieri: 20 mila finivano a Mario Boscolo Bacheto, presidente della San Martino, anche lui indagato e deceduto quest’estate; 30 mila direttamente a Giampietro Marchese e dunque al Pd, visto che le indagini hanno sempre dimostrato che lui non raccoglieva i soldi per se stesso, ma per il partito; gli altri 40 li teneva lui, una parte per se stesso, un’altra per fini politici. Basta fare la moltiplicazione per i sette cassoni su cui il giochino funzionò per trovare le cifre: 140 mila euro a Bacheto, 210 mila a Marchese, 280 mila a Savioli. «Di questi, 100 mila andarono al sottoscritto - ha poi spiegato - 80 mila per le elezioni comunali del 2010, consegnati a Marchese, 100 mila per le politiche del febbraio 2013, consegnati anche questi a Marchese». «Marchese era perfettamente a conoscenza che le somme “in nero” giungevano dal Consorzio», ha continuato. Un mix di «nero» e di «bianco» a disposizione per finanziamenti elettorali (tra i vari nomi del Pd finanziati dal Coveco regolarmente ci sono Davide Zoggia, Sergio Reolon, Lucio Tiozzo, Andrea Martella, Delia Murer), che la procura in altri casi ha contestato come illeciti perché nascondevano il vero erogatore, cioè il Consorzio Venezia Nuova. Ed è questa infatti l’accusa che i pm Stefano Ancilotto e Stefano Buccini sono pronti a sostenere contro l’ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni (sostenuto dal Pd) e l’ex europarlamentare Lia Sartori (Pdl). Il primo ha ricevuto 110 mila euro da tre aziende (San Martino, Clea e Cam Ricerche) e – secondo l’accusa – 450 mila in contanti da Mazzacurati. La seconda ha ricevuto 25 mila euro dal Coveco e – dicono i pm –200 mila da Mazzacurati. Dei soldi a Sartori parla, in un interrogatorio del 16 luglio 2014 finora inedito, Franco Morbiolo, presidente del Coveco, anche lui arrestato il 4 giugno e che poi ha chiuso la sua posizione patteggiando un anno e mezzo. Di fronte al pm Paola Tonini che gli chiede conto di quel contributo al Pdl («Questi sono in linea con le cooperative - dice il pm dopo aver elencato alcuni uomini Pd - ma Sartori che cosa c’entra?»), Morbiolo abbozza. «Ho capito meno la Sartori», ammette. «E’ venuto Savioli - racconta - ha detto: “E’ necessario farlo... Ci può servire, ha tanti rapporti, poi sai com’è...Sennò i rapporti con... mi vanno in crisi». A Orsoni, invece, il 19 dicembre scorso, i pm chiedono di spiegare perché nel verbale del 9 giugno avesse detto di essersi posto un problema di «opportunità» dei finanziamenti da aziende del Consorzio. «Avevo vissuto il clima generale dell’opposizione da parte della
politica veneziana soprattutto riferita alla sinistra, a gran parte della coalizione che mi avrebbe sostenuto, una politica di avversione al Consorzio e al Mose - racconta - avevo percepito che si erano un po’ ammorbiditi nei confronti di questa iniziativa (...) Mi sono posto il problema di non essere un domani smentito dai miei sostenitori se per caso vedevano che alcune delle imprese che facevano riferimento a questo mondo avevano versato dei contributi legittimi alla mia campagna elettorale». I pm a quel punto obiettano: ma se sono gli stessi che hanno ricevuto soldi nelle campagne elettorali precedenti? Orsoni alza le braccia, ma è tagliente: «Se i partiti avevano deciso che facevano la faccia feroce davanti al pubblico, poi però si accordavano in altri... Questo non lo sapevo». LA NUOVA Pag 1 Il sistema mazzette di Mazzacurati di Renzo Mazzaro Trent’anni di sistema Mazzacurati a processo e manca proprio lui, l’ingegner Giovanni Mazzacurati, prima direttore generale e poi presidente del Consorzio Venezia Nuova, l’uomo che ha costruito e tenuto in piedi il grande affare del nuovo secolo. Il Mose è la più grande opera pubblica in costruzione in Italia, ci costerà 6 miliardi e mezzo a fine corsa, se tutto andrà bene. Nel frattempo su 5 miliardi e mezzo erogati dallo Stato, uno ha preso il volo in tangenti, sovrafatturazioni, finanziamenti indebiti, sprechi. A tenere i cordoni della borsa era l’ingegnere. Gelosissimo dei rapporti con Roma. Unico a trattare con i ministeri, con i ministri, con la presidenza del consiglio dei ministri. Mazzacurati dava senza farsi pregare, tanto non erano soldi suoi, ma con generosità oculata. A tutti, purché ci fosse una buon ragione. Incluso se stesso, si capisce. Cento milioni all’anno, ha fatto il conto un altro ingegnere, Piergiorgio Baita, che gli teneva compagnia nel consiglio direttivo del Consorzio, era il “fabbisogno sistemico” per la grande opera. Sentite come suona elegante e asettica questa definizione. Gli ingegneri sono scientifici. E sono andati avanti per una decina d’anni, da quando il Comitatone ha rotto gli indugi e lo Stato ha cominciato a pompare denaro. Cento milioni all’anno sopra il costo dell’opera, s’intende. Mazzacurati teneva un libriccino dove segnava con simboli che capiva solo lui, i nomi e le cifre. Ma l’accusatore principe non verrà a decriptare i geroglifici: è negli Stati Uniti, anziano, malato. Qualche giornalista ha provato a rintracciarlo, senza successo. Solo lui potrebbe spiegare, per esempio, perché il Consorzio dava incarichi ad un’impresa priva di requisiti tecnici minimi come quella del romano Erasmo Cinque. Il quale poi, secondo l’accusa, girava la mazzetta all’ex ministro Altero Matteoli, che aveva concordato il reclutamento. Erasmo Cinque non muoveva un dito, vendeva il lavoro alla Mantovani di Baita, che si accollava le operazioni lasciandogli un 6-7%. Gratis. Una forma di appalto. Nel Consorzio lo chiamano sub-affidamento, lo praticano tutte le imprese. L’ha confermato Giuseppe Fiengo, uno dei tre commissari nominati da Cantone, in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, spiegando così gli incidenti al cassone di Chioggia (Condotte aveva venduto il lavoro ad un’impresa minore) o alla chiusa nella conca di navigazione a Malamocco. Il processo cercherà la prova del passaggio di denaro tra Cinque e Matteoli, che alla vigilia non risulta. Senza il denaro, la corruzione si trasforma in traffico d’influenza e si scende di grado. E’ un passaggio delicato. Il denaro non si è trovato neanche per Renato Chisso. O per Giancarlo Galan, per citare due imputati eccellenti usciti dal processo con il patteggiamento. A chi ha patteggiato non potranno più essere chiesti i danni, se non attraverso un processo in sede civile. Qui si apre il capitolo delle parti civili. L’ammissione sarà una battaglia dura, ma la presenza dello Stato che si costituisce con la presidenza del consiglio e tre ministeri, ridà alla vicenda Mose la dimensione di scandalo nazionale che ha sempre avuto. Nonostante la coltre di silenzio che l’ha subito ricoperta. E’ da sperare che se ne accorgano anche trasmissioni come Porta a Porta, che preferiscono puntare su Mafia Capitale (rapporto 1 a 10 con il Mose in “fatturato criminale”) o sui Casamonica. Potrebbe nuocere alla spettacolarità del processo l’assenza di figure di spicco dell’inchiesta, giù uscite con il rito alternativo. Ma l’unico processo Mose disponibile è quello che si apre domani e finirà per riaprire tutti i fronti. Se poi il successo dell’accusa si misura dal risultato e non dagli articoli di giornale, i pm l’hanno già portato a casa, costringendo nei mesi scorsi a patteggiare imputati eccellenti che presumibilmente avevano altro da nascondere. Con i limiti che questo ha comportato,
primo fra tutti la rinuncia a perseguire i reati nelle sedi romane, mettendo a nudo lo scandalo dalle fondamenta. In ogni caso la pluralità dei soggetti coinvolti nello scandalo è assicurata. Si va da Vittorio Giuseppone, ex magistrato della Corte dei conti, a Maria Giovanna Piva del Magistrato alle Acque, da un professionista molto introdotto nei lavori pubblici veneti oltre che a Villa Rodella come Danilo Turato a dirigenti della Regione con imputazioni diverse e gravità da verificare, come Luigi Fasiol o Giovanni Artico. Quanto a notorietà, la parte del leone sarà senz’altro dell’ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e dell’ex eurodeputata Lia Sartori. Hanno imputazioni modeste (finanziamento pubblico al partito) ma grande notorietà. E ruoli di spicco, non solo politici, soprattutto Lia Sartori, legatissima a Giovanni Mazzacurati. Tutti i i lavori affidati ad Erasmo Cinque a Marghera (350 milioni circa) erano su progetto dello Studio Altieri. Pag 4 “Un grande benefattore dei Centri Don Vecchi” di Giacomo Costa La tragedia di Mestre: don Armando Trevisiol ricorda le difficoltà e la generosità dell’ingegnere Mestre. «Per Ernesto Cecchinato provo un vero e sincero sentimento di stima e affetto, che andava al di là del mio ruolo di religioso»: don Armando Trevisiol, ex parroco di Carpenedo e fondatore dei centri di accoglienza Don Vecchi, confessa il rapporto di amicizia e collaborazione che lo lega all’ingegnere 95enne mestrino che ieri mattina ha cercato di togliersi la vita nell’androne dell’ospedale dell’Angelo, dopo aver sparato alla moglie. Don Armando tratteggia un grande uomo, di enorme generosità. «Ernesto è stato uno dei principali responsabili della rinascita di viale Don Sturzo. Si era occupato assieme ai suoi soci di bonifiche e pianificazione, riuscendo a restituire vivibilità al quartiere», spiega Trevisiol, che proprio tra gli alberi e l’erba del viale che collega via Pasqualigo a via Vallon nel 1994 ha dato vita al suo primo (e quindi al secondo, nel 2001) centro di residenze per anziani, «è a lui che dobbiamo l’attuale aspetto della strada, eppure è un uomo umile e modesto”. Negli anni che seguirono i lavori, stando a quanto racconta il sacerdote, Ernesto Cecchinato si trovò alle prese con alcuni contenziosi con il Comune di Venezia, che a lungo andare lo portarono sulla strada dell’esaurimento nervoso. «Per affrontare la cosa e ritrovare la sua serenità si è dedicato alla pittura», continua don Armando, che ricorda bene le difficoltà che ha attraversato l’amico», è un artista autodidatta e la maggior parte delle sue opere sono copie, spesso realizzate con l’aiuto di un proiettore, ma le sue pennellate hanno comunque un loro carattere e la mano è pregevole, pur non essendo quella di un maestro». Proprio l’amatoriale ma consistente produzione pittorica è stato uno dei regali del professionista all’associazione Carpinetum di don Armando: «Un giorno Ernesto è venuto da me e, dopo avermi raccontato del suo percorso terapeutico attraverso tele e colori, ha voluto donarmi ben 150 quadri realizzati da lui, assieme a cinque milioni delle vecchie lire per il centro Don Vecchi». Incorniciati e firmati per la maggior parte con una semplice iniziale, i dipinti sono esposti tra i corridoi e nelle sale della struttura di viale Don Sturzo, per la maggior parte nell’ampio spazio affidato all'associazione “300 campi”, ma qualche opera si può individuare anche vicino all’entrata e alla sala mensa, tra le porte delle residenze per anziani. In seguito l’ex parroco di Carpenedo e i coniugi Cecchinato hanno continuato a tenersi in contatto, anche se non con frequenza, fino a qualche anno fa, quando un amico in comune impegnato con le attività dell'Avis di Marghera non è tornato a fare il nome dell'ingegnere in presenza di don Armando. «Ho saputo allora che non stava più bene», continua il religioso, «e che aveva intenzione di fare un’altra donazione a nostro favore; avevo sentito di qualche guaio finanziario, ma alla fine ha deciso di offrirci ben centomila euro per la costruzione del Don Vecchi 5 e ho quindi pensato che tutto si stesse risolvendo». Il prete e l’urbanista hanno continuato a tenersi in stretto contatto, anche negli ultimi mesi: «Ogni settimana Ernesto ci tiene a ricevere una copia del nostro settimanale, “L'incontro”, che io gli invio personalmente. Sapevo che lui e la moglie stavano ormai molto male, e una volta parlando con me l’ingegnere ha confessato quasi in imbarazzo di non essere molto credente. Io gli ho risposto che si possono vedere molte sfaccettature della cosa, ma soprattutto che una persona buona come lui non deve avere alcun timore, perché chi fa del bene e si impegna per il suo prossimo non può essere lontano dalla grazia divina».
IL GAZZETTINO DI VENEZIA Pagg VI – VIII “Era malato, ma ci aiutava” di Fulvio Fenzo Don Armando Trevisiol ricorda Cecchinato. I famigliari: “Ernesto, un filantropo che era stanco di lottare” «Gli avevo appena inviato l’ultimo numero de "L’incontro", il nostro settimanale. Lunedì l’avevo imbustato, come facevo sempre, per spedirglielo ad Abano». Don Armando Trevisiol conosce da anni Ernesto Cecchinato. Anche qualche settimana fa si erano sentiti al telefono ed avevano parlato a lungo. «Sapeva di essere nella fase finale della sua malattia - racconta don Armando -, ma si interessava ancora alla vita del quartiere che lui aveva contribuito a costruire. È una persona cara, affettuosa. Alcuni anni fa delle persone che lo conoscono mi dissero del suo male e di quello di cui soffriva sua moglie, e mi chiesero di essergli vicino perché lui non è credente. Io sono un prete, è questo che devo fare». Nel 2013 Cecchinato fece una cospicua donazione a favore della Fondazione Carpinetum per la costruzione del “Don Vecchi 5” in località Arzeroni, un centro per anziani in perdita di autonomia: centomila euro di cui, però, non voleva che si sapesse nulla. «Chiesi in banca l’indirizzo del generoso benefattore ed allora, pian piano, capii che si trattava di una cara e vecchia conoscenza: l’ingegner Ernesto Cecchinato» racconta il sacerdote. Parecchi anni prima, infatti, Cecchinato si presentò al Centro Don Vecchi di viale Don Sturzo con 150 quadri, tutti realizzati da lui. "Voglio donarveli", disse l’ingegnere, staccando anche un assegno di 5 milioni di vecchie lire. «Li accettai di buon grado perché sono appassionato di pittura e perché mi dava modo di ornare l’immensa "sala dei 300", nell’interrato del Don Vecchi, dove ogni settimana celebro messa per i residenti». Quadri che sono ancora lì: paesaggi (soprattutto di Venezia), nature morte, fiori, uno dietro l’altro, appesi alle pareti e alle colonne del salone. Non sono opere d’arte, ma nel complesso ci stanno bene. «Cecchinato si appassionò alla pittura dopo un brutto esaurimento nervoso, da cui ne uscì proprio dipingendo - prosegue don Armando -. Era rimasto duramente provato dalle vicende che seguirono la realizzazione dei condomini di viale don Sturzo, anche per colpa di un "faccendiere" che si era inserito nell’operazione. Era intervenuto sulle cave che un altro paesano di Carpenedo, il signor Casarin, aveva scavato per cuocere i mattoni nella sua fornace». Cave che si stanno tuttora bonificando da parte del Comune, per mettere in sicurezza dei terreni sui quali, decenni fa, venne scaricato di tutto. Ma questa è la storia. Ieri la tragedia. «Sono profondamente dispiaciuto per quanto è avvenuto all’Angelo - abbassa gli occhi il sacerdote -. Quello che so di Ernesto Cecchinato è che è una persona autentica, onesta. Poi la malattia, la solitudine... Cose che venivano fuori dalle nostre conversazioni telefoniche. Lui mi ha sempre detto di non credere, ma io lo sentivo come una persona in ricerca della verità. Mi aveva detto che lui e sua moglie non avevano ancora davanti a sé molto tempo per vivere». Nulla, comunque, che facesse presagire la decisione di farla finita. «Era stanco di lottare contro i suoi malanni e quelli della moglie. Quanto è successo non deve farci dimenticare che Ernesto Cecchinato è una persona di una bontà infinita. Umile, pur essendo un benefattore». L’avvocato Lorenzo Cecchinato è il nipote di Ernesto. La sua preoccupazione è come far sapere ciò che è accaduto all’anziana sorella del 95enne che vive in via Cappuccina. Il suo studio è a una cinquantina di metri da dove, fino a qualche anno fa, vivevano Cecchinato e la moglie Loredana Pedrocco prima di trasferirsi ad Abano Terme. «Ci siamo sentiti tra parenti - racconta -. Anche mio cugino, quello che seguiva più direttamente le loro condizioni di salute, mi ha confermato che non avevano visite programmate né dovevano ritirare dei referti all’ospedale dell’Angelo. Forse gli avevano nascosto qualcosa, o forse chissà. Non possiamo saperlo». L’ultima volta che si sono sentiti risale a un paio di mesi fa. «Cordiale, buono come sempre - prosegue il nipote -. Una persona intelligentissima, capace di ricordare ogni cosa e con la passione per la storia. Ricordo quando interrogava mio figlio. Un uomo di una bontà infinita». E un filantropo senza farlo sapere in giro. «È stato più che generoso con tante istituzioni locali - prosegue Lorenzo Cecchinato -. I 100mila euro donati al Centro Don Vecchi sono gli unici di cui si è saputo, ma lui stesso avrebbe preferito che rimanessero sotto traccia. Voleva il basso profilo. Posso solo dire che ha fatto un’altra donazione ad un ente che avrebbe voluto ringraziarlo
pubblicamente. Ho seguito personalmente questa pratica e, quando gli ho fatto sapere questa cosa, mi ha risposto: "fate finta che io non esisto". Davvero non posso dire a chi ha donato questo denaro perché offenderei la sua volontà». Del resto con la sua attività di imprenditore Ernesto Cecchinato aveva messo da parte una ricchezza non indifferente, quella che gli consentiva di vivere da anni in un albergo di Abano Terme. «Far sapere in giro di queste donazioni scatenava la corsa da parte di tanti a chiedere prestiti, come avvenne quando si seppe del contributo al Centro Don Vecchi - conclude il nipote -. Lui e la moglie volevano restare nell’ombra». Torna al sommario 8 – VENETO / NORDEST CORRIERE DEL VENETO Pag 1 Il Nordest corre con il digitale di Sandro Mangiaterra Competitività, la nuova sfida Metti il digitale nel motore e il Nordest tornerà a volare. Non è uno slogan, ma una realtà supportata dai dati. Basta mettere a confronto due recentissime indagini sull’introduzione dell’hi-tech nelle imprese di ogni settore e di ogni grandezza, una condotta in Veneto dalla Fondazione Nordest in collaborazione con Make in Italy e Prometeia, l’altra portata avanti a livello nazionale dall’università di Brescia. Si scopre che le stampanti 3D, simbolo del nuovo manifatturiero, sono già utilizzate dal 34 per cento delle nostre aziende, contro una media italiana del 21 per cento. Ancora maggiore è la distanza per quanto riguarda la robotica e la sensoristica avanzata, presenti nel 43,5 per cento delle fabbriche della regione, rispetto a un misero 11 per cento del resto del Paese. E siamo appena all’inizio, visto che la Fondazione Nordest parla per il Veneto, semplicemente grazie ai miglioramenti tecnologici, di un Pil aggiuntivo di 1,7 miliardi e della creazione di almeno 8 mila posti di lavoro. Insomma, il digitale sta trasformando il Nordest. Ben vengano, allora, iniziative come Digitalmeet, promosso da Fondazione Comunica e dai Talent Garden di Padova e Pordenone. Duecentoquaranta relatori e un’ottantina di eventi che si snodano da Verona a Trieste, con puntate a Nord verso Merano e a Sud fino a Rovigo. Titolo: Manifattura digitale, occasione per la crescita. Quattro giorni, dal 22 al 25 ottobre, dove piuttosto che lamentarsi del digital divide (che pure esiste) e del piano banda larga (che pure fatica a decollare), si proverà a spiegare perché gli investimenti in alta tecnologia facciano la differenza. Parecchi passi avanti sono stati fatti. L’attenzione nei confronti dell’Ict (Information and communication technologies) di sicuro ha un ruolo centrale nel boom dell’export: più 7,3 per cento nei primi sei mesi del 2015 per il Veneto, più 7,6 per il Friuli Venezia Giulia, mentre la media nazionale si ferma a più 5 per cento. Certo, oggi è possibile raggiungere in tempi rapidissimi clienti sparsi ai cinque continenti e l’e.commerce è uno strumento efficacissimo, capace tra l’altro di abbattere i costi. La strada da percorrere, tuttavia, resta lunga. E la posta in gioco porta dritto dritto al nuovo modello di sviluppo del Nordest. La rivoluzione digitale libera le aziende dall’ossessione dei quantitativi da realizzare, consente di progettare i prodotti direttamente con il cliente, sposta l’attenzione dalle produzioni di serie a quelle personalizzate e su misura. Una manna per la patria della piccola impresa e dell’artigianato di qualità. Se si ha coraggio, è la volta che la Germania rimane davvero dietro di noi. Torna al sommario … ed inoltre oggi segnaliamo… CORRIERE DELLA SERA Pag 1 Il partito che Renzi non ha di Ernesto Galli della Loggia Il Pd e il governo Matteo Renzi è alla ricerca di un partito. Sembra paradossale dirlo per uno che come si sa è il segretario del Pd, ma il fatto è, come è ben noto, che del suo partito egli ha un
controllo abbastanza evanescente. Proiettato alla sua testa da un voto alle primarie in cui gli iscritti veri e propri erano certamente una decisa minoranza, e in cui si contavano perfino non pochi che non ne erano neanche elettori, Renzi oggi ne domina con fatica il centro, cioè i gruppi parlamentari; ma ben poco la periferia. Nel primo caso tutto certamente cambierà con le prossime elezioni, quando il segretario procederà alle inevitabili epurazioni da cui si salverà - se si salverà - solo un pugno dei suoi attuali avversari interni. Nelle periferie, invece, la regola perversa delle primarie aperte - che però Renzi non può cancellare essendo finora il suo unico e comunque massimo titolo di legittimazione - rende ogni volta la designazione del candidato sindaco un gioco di bussolotti. Oggi più che mai, dal momento che oggi, nelle periferie, il Partito democratico sta di fatto evaporando. Intendiamoci: gli iscritti, sia pure molto diminuiti rispetto al passato, restano. Un partito però non sono solo gli iscritti: è anche un luogo di elaborazione/ discussione di idee, è uno strumento per organizzare e gestire il conflitto sociale, e quindi uno strumento di selezione di quadri; è infine un canale di comunicazione dal centro verso la periferia e viceversa. Ma c’è qualche traccia di questo partito, mi domando, nell’attuale realtà del Pd? Non mi sembra proprio. Dalle Alpi alla Sicilia la sua periferia si presenta come un insieme di feudi più o meno grandi in mano a capi locali virtualmente autonomi, di centri di potere di fatto indipendenti, di coalizioni decise ogni volta sul posto. O altrimenti di grandi spazi vuoti. La conseguenza è che sindaci renziani di qualche peso oggi, tranne a Firenze, non ne esistono. Né sembra facile trovarne qualcuno nei prossimi mesi per Roma, Napoli o Milano. Può mai darsi però il caso di un partito che esiste solo al centro? E che poi, tra l’altro, al centro esiste soltanto nella persona del suo capo? La risposta è nelle cose. Nell’Italia di oggi esiste Renzi ma un Pd renziano, un Pd diciamo così modellato e ispirato dalle idee del presidente del Consiglio, non si vede proprio. Né mi sembra personalmente probabile che una simile creatura veda mai la luce. In un certo senso, infatti, il renzismo si identifica pienamente nella natura antipartitica/apartitica all’insegna della quale è nata la Seconda Repubblica, almeno per questo collocandosi in un'ideale prosecuzione con il berlusconismo. Con un’importante differenza però: che mentre nel Cavaliere quella natura anti e apartitica si rivestiva di toni antisistema e di un’arcaica vocalità antisinistra che erano decisivi nel mantenere in vita per contrapposizione la Sinistra stessa, dandole l’illusione di esistere, con Renzi ciò non avviene. Con il presidente del Consiglio ogni tono contrappositivo viene meno (è riservato solo alla sua insignificante minoranza interna o alle frange antisistema reputate irrecuperabili, tipo i leghisti definiti «bestie»). I confini e le differenze di contenuto tra tutti i partiti - almeno quelli compresi in un arco che invece che costituzionale ora potremmo chiamare della «ragionevolezza operosa» - risultano virtualmente cancellati. È soprattutto virtualmente cancellata la distinzione fondativa di ogni sistema politico di tipo parlamentare: quella tra Destra e Sinistra, ancora ben viva all’epoca berlusconiana. Non a caso ciò avviene a opera di chi figura come leader della Sinistra. Infatti, se è sempre stata la Sinistra a definire che cosa è di destra e che cosa è di sinistra, non poteva che essere una voce titolata a parlare a nome della Sinistra stessa, ad averne in certo senso la rappresentanza, a dichiarare caduta di fatto la separazione tra i due campi. È in questo modo che la Seconda Repubblica, nata contro la Prima, accusata di essere una Repubblica dei partiti, grazie a Renzi porta a compimento il suo programma di una Repubblica senza partiti. Esiste un contrasto che mi verrebbe da definire ontologico tra la personalità di Renzi e l’idea di partito, sicché è assai improbabile che possa mai esserci realmente un Partito democratico renziano. Un partito nasce e vive intorno a una scala di valori, a un’idea-messaggio forte, a una visione della storia del Paese entro la quale collocarsi. Implica il lungo periodo; e naturalmente il richiamarsi non al tutto ma a una parte, almeno in un qualche momento del suo discorso. Tutte cose, se non sbaglio, che non sono nel modo d’essere e di pensare e tanto meno nello stile del presidente del Consiglio. Alla personalità aperta, naturalmente ottimistica e superenergetica di Renzi, i tempi lunghi non dicono molto. Egli crede alle sfide che si vincono o si perdono sul tamburo. Al messaggio indirizzato alla sua parte anteporrà sempre l’arringa rivolta al pubblico, all’essere convincente il risultare simpatico. Quanto ai valori, quelli veri, gli sembrano forse cosa troppo importante per mischiarli pubblicamente con la politica: che alla fine, come sospetto, deve apparirgli solo una grande messa in scena. Renzi non è fatto per la politica di partito. È fatto per governare. Lì il suo temperamento lo ha prepotentemente indirizzato, lì - bisogna
augurarsi - egli può dare i risultati migliori. Ma senza un partito alle spalle il suo retroterra è destinato a restare perennemente sguarnito. Presidiato da successi elettorali forse anche importanti, ma di scarsa utilità quando si tratta di pensare le cose da fare, come farle, con chi farle. Destinato ad avere un numero sempre crescente di clienti, di amici, di ammiratori, questo è sicuro, tuttavia egli poggerà sempre su una base in certo senso poco solida. E nella sua azione come nel suo ruolo apparirà sempre, prima o poi, come già appare oggi, qualcosa di insuperabilmente fragile. Pag 33 Tre considerazioni contro la guerra in Medio Oriente di Carlo Rovelli Dubbi morali e politici Il governo italiano ha fatto sapere che sta valutando la possibilità che aerei da guerra italiani bombardino obiettivi in Iraq. Senza alcuna competenza di politica internazionale, come cittadino, vorrei offrire tre considerazioni. La prima riguarda l’ondata di migranti che sta arrivando in Europa. Quasi nessuno di questi viene dai territori controllati dall’Isis in Iraq. Perché? Me lo ha spiegato poco tempo fa in Giordania un rappresentante di organizzazioni di aiuto ai profughi: la gente non ha ragione di fuggire da molte zone sotto il controllo dell’Isis perché questi territori ora non sono più in guerra. I racconti dei migranti che arrivano in Europa sono storie di orrore: famiglie sterminate, città, come Aleppo, ridotte in macerie (spesso proprio dai nemici dell’Isis, come lo stato siriano). Ogni nuova azione di guerra contribuisce ad aumentare ulteriormente il dolore e la marea dei profughi. La seconda considerazione riguarda gli orrori commessi dall’Isis, che ci hanno profondamente scosso. Le guerre seguono intense emozioni, dove l’attenzione si focalizza su orrori commessi dal nemico. Questi orrori sono messi a fuoco, ripetuti, si cristallizzano nelle emozioni, mentre altri orrori del mondo ci strappano un triste sospiro. Ma penso che agire per emozione viscerale sia cattiva scelta, sia nei litigi fra persone, sia in quelli fra popoli. L’indignazione è giusta, ma le decisioni che comportano guerra e morte non devono essere motivate da pure reazioni emotive. Non ci piacciono gli Stati totalitari, ma non per questo bombardiamo Singapore. A molti di noi non piace l’idea di uno Stato in cui la legge sia basata sulla Sharia, ma non per questo bombardiamo l’Arabia Saudita, il Qatar, la Mauritania. Un uomo decapitato in un video ci fa orrore, ma mi sembra sbagliato reagire uccidendo cento innocenti con una bomba. La terza considerazione riguarda gli obiettivi. Lo stato di sofferenza e conflitto in Iraq e Siria è drammatico. La presenza militare sia russa che americana, con obiettivi discordanti, sta allarmando il mondo. Sarebbe nobile partecipare alla soluzione, per alleviare le sofferenze di quelle terre. Potremmo farlo cercando di contribuire a un accordo diplomatico fra Stati Uniti e Russia. Mi sembra che oggi là si muoia perché Stati Uniti e Russia non si mettono d’accordo su chi deve governare. La guerra in Iraq e in Siria c’era prima dell’Isis e la sola eliminazione dell’Isis non la farebbe smettere. Mandare i nostri aerei mi sembra più che altro contribuire alle prove di forza della potenza egemone. Ma il governo degli Stati Uniti non pare voler risolvere davvero la situazione militarmente, e appare confuso agli stessi americani. Un recente fondo non firmato del New York Times titola «Una strategia di guerra incoerente in Siria». Andiamo ad appoggiare un governo iracheno che non è riuscito a farsi rappresentante di larghe componenti del suo popolo, sia al Nord sia all’Ovest, ed è apertamente in guerra con gran parte della sua gente. Alla televisione vediamo solo i missili sugli «obiettivi militari», ma la realtà della guerra, sappiamo bene, è quella di corpi dilaniati, famiglie disperate, quartieri in macerie pieni di brandelli di esseri umani, lacrime, orrore. La prima guerra in Iraq, di cui vedevamo la precisione dei missili in televisione, ha fatto più di 150 mila morti. Anche allora sembrava ci fosse grande pericolo per l’Occidente: poi si è capito che non c’era. Bombardare significa uccidere uomini, donne e bambini iracheni. Rispondere all’orrore producendo ulteriore orrore non mi sembra né lungimirante né moralmente giusto. Perché lo dobbiamo fare? Non sappiamo chi stiamo andando ad aiutare. Nessun popolo ce lo ha chiesto. L’Isis non riesce nemmeno a togliere Kobane ai curdi, figuriamoci se riesce a minacciare la Nato. Ci ripetiamo sempre che nelle situazioni di conflitto la prima cosa da fare è cercare di deporre le armi e parlare. Anche quando si è accecati dalla retorica dell’annientamento reciproco e dell’orrore. Non è questo che secoli di illuminismo, di razionalismo, di pensarci «civili» ci hanno insegnato? Sappiamo solo rispondere a una decapitazione con un bombardamento? Violenza e guerra nel mondo
stanno aumentando. Io sarei orgoglioso di un’Italia che abbia il coraggio di non contribuire a questa crescente spirale di violenza, e restare dalla parte dei molti che cercano invece di calmare il gioco. Ricordiamo la parte migliore di noi, e le parole del miglior illuminismo, come quelle di Locke: «Non è la differenza delle opinioni (che è inevitabile), ma il rifiuto di tollerare coloro che hanno opinioni differenti […] che produce i disordini e le guerre». LA REPUBBLICA Pag 1 La strada corta di Salvini di Stefano Folli Matteo Salvini ama parlare di una "fase due" della Lega che egli proietta ormai verso il governo. Ma la realtà è un po' meno ottimistica. I temi leghisti sono gli stessi di sempre e puntano a trasformare in consenso elettorale il senso di insicurezza, la paura collettiva, l'inquietudine verso il lato oscuro dell'immigrazione. Ieri il leader del Carroccio si è affrettato a spendere sul mercato politico il dramma del pensionato che ha ucciso senza volerlo un ladro che gli si era introdotto in casa. Dov'è la fase due? Fin qui siamo al consueto leghismo "lepenista" di cui Salvini è stato l'inventore ed è a tutt'oggi il sommo interprete, forse l'unico. Sta di fatto che i sondaggi ormai da tempo marcano il passo: si attestano fra il 14 e il 15 per cento, soglia ragguardevole ma non sufficiente per nutrire aspirazioni di governo. Nemmeno se al volto del leader, usurato dall' esposizione televisiva, dovessero sovrapporsi quelli di altri personaggi dell'arcipelago leghista: a cominciare dal presidente del Veneto, Zaia, il quale porterebbe l'esperienza di governo in una regione importante, il Veneto. Con ciò sottolineando l' impronta nordista del partito e l'addio alle speranze, coltivate senza troppa convinzione, di espandere al sud una filosofia politica improntata non più al separatismo, bensì al nazionalismo. Comunque sia, Salvini è inchiodato al 14-15 per cento. Percentuale che, a ben vedere, non gli basta nemmeno per stabilire una solida e duratura egemonia sul centrodestra, facendo di Forza Italia un proprio satellite. Questo è ancora l'obiettivo ufficiale, che farebbe dell'asse fra Salvini e Berlusconi un agglomerato fra il 24 e il 27 per cento con leadership leghista. Tuttavia Forza Italia, benché ormai priva di una guida, continua a raccogliere abbastanza consenso da ritrovarsi più o meno alla pari con l'alleato-rivale del Carroccio. Risultato: non si sa in mano di chi sia il bastone di comando e la proposta politica è assente. La Lega "di governo" non va oltre i temi tipici della protesta estremista, declinati in una chiave di destra. E il partito berlusconiano sopravvive come l'onda lunga dopo la tempesta. Del resto, sul piano del populismo puro Beppe Grillo è più efficace. Anche perché può permettersi di mescolare spunti di destra e di sinistra, miscelati insieme con abilità propagandistica, laddove Salvini è chiuso nel suo copione "lepenista". Per espandersi il capo leghista avrebbe bisogno di alcuni capisaldi che sono venuti a mancare. Intanto di un Papa intransigente e votato alla crociata anti-islam, o almeno convinto di dover difendere la vecchia civiltà europea dalle ondate dell'immigrazione clandestina. Viceversa, Francesco parla un altro linguaggio e Salvini si trova nella scomoda posizione, alla lunga non gestibile, di dover polemizzare con il Pontefice. L'altro caposaldo doveva essere la sconfitta progressiva del centrodestra europeo moderato a vantaggio dei movimenti estremisti e anti-stranieri. A tale proposito, il risultato della Svizzera non basta a consolare Salvini: al momento la destra vincente è ancora quella di Angela Merkel e del Partito Popolare, un orizzonte molto lontano dal leghismo territoriale. Ne deriva che nella bizzarra architettura tripolare del sistema italiano, i cinquestelle, pur con i loro aspetti incongrui, sono più credibili e meglio radicati da nord a sud di quanto non sia Salvini da solo o in forzata coabitazione con i residui del mondo berlusconiano. Non è strano allora che sia il piccolo centro a elaborare un' iniziativa di qualche interesse. Quel che si muove in tale area, da Verdini a Cicchitto, dallo stesso Alfano a Tabacci e agli ultimi seguaci di Monti, non ha ancora una precisa direzione, ma è un tentativo di ragionare in termini politici. E in ogni caso un punto è certo. Al centro prevale la tendenza all' accordo con il premier, per costruire una sorta di ala destra del "renzismo". Al di là di questo, non c'è la Merkel in versione italiana, bensì un contraddittorio estremismo. Con un evidente vantaggio offerto al terzo polo, il movimento grillino. AVVENIRE
Pag 3 Figli e consumi degli altri, la crisi del modello tedesco di Massimo Calvi Volkswagen, export, demografia: perché Berlino trema Non è un bel momento per la Germania. Dallo scandalo dei motori truccati alla Volkswagen, i tedeschi hanno incassato un filotto impressionante di notizie negative, tanto che oggi si incomincia a parlare di fine di un modello, di inversione di tendenza di un ciclo positivo che durava da almeno un decennio. Nel mese di ottobre Berlino ha dovuto fare i conti con il calo degli ordini dell’industria (-1,8%), la caduta della produzione industriale (-1,2%), il crollo delle esportazioni (-5,2%), tutti dati riferiti ad agosto. Anche considerando i fattori stagionali, il rallentamento dell’attività, dovuto in larga parte alla frenata dell’economia cinese, è stato più forte del previsto. Non solo: a ottobre è precipitato anche l’indice che misura la fiducia degli investitori, mentre il governo ha rivisto al ribasso la previsione del Pil per il 2015, dall’1,8 all’1,7%. UN MODELLO CHE VACILLA - Può dirsi preoccupato un Paese la cui espansione del prodotto viaggia a un ritmo che per altri vorrebbe dire la fine di ogni problema e con una disoccupazione al 4,5%, ai minimi dalla riunificazione? Il punto è che ad essere in crisi sono i principali punti di forza del sistema tedesco: la struttura del modello di sviluppo, la pretesa superiorità morale, la dinamica della popolazione. Capire le difficoltà della locomotiva europea può aiutare a comprendere la natura di molti problemi comuni. Il caso Volkswagen, inteso come fallimento di uno stile di gestione e di approccio al mercato, ha compromesso l’immagine di un’intera classe dirigente. E la perdita di 6,2 miliardi di euro annunciata nei giorni scorsi da Deutsche Bank nel terzo trimestre è in fondo un’altra faccia dello stesso problema: il 'rosso' è stato motivato con le necessità di pulizia nei conti di una banca che, come il gruppo automobilistico di Wolfsburg, appartiene alla cerchia dei 'campioni nazionali', sostenuti e protetti, ma che si è dimostrata essere anche 'campione' di speculazioni, di derivati e titoli tossici, di leva finanziaria, di scandali, come nel caso della manipolazione truffaldina del tasso di interesse Libor. IL DECLINO MORALE - Il dato etico, per il Paese che a colpi di austerity e di lotta all’'azzardo morale' ha voluto impartire lezioni di rigore a tutta Europa, non è questione da poco. Le attuali difficoltà tedesche mettono in discussione un modello economico e di sviluppo che non è riproponibile in eterno. Le riforme nella direzione della flessibilità e della riduzione del costo del lavoro di questa stagione hanno reso l’industria tedesca più competitiva, ma hanno minato il potere d’acquisto dei suoi lavoratori. Non è un caso se Berlino ha registrato per lungo tempo consumi nazionali prossimi allo zero ed esportazioni a livelli record. Lo scorso anno il surplus della bilancia commerciale, cioè il rapporto tra esportazioni ed importazioni, ha sfiorato i 220 miliardi di euro, e per l’ottavo anno consecutivo ha sfondato il tetto del 6% sul Pil previsto dagli accordi europei. Buon per la Germania, se non fosse che la forza delle esportazioni tedesche l’abbiamo sostenuta (e pagata) tutti, con l’euro. Nessun Paese avrebbe potuto mantenere simili livelli di export in un regime di cambi flessibili: prima o poi la sua moneta si sarebbe rafforzata a tal punto da farlo rientrare dallo squilibrio e dal vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. L’INVERNO DEMOGRAFICO - Oggi molti nodi sembrano essere venuti al pettine: i campioni nazionali vacillano, la fiducia nella forza morale è scalfita, la frenata della Cina e dei Paesi emergenti sta trasformando il modello tutto-export in un fattore di fragilità, le riforme interne e il proliferare dei mini-jobs a bassi salari si stanno rivelando un problema: una ripresa dei consumi interni c’è stata, eppure l’ultima revisione del Pil ha indicato che a frenare sono state le spese delle famiglie. Quello che più preoccupa, tuttavia, in una prospettiva di medio termine, è la struttura demografica del Paese. In Germania nascono solo 8,2 bambini ogni mille abitanti, il dato più basso al mondo, un quinto della popolazione ha più di 65 anni e solo il 14% meno di 15. Nessuna nazione può mantenere a lungo una leadership con una tale dinamica della popolazione. All’ultimo forum di Davos la cancelliera Angela Merkel ha spiegato che nei prossimi 15 anni il Paese perderà 6 milioni di lavoratori, rendendo sempre meno sostenibile il suo sistema di welfare. L’inverno demografico ha un costo elevato: uno studio della Banca di Spagna (Demographic structure and macroeconomic trends) ha calcolato che nel decennio 2010-2019 la Germania perderà quasi un punto di Pil all’anno in media a causa dei figli che non nascono. La denatalità tedesca, peraltro, sembra un paradosso: con 195
miliardi stanziati ogni anno la Germania è tra i Paesi più generosi in termini di spesa per la famiglia e la natalità, eppure le donne hanno in media 1,36 figli a testa, le famiglie con bambini sono meno di una ogni tre e il 43% dei nuclei è composto da single. LA RISORSA IMMIGRAZIONE - Perché i tedeschi non fanno figli? Una delle spiegazioni è che i soldi contano fino a un certo punto nella decisione di generare, e la Germania del benessere conquistato, diffuso e acquisito non appare più di tanto disposta a farsi carico di questo tipo di 'sacrificio'. Una sorta di ammorbidimento nel carattere morale non molto diverso dagli altri tratti declinanti. La questione è seria. La Germania, ha sentenziato qualche tempo fa l’Istituto per l’economia internazionale di Amburgo, non sarà in grado di gestire la bomba demografica se non importando nuova immigrazione. Ed è proprio in questa opzione che si può trovare una delle strade più convincenti contro il rischio declino. In questi anni la crescita della Germania, oltre che sulla robustezza delle esportazioni, si è basata sulla capacità di attrarre popolazione, in particolare giovane e altamente qualificata. Il modello di sviluppo tedesco, in buona sostanza, si è fondato sui consumi degli altri e sui figli degli altri. Funzionale, ma in fondo fragile. Lo scorso anno la popolazione tedesca è aumentata di 500.000 unità solo grazie al milione e mezzo di immigrati entrati nel Paese (il 20% in più rispetto al 2013). E l’80% dei richiedenti asilo nei primi sei mesi di quest’anno aveva meno di 35 anni. Quanto potrà durare? Per quanto ancora la Germania riuscirà a presentarsi come una meta ambita e accogliente, arginando l’ostilità crescente verso gli stranieri? TENSIONI E SPERANZE - Attrarre persone e lavoratori è una vocazione antica per il Paese: è quello che Berlino ha fatto negli anni 50 con italiani, spagnoli, greci e turchi, negli anni 90 con i 'fratelli' dell’Est, durante la crisi del debito con gli europei più preparati. Ed è ciò che sta continuando a fare nella crisi di oggi, seppur con modalità diverse. In una fase in cui l’Europa è diventata terra di speranza e di approdo per milioni di profughi, la svolta nella direzione dell’accoglienza indicata da Angela Merkel ha le caratteristiche della risposta capace di unire alla componente emotiva quella di una visione solidale e perfettamente razionale allo stesso tempo. Difficile dire ora se pagherà o peserà politicamente. Ma nell’inverno demografico che sta congelando l’Europa, la Germania ha individuato una strada contro il declino e per continuare a proporsi come guida e modello. Il problema è convincere l’opinione pubblica. Non solo in Germania. LA NUOVA Pag 13 La corsa del premier equilibrista di Fabio Bordignon Sembrava un percorso insidioso, quasi azzardato, quello scelto da Matteo Renzi, quando ha assunto la guida del governo. Sul suo cammino, i mille ostacoli di un Parlamento balcanizzato, le trappole disseminate dalle opposizioni, le barriere erette da alleati e avversari interni. Eppure, la corsa del premier non si è fermata. Sorprende, anzi, l’apparente facilità con la quale procede. Passo dopo passo. Ostacolo dopo ostacolo. Palazzo dopo palazzo: si tratti del Campidoglio, del Quirinale o di Palazzo Madama. Sembra quasi di trovarci di fronte la scena di un parkour. Riprendiamo da Wikipedia. Parkour, percorso di guerra: «Disciplina metropolitana nata in Francia all’inizio degli anni’90. Consiste nell’eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo vi sia presente con la maggior efficienza di movimento possibile». Ricorda molto l’arrampicata del premier attraverso i palazzi romani. Pronto a individuare, di volta in volta, il “gesto tecnico” più opportuno. Il migliore appiglio. Il trick per andare oltre. La scorsa settimana, è toccato al Senato: certo, mancano ancora diversi passaggi in aula, ma il disegno di legge Boschi appare ormai in cassaforte. Nel parkour di Renzi, il punto d’arrivo coincide col punto di partenza: il ritorno a Palazzo Chigi, attraverso la sequenza riforme-referendum-nuove elezioni. Ogni passaggio, ogni obbiettivo intermedio, è affrontato in modo pragmatico, funzionale della destinazione finale. E agli interessi personali. Adattandosi a un ambiente complesso, individuando un “modo nuovo” di andare oltre: come quel Dick Fosbury eletto a simbolo della Leopolda 2012. Se poi il salto è troppo lungo, ecco pronta l’agilità di un canguro. Se il muro da superare è troppo alto, può essere aggirato. O abbattuto, come nel caso del Senato. In fondo, il parkour di Renzi attraversa un paesaggio istituzionale degradato: le macerie della Seconda Repubblica, il linguaggio e i gesti poco “urbani” dei suoi attori. Perciò, il premier miscela forza, leggerezza e rapidità di movimento. Sprezzo del pericolo, e delle “regole del
gioco”: quantomeno, delle vecchie regole che si propone di ri-scrivere. In questo modo, fa apparire facile ciò che sembrava difficile. Gioca di sponda: un volteggio a destra, un volteggio a sinistra. E intanto procede. I nemici rimangono sul posto. Da Letta a Varoufakis, da Civati a Marino: «se li semo tolti». (Forse...) A volte, lascia con il fiato sospeso. Sta rischiando troppo. La mano sembra perdere la presa, il piede sul punto di scivolare. Sta per cadere. Ma eccolo di nuovo in piedi, sorretto da nuovi compagni di viaggio e nuove alleanze. Tanto da far dimenticare i piccoli incidenti di percorso. Tutte le volte in cui è andato vicino al clamoroso scivolone. Una piroetta a favore del pubblico e via: verso l’ostacolo successivo. È già successo con l’elezione del capo dello Stato, con la riforma del mercato del lavoro, con l’Italicum. E in altre occasioni. Muri che apparivano insormontabili sono stati scavalcati. Ridimensionando - ex post - le preoccupazioni della vigilia. Certo, il percorso è ancora tortuoso, sdrucciolevole. Pieno di ostacoli. A partire da una tornata amministrativa delicata e potenzialmente cruciale. Con un Pd in calo nei sondaggi e allo sbando sul territorio. Mentre appare ancora troppo incerto l’appiglio più importante: quello di una ripresa economica difficile da agganciare. Tuttavia, ormai incassata la riforma del Senato, la traccia del parkour renziano si proietta già al referendum costituzionale dell’autunno 2016. Destinato a essere caricato di un valore, simbolico e sostanziale, addirittura superiore a quello del voto di primavera. Renzi punta a trasformare la consultazione popolare in un plebiscito personale: Sì o No a questo governo, a questo premier. Per aprirsi la strada verso la riconferma: al Nazareno e a Palazzo Chigi. Nel 2018, o forse prima. Una volta entrata in vigore la nuova legge elettorale e superato il referendum: ogni momento è buono. Per l’ennesimo salto, l’ennesima (studiata) acrobazia. Un premier costantemente sospeso: tra un morbido atterraggio e una rovinosa caduta. Pag 14 Erri De Luca e la libertà di opinione di Giovanni Palombarini Il processo a carico di Erri De Luca si è concluso, per il primo grado, con la sentenza di assoluzione del tribunale di Torino con formula ampia, «perché il fatto non sussiste». Per fortuna, verrebbe da dire, perché quello contestato allo scrittore era un tipico reato di opinione. Infatti De Luca aveva risposto ad alcune domande sull’opera con valutazioni e parole che erano state riportate dalle agenzie Huffington Post e Ansa: «La Tav va sabotata, ecco perché le cesoie servivano: sono utili a tagliare le reti. Nessun terrorismo… sono necessari per far comprendere che la Tav è un’opera nociva e inutile… hanno fallito i tavoli di governo, hanno fallito le mediazioni: il sabotaggio è l’unica alternativa… resto convinto che il Tav sia un’opera inutile e continuo a pensare che sia giusto sabotare quest’opera». Valutazioni, dunque, opinioni di uno scrittore al quale non è mai piaciuto il modo in cui una “grande opera”, molto costosa e destinata a influire pesantemente sulla vita di un’intera vallata, era stata decisa e viene realizzata. Dalla pubblica accusa erano stati richiesti otto mesi di reclusione per istigazione al sabotaggio della Tav, ma la richiesta è stata disattesa dai giudici. Era tanto che con riferimento a rilevanti questioni di spessore politico e sociale non si sentiva parlare di istigazione a delinquere. Sono infatti lontani i tempi in cui, nel 1977, il giudice istruttore di Roma Antonio Alibrandi spiccò decine di mandati di cattura per istigazione di militari a disobbedire alle leggi contro persone che sostenevano le lotte dei cosiddetti Pid (proletari in divisa). Era il tempo in cui qualsiasi critica all’organizzazione dell’Esercito, alle modalità del servizio e alla disciplina proveniente da singoli o organizzazioni antimilitariste o semplicemente per la democratizzazione delle Forze Armate veniva duramente repressa. Gli arrestati appartenevano a diversi movimenti e partiti: a Lotta continua e ad Avanguardia operaia, al Pdup e al Partito Radicale. Tra gli aderenti a questo partito furono colpiti dal provvedimento restrittivo il matematico settantunenne Bruno De Finetti, accademico dei Lincei, Giancarlo Cancellieri, Roberto Cicciomessere (segretario del partito), Andrea Tosa e Valter Vecellio. Costoro decisero di costituirsi, Cicciomessere fu arrestato davanti a Montecitorio, gli altri dettero appuntamento alla polizia in coincidenza con l’apertura dell’Accademia dei Lincei. La difesa fu assunta da Umberto Terracini, un giurista che ha firmato la Costituzione. Fatti lontani, ormai dimenticati. Era sperabile che anche il reato contestato allo scrittore fosse caduto nel dimenticatoio, ma non è stato così. Eppure le domande che la magistratura inquirente si poteva porre nel momento in cui De Luca è stato denunciato dalla società che costruisce
la linea Torino-Lione non erano poche. Accogliendo l’impostazione dei pubblici ministeri torinesi, quanti libri e riviste dovrebbero finire sotto processo? La norma incriminatrice può considerarsi ancora oggi rispettosa della Costituzione? Qual è in una democrazia il senso della previsione dell’articolo 21 della legge fondamentale secondo cui tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione? È evidente che una simile norma ha lo scopo di tutelare l’anticonformismo, le minoranze e le opinioni dissenzienti, anche se sgradite al potere politico o a quello economico. Interventi come quello di Erri De Luca servono infatti a sottolineare che la Tav non è solo molto costosa e destinata a incidere negativamente sul territorio del val di Susa, ma anche che è stata imposta a un’intera collettività, in nome di un discutibile interesse nazionale, prescindendo totalmente dalle sue istanze e dalla sua volontà. È dunque giusta la sentenza del tribunale di Torino; e della Tav è opportuno continuare a discutere. Torna al sommario