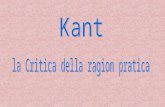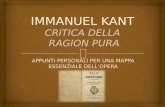Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali · tal proposito c'è da dire che...
Transcript of Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali · tal proposito c'è da dire che...
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
2
Alla realizzazione del presente Rapporto hanno collaborato più persone,
all'interno di un progetto comune tra i funzionari ed i responsabili del-l'Amministrazione Provinciale, nel cui ambito è stato curato lo sviluppo del-l'Osservatorio per le Politiche Sociali, e i docenti e ricercatori del Diparti-mento di Scienze Sociali dell'Università di Pisa, che ne hanno garantito l'af-fidabilità scientifica. In particolare, per la Provincia di Livorno, un sentito ringraziamento va alla Dr.ssa Francesca Romano e alla Dr.ssa Caterina Tocchini per la paziente opera di raccolta dei dati.
Per il Dipartimento di Scienze Sociali, il Prof. Fedele Ruggeri ha assicu-
rato la supervisione dell'attività, co-progettata con il Prof. Andrea Salvini, che ne ha curato la messa in opera. La Dr.ssa Dania Cordaz ha seguito gli aspetti tecnici di rappresentazione statistica e grafica dei dati.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
4
Questo Rapporto costituisce la prima riflessione organica sulle informa-zioni che sono state raccolte nell'ambito dell'Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Livorno nell'ultimo anno.
Esso è stato elaborato con il convincimento di dover soddisfare una serie di esigenze, che qui si richiamano brevemente in modo da introdurre il lettore alla logica di costruzione che presiede a questo prodotto. L'obiettivo è quello di spiegarne struttura e modalità, convinti così di migliorarne l'utilizzazione.
Innanzi tutto questo è un Rapporto Sociale e come tale illustra l'evoluzio-ne della realtà territoriale a partire da un punto di osservazione ben preciso, che è quello delle principali tendenze strutturali che sono più direttamente coinvolte nella genesi e manifestazione dei bisogni sociali. Non si tratta di un rapporto, dunque, che descrive tutti gli aspetti possibili che riguardano le dinamiche sociali, ma quelli più rilevanti nell'ottica delle politiche sociali; d'altra parte, il contesto in cui si colloca l'Osservatorio per le Politiche Sociali, implica di per sé un processo selettivo delle informazioni su cui concentrare l'attenzione.
Lo scopo di questo Rapporto, dunque, non è quello di offrire al lettore ed all'operatore sociale un compendio di dati statistici - il prodotto esiste già ed è la base informativa - ma uno strumento su cui riflettere in direzione di una più ampia comprensione del modo in cui si strutturano le esigenze sociali. A tal proposito c'è da dire che l'ipotesi di lavoro di fondo è che la ragion d'essere delle politiche sociali sia nelle difficoltà, originarie o sopravvenute, che i soggetti sperimentano a realizzarsi ed agire come cittadini. Difficoltà che producono sofferenze e, a volte, danni per soggetti particolari e deperimento delle condizioni generali per tutti. Da qui la necessità di capire i disagi e di ricostruire i processi di fragilizzazione.
Il Rapporto, dunque, si pone come uno strumento coerente con l'impianto concettuale e metodologico dell'Osservatorio per le Politiche Sociali e ne rappresenta il prodotto di sintesi più efficace dal punto di vista del supporto alla programmazione dei piani di intervento a livello territoriale. Si potrebbe affermare che, a regime, il Rapporto Sociale costituisce il luogo privilegiato di sintesi del patrimonio informativo e conoscitivo realizzato dall'Osservatorio, senza peraltro rinunciare a valorizzare gli eventuali contributi di informazione e riflessione che derivino da altri soggetti operanti sul territorio.
D'altra parte il Rapporto Sociale è anche lo strumento attrave rso cui è possibile individuare le carenze conoscitive rispetto a fenomeni e processi pertinenti e rilevanti con riferimento alla ragion d'essere di un osservatorio. In questo senso quanto si sta proponendo rappresenta un'occasione significa-tiva per verificare la congruità concettuale e metodologica del modello di osservazione adottato e per aggiustare e sviluppare gli strumenti di indagine necessari ad una migliore comprensione dei fenomeni sociali su cui si dirige l'attenzione.
Introduzione
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
5
Per facilitare la lettura del Rapporto, si dirà preliminarmente che esso è articolato in tre parti: nella prima si descrivono le principali dinamiche che hanno caratterizzato l’evoluzione strutturale della realtà provinciale pisana sia da un punto di vista socio–economico che demografico, in modo che sia più chiaro cogliere i fenomeni congiunturali all’interno di un quadro evolutivo più ampio. Nella seconda si descrivono le tendenze recenti che caratterizzano l’evoluzione dei processi che sono più immediatamente coinvolti nel garantire livelli sempre più avanzati di esercizio della cittadinanza, come la struttura e le relazioni familiari, i processi formativi, l’accesso al lavoro, il tessuto associazionistico; sono stati definiti “luoghi della cittadinanza –processi e soggetti” proprio per sottolineare la loro funzione “integrativa” – o inclusiva –, e la corrispondente rilevanza della sofferenza sociale che può derivare da un loro non corretto funzionamento (fragilizzazione).
Infine, nella terza parte si è affrontato il tema dei percorsi di fragilizzazione a partire da alcune fattispecie sociali di maggior rilevanza per la programmazione sociale – gli anziani, le famiglie ed i minori, i disabili, le dipendenze, gli immigrati, l’emarginazione grave – ed affiancando alla descrizione delle misure quantitative più rilevanti che definiscono quei percorsi, la prefigurazione degli interventi istituzionali che si organizzano sul territorio per dare risposta alle esigenze di un loro contenimento. La descrizione dei dati e degli interventi istituzionali viene compiuta con una certa rapidità per non appesantire la trattazione tentando di non sacrificare la comprensione del senso di questa parte, che è quello di descrivere i modi attraverso cui la realtà territoriale si organizza per fronteggiare in modo competente i propri bisogni.
Come ulteriore scrupolo nella redazione del testo, si è tentato di utilizzare
un linguaggio che non indugiasse sugli specialismi e sulla tecnicità – per altro mai del tutto evitabile – per favorire una lettura il più possibile piana e non eccessivamente impegnativa. Solo gli opportuni feed–back con i principali destinatari del Rapporto (gli operatori sociali, gli amministratori, ecc…) diranno se il tentativo ha sortito effetto, e offriranno spunti di rilievo per le prossime stesure. Ovviamente, questi “ritorni” informativi assumono maggior peso soprattutto sul versante dei contenuti e dei debiti informativi. Si tratta di procedere in modo il più possibile partecipato affinché il Rapporto Sociale costituisca uno strumento di lavoro e di riflessione effettivamente fruibile, almeno sul piano della progettazione sociale.
Uno dei limiti metodologici fondamentali incontrati nella costruzione del
Rapporto, come ben si può immaginare, è stata la disponibilità dei dati, non solo nel senso del loro aggiornamento, ma anche della loro pertinenza con i contenuti trattati. I problemi legati alla disponibilità non riguardano tanto l’aggiornamento, quanto la disaggregazione territoriale. È innegabile, certamente, l’esigenza di avere dati aggiornati – i più aggiornati – anche se, considerando i modi dell’evoluzione dei processi sociali, si dovrebbe tentare
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
6
di ridurre lo “stress da aggiornamento” per concentrare le energie intellettuali anche sulla comprensione delle dinamiche di trasformazione e di mutamento dei caratteri dei fenomeni stessi a livello territoriale.
In questo quadro non poche sono le carenze che derivano dalla ancora
non completa realizzazione del sistema di osservazione. Va da sé che proce-dere in modo graduale è virtuoso, oltre che necessario, proprio per apprez-zare e realizzare i diversi aspetti e le varie coerenze del modello adottato e per dispiegare quella partecipazione e crescita conoscitiva che sono essenziali per la sua funzionalità nel tempo; tuttavia, proprio il carattere di sistema dice della necessità di una attuazione armonica per averne la piena manifestazione del potenziale di conoscenza.
È nel complesso di tale dimensione attuativa, purtroppo, che si riscon-trano le maggiori lacune informative. Così per molti temi rilevanti territo-rialmente, come si vedrà più avanti, non esistono dati attendibili ed affidabi-li a livello di comune e di zone socio-sanitarie e, in alcuni casi, nemmeno a livello provinciale (come accade per la struttura della famiglia). Non è certo questa la sede per interrogarsi sulle cause di tale assenza strutturale di informazioni su questioni strategicamente rilevanti per le politiche sociali; tuttavia, si deve tenere presente che le difficoltà "tecniche" (costi di rilevazione, coordinamento fra soggetti, ecc…) non sono sufficienti per dare una risposta adeguata a tale interrogativo.
Fatto sta che l’Osservatorio per le Politiche Sociali costituisce, ad oggi,
l’unico strumento istituzionale in grado di colmare tale lacuna, anche realizzando le opportune sinergie istituzionali. D’altra parte, la questione del debito informativo è rilevante proprio per diffondere la consapevolezza sul patrimonio informativo ad oggi effettivamente utilizzabile e quello che potrebbe esser costruito mediante l’attivazione di specifici processi ad hoc.
Le fonti statistiche ed informative da cui si è attinto per la stesura del
rapporto fanno sostanzialmente riferimento a quanto raccolto e prodotto dall’Osservatorio per le Politiche Sociali durante la sua attività.
Dove non specificato, le tabelle sono tratte dalla Base Informativa Statistica dell’OPS, sia nella sua prima versione, sia in quella in via di aggiornamento a cura dei funzionari dell’Amministrazione Provinciale. D’altra parte, le fonti a cui fa riferimento la Base Informativa sono piuttosto numerose, ma tutte sono fonti ufficiali.
Per la terza parte del Rapporto, si è fatto riferimento anche ai piani di zona prodotti nell’ambito della programmazione degli interventi sociali per il 2001, ma soprattutto anche alle informazioni derivanti dalla produzione conoscitiva di diverse organizzazioni di volontariato e dei servizi socio–sanitari territoriali. Per un elenco delle organizzazioni e degli enti che hanno costituito fonti importanti per la realizzazione di questo Rapporto si rimanda al termine di questo volume.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
7
Infine, si è cercato di valorizzare anche il patrimonio conoscitivo che è stato possibile acquisire attraverso la realizzazione di due delle tre indagini previste dal modello di OPS, all’interno delle “rilevazioni sui funzionamenti societari”, cioè quella sui giovani e quella sugli anziani.
Naturalmente, si è cercato di agire in modo selettivo, individuando le tematiche più pertinenti nell’economia di questo Rapporto Sociale. Il contributo conoscitivo che ne è derivato è assai ricco e fecondo di implicazioni non soltanto sul piano contenutistico della completezza informativa, ma anche su quello metodologico della possibilità di integrazione tra dati di rilevazione diretta (indagini sul territorio) e indiretta (da fonti amministrative o secondarie).
Andrea Salvini Fedele Ruggeri
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
8
La realtà sociale della provincia di Livorno sta sperimentando una fase di lenta quanto graduale trasformazione nelle sue componenti strutturali, che si riflettono, da una parte, nelle dinamiche intere alla configurazione socio–economica e, dall’altra, nel consolidamento di processi di cambiamento demografico – molti dei quali sono condivisi, sebbene in misura variabile, con le altre province della Toscana.
Le direzioni di questo movimento strutturale sono molteplici e non sempre di immediata rappresentazione; uno sguardo di insieme ai principali caratteri socio–demografici del territorio consente di individuare situazioni molto differenziate che richiedono una specifica attenzione in fase di descrizione (come per esempio la realtà elbana); ma ciò non impedisce di rintracciare tratti comuni e uniformità nell’area provinciale.
D’altra parte, alcuni dei processi più recenti in campo demografico e in quello del mercato del lavoro, possono essere l’effetto di fattori congiunturali, per i quali è necessario attendere ulteriori conferme prima di poter essere effettivamente interpretati come cambiamenti strutturali.
I dati tipici che contraddistinguono la particolare collocazione della Toscana nel contesto sociale italiano, nel territorio livornese trovano frequenti conferme, ed altre volte vengono parzialmente modificati da evidenze empiriche che delineano i tratti di una realtà relativamente discontinua rispetto ai valo ri medi regionali. Inoltre, se si considerano le quattro suddivisioni amministrative che verranno costantemente esaminate in questo Rapporto – le zone socio–sanitarie – la provincia evidenzia ulteriori discontinuità interne che trovano motivo anche nella diversità delle vocazioni economico–sociali espresse dal territorio.
Come sempre, i processi di cambiamento devono essere letti ed
interpretati ampliando, se possibile, il raggio di osservazione; limitandoci, tuttavia, a considerare gli ultimi trent’anni attraverso i dati di censimento, possiamo individuare preliminarmente alcuni passaggi cruciali che segnano la struttura sociale provinciale livornese. In particolare, questi anni sono stati caratterizzati da importanti processi di destrutturazione della base industriale tipica della forma economica del secondo dopoguerra, e da più recenti tentativi di riconfigurazione di quella stessa base. È ormai noto come la crisi della grande industria nel territorio provinciale – segnatamente quella a partecipazione statale –, l’aumento dei competitività a livello internazionale (non solo con riferimento al mercato delle merci, ma anche a quello delle infrastrutture, come quelle portuali) siano stati fattori critici di modificazione della configurazione economica e sociale locale.
L’economia livornese ha attraversato, alla fine degli anni ’80, un periodo di crisi assai profonda, dovuta al clima generale di recessione e alla rigidità dei suoi caratteri strutturali; questi elementi hanno condotto ad una riduzione dell’occupazione nel settore industriale – quindi ad una contrazione dell’occupazione in generale, all’abbassamento del tasso di attività e a un innalzamento del tasso di disoccupazione, che fino a pochi
Capitolo 1
Caratteri e dinamiche strutturali della società livornese
Caratteri della struttura sociale
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
9
anni fa è stato uno dei più alti in Toscana, accanto a quello delle province di Massa Carrara e di Grosseto.
L’impatto sociale di questi fattori critici può essere rintracciato con evidenza nel mutamento occorso all’interno della distribuzione della popolazione attiva secondo la posizione nella professione e l’attività economica1. Nell’arco di vent’anni, dal 1971 al 1991, la popolazione attiva compresa nella categoria dei “lavoratori dipendenti” è scesa di circa 10 punti percentuali – rispetto al complesso degli attivi –, mentre nello stesso periodo si nota l’incremento degli attivi collocati nella posizione di “lavoratori in proprio”, “imprenditori e liberi professionisti”2. In generale, già in questi anni, e specificatamente tra il 1981 e il 1991, si possono rintracciare i segnali di un consistente cambiamento della struttura sociale livornese, descritti dalla riduzione del lavoro operaio e dall’aumento del lavoro autonomo, pur all’interno di un contesto occupazionale gravato da elevati tassi di disoccupazione (generale e specifico). La categoria del lavoro impiegatizio (soprattutto nel settore dei servizi pubblici e privati) non subisce particolari modificazioni a livello provinciale, sebbene si debba segnalarne un incremento soprattutto tra il 1971 e il 1981.
Questo duplice movimento (riduzione del lavoro industriale, aumento del
lavoro autonomo) si riscontra soprattutto all’interno della zona della Val di Cornia (–10,8 punti percentuali nella classe dei lavoratori dipendenti) e di quella livornese (–10,4 punti percentuali), data la collocazione dei principali insediamenti industriali; segue la Val di Cecina con una riduzione di circa 8 punti e la zona elbana (–4 punti circa).
Piuttosto consistenti sono gli incrementi che si verificano nella zona livornese e nella zona della Val di Cecina rispetto alla presenza di lavoratori in proprio, che si concentrano soprattutto nell’area del settore terziario, anche se questo settore non assorbe completamente il decremento che si verifica in quello industriale.
In tutte le zone considerate, il lavoro dipendente costituisce ancora l’area di maggior concentrazione della popolazione attiva soprattutto nella Val di Cornia e nella Val di Cecina, ma ciò costituisce comunque un carattere significativo della struttura sociale livornese.
Un secondo aspetto comune a tutte le zone, sebbene con intensità diverse, è che l’incidenza femminile nella popolazione attiva – soprattutto nei settori tradizionali – è assai minoritaria; nel contempo, però, è in costante aumento; come si vedrà in seguito, l’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro costituisce uno dei fattori più importanti di cambiamento nella struttura sociale; vale la pena sottolineare come la posizione di
1 Questo riferimento è importante poiché assumiamo che la distribuzione della
popolazione in grandi gruppi socio–professionali possa essere considerata come equivalente funzionale della suddivisione in classi sociali e comunque costituisca una rappresentazione significativa della struttura sociale di un territorio.
2 Secondo le classificazioni utilizzate nei censimenti considerati, tra i lavoratori dipendenti dobbiamo includere in particolare gli operai, nei diversi livelli di qualificazione.
La struttura sociale nelle zone socio – sanitarie
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
10
minoranza del segmento femminile tra la popolazione attiva negli anni considerati sia un indicatore significativo dell’accentuata divisione del lavoro secondo il genere, tipica del modello socio–economico basato sulla grande impresa.
Tabella 1. Evoluzione della popolazione della provincia di Livorno per posizione nella professione
Imprenditori e lib. Prof. 1971 1981 1991 Var %
Zona livornese 1355 2868 4896 261,328
Zona Val di Cecina 437 811 1930 341,648
Zona Val di Cornia 430 569 1289 199,767
Zona Elbana 218 401 1039 376,606
Provincia Livorno 2440 4649 9154 275,164
Lavoratori in proprio 1971 1981 1991 Var %
Zona livornese 7928 7988 10356 30,6256 Zona Val di Cecina 4292 4371 5000 16,4958
Zona Val di Cornia 3824 3453 3996 4,49791
Zona Elbana 2050 2014 2305 12,439 Provincia Livorno 18094 17509 21759 20,2553
Dirigenti e impiegati
1971 1981 1991 Zona livornese 17921 23162 22300 24,435
Zona Val di Cecina 3660 5122 5769 57,623
Zona Val di Cornia 3768 5578 5105 35,483 Zona Elbana 1508 1751 2198 45,756
Provincia Livorno 26857 35710 35364 31,6752
Lavoratori dipendenti
1971 1981 1991 Var % Zona livornese 30256 29880 26396 -12,7578
Zona Val di Cecina 11574 12520 11016 -4,82115
Zona Val di Cornia 12273 12114 9770 -20,3944
Zona Elbana 4514 4629 4818 6,7346
Provincia Livorno 58617 58943 52000 -11,2885 Coadiuvanti
1971 1981 1991 Var % Zona livornese 1896 2211 1942 2,42616
Zona Val di Cecina 1201 1188 924 -23,0641
Zona Val di Cornia 737 834 810 9,90502 Zona Elbana 470 491 435 -7,44681
Provincia Livorno 4304 4724 4111 -4,4842 Fonte: ISTAT, Censimenti della popolazione 1971, 1981, 1991
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
11
Negli anni a noi più vicini, nuovi elementi contribuiscono a consolidare e, nel contempo, ad articolare il quadro delle trasformazioni appena descritte. In attesa dei dati del censimento effettuato nel 2001 – che offriranno un quadro certamente più dettagliato a livello territoriale – dovremo riferirci alle fonti che trattano del mercato del lavoro a livello provinciale e alle interpretazioni correnti circa la sua attuale configurazione 3.
In primo luogo, la riduzione della base occupazionale dell’industria sembra in fase di deciso rallentamento, mentre si conferma il consistente movimento verso le attività autonome. A prescindere dalla natura di tali attività, vale la pena sottolineare che a tale movimento ha corrisposto una notevole riduzione del tasso di disoccupazione e un aumento dell’occupazione nel settore dei servizi privati e pubblici (servizi alle imprese, alle famiglie, alle persone).
I dati sulla nati–mortalità delle imprese mostrano due caratteri assai significativi:
§ una tendenza alla frammentazione dei soggetti economici: secondo il Censimento Intermedio dell’Industria e dei Servizi, effettuato dall’ISTAT nel 1996, il 96,4% delle imprese livornesi ha un numero di addetti compreso tra 1 e 9, e ben il 72,7% ha 1 o 2 addetti (dato leggermente superiore alla situazione toscana);
§ valori di nati–mortalità piuttosto elevati (i tassi sono risultati, per il biennio 1998–2000, rispettivamente pari a 9,0 e a 7,0, con un tasso di evoluzione pari a 2,0, leggermente superiore al valore toscano).
Questi dati sembrerebbero indicare un lento distacco dai meccanismi di dipendenza dai settori tradizionali dell’economia, una certa vitalità imprenditoriale e, soprattutto, un riequilibrio della dinamica occupazionale, che ha consolidato l’incidenza del settore terziario e dei servizi anche nell’economia livornese, nel quale converge il 72% degli occupati nel territorio provinciale.
Dal punto di vista della struttura sociale, ciò si riflette nell’ampliamento dei gruppi socio–professionali dei lavoratori autonomi, degli impiegati e dirigenti, soprattutto in considerazione della crescita del lavoro flessibile (in particolare delle prestazioni di lavoro coordinato e continuativo, ma anche delle altre forme flessibili, come il lavoro interinale, i contratti di formazione–lavoro, ecc…); anche l’occupazione femminile segna un significativo incremento, assieme a quella giovanile, contribuendo entrambi all’abbassamento del tasso di disoccupazione all’8,4%4.
Le trasformazioni dei caratteri strutturali della realtà socio–economica
provinciale descrivono attualmente una situazione connotata da alcuneambivalenze: da una parte, i risultati economici non appaiono particolarmente brillanti se comparati con la situazione toscana e italiana:
3 Cfr., ad esempio, Aa.Vv., Il mercato del lavoro in provincia di Livorno – anno 2001. Ripresa occupazionale e nuove dinamiche nel sistema economico locale, Settembre 2001.
4 Questi temi saranno approfonditi nella seconda parte del Rapporto.
Processi recenti
Le graduatorie del benessere provinciale
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
12
basti qui considerare la modesta incidenza del valore aggiunto prodotto dalla provincia sul totale nazionale e il livello del reddito disponibile pro–capite (che nel 1995, secondo Unioncamere, era pari a 29,2 milioni di lire) – inferiore sia a quello toscano che quello italiano; dall’altra, gli indicatori relativi alla competitività del territorio 5 e ai consumi finali interni (al 1999) mostrano sintonie più accentuate con la situazione regionale. Nella graduatoria della dotazione di infrastrutture economiche elaborata dal Tagliacarne, la Provincia di Livorno si colloca al secondo posto, mentre in fatto di infrastrutture sociali si colloca al 29°. Rispetto alla qualità della vita complessiva, la posizione della Provincia cambia in relazione alle modalità di costruzione metodologica degli indici. Secondo la graduatoria di “Italia Oggi”, Livorno occupa la 9° posizione, mentre è al 15° posto secondo la prospettiva di Legambiente; infine è al 37° considerando la scala proposta da “Il Sole – 24ore”. Anche l’IRPET, nel suo primo Rapporto sulla società toscana, ha avanzato una propria graduatoria sulle “dimensioni del benessere”, frutto dell’applicazione di un complesso modello statistico. Come riconosce lo stesso Istituto in via preliminare alla presentazione dei dati “…anche la nostra graduatoria risente di elementi di arbitrarietà e soggettività che sono per definizione ineliminabili, in quanto connessi alla scelta dei vari indicatori e del peso loro assegnato”6. La graduatoria provinciale elaborata dall’IRPET mostra come le province toscane siano tutte collocate nella prima metà della classifica finale della stima del benessere. In particolare Livorno è collocata al 35° posto, terzultima tra le province toscane, prima di Pistoia e Massa Carrara. Si riportano, a livello esemplificativo, le valutazioni qualitative circa le dimensioni del benessere elaborate dall’IRPET per le province d’area vasta.
Tabella 2. Graduatoria del benessere per le province di area vasta.
Livorno Pisa Lucca Massa–Carrara
Benessere economico
Medio–basse In media In media Medio–basse
Solidità dello sviluppo economico
Medio–alte Medio–alte In media Medio–basse
Ambiente di vita e di lavoro
Medio–basse Medio–alte Medio–basse Medio–basse
Disagio sociale Medio–alte In media Medio–basse Medio–alte Infrastrutture socio–culturali
In media In media In media In media
Sicurezza Medio–basse Medio–basse Medio–basse Medio–basse
Fonte: IRPET
5 Fonte: banca dati Starnet, Atlante della competitività delle Province, consultabile sul
sito www.starnet.unioncamere.it. 6 Pescarolo A. (a cura di), Modi di vivere, bisogni, politiche. 1° Rapporto sulla società
toscana , IRPET, Firenze, 2001, p.119 e segg.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
13
L’andamento della popolazione residente nella provincia di Livorno
mostra una duplice tendenza, a seconda del riferimento temporale considerato. Se si amplia l’orizzonte di osservazione fino a comprendere gli ultimi 50 anni, i dati di censimento evidenziano un complessivo aumento della popolazione residente in tutto il territorio, specialmente nella zona della Val di Cecina e nella zona livornese. Non abbiamo considerato, nel calcolo della variazione percentuale, i dati provvisori del 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, poiché in alcuni casi restituiscono valori che si discostano in modo consistente da quelli registrati dalle anagrafi nel precedente anno 7.
In particolare, dal 1951 al 1981, la crescita della popolazione residente è particolarmente sensibile in quasi tutte le sotto–aree provinciali, con esclusione della zona elbana, dove si assiste ad un’emorragia pari al 4% circa della popolazione. A partire dal 1981, invece, la crescita si arresta ed anzi, è evidente una riduzione della popolazione residente, lenta quanto decisa – con esclusione della zona elbana che recupera la perdita degli anni precedenti e registra un ulteriore incremento, ed anche della zona cecinese, che mantiene positivo il proprio saldo demografico.
Come si noterà, la riduzione della popolazione è più evidente nelle zone dove più che in altre – come si è visto in precedenza – si è fatta sentire l’influenza della crisi economica dei settori tradizionali, ed in particolare dove più aspro è stato l’impatto sociale del processo di de–industrializzazione.
D’altra parte, all’interno delle stesse zone socio–sanitarie si assiste a
processi piuttosto differenziati: nella zona livornese, ad esempio, ad una riduzione in valore assoluto della popolazione residente nel capoluogo di provincia di circa 6000 unità negli ultimi dieci anni (–3,7 come variazione percentuale), corrisponde un aumento, sempre in valore assoluto e nello stesso periodo, della popolazione nel Comune di Collesalvetti di circa 1000 unità (+7,8 come variazione percentuale).
Nella zona cecinese, ad una sostanziale tenuta demografica di Rosignano M.mo e di Castagneto Carducci, corrisponde un aumento della popolazione nel comune di Cecina e in quello di Bibbona.
Ancora, nella Val di Cornia si registra una caduta della popolazione residente per i comuni più esposti sul piano delle attività industriali (Piombino: –6,1%, San Vincenzo: –4,7%) mentre nella zona elbana si
7 Poiché si tratta di dati provvisori e dato che, nel momento in cui viene realizzato questo
Rapporto, in alcuni comuni toscani le operazioni di censimento non sembrano ancora del tutto concluse, non ci è sembrato il caso di utilizzare le prime risultanze censuarie per definire processi e tendenze. Tuttavia, li abbiamo riportati poiché sono stati effettivamente diffusi in via ufficiale dall’ISTAT e pubblicati sul sito internet www.istat.it .
Tale diffusione ha generato le immediate proteste di alcuni comuni che hanno evidenziato la non congruità dei risultati provvisori con i dati anagrafici.
Dinamiche della struttura demografica
La popolazione residente nelle zone socio–sanitarie
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
14
registra, sempre negli ultimi 10 anni un incremento piuttosto generalizzato (con esclusione di Marciana Marina).
Tabella 3. Evoluzione della popolazione residente per comune e zone socio-sanitarie.
Valori assoluti anni 1951-2001
1951 1961 1971 1981 1991 2000 2001* Var % Livorno 142.333 161.077 174.791 175.741 167.512 161.288 148.143 -3,7 Collesalvetti 10.825 10.395 10.285 14.346 15.087 16.270 15.866 7,8 Capraia Isola 465 467 323 395 267 348 335 30,3 Zona livornese 153.623 171.939 185.399 190.482 182.866 177.906 164.344 -2,7
Rosignano M.mo 23.776 27.083 28.799 29.985 30.021 30.495 30.558 1,6 Cecina 12.539 16.590 21.369 24.336 24.636 26.464 26.355 7,4 Castagneto Carducci 8.219 7.866 7.622 8.240 8.256 8.324 8.204 0,8 Bibbona 3.333 3.109 2.640 2.651 2.793 3.036 3.017 8,7 Zona Val di Cecina 47.867 54.648 60.430 65.212 65.706 68.319 68.134 4,0
Piombino 32.482 36.102 39.654 39.401 36.774 34.521 33.917 -6,1 Campiglia M.ma 8.783 9.266 11.350 12.463 12.513 12.550 12.543 0,3 San Vincenzo 5.089 5.673 7.182 7.558 7.175 6.837 6.528 -4,7 Suvereto 4.086 3.246 3.025 3.173 3.053 2.915 2.897 -4,5 Sassetta 1.233 873 682 585 553 619 548 11,9 Zona Val di Cornia 51.673 55.160 61.893 63.180 60.068 57.442 56.433 -4,4 Campo nell' Elba 4.231 4.064 4.066 4.148 4.274 4.335 4.158 1,4 Capoliveri 2.233 2.168 2.193 2.239 2.435 3.163 3.108 29,9 Marciana 2.309 2.191 2.186 2.305 2.244 2.281 2.140 1,6 Marciana Marina 1.751 1.777 1.830 1.955 1.971 1.893 1.891 -4,0 Porto Azzurro 3.078 3.006 2.929 3.073 3.111 3.434 3.211 10,4 Portoferraio 10.385 10.272 10.629 10.839 11.042 11.999 10.232 8,7 Rio Marina 3.533 3.613 2.681 2.317 2.043 2.267 2.152 11,0 Rio nell' Elba 1.601 1.372 1.029 907 866 999 954 15,4
Zona Elbana 29.121 28.463 27.543 27.783 27.986 30.371 27.846 8,5
*Dati provvisori del 14° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni - 2001
Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
15
Tabella 4. Evoluzione della popolazione residente in Provincia di Livorno: dettaglio per zone socio-sanitarie - Anni 1951 - 2001 - Valori assoluti
1951 1961 1971 1981 1991 2000 2001*
Zona livornese 153.623 171.939 185.399 190.482 182.866 177.906 164.344 Zona Val di Cecina 47.867 54.648 60.430 65.212 65.706 68.319 68.134 Zona Val di Cornia 51.673 55.160 61.893 63.180 60.068 57.442 56.433 Zona Elbana 29.121 28.463 27.543 27.783 27.986 30.371 27.846
Provincia 282.284 310.210 335.265 346.657 336.626 334.038 316.757
Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno Uno sguardo alla tabella relativa al movimento della popolazione
residente, mostra come in tutte le zone considerate si incontrano saldi naturali negativi e, corrispondentemente, saldi migratori positivi; peraltro, solo nella zona elbana e cecinese questo saldo positivo compensa il saldo naturale e contribuisce ad incrementare il saldo complessivo. Risultano così di più immediata comprensione gli indici demografici sintetici, che mostrano un tasso di natalità che si approssima al 7‰ e un tasso di mortalità che si attesta attorno al 12‰ (si osserverà nella Val di Cornia si riscontra il valore minimo della natalità e quello massimo della mortalità, mentre all’Isola d’Elba i termini sono invertiti), e dunque l’indice di crescita naturale a livello provinciale è pari al –5‰ circa.
L’indice di crescita migratoria è positivo dovunque, ma in particolar modo nella Val di Cecina e all’Elba, per cui l’indice di crescita totale risulta positivo solo in queste due ultime aree territoriali.
Tabella 5. Evoluzione della popolazione residente nella Provincia di Livorno: dettaglio per zone socio-sanitarie. Variazioni percentuali Anni 1951-2000
Var % 51 – 00 Var % 51 – 81 Var % 81 –00 Zona livornese 15,8 24,0 -6,6 Zona Val di Cecina 42,7 36,2 4,8 Zona Val di Cornia 11,2 22,3 -9,1 Zona Elbana 4,3 -4,6 9,3 Provincia 18,3 22,8 -3,6
Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno La tendenza più evidente e più nota nell’andamento demografico della
provincia livornese e, in generale, di quello toscano (e italiano) è quella relativa al rapido invecchiamento della popolazione residente. Questo processo costituisce un elemento strutturale della realtà sociale livornese, sebbene si possano individuare aree di differenziazione del fenomeno.
Prima di tutto, però, conviene prestare attenzione alla rapidità dei processi di invecchiamento. Dal 1961 al 1999 la popolazione ultra–sessantacinquenne nella provincia di Livorno passa, in valore assoluto, da 34149 a 74204 persone; nel corso di questi quaranta anni, gli anziani livornesi sono quasi raddoppiati in numero; la percentuale degli anziani sul
I processi di invecchiamento
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
16
totale della popolazione residente passa dall’11% del 1961 al 22,2% del 1999. L’indice di vecchiaia aumenta di tre volte e mezzo, attestandosi nel 1999 a 203,3.
Se, da una parte, l’incidenza della popolazione anziana sul totale della popolazione si incrementa, nel corso dei decenni, in modo relativamente costante (l’aumento oscilla tra il 15 e il 20% in ogni singolo decennio a partire dal 1971) l’aumento dell’indice di vecchiaia segnala un picco notevole tra il 1981 e il 1991, periodo dove più acuto si manifesta il fenomeno del decremento delle nascite, che sembra invece conoscere una lieve battuta di arresto negli anni a noi più vicini.
Tabella 6. Movimento della popolazione residente per zona socio-sanitaria al 1999
Zona socio-sanitaria Popolazione
al 1/1 Nati vivi Morti Saldo
naturale Iscritti Cancellati Saldo
migratorio Popolazione al 31/12
Donne in età feconda
Val di Cornia 58.676 377 772 -395 1.212 1.099 113 58.394 12.623
Livornese 178.790 1.270 2.199 -929 3.211 2.879 332 178.193 41.787
Elba 30.093 239 344 -105 826 675 151 30.139 6.960
Bassa Val di Cecina 75.928 548 937 -389 2.325 1.553 772 76.311 15.407
Provincia Livorno 343.487 2.434 4.252 -1.818 7.574 6.206 1.368 343.037 76.777
Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno
Tabella 7. Tassi demografici dell'andamento della popolazione residente per zona (per 1000 abitanti) - Anno 1999
Zona socio-sanitaria Tasso
generico di natalità
Tasso generico di mortalità
Indice di crescita naturale
Indice di immigratorietà
Tasso generico di
emigratorietà
Indice di crescita
migratoria
Indice di crescita totale
Tasso generico di fecondità
Val di Cornia 6,4 13,2 -6,7 20,7 18,8 1,9 -4,8 29,9
Livornese 7,1 12,3 -5,2 18,0 16,1 1,9 -3,3 30,4
Elba 7,9 11,4 -3,5 27,4 22,4 5,0 1,5 34,3
Bassa Val di Cecina 7,2 12,3 -5,1 30,5 20,4 10,1 5,0 35,6
Provincia Livorno 7,1 12,4 -5,3 21,6 17,8 3,7 -1,5 31,7
L’indice di dipendenza si attesta attorno al valore di 49, che sicuramente costituisce un indicatore significativo se letto nell’ottica – sia pur parziale per la comprensione del significato della presenza anziana nella nostra realtà – del “peso” sociale ed economico esercitato dalle classi cosiddette “improduttive” (giovani e anziani) su quella produttiva intermedia8.
8 Il ragionamento sarà ripreso nel capitolo 2 per sottolineare l’opportunità di considerare
i processi di invecchiamento non tanto come un “peso” quanto come una risorsa per la nostra società. È certo, tuttavia, che determinati costi sociali (il ruolo della famiglia nel sostegno ali membri anziani) ed economici (la spesa previdenziale) dovranno essere necessariamente fronteggiati.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
17
La rapidità del fenomeno assume proporzioni differenti all’interno delle diverse aree provinciali.
La zona socio–sanitaria elbana e quella livornese, infatti, appaiono aree territoriali con valori meno “pesanti” relativamente ai processi di invecchiamento, al contrario di quanto accade nella Val di Cornia, dove l’indice di vecchiaia raggiunge livello 246,8 – qui, del resto, l’incidenza della popolazione ultra–sessantacinquenne è maggiore che nelle altre aree territoriali.
Tuttavia si deve notare che la minor evidenza dei processi di invecchiamento nell’area livornese dipende dal fatto che il comune di Collesalvetti e di Capraia Isola mostrano un quadro meno intenso di quanto non avvenga nel Comune di Livorno. La particolare configurazione territoriale e socio–economica del Comune di Collesalvetti, ad esempio, favorisce l’insediamento di famiglie con coppie giovani che contribuiscono ad incrementare la presenza della popolazione d’età media più bassa.
Nella Val di Cornia si verifica il concomitante fenomeno della minor incidenza della popolazione giovanile e della maggior incidenza della popolazione anziana sul totale della popolazione – in particolare a San Vincenzo e Piombino, mentre nella zona elbana si verifica il fenomeno inverso. Nella bassa Val di Cecina livornese, la percentuale dei giovani si attesta attorno alla media provinciale, mentre quella degli anziani la oltrepassa, sebbene non in modo cospicuo. All’interno di questa realtà territoriale, Bibbona sembra avvicinarsi più alla tipologia “elbana” (e di Collesalvetti) rispetto agli altri comuni. Vale la pena segnalare, come ulteriore motivo di differenziazione territoriale, che all’interno della zona dell’Isola d’Elba non tutti i comuni presentano la situazione sopra descritta, ma da essa si diversificano notevolmente le aree di Marciana, Rio Marina e Rio nell’Elba, che si presentano come i comuni con più alto indice di invecchiamento dell’Isola.
Tabella 8. Popolazione residente per alcune classi di età e zona socio-sanitaria - Anno 2000
0–14 15–64 65 e più 0–4 15–19 15–39 40–64 60–64 75 e +
Zona livornese 11,3 70,9 17,7 3,8 3,8 34,8 36,1 7,1 7,5Zona Val di Cecina 11,2 66,5 22,4 3,7 4,3 32,9 33,5 6,8 10,1Zona Val di Cornia 10,0 66,5 23,5 3,3 4,1 32,1 34,4 7,1 10,8Zona Elbana 11,6 66,4 22,0 3,9 4,1 33,7 32,7 6,1 10,8
Provincia di Livorno 11,0 67,6 21,4 3,7 4,1 33,4 34,2 6,8 9,8
Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno – Aggiornamento al
31/12/1999.
L’invecchiamento nelle zone socio–sanitarie
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
18
Tabella 9. Alcuni indici demografici della struttura per età della popolazione residente per zone socio-sanitarie - Anno 2000
Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza Età media
Zona livornese 156,2 41,4 42,6 Zona Val di Cecina 200,5 50,6 44,3 Zona Val di Cornia 237,2 50,3 45,4
Zona Elbana 193,1 50,8 44,0
Provincia di Livorno 196,7 48,3 44,1
Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno – aggiornamento al
31/12/1999
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
19
Tabella 10. Popolazione per alcune classi di età e indici demografici per comune di residenza. Anno 2000
0–14 15–64 65 e più 0–4 15–19 15–39 40–64 60–64 75 e +
Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza
Età media
Livorno 11 67 21,9 3,5 4,3 33,6 33,4 6,4 10,5 198,7 49,2 44,1Collesalvetti 12,3 69,9 17,7 4,1 4,9 35,8 34,1 6 8,3 143,5 43 41,8Capraia Isola 10,7 75,8 13,5 3,9 2,3 34,9 40,8 9 3,7 126,3 32 41,8
Zona livornese
Rosignano M.mo 11,1 65,2 23,8 3,6 4,1 32 33,1 6,9 11,3 214,5 53,5 45Cecina 11,1 66,5 22,5 3,5 4,3 32,8 33,6 6,7 10,3 202,7 50,5 44,4
Castagneto Carducci 10,7 66 23,4 3,6 3,9 32,5 33,4 6,7 10,4 219,4 51,6 44,8Bibbona 12 68,1 19,9 4,2 4,7 34,1 34 7 8,3 165,4 46,9 43
Zona Val di Cecina
Piombino 9,5 65,7 24,8 3,2 3,4 30,1 35,6 7,9 11,6 261,5 52,2 46,6Campiglia M.ma 10,7 67,6 21,7 3,4 3,8 32,2 35,3 7,3 9,6 203,3 48 44,6San Vincenzo 9,3 65,9 24,8 2,8 3,3 30,1 35,9 8,3 10,6 266,6 51,7 46,6
Suvereto 9,4 67,2 23,4 3,3 4,4 31 36,2 7,5 10,6 248,6 48,8 45,8Sassetta 11 66,3 22,7 4 5,4 37,1 29,2 4,6 11,8 205,8 50,8 43,4
Zona Val di Cornia
Campo nell' Elba 11,3 68,3 20,5 4 4,4 35,5 32,8 6,7 10,1 181,7 46,5 43,4Capoliveri 12,6 68 19,4 4,7 4,1 32,7 35,4 6,5 8 153,6 47 42,9Marciana 10,7 61,6 27,7 3,8 4,2 31,8 29,8 5,6 14 257,4 62,3 46,3
Marciana Marina 10,5 67,1 22,3 2,7 4,2 33,1 34 7,2 10,9 212,1 49 44,8Porto Azzurro 13,6 69 17,4 4,6 4,2 37,5 31,5 5,5 8,2 127,8 45 41,2Portoferraio 12,7 67,7 19,6 4,3 4,3 35,6 32,1 6,1 9 155 47,6 42,4Rio Marina 9,6 66,7 23,7 3,2 4,4 32,3 34,4 6,7 11,8 245,5 49,9 45,3
Rio nell' Elba 11,9 63 25,1 3,6 2,9 31,2 31,8 4,8 14,3 211,6 58,8 45,6
Zona Elbana
Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno – Aggiornamento al
31/12/1999
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
20
La famiglia costituisce un soggetto di indiscussa centralità sociale, per la grande quantità di ruoli sociali che le vengono assegnati, dalla socializzazione dei più giovani alla cura dei più anziani, dal costituirsi come significativo ammortizzatore sociale al proporsi come luogo privilegiato di sperimentazione di innovazione sociale. Dal punto di vista delle politiche sociali, la presenza sociale della famiglia e la sua evoluzione nel tempo hanno costituito – anche in modo diversificato – caratteri irrinunciabili per la realizzazione di strategie di intervento di sostegno, di cura e di promozione dei soggetti più deboli della società, rischiando, peraltro, di saturare le effettive capacità della stessa famiglia di farsi carico delle funzioni ad essa delegate dal sistema di welfare9.
La famiglia è, nel contempo, beneficiaria dei processi di ampliamento della cittadinanza sociale e soggetto protagonista, attore, di que lla stesso ampliamento. La normativa sociale regionale e la legge quadro nazionale sull’assistenza sociale riconoscono nella famiglia un soggetto legittimato alla partecipazione a pieno titolo nella realizzazione delle politiche sociali – proprio in virtù della capacità di svolgere funzioni significative a supporto dei propri membri più deboli.
Le trasformazioni della famiglia, di conseguenza, costituiscono un nodo
conoscitivo centrale sia per cogliere i cambiamenti della realtà sociale (anche a livello territoriale), sia per comprendere le modalità di formazione dei bisogni sociali e le complesse dinamiche di fronteggiamento di quei bisogni che le famiglie stesse predispongono sia ricorrendo a risorse interne (le reti cosiddette “informali”), sia ricorrendo alle risorse pubbliche (i servizi socio–sanitari, ad esempio) e private (sociali e non).
Da questo punto di vista, si deve purtroppo riconoscere che le fonti conoscitive sulla famiglia non sono poi così numerose e pertinenti, soprattutto a livello locale. Le informazioni disaggregate a livello territoriale possono essere considerate complete, attualmente, soprattutto con riferimento ai dati di struttura, ma non, ad esempio, a quelli relativi alla qualità e natura delle relazioni familiari, ai bisogni reali di sostegno, alla gestione delle reti sociali, alle dinamiche intergenerazionali, in una espressione, alle dimensioni della vita quotidiana familiare10.
9 Non mancano certo gli esempi che potrebbero agevolmente dimostrare l’esistenza di
tale contraddizione; qui basterà soltanto ricordare come le politiche di de–istituzionalizzazione – peraltro di indiscutibile rilevanza – corrano il rischio di far gravare i propri costi sociali sulle famiglie.
10 Da questo punto di vista, le Indagini Multiscopo dell’ISTAT hanno colmato un vuoto negli anni più recenti; tuttavia queste indagini restituiscono i dati con disaggregazione a livello territoriale. Un compito fondamentale dell’Osservatorio per le Politiche Sociali è proprio quello di offrire informazioni utili alle politiche sociali a livello almeno provinciale e, meglio ancora, per zone socio–sanitarie. Nel caso dell’esperienza livornese di OPS, la realizzazione delle indagini sulla popolazione anziana e su quella giovanile consentono di rispondere in modo significativo a tale debito informativo. Come si vedrà in seguito, in questo Rapporto sono recuperati molti degli elementi conoscitivi emersi proprio da quelle rilevazioni. La realizzazione della indagine sulla popolazione adulta il prossimo anno
Capitolo 2
Processi e soggetti della cittadinanza sociale
Le trasformazioni della famiglia
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
21
In questa parte del Rapporto Sociale si offrirà un quadro informativo articolato, in modo da cogliere le principali dinamiche di trasformazione familiare nel territorio livornese ed approfondire alcune tematiche di assoluto rilievo per la partecipazione delle famiglie alla costruzione della cittadinanza sociale.
In primo luogo converrà avvertire che la lettura dei dati circa le
trasformazioni familiari si presta ad una duplice interpretazione: da una parte, se si confronta la situazione italiana con quella europea, si potrebbe ancora affermare la sostanziale stabilità – o la “tenuta” – del modello familiare “mediterraneo”, nel quale ovviamente si inserisce anche la famiglia toscana e livornese. D’altra parte, la riduzione della nuzialità e della natalità nel nostro Paese – e in particolar modo nella nostra provincia –, dimostrerebbero pure una evidente disaffezione verso la formalizzazione dei legami familiari e verso i tradizionali comportamenti riproduttivi11.
D’altra parte, dall’analisi dei dati si nota agevolmente il declino graduale della nuzialità anche nel territorio livornese; attraverso la tabella relativa all’andamento del tasso di nuzialità dal 1992 al 1998, si osserva come la riduzione sia evidente, ma non così particolarmente consistente (diversa è la situazione della provincia di Lucca o di Massa–Carrara, dove il decremento è più intenso); inoltre, il valore livornese non si discosta mai eccessivamente da quello toscano e quello nazionale che, ad esempio, nel 1995 era pari a 4,9. Tuttavia, se si considera che negli anni ’70 il tasso di nuzialità oscillava attorno al 7‰ non si può non segnalare come un dato strutturale la graduale disaffezione verso l’istituto matrimoniale.
Disaffezione che è segnalata anche dall’aumento del numero dei procedimenti di separazione civile e dei divorzi nella nostra provincia; in particolare, l’indice di separazione quasi raddoppia tra il 1992 e il 1996, portando l’indice di instabilità matrimoniale dal 15,7 al 22,2. Vale la pena sottolineare, peraltro, che nel confronto con le altre province emerge che il tasso di nuzialità a Livorno è uno dei più bassi in Toscana (è preceduta solo da Grosseto e Massa–Carrara), mentre l’indice di instabilità familiare è il più alto in assoluto.
consentirà di completare il sistema di rilevazioni e di realizzare un’integrazione conoscitiva di assoluto rilievo.
11 Ci sia consentito rinviare, per un approfondimento, a A. Salvini, Famiglie e fonti statistiche ufficiali. Elementi di sintesi, in M.A.Toscano (a cura di), Ambigui lari. Viaggio nelle penombre della famiglia , Jaca Book, Milano, 1999.
La graduale disaffezione verso l’istituto matrimoniale
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
22
Tabella 11. Evoluzione del tasso di nuzialità* nelle Province toscane dal 1993 al 1998
Provincia 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Arezzo 4,53 4,57 4,61 4,67 4,50 4,49 4,64
Firenze 4,79 5,98 5,58 4,80 4,74 4,71 5,01
Grosseto 4,62 4,49 4,42 4,47 4,22 4,05 3,75
Livorno 4,63 4,77 4,24 4,14 4,19 3,98 4,34
Lucca 5,28 5,11 4,68 4,99 4,69 4,65 4,41
Massa-Carrara 5,03 4,84 4,60 4,41 4,26 4,23 4,25
Pisa 4,81 4,71 4,53 4,59 4,67 4,42 4,62
Pistoia 5,03 4,70 4,81 4,78 4,90 4,77 5,10
Prato 4,53 4,43 4,45 4,34
Siena 4,96 4,77 4,71 4,88 4,49 4,45 4,58
Totale 4,84 4,80 4,56 4,67 4,57 4,49 4,62
Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno
*Tasso di nuzialità = (matrimoni totali)/(pop. Residente)*1000
Tabella 12. Evoluzione dell'indice di instabilità familiare* dal 1992 al 1996 nelle province toscane
Provincia 1992 1993 1994 1995 1996
Arezzo 9,5 12,0 13,5 13,4 14,9
Firenze 17,4 20,9 23,6 24,1 19,9
Grosseto 10,5 6,0 8,5 15,3 19,1
Livorno 15,7 19,8 21,5 12,1 22,2
Lucca 21,1 8,3 11,8 6,6 20,3
Massa-Carrara 12,8 14,0 10,2 14,8 17,2
Pisa 15,2 7,7 18,7 11,5 19,3
Pistoia 15,4 14,7 20,5 16,9 21,8
Prato - - - - 18,2
Siena 11,7 14,2 13,0 11,9 15,2
Totale 15,5 13,7 16,5 14,8 19,2
Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno
* Indice di instabilità familiare = (separazioni+divorzi)/Popolazione totale*10.000
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
23
Tabella 13. Andamento dell'indice di separazione e dell'indice di divorzialità nelle province toscane - Anni 1992-1996
Indice di separazione Indice di divorzialità
Provincia 1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996
Arezzo 7,49 8,51 9,39 8,71 9,03 2,0 3,5 4,1 4,6 5,9
Firenze 10,52 13,89 14,53 13,04 13,18 6,9 7,0 9,1 11,1 6,7
Grosseto 7,67 2,85 4,96 9,97 11,46 2,8 3,1 3,6 5,3 7,7
Livorno 8,54 13,48 14,02 12,09 15,04 7,2 6,3 7,5 - 7,2
Lucca 13,21 4,75 11,01 4,29 12,11 7,9 3,6 0,8 2,3 8,2
Massa-Carrara 8,70 8,94 6,93 9,14 11,50 4,1 5,0 3,2 5,6 5,7
Pisa 10,67 2,91 12,26 7,02 12,55 4,5 4,8 6,4 4,5 6,8
Pistoia 9,84 9,94 12,20 11,05 13,90 5,6 4,8 8,3 5,9 7,9
Prato - - - - 11,13 - - - - 7,1
Siena 7,85 8,54 7,52 7,96 10,49 3,9 5,7 5,5 3,9 4,7
Totale 9,84 8,69 10,79 9,23 12,33 5,6 5,0 5,8 5,5 6,8 Fonte: Base informativa statistica OPS – Provincia di Livorno
Parallelamente a questo fenomeno, si verifica nella provincia livornese un processo anch’esso ormai noto e consolidato come quello della nuclearizzazione della famiglia. Da un punto di vista strettamente demografico, la nuclearizzazione si manifesta nella contrazione della dimensione della famiglia (riduzione del numero medio dei componenti delle famiglie); questa contrazione è dovuta, sostanzialmente, ad alcuni processi concomitanti come:
§ la riduzione della natalità, che ha condotto alla diminuzione della presenza dei figli nella famiglia; ciò significa che la configurazione tipica della famiglia secondo il modello “mediterraneo” prevede la prevalenza di famiglie composte da marito – moglie – un figlio12;
§ il graduale aumento delle famiglie monogenitoriali, dovuto alla morte precoce di uno dei genitori ma soprattutto al processo di disgregazione familiare con le separazioni (di fatto e legali) e i divorzi;
12 Per avere un quadro dettagliato della composizione familiare secondo il numero di
figli presenti a livello comunale, si dovrà attendere la diffusione dei dati di Censimento del 2001, poiché la ricostruzione di questa informazione attraverso le anagrafi comunali non è agevole. L’ISTAT, nella situazione attuale, offre questo dato disaggregato al livello regionale, poiché viene elaborato attraverso le Indagini Multiscopo sulle famiglie, cioè rilevazioni campionarie. L’OPS della Provincia di Livorno avrà disponibile questo dato dopo l’effettuazione della indagine sulle famiglie e gli adulti del prossimo anno.
La nuclearizzazione delle famiglie
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
24
Tabella 14. Famiglie per tipologia in alcune regioni d'Italia e in Toscana - Anno 1998 – Dati in migliaia
Regioni Coppie con figli
Coppie senza figli
Monogenitore maschio
Monogenitore femmina
Totale
Lombardia 1600 764 52 241 2657 Veneto 805 352 21 117 1295 Emilia Romagna 666 402 17 111 1196 Lazio 873 456 26 143 1498 Campania 1052 289 31 144 1516 Sicilia 943 328 23 124 1417 Toscana 603 348 9 86 1046
Italia 10080 4608 284 1503 16475
Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo su “Famiglie e soggetti sociali” – Anno 1998
Tabella 15. Famiglie per tipologia in alcune regioni d'Italia e in Toscana - Anno 1998 - Composizione percentuale – per 100 nuclei familiari della stessa zona
Regioni Coppie con figli
Coppie senza figli
Monogenitore maschio
Monogenitore femmina Totale
Lombardia 60,2 28,8 2 9,1 100 Veneto 62,1 27,2 1,6 9 100 Emilia Romagna 55,7 33,6 1,5 9,3 100 Lazio 58,3 30,4 1,8 9,6 100 Campania 69,4 19 2,1 9,5 100 Sicilia 66,5 23,2 1,6 8,7 100 Toscana 57,6 33,3 0,9 8,2 100
Italia 61,2 28 1,7 9,1 100
Tabella 16. Nuclei monogenitore per sesso in alcune regioni e in Toscana, di 65 anni e più - Anno 1998 - Dati in migliaia
Maschi Femmine M + F di cui vedovi
Lombardia 52 241 293 201
Veneto 21 117 138 91
Emilia-Romagna 17 111 128 72
Lazio 26 143 170 90
Campania 31 144 175 125
Sicilia 23 124 146 95
Toscana 9 86 95 47
Italia 284 1.503 1.787 1.120
Fonte: ISTAT Indagine Multiscopo sulle Famiglie 1998
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
25
Tabella 17. Nuclei monogenitore in alcune regioni e in Toscana per sesso - di 65 anni e più - per 100 nuclei monogenitore della stessa regione
Maschi Femmine M + F di cui vedovi
Lombardia 17,7 82,3 100 68,7
Veneto 15,4 84,6 100 65,6
Emilia-Romagna 13,6 86,4 100 56,1
Lazio 15,6 84,4 100 52,8
Campania 17,8 82,2 100 71,2
Sicilia 15,5 84,5 100 64,7
Toscana 9,8 90,2 100 49,5
Italia 15,9 84,1 100 62,7
Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo sulle Famiglie – Anno 1998
§ il deciso aumento delle famiglie unipersonali; queste famiglie, che sono più generalmente conosciute sotto la dizione di famiglie di singles, in realtà sono costituite, per la maggior parte, da nuclei familiari composte da persone anziane rimaste sole – soprattutto donne;
Tabella 18. Persone sole per sesso, di 65 anni e più in alcune regioni e in Toscana - Dati in migliaia
Maschi Femmine M + F più di 65
Lombardia 259 504 763 425
Veneto 111 244 354 205
Emilia-Romagna 128 227 355 202
Lazio 194 334 528 257
Campania 109 239 348 226
Sicilia 103 218 322 199
Toscana 105 192 298 176
Italia 1.566 3.028 4.594 2.576
Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo sulle Famiglie, Anno 1998
Tabella 19. Persone sole per sesso, di 65 anni e più in alcune regioni e in Toscana - per 100 persone sole della stessa regione
Maschi Femmine M + F più di 65
Lombardia 33,9 66,1 100 55,7
Veneto 31,3 68,7 100 57,9
Emilia-Romagna 35,9 64,1 100 56,8
Lazio 36,7 63,3 100 48,7
Campania 31,2 68,8 100 64,9
Sicilia 32,1 67,9 100 61,8
Toscana 35,4 64,6 100 59
Italia 34,1 65,9 100 56,1Fonte: ISTAT. Indagine Muliscopo sulle Famiglie, Anno 1998
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
26
§ l’affacciarsi di strutture familiari fondate sulla coppia, non soltanto con riferimento ai cosiddetti “nidi vuoti” (le famiglie in cui i figli sono “usciti” per formarsi una propria famiglia autonoma), ma anche con riferimento ai modelli più recenti di coppie giovani che rinviano la scelta relativa alla nascita dei figli13.
Tabella 20. Coppie con donne in età compresa tra 15 e 34 anni per condizione dei
partner e alcune regioni - Anno 1998 - Dati in migliaia
Regione Lavorano entrambi
Lui lavora, lei casalinga
Altra condizione Totale
Lombardia 319 112 35 466
Veneto 180 48 18 247
Emilia-Romagna 136 37 16 188
Lazio 109 123 39 272
Campania 52 191 83 326
Sicilia 65 147 84 296
Toscana 95 37 24 156
Italia 1.408 1.090 465 2.963
Fonte: ISTAT Tabella 21. Coppie con donne in età compresa tra 15 e 34 anni per condizione dei
partner e alcune regioni - per 100 coppie della stessa zona
Regione Lavorano
entrambi Lui lavora,
lei casalinga Altra
condizione Totale
Lombardia 68,4 24,2 7,5 100
Veneto 73 19,7 7,4 100
Emilia-Romagna 72 19,6 8,5 100
Lazio 40,2 45,3 14,5 100
Campania 16 58,5 25,5 100
Sicilia 21,9 49,7 28,4 100
Toscana 60,6 24 15,4 100
Italia 47,5 36,8 15,7 100
Fonte: ISTAT Quelli sopra descritti sono fenomeni di particolare importanza per la
comprensione dei cambiamenti strutturali che coinvolgono la famiglia livornese e quella italiana; questi processi sono strettamente collegati al cambiamento degli stili di vita, delle opzioni culturali e delle dinamiche socio–economiche che attraversano la popolazione e le comunità territoriali.
13 Nei paesi anglosassoni questo modello familiare è conosciuto, in termini divulgativi,
con l’acronimo DINKS, cioè “Double Income No Kids”, poiché si tratta di famiglie senza figli in cui entrambi i membri della coppia lavorano.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
27
Tabella 22. Evoluzione del numero di famiglie residenti per Comune e zona socio-sanitaria - Anni 1993-2001
Comune 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001
Livorno 60.410 59.856 63.125 63.375 63.603 63.855 65.049
Collesalvetti 5.434 5.536 5.645 5.738 5.738 5.829 6.000
Capraia Isola 154 151 126 150 176 193 193
Zona livornese 65.998 65.543 68.896 69.263 69.517 69.877 71.242
Rosignano Marittimo 12.528 12.588 12.653 12.787 12.918 13.126 13.641
Cecina 9.158 9.934 10.025 10.141 10.314 10.504 10.950
Castagneto Carducci 3.147 3.120 3.101 3.121 3.147 3.160 3.525
Bibbona 1.115 1.127 1.138 1.161 1.184 1.197 1.198
Zona Val di Cecina 25.948 26.769 26.917 27.210 27.563 27.987 29.314
Piombino 14.486 14.516 14.553 14.592 14.610 14.686 14.805
Campiglia Marittima 4.585 4.634 4.679 4.744 4.783 4.808 4.973
San Vincenzo 2.801 2.775 2.789 2.800 2.789 2.801 2.889
Suvereto 1.147 1.159 1.160 1.162 1.179 1.196 1.344
Sassetta 277 288 296 302 295 284 –
Zona Val di Cornia 23.296 23.372 23.477 23.600 23.656 23.775 24.011
Campo nell'Elba 1.568 1.658 1.714 1.778 1.816 1.872 1.999
Capoliveri 812 1.315 1.230 1.327 1.361 1.386 –
Marciana 994 1.001 991 1.001 994 996 –
Marciana Marina 652 835 841 843 840 845 850
Porto Azzurro 1.053 1.088 1.108 1.149 1.156 1.184 1.337
Portoferraio 3.880 4.616 4.674 4.683 4.773 4.761 5.089
Rio Marina 1.066 1.067 1.047 1.048 1.143 1.121 1.094
Rio nell'Elba 407 423 440 445 448 457 501
Zona Elbana 10.432 12.003 12.045 12.274 12.531 12.622 10.870
Fonte: Base informativa statistica – OPS Provincia di Livorno – Aggiornamento al 2001
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
28
Tabella 23. Dimensione media delle famiglie per comune - Anni 1993-2001
1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001
Comune
2,74 2,77 2,61 2,59 2,56 2,54 2,45
Livorno 2,86 2,84 2,82 2,80 2,80 2,76 2,67
Collesalvetti 1,94 1,91 2,51 2,27 2,00 1,84 1,76
Capraia Isola 2,75 2,77 2,62 2,60 2,58 2,56 2,47
Zona livornese
2,44 2,42 2,41 2,38 2,35 2,32 2,22
Rosignano Marittimo 2,74 2,57 2,56 2,55 2,53 2,50 2,40
Cecina 2,65 2,66 2,66 2,66 2,64 2,62 2,34
Castagneto Carducci 2,53 2,52 2,53 2,51 2,48 2,48 2,53
Bibbona 2,58 2,52 2,50 2,48 2,46 2,43 2,32
Zona Val di Cecina
2,50 2,48 2,45 2,42 2,40 2,38 2,30
Piombino 2,75 2,72 2,69 2,66 2,64 2,61 2,51
Campiglia Marittima 2,58 2,56 2,53 2,52 2,49 2,47 2,34
San Vincenzo 2,62 2,57 2,58 2,54 2,51 2,46 2,63
Suvereto 2,13 2,10 2,07 2,14 2,22 2,29 –
Sassetta 2,55 2,53 2,51 2,48 2,46 2,43 2,36
Zona Val di Cornia
2,75 2,62 2,57 2,48 2,44 2,31 2,17
Campo nell'Elba 3,00 1,88 2,28 2,19 2,18 2,17 –
Capoliveri 2,29 2,30 2,32 2,29 2,29 2,28 –
Marciana 3,00 2,34 2,33 2,30 2,29 2,27 2,20
Marciana Marina 3,00 2,99 2,91 2,89 2,86 2,84 1,97
Porto Azzurro 3,00 2,55 2,55 2,54 2,52 2,52 2,32
Portoferraio 2,19 2,18 2,20 2,18 2,00 2,03 2,04
Rio Marina 2,22 2,09 2,09 2,12 2,07 2,04 1,98
Rio nell'Elba 2,78 2,44 2,47 2,44 2,41 2,38 2,20
Zona Elbana Fonte: Base informativa statistica – OPS Provincia di Livorno
Tabella 24. Variazione percentuale della dimensione media delle famiglie per zona socio-sanitaria - Anni 1993-2001
Comune 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001 Var. %
Zona livornese 2,75 2,77 2,62 2,60 2,58 2,56 2,47 - 10,11
Zona Val di Cecina 2,58 2,52 2,50 2,48 2,46 2,43 2,32 - 10,11
Zona Val di Cornia 2,55 2,53 2,51 2,48 2,46 2,43 2,36 - 7,56
Zona Elbana 2,78 2,44 2,47 2,44 2,41 2,38 2,20 –14,3 Fonte: Base informativa statistica – OPS Provincia di Livorno
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
29
In particolare si dovrà accennare, rinviando ai prossimi capitoli per gli opportuni approfondimenti, ad alcuni processi assai rilevanti anche dal punto di vista della strutturazione dei bisogni sociali e dei modi di dar loro risposta; sul versante dei processi strutturali a monte dei fenomeni di nuclearizzazione si dovranno considerare, tra gli altri:
§ il progressivo aumento dei livelli di scolarizzazione e dei titoli di studio, che ha generato aspettative crescenti circa le forme di realizzazione soggettiva nell’ambito professionale;
§ l’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, in corrispondenza all’importanza assunta dal settore terziario nell’economia provinciale (e non solo provinciale);
§ il cambiamento culturale in atto in ordine al progetto familiare, per il quale la domanda di realizzazione soggettiva degli attori sociali deve necessariamente coniugarsi con le possibilità oggettive di risposta a quella stessa domanda (ad esempio: sostenibilità dei tempi e delle esigenze familiari con il lavoro; la presenza di risorse territoriali e familiari rispetto alla cura e al sostegno dei bambini e degli anziani).
Sul versante dei processi a valle dei processi di nuclearizzazione, si dovrà quanto meno far riferimento a:
§ i cambiamenti nei percorsi di socializzazione primaria e secondaria, caratterizzati dalla crescente richiesta di servizi per l’infanzia, dalla necessità di far ricorso a soggetti e strutture multiple per la cura e la gestione del tempo libero dei bambini e degli adolescenti (reti parentali, servizi scolastici, sostegni privati); a ciò si dovrà aggiungere un cambiamento nella sostanza dei contenuti della socializzazione, che sono rivolti sempre più a bambini che crescono senza fratelli e senza sorelle in una realtà sempre più connotata dalla presenza di adulti ed anziani14;
§ i cambiamenti nelle modalità di supporto alle famiglie, sia in termini di politiche di conciliazione dei tempi, sia in termini di costruzione di reti di sostegno più solide e consistenti. Le considerazioni svolte poco sopra sulle strutture familiari e sulle relative dinamiche socio–economiche consentono di comprendere anche l’incremento delle cosiddette “famiglie a doppia carriera”, cioè quelle famiglie in cui nella figura femminile adulta si concentra il maggior carico nel senso della cura dei membri familiari (giovani e anziani) in aggiunta al carico di lavoro di tipo professionale;
§ l’aumento di criticità della situazione delle donne anziane sole.
14 Gli effetti qualitativi del cambiamento nel rapporto quantitativo tra bambini e adulti
sono stati interpretati da alcuni come un’accentuazione del “peso psicosociale” della pressione socializzante. Per gli opportuni approfondimenti si rinvia a M. Orsi, Educare alla responsabilità nella globalizzazione. Società della conoscenza e sfide per la scuola, EMI, Bologna, 2002.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
30
Purtroppo, l’assenza di dati a livello comunale non ci consente di ricostruire il quadro complessivo delle famiglie cosiddette “atipiche”15, che sono costituite, oltre che dalle famiglie unipersonali, dalle unioni di fatto e dalle famiglie ricostituite.
Nel corso degli ultimi dieci anni, il numero delle famiglie, in valore
assoluto, nella provincia di Livorno è passato da 122.604 a 135.437, con una variazione percentuale pari al 10,5%; dal 1991 al 2001, le famiglie composte da un componente sono aumentate del 62% quelle con due componenti del 13.5%, quelle con tre del 2,25%; le famiglie con quattro componenti sono invece diminuite del 16% e quelle con cinque e più componenti del 35,5%. Queste variazioni si riflettono, ovviamente, nei valori relativi alle dimensioni medie delle famiglie; infatti, la nuclearizzazione della famiglia, come si è detto, va di pari passo alla sua frammentazione: il numero delle famiglie cresce dovunque, in provincia, ma diminuisce il valore medio del numero di componenti.
La maggior contrazione delle dimensioni familiari si verifica nella zona Elbana dove da un valore medio del 2,78 nel 1991 si passa al 2,2016 nel 2001 (–14,3%, con i valori relativi al 1998). Nelle altre aree, la riduzione è relativamente inferiore (la differenza percentuale ruota attorno al –10% per la zona livornese e quella della Bassa Val di Cecina, mentre si attesta vicino al –8% nell’area della Val di Cornia). Livorno, Cecina, Castagneto e San Vincenzo sono le realtà cittadine dove più consistente è il fenomeno della nuclearizzazione, mentre assai più consistenti sono i valori che si riscontrano in alcune aree elbane.
Uno dei fenomeni più caratteristici delle recenti trasformazioni familiari
anche nella Provincia di Livorno è costituito dalla cosiddetta “famiglia lunga”, cioè la famiglia nella quale la permanenza dei giovani si prolunga sino ad età in cui si è considerati anagraficamente ormai “adulti”. La questione ha risvolti importanti sul piano delle politiche sociali, poiché molti osservatori hanno spiegato il fenomeno sottolineando l’influenza delle rigidità socio–economiche che impediscono l’effettivo svolgersi del percorso di inserimento dei giovani nella realtà sociale; la posticipazione degli eventi socio–demografici più significativi (formazione di una propria famiglia autonoma, procreazione, ecc…) sembrano dovute nel nostro Paese soprattutto alla progressiva diffusione di un modello formativo prolungato nel tempo a garanzia di maggiori opportunità di inserimento sociale e lavorativo. Sono note, d’altra parte, le rigidità del mercato del lavoro ed anche del mercato delle abitazioni, che ostacolano, nel nostro Paese, i processi di emancipazione dei giovani dalle famiglie di origine.
15 Il termine viene utilizzato, ovviamente, non in senso valutativo, ma secondo le
definizioni in uso nell’ambito della statistica ufficiale. 16 Il valore è calcolato in assenza, per il 2001, dei dati relativo a Campo nell’Elba e a
Marciana. È assente anche il valore relativo a Sassetta.
Le famiglie nelle zone socio–sanitarie
L’adolescenza prolungata ed i progetti familiari in Provincia di Livorno
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
31
Altri autori hanno infine avanzato l’ipotesi che si possa prefigurare – a prescindere dalle cause di natura strutturale – l’affermazione graduale di un nuovo modello di coabitazione intergenerazionale, come se le relazioni familiari, soprattutto quelle di tipo affettivo oltre che di tipo economico, si stessero riconfigurando al fine di fronteggiare con successo i cambiamenti nell’ambito extrafamiliare17.
Tabella 25. Coppie con figli per numero di figli ed alcune regioni - Anno 1998 - Dati in migliaia
1 2 3 + Totale
Lombardia 829 653 118 1.600
Veneto 424 306 75 805
Emilia-Romagna 404 231 30 666
Lazio 366 423 84 873
Campania 316 486 251 1.052
Sicilia 336 429 178 943
Toscana 341 232 30 603
Italia 4.555 4.306 1.219 10.080Fonte: ISTAT. IMF 1998
Tabella 26. Coppie con figli per numero di figli ed alcune regioni - Anno 1998 - per 100 coppie con figli della stessa regione
1 2 3 + Totale
Lombardia 51,8 40,8 7,4 100
Veneto 52,7 38 9,3 100
Emilia-Romagna 60,7 34,8 4,6 100
Campania 30 46,1 23,8 100
Sicilia 35,7 45,5 18,8 100
Toscana 56,5 38,5 4,9 100
Italia 45,2 42,7 12,1 100
17 Per una analisi sintetica della problematica, ci sia consentito rinviare a Salvini, op. cit.,
pp. 64–70.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
32
Tabella 27. Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per sesso ed alcune regioni - Anno 1998 - Dati in migliaia
Maschi Femmine Maschi e femmine Regioni 18–24 25–34 Totale 18–24 25–34 Totale 18–24 25–34 Totale
Lombardia 388 402 789 358 229 588 746 631 1377
Veneto 175 206 381 182 99 280 357 304 662
Emilia Romagna 142 154 296 129 84 213 271 239 509
Lazio 225 198 423 200 125 325 425 323 748
Campania 304 217 521 254 116 370 558 333 891
Sicilia 237 156 393 208 90 297 444 246 690
Toscana 133 139 272 116 87 203 249 226 475
Italia 2460 2254 4714 2229 1312 3541 4688 3566 8254
Tabella 28. Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore
per sesso ed alcune regioni - per 100 giovani dello stesso sesso, classe di età e regione - Anno 1998
Maschi Femmine Maschi e femmine Regioni 18–24 25–34 Totale 18–24 25–34 Totale 18–24 25–34 Totale
Lombardia 97,5 52,6 68 90,9 32,5 53,4 94,2 42,9 60,9
Veneto 93,5 56,4 69 89,5 27,5 50 91,4 42,1 59,4
Emilia Romagna 93 48,9 63,3 85,6 30,6 50 89,3 40,3 56,9
Lazio 98,6 50 67,8 88,4 29,6 50,1 93,5 39,5 58,8
Campania 97,4 50,7 70,4 84 26,8 50,3 90,8 38,7 60,4
Sicilia 93,2 42,8 63,5 86,6 23,7 48,1 90 33,1 55,8
Toscana 93,4 51,7 66,2 87,4 34,3 52,5 90,5 43,3 59,6
Italia 95,3 50,7 67 87,5 30 51,1 91,4 40,4 59,1
Per ciò che concerne le dimensioni e le cause del fenomeno nella
Provincia di Livorno, l’indagine sulla realtà giovanile compiuta nell’ambito dell’OPS consente di acquisire dati e informazioni di estrema rilevanza.
Dai dati dell’indagine, si può intanto osservare che quasi tutti i giovani d’età fino a 18 anni abita con i genitore o in un nucleo monogenitoriale (rispettivamente il 90,4% e il 9,2% dei rispondenti al di sotto dei 18 anni); il restante abita con altri parenti. Nella fascia d’età superiore – da 18 a 24 anni, troviamo una situazione leggermente diversa: l’80% circa vive con entrambi i genitori e il 9,4% con un solo genitore; il 4,3% con il coniuge o con il partner (questi ultimi incidono per l’1,9%).
Anche nella fascia d’età superiore, tra quelle considerate nell’indagine, ben il 90% circa degli intervistati vive ancora in famiglia. Quali sono, dunque, i motivi dichiarati per i quali i giovani maggiorenni permangono nel proprio nucleo familiare?
Il 33% circa motiva tale permanenza per il fatto di trovarsi ancora nella posizione di studente, mentre il 29% dichiara di “essere troppo giovane” per
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
33
poter pensare ad una collocazione diversa. Ancora, il 20% circa degli intervistati maggiorenni afferma di “trovarsi bene così”, perché comunque, si conserva “la propria libertà”. Solo il 12,2% afferma di vivere nel proprio nucleo familiare per il fatto di non trovare un lavoro stabile e di non potersi mantenere autonomamente. Infine, vale la pena segnalare il fatto che il 5% dei rispondenti afferma che “la famiglia ha bisogno di me”.
Sembrerebbe emergere, dunque, una prospettiva per la quale la permanenza in famiglia è motivata soprattutto dall’assenza delle condizioni di fondo che consentono l’emancipazione, condizioni che si esprimono in forma diretta (sto ancora studiando) e indiretta (sono ancora giovane) – come se la propria condizione dell’essere giovane costituisse, per definizione, un ostacolo alla capacità di agire la propria autonomia familiare. Ciò, ovviamente, non implica che tale condizione venga vissuta come un limite, ma semplicemente rientra, per così dire, nelle prerogative della propria condizione di giovane. La famiglia è dunque un luogo di sostegno, di supporto al percorso di “preparazione” che conduce all’acquisizione di livelli ulteriori di autonomizzazione – che comunque, come si è visto, possono anche essere ritagliati nelle condizioni attuali.
Le motivazioni che denotano un maggior grado di costrittività (“non potrei mantenermi autonomamente), coinvolgono solo una parte circoscritta degli intervistati (12% circa); di conseguenza, almeno in questa fascia d’età, il permanere in famiglia non sembra costituire un fattore problematico per la maggior parte dei giovani.
Si deve peraltro notare come il dato assuma un significato diverso se visto alla luce delle differenze tra maschi e femmine; se, infatti, le risposte date dai due gruppi si avvicinano nel caso dell’essere “troppo giovani per lasciare la casa dei genitori”, esse differiscono in relazione al “trovarsi bene” in famiglia e all’essere studenti. In questa seconda condizione troviamo un maggior numero di femmine rispetto ai maschi; del resto, le ragazze segnalano in minor misura rispetto ai maschi il fatto di star bene e di riuscire a ritagliarsi propri spazi di libertà.
A livello di zone socio–sanitarie, le percentuali più alte di risposta alla motivazione di tipo “costrittivo” si riscontrano nella zona livornese e in quella della Val di Cecina (14% e 13,6%), ma questi valori non sembrano costituire scostamenti significativi. In Val di Cornia e Val di Cecina acquistano particolare rilevanza rispetto alle altre zone i riferimenti all’essere studente, poiché questa motivazione è stata avanzata rispettivamente dal 49% e dal 41% dei rispondenti.
In linea con l’idea che a quest’età il permanere in famiglia debba considerarsi, per così dire, “nell’ordine delle cose”, si collocano i risultati sul progetto familiare; è stato chiesto, infatti, se nei propri progetti c’è quello di formarsi una propria famiglia. Solo il 13,6% ha risposto di “non saperlo”, e l’1,1% ha risposto, in modo deciso, “no”.
Gli altri giovani maggiorenni ha risposto positivamente, ma indicando prospettive differenziate: il 7,4% ha di fronte a sé questa prospettiva “fra non molto tempo”. Il 43,9% dichiara che, pur avendo in progetto la
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
34
formazione di una propria famiglia, considera ancora “troppo presto” il pensarci seriamente. Il 16,3% attende di poter costruire le condizioni necessarie (il lavoro e la casa), mentre il 14,2% attende di realizzare la condizione indispensabile per il progetto stesso, cioè “trovare la persona giusta”.
In linea generale si può affermare che la famiglia è presente nelle prospettive progettuali dei giovani intervistati, ma che per via della loro età (e dei caratteri sociali che tale età implica), la sua effettiva realizzazione è rinviata ad altro momento. Si comprende come la costruzione effettiva delle condizioni per l’autonomizzazione dalla famiglia d’origine – a meno che non si verifichi una modificazione nelle prospettive progettuali – si collochino in una fascia d’età che oltrepassa ampiamente quelle considerate nell’indagine (14–24).
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
35
L’analisi della relazionalità sociale degli anziani e dei processi di scambio che li vedono inseriti all’interno di reti sociali e familiari più o meno ampie, riveste un notevole interesse conoscitivo, poiché rende conto della capacità di queste reti di porsi come risorsa effettiva per facilitare l’integrazione sociale o, quanto meno, ridurre gli ostacoli che impediscono una piena cittadinanza degli attori sociali più fragili nel territorio. L’indagine sulla presenza sociale degli anziani condotta nell’ambito delle attività dell’OPS in Provincia di Livorno, consente di offrire qualche utile indicazione su questi temi che, data la loro importanza, viene di seguito fornita e discussa18.
Si deve peraltro ricordare che per “anziani” si è inteso quel segmento di popolazione da 60 anni in poi, non tanto per “ampliare” artificiosamente quella condizione anagrafica, quanto per meglio verificare l’esistenza di diversità/uniformità sociali relativamente indipendenti dall’evento del pensionamento (normalmente collocato al 65° anno di età).
La fonte principale di sostegno (nel caso di presenza di problemi di salute) per gli anziani intervistati è costituita, ovviamente, dal coniuge (dalla coniuge) per il 65,4% degli intervistati, mentre ad altre figure parentali femminili (figlia/nuora, sorella/cognata, nipote), fa riferimento il 21% degli intervistati; le figure parentali maschili sono presenti solo per il 7% di essi. Poco più del 5% non saprebbe a chi potersi rivolgere. Se si amplia l’orizzonte delle reti di sostegno, si deve osservare che solo il 44% potrebbe far riferimento a familiari non conviventi, e il 15% alle reti informali di tipo amicale e di vicinato. Il ricorso ai servizi pubblici o privati pare possibile solo per il 9% circa, mentre il volontariato è indicato come fonte possibile di sostegno solo per l’1,7%. Non saprebbe a chi rivolgersi ben il 27% degli intervistati.
Come si può notare, la risorsa–famiglia costituisce nel contempo una risorsa e un carattere di fragilità nelle condizioni di vita degli anziani; da una parte, infatti, là dove sono presenti reti familiari sufficientemente strutturate (presenza del coniuge, vicinanza dei figli, ecc…), esse si costituiscono come effettivi canali di supporto, specie nel caso di problemi di salute; dall’altra, in caso di assenza di tali reti, il ricorso a flussi informali di più ampio raggio sembra incontrare maggiori difficoltà. D’altra parte, appare insostituibile il ruolo giocato dalla coniuge nel caso degli anziani maschi e, in generale, dalle figure parentali femminili (figlia/nuora/nipote)19.
Il carattere di fragilità si evidenzia nel momento in cui, dunque, vengano a mancare le condizioni di base della presenza di familiari conviventi (o vicini); poco più di un quarto degli anziani intervistati dichiarano di aver difficoltà a individuare una fonte di supporto e pochi fra essi indicano i servizi pubblici e privati come soggetti di riferimento.
18 Per gli opportuni approfondimenti si rinvia a F. Ruggeri, A. Salvini (a cura di),
Anziani a Livorno. Report 2001, OPS, Livorno, 2001, specie il capitolo curato da M.G. Ricci “Reti e relazioni familiari”.
19 Ciò a conferma di quanto detto in precedenza circa le famiglie a doppia carriera e, comunque, della divisione di genere del lavoro di cura familiare.
Famiglia e reti di sostegno familiari: la situazione degli anziani e dei giovani in Provincia di Livorno
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
36
Questo dato può esser determinato da molti fattori, che hanno a che fare con eventuali rigidità soggettive e caratteriali, con le condizioni di isolamento territoriale e sociale in cui versano alcuni segmenti di popolazione anziana, con le carenze informative circa i servizi presenti sul territorio. Sembra utile, tuttavia, sottolineare quanto importante sia la costruzione di reti di sostegno che riescano ad integrare le diverse tipologie di risorse che sono attive sul territorio al fine di realizzare un contesto di tutela e di cura che possa essere non soltanto “conosciuto” (a livello informativo) dagli anziani, ma anche effettivamente “fruito” (nel senso della “familiarità” dell’accesso a tali servizi). Questo dato trova conferma oltre che in relazione alla cura verso le condizioni di salute, anche nel caso del fronteggiamento di eventuali difficoltà economiche.
L’analisi dei dati a livello sub–provinciale, mostra un andamento leggermente diverso rispetto a quello prospettato a livello provinciale per gli anziani della zona elbana, per i quali appare più bassa la possibilità di ricorso alla rete familiare e più alta la difficoltà a individuare sostegni al di fuori della cerchia parentale. Valori significativi si riscontrano, su quest’ultimo aspetto, anche nella zona livornese; la realtà urbana, da una parte, e quella isolana, dall’altra, sono contesti che per diverse ragioni tendono ad amplificare il senso di solitud ine degli anziani e le difficoltà di ricorso a risorse familiari e sociali.
Anche la frequenza di incontro con i familiari, essendo piuttosto alta in tutte le quattro zone, può essere considerata come un indicatore di importanza del contesto familiare rispetto alle condizioni di vita degli anziani; tuttavia, solo il 55% circa degli intervistati è soddisfatto di tali relazioni; il 28% desidererebbe incontrare più spesso i propri parenti, e il 10% poter avere maggior aiuto da essi.
Non si deve peraltro dimenticare che gli stessi anziani costituiscono una fonte di supporto per la propria famiglia: ben il 52,5% degli intervistati dichiara di prestare regolarmente aiuto ai propri parenti e ben il 70% dichiara di interessarsi regolarmente della cura dei nipoti (là dove presenti). Il flusso delle relazioni di sostegno tra anziani ed i propri parenti deve essere considerato in entrambe le direzioni possibili; se da una parte questo dato conferma l’importanza della famiglia nella strutturazione anche articolata di reti di sostegno, deve far riflettere anche sulla possibile debolezza che può derivare, specie per i soggetti più deboli, nel caso in cui le condizioni di tale strutturazione vengano meno (a causa di malattie o decessi, trasferimenti o allontanamenti, modifica delle condizioni professionali, ecc…).
L’importanza della presenza degli anziani nelle proprie famiglie è confermata dal fatto che ben il 31,1% dei giovani intervistati nella ricerca livornese dell’OPS, afferma di mantenere con i propri nonni un rapporto di dialogo e confidenza e ben il 16,7% sottolinea una particolare predisposizione ad “ascoltare le cose che hanno da raccontare”. Tuttavia da quella stessa indagine emergono aspetti di maggior criticità, dovuti alla circostanza, per esempio, che sovente si riscontrano rapporti intergenerazionali discontinui, se non labili: ben 39 giovani su 100 va a
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
37
trovare i propri nonni “ogni tanto” e il 6,7% dichiara apertamente di intrattenere con loro rapporti non buoni; la stessa percentuale di intervistati, inoltre, afferma che “gli anziani non possono capire i problemi di un giovane”. Questi valori mostrano la crucialità delle relazioni integenerazionali, e manifestano la profonda ambivalenza che contraddistingue i rapporti di vicinanza – lontananza tra giovani e anziani.
All’Isola d’Elba si riscontrano valori comparativamente più elevati sugli aspetti più problematici di questa relazione, perché le tre voci che descrivono, sia pur con diversa intensità – la “lontananza” in questa zona quasi il 60% sul totale delle risposte. Nelle altre zone si riscontra complessivamente un maggior equilibrio nelle posizioni espresse.
Diverso è, invece, il ruolo assunto dai fratelli e dalle sorelle per i giovani intervistati: nel 57% dei casi questo rapporto è connotato da scambio di aiuti, consigli e anche di confidenze; solo il 3% è in aperto disaccordo con i fratelli, il 23,4% dichiara di litigare su piccole cose e il 9% afferma di “parlare poco” con loro. Interessante è il fatto che solo il 4% esce con i fratelli. L’esperienza del “crescere insieme” a fratelli e sorelle viene dunque considerata in modo positivo, soprattutto dal punto di vista del sostegno che può derivare da quella relazione, soprattutto in senso psicologico–affettivo.
Anche all’interno delle famiglie dei giovani intervistati si rintracciano aspetti rilevanti di coesione, almeno dal punto di vista del sostegno e della cura verso i propri membri: nel caso in cui uno dei familiari avesse problemi di salute, solo il 3% dei giovani dichiara che non ci sarebbe nessuno in grado di poter offrire un qualche aiuto (all’Isola d’Elba questa percentuale sale al 6%, nell’area livornese e cecinese scende attorno al 2%). Naturalmente le persone più immediatamente coinvolte all’interno del lavoro di cura sono il padre (dei rispondent i) e soprattutto la madre, indicata dal 42% dei giovani (il padre dal 28%). L’aspetto interessante è che nelle aree più urbanizzate (Livorno – Cecina) la figura femminile viene indicata con maggior rilievo rispetto a quanto non avvenga nelle altre zone.
Assai rilevante è anche il ruolo dei familiari non conviventi, che rappresentano un sostegno reale per il 54% dei rispondenti, e poi gli amici, segnalati dal 15%; peraltro, un altro 15% dichiara di non poter far affidamento su nessuno al di fuori della famiglia. La distribuzione dei valori percentuali per singole zone non mostra differenze significative.
È di rilievo strategico, dunque, che le politiche sociali a livello territoriale siano orientate a consolidare il quadro delle “responsabilità familiari” circa la tutela e la cura verso i propri membri20, favorendo, soprattutto, le condizioni di sostenibilità degli impegni derivanti (riducendo, ad esempio, la sovraesposizione femminile all’eccesso cumulativo di carichi familiari e lavorativi). Si dovrebbe, inoltre, favorire l’inserimento delle famiglie in reti di sostegno più ampie a livello di comunità territoriale, in modo da poter
20 Cfr., ad esempio, quanto previsto tra le azioni individuate per il perseguimento degli
obiettivi del Piano Integrato Sociale Regionale – come descritto nelle linee guida per il 2002–2004, Allegato B.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
38
fronteggiare con più risorse gli eventuali cambiamenti – anche improvvisi – nei legami parentali.
In particolare, l’aumento delle famiglie “a doppia carriera” impone carichi consistenti – soprattutto sulla figura femminile, come si è visto dai dati dell’indagine sui giovani – e un maggior impegno per le reti familiari e rende sempre più evidente la necessità di politiche pubbliche mirate (politiche di conciliazione dei tempi, di sostegno alla maternità, flessibilità nell’organizzazione del lavoro; offerta di servizi all’infanzia).
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
39
I processi di cittadinanza sono pensati, oggi, non soltanto come percorsi di riconoscimento di diritti da esigere (secondo la originaria impostazione di T. H. Mashall21), come rivendicazione di condizioni di uguaglianza di opportunità, ma anche come sviluppo sempre più ampio di capacità di agire. Di conseguenza, le politiche di welfare attuali vengono arricchite attraverso la promozione dell’agire autonomo e progettuale, di modo che le condizioni di benessere, di vantaggio degli individui siano costituite da un insieme coerente di disponibilità materiali e di abilità soggettive che renda effettivamente praticabile il raggiungimento degli obiettivi essenziali che essi si pongono. Di converso, le posizioni di svantaggio, oltre ad indicare una condizione di deprivazione dovuta all’accesso squilibrato e diseguale alle risorse messe a disposizione dai sistemi di welfare, segnalano anche le incapacità soggettive degli attori di poter disporre di tali opportunità “anche in presenza di una loro potenziale oggettiva disponibilità”22.
Rispetto agli obiettivi di ampliamento delle sfere della cittadinanza sociale, dunque, le politiche sociali devono tendere al raggiungimento di livelli sempre più elevati di integrazione con altre aree di intervento che consenta non soltanto di limitare e ridurre le zone di esclusione sociale e di dilatare quelle dell’inclusione, ma soprattutto di promuovere le condizioni di praticabilità della capacità di agire degli individui e di realizzare forme sempre più consistenti di coesione sociale.
Da questo punto di vista, riflettere sui processi formativi che si realizzano all’interno di una comunità territoriale significa prendere in considerazione componenti strategiche che possono sostenere in modo determinante i processi di inclusione sociale e di promozione della progettualità individuale e sociale; per questo si parla, nel caso dell’educazione e dell’istruzione, di capitale umano di un territorio.
D’altra parte, si deve osservare come all’interno dei percorsi di socializzazione si stia assistendo ad una sorta di “perdita di centralità della scuola” a causa della pluralizzazione delle offerte formative, del moltiplicarsi delle nuove forme di socializzazione – tra cui si devono annoverare senz’altro i mass–media e le opportunità offerte dalle reti telematiche 23. Da un certo punto di vista, l’avvento della società dell’informazione consente l’accesso sempre più facile ed amichevole ad un’immensa quantità di informazioni, banche dati, notizie tanto da prefigurare forme sempre più intense di auto–istruzione e di alfabetizzazione mediata attraverso le tecnologie informatiche. Tuttavia, questa indiscutibile opportunità di autonomizzazione dei percorsi di auto–
21 Cfr. T.H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale, UTET, Torino, 1976. 22 Cfr. G. Tomei, Città, cittadinanza e welfare municipale. Primo rapporto sulle
politiche sociali nel Comune di Viareggio”, Mauro Baroni Editore, Viareggio, 2001, pp. 85–86. Per un approfondimento del tema della cittadinanza si rinvia alla lettura del volume di A. Messeri, F. Ruggeri (a cura di), Quale cittadinanza? Esclusione ed inclusione nella sfera pubblica moderna, FrancoAngeli, Milano, 2000.
23 Cfr. M. Morcellini, Passaggio al futuro. La socializzazione nell’età dei mass–media, Angeli, Milano, 1992.
I processi formativi
La scuola nei processi di amplimanto della cittadinanza sociale
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
40
formazione rischia di condurre ad un consumo acritico delle informazioni e ad una incapacità di tradurle in conoscenza utile – non soltanto in senso strumentale e professionale, ma anche nel senso della costruzione di una personalità individuale e sociale che non si fondi su immagini di realtà mediata dalle tecnologie stesse. Si tratta pur sempre di una alfabetizzazione debole, non in grado di produrre forme di rielaborazione critica delle conoscenze: per questo non sembra venir meno il ruolo della scuola come agenzia fondamentale di sostegno alla socializzazione e di inclusione socio–culturale.
Per molti aspetti, dunque, l’interesse verso la ricostruzione del quadro strutturale della fruizione scolastica, nonché degli esiti della carriera scolastica stessa dei giovani costituisce un nodo conoscitivo irrinunciabile per la comprensione dei processi di inclusione ed esclusione all’interno di una comunità territoriale. In positivo perché, come si è detto, l’accesso ai processi formativi – ed il loro successo dal punto di vista soggettivo –, costituiscono ancora canali di promozione individuale e sociale, fattori di integrazione culturale ed economica, di costruzione della identità personale e della propria soggettività. In negativo, poiché i fenomeni di insuccesso scolastico (che si traducono nei fenomeni dell’interruzione e dell’abbandono, ma anche nelle inadeguatezze strutturali della scuola come istituzione e delle relazioni tra i soggetti che vi operano) costituiscono ostacoli effettivi all’esercizio effettivo della cittadinanza sociale.
La provincia di Livorno, al Censimento del 1991, presenta un tasso di
analfabetismo assai contenuto, pari all’1,1% della popolazione, leggermente al di sotto del valore medio regionale. Già dice anni fa, questo fenomeno poteva considerarsi residuale e limitato sostanzialmente ad alcuni segmenti della popolazione anziana.
Nello stesso anno, solo l’11,4% della popolazione compresa tra 15 e 42 anni non ha concluso l’obbligo scolastico, valore inferiore a quello di molte province limitrofe e della stessa media regionale, attestata al 12,4%. La scolarizzazione di base della provincia, dunque, appare significativa all’interno del panorama regionale – sebbene mostri una certa diversità tra la popolazione maschile e quella femminile, quest’ultima relativamente svantaggiata.
Lo svantaggio, tuttavia, si riduce e si traduce in un vantaggio relativo già al Censimento del 1991, considerando la fascia d’età 19–34 anni e l’indice di conseguimento del diploma della scuola superiore: ciò significa che nelle generazioni più giovani, il tasso di scolarizzazione nei livelli più elevati del percorso formativo è più alto tra le femmine piuttosto che nei maschi.
Si deve peraltro osservare che l’aumento della scolarizzazione femminile, soprattutto nei processi formativi post–secondari, costituisce una costante nell’andamento della fruizione sclastica in provincia di Livorno, fenomeno da cui derivano effetti ulteriori nella variazione della strut tura dell’offerta sul mercato del lavoro.
La fruizione scolastica in Provincia di Livorno
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
41
Da un punto di vista strutturale, si deve rilevare inoltre la consistente crescita del tasso di scolarizzazione che si è verificata nel corso degli ultimi anni.
I caratteri principali di questa evoluzione sono sostanzialmente tre: § in primo luogo, la massiccia presenza degli studenti nella scuola
dell’obbligo in rapporto alla consistenza demografica delle classi d’età corrispondenti;
§ in secondo luogo, l’elevato tasso di passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore;
§ in terzo luogo, il calo delle iscrizioni generalizzato, in corrispondenza alla diminuzione in valore assoluto della popolazione giovanile.
I dati messi a disposizione dall’Osservatorio Scolastico Provinciale,
consentono di confermare gli elevati tassi di scolarizzazione che si verificano nella nostra provincia, e che si collocano – per ciò che concerne le scuole superiori – al di sopra della media regionale. Nell’anno scolastico 1998–1999, la provincia di Livorno mostra un tasso di scolarizzazione più alto rispetto alle Province di Pisa, Prato, Firenze e simile a quello di Grosseto, Arezzo e Siena; una tale configurazione non rende possibile la ricostruzione di correlazioni significative tra andamento della scolarizzazione e livelli di occupazione/disoccupazione nella realtà giovanile toscana, ma evidenzia complessivamente una tendenza alla crescente scolarizzazione delle giovani generazioni24.
Tabella 29. Percentuale degli iscritti alla scuola media inferiore sul totale dei ragazzi dello stesso anno d'età - per zona socio-sanitaria - Anno scolastico 1998-99.
nati 1988 nati 1987 nati 1986Zona livornese 99,65% 100,60% 98,75%Zona Bassa Val di Cecina 94,60% 105,85% 105,42%Zona Val di cornia 111,08% 107,82% 106,52%Zona elbana 79,85% 87,05% 82,21%
Provincia 97,94% 101,56% 99,79%Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
Tabella 30. Percentuale di iscritti alla scuola media superiore sul totale dei ragazzi
dello stesso anno di età - per zona socio-sanitaria - Anno scolastico 1998-99
nati 1985 nati 1984 nati 1983Zona livornese 98,71% 97,24% 89,84%Zona Bassa Val di Cecina 102,59% 102,23% 101,41%Zona Val di cornia 92,18% 87,33% 79,22%Zona elbana 89,67% 91,98% 79,69%
Provincia 97,90% 96,48% 89,99%Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
24 Cfr. Pescarolo, op. cit., p. 48.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
42
Se si considera il numero degli iscritti nella scuola media inferiore per l’anno scolastico 1998–99, secondo quanto descritto dai dati dell’Osservatorio Scolastico Provinciale, il tasso di scolarizzazione è pari quasi al 100%: questo tasso esprime il rapporto tra numero di iscritti e la numerosità della popolazione residente nella classe di età corrispondente. All’interno della Provincia, solo la zona elbana mostra evidenti difformità rispetto al resto della Provincia, poiché i tassi di scolarizzazione differiscono in modo significativo dalle medie provinciali.
Uno sguardo ai tassi di scolarizzazione nella scuola media superiore in Provincia, nello stesso periodo di tempo, consente di verificare come i valori si abbassino leggermente, ma non di molto, se si eccettua ancora la zona elbana e anche la Val di Cornia. Ciò significa che il diploma di scuola media inferiore non è più considerato sufficiente per garantirsi un livello di istruzione ed un titolo sufficiente rispetto alle aspettative individuali e sociali. Tuttavia, vale la pena sottolineare che nell’area più a sud della provincia si registra una fuoriuscita dei giovani dal processo formativo alla conclusione dell’obbligo più intensa di quanto non accada nel resto della provincia.
Per ciò che concerne il terzo punto, e descritti gli elevati tassi di scolarizzazione sia nella scuola media inferiore che in quella superiore, i dati dell’Osservatorio Scolastico relativamente agli studenti delle scuole superiori, mettono in evidenza un calo di iscrizioni che, in valore assoluto, è passato da 13.669 dell’anno scolastico 1996–97 a 12.037 dell’anno scolastico 2000–01, con una variazione percentuale pari a –11,9%; per gli iscritti alle classi prime, la diminuzione nel corso di questi cinque anni è stata pari al 10%, mentre per ciò che concerne le classi quinte, la diminuzione è stata pari al 15,9%25. Questo dato anticipa alcune delle questioni che analizzeremo tra breve, cioè quelle legate all’irregolarità del percorso scolastico, irregolarità che è caratterizzata dalle ripetenze, dalle interruzioni e dall’abbandono del percorso formativo.
Tabella 31. Distribuzione degli iscritti per tipologia di scuola superiore e per zona socio-sanitaria. Valori assoluti e composizione percentuale
Zona livornese Zona Bassa Val di
Cecina Zona Val di Cornia Zona elbana Totale
indirizzo umanistico 15203 4488 2717 2005 24413
43,7 29,7 33,1 35,2 38,3
indirizzo tecnico 13237 3939 2528 2778 22482
38,0 26,1 30,8 48,8 35,2
indirizzo professionale 6354 6691 2952 915 16912
18,3 44,3 36,0 16,1 26,5
Totale 34794 15118 8197 5698 63807
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
25 Per gli opportuni approfondimenti relativi all’andamento di ogni singola scuola
superiore della provincia, si rinvia al Rapporto dell’Osservatorio Scolastico Provinciale, di prossima pubblicazione.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
43
Prima di passare, però, alla descrizione dei percorsi scolastici degli
studenti, vale la pena riportare un’informazione assai importante che deriva dalle analisi condotte dall’Osservatorio Scolastico Provinciale, relativo alle iscrizioni degli studenti – considerate complessivamente negli ultimi cinque anni, per indirizzo di studio e per zona. Come si vede dalla Tabella poco sopra, sembra sussistere una sorta di suddivisione della scelta di indirizzo formativo a seconda dell’area territoriale considerata: nella zona livornese, infatti, è stata prevalente la scelta dell’indirizzo umanistico–scientifico, nella Bassa Val di Cecina si è avuta la prevalenza dell’indirizzo professionale; nella zona elbana, invece è stata data preferenza soprattutto all’indirizzo tecnico, mentre nella Val di Cornia si verifica un maggiore equilibrio delle scelte – con un leggero vantaggio per l’indirizzo professionale.
Risulta ovvio, dunque, come la configurazione socio–economica del territorio giochi ancora un ruolo determinante, sebbene non esclusivo, nella scelta dei percorsi di studio, che dovrebbero in ipotesi facilitare i percorsi di inserimento professionale in quello stesso contesto.
Sulla regolarità dei percorsi scolastici si concentra, ormai da tempo,
l’attenzione degli operatori con lo scopo di verificare le ragioni dell’insuccesso scolastico e di individuare qualche rimedio ai possibili effetti negativi sul piano dei costi individuali e sociali. Generalmente l’irregolarità del percorso scolastico viene analizzata mediante semplici indicatori come il numero delle ripetenze o attraverso la stima degli abbandoni o delle interruzioni. Deve esser chiaro che queste due ultime tipologie concettuali rinviano ad eventi tra loro strutturalmente diversi; tuttavia, spesso, i dati disponibili non consentono di distinguere con precisione se si stanno descrivendo veri e propri abbandoni del sistema formativo o interruzioni finalizzate al ri–orientamento verso altri indirizzi scolastici e formativi.
Se considerata in senso stretto, la dispersione scolastica come abbandono definitivo del percorso scolastico costituisce una questione rilevante statisticamente soprattutto per le scuole medie superiori; nelle scuole medie inferiori, almeno nel contesto toscano e provinciale, il fenomeno è molto circoscritto e contenuto dal punto di vista quantitativo.
Si dovrà affrontare il problema innanzitutto dal punto di vista della discontinuità della carriera scolastica degli studenti e della regolarità del percorso compiuto. I dati dell’Osservatorio Scolastico Provinciale consentono di definire nel dettaglio la situazione della regolarità e della discontinuità nella scuola media superiore, segnalando in primo luogo il fatto che gli studenti che mancano l’obiettivo di raggiungere il diploma nel corso dei cinque anni dovuti costituiscono il 41,9% degli iscritti al primo anno (dati registrati nell’anno scolastico 1998–99). Poco meno della metà degli iscritti alle scuole superiori, dunque, sperimenta una qualche forma di
La regolarità del percorso scolastico
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
44
irregolarità della carriera scolastica – soprattutto con riferimento al fenomeno delle ripetenze e delle pluri–ripetenze.
Se i dati relativi alla zona livornese si avvicinano sostanzialmente ai valori medi provinciali, quelli relativi alla zona elbana se ne discostano in modo significativo, poiché salgono al 54,1%; leggermente inferiori sono i valori che si riscontrano nella Val di Cornia. Si deve peraltro considerare che già al terzo anno le percentuali di studenti “irregolari” si colloca significativamente attorno al 20%.
Questi dati segnalano un diffuso malessere che attraversa la scuola media superiore, che ha a che fare con le difficoltà che vengono incontrate nell’inserimento scolastico e nel far fronte ai “compiti di sviluppo” connessi con lo studio e l’andare a scuola. La gran parte dei casi di “mancato obiettivo” – cioè il raggiungimento del diploma in cinque anni – si verificano soprattutto nelle scuole con indirizzo professionale (56,7%), seguite da quelle con indirizzo tecnico (48,6%); la percentuale del mancato obiettivo nei licei–magistrali è pari al 25%.
Se si analizzano i dati relativi alle iscrizioni dell’anno scolastico 2000–01 per anno di nascita degli iscritti e classi di iscrizioni, è possibile compiere una stima degli studenti “in ritardo” all’interno del percorso scolastico; complessivamente, su 11977 iscritti ne lle scuole medie superiori della provincia, ben 3647 sono gli studenti non in regola con la propria carriera scolastica, cioè il 30,45%.
La distribuzione per zone ci mostra una sostanziale omogeneità tra l’area livornese e quella elbana, che si collocano leggermente al di sopra della media provinciale (entrambe con il 31,7%) e tra l’area cecinese (27,6%) e quella della Val di Cornia (29,8%). Ben diversa è la distribuzione dei “ritardi” per indirizzo di studi, dove ben il 54,4% si concentra negli istituti professionali, il 30,2% negli istituti tecnici e solo il 14,5% nei licei–magistrali.
Se si considera che, in linea generale, la provenienza socio–culturale dello studente è determinante nella scelta della scuola superiore26, si deve segnalare il fatto che la prosecuzione regolare degli studi nella scuola superiore è particolarmente difficile per gli studenti con più basso status socio–culturale, di modo che la formazione personale e la possibilità di consolidamento delle capacità individuali ad essa correlate dipendano ancora in modo formidabile dalla collocazione degli individui all’interno della scala socio–culturale.
Tuttavia mancano ancora indagini specifiche che consentano di verificare il peso specifico di variabili relativamente indipendenti dalla provenienza socio–culturale degli studenti, che riguardano l’incongruenza tra aspettative soggettive e offerta formativa (che si può tradurre nel problema dell’orientamento scolastico e della scelta in condizioni informative adeguate), o le difficoltà di integrazione relazionale nell’ambito scolastico
26 Cfr. G. Gasperoni, Diplomati e istruiti. Rendimento scolastico e istruzione secondaria
superiore, il Mulino, Bologna, 1996.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
45
specifico. Allo stato attuale delle conoscenze – confermate dalle elaborazioni e dalle
analisi dell’ISTAT –, la selettività del percorso scolastico risulta congruente con la “struttura gerarchica dei corsi” (licei – istituti tecnici – istituti professionali) per cui, in assenza di “un’offerta formativa sufficientemente integrata ed articolata”, il graduale “declassamento” delle scelte (cioè il passaggio da un corso di studi all’altro secondo una direzione discendente nella struttura gerarchica), si conclude spesso con un abbandono degli studi27.
L’indagine sulla realtà giovanile dell’Osservatorio Provinciale per le
Politiche Sociali consente di approfondire con dettaglio contenutistico e territoriale il quadro dell’esperienza scolastica dei giovani nella provincia di Livorno 28.
Intanto si deve dire che il campione dei giovani intervistato è composto soprattutto da studenti (86% per i giovani fino a 18 anni, 35,4% per quelli della fascia d’età superiore, i quali sono ovviamente più presenti sul mercato del lavoro: 41,3% rispetto al 3,4% di coloro che anno 14–18 anni). Vi sono molti giovani che studiano e lavorano contemporaneamente (sulla base dei dati non si riesce a stimare quale sia l’attività preponderante tra le due): si tratta del 6% circa degli intervistati. Le ragazze sono più inserite dei ragazzi nei processi formativi, e meno inserite nell’ambito del lavoro (64,4% le studentesse sul totale delle femmine, 54,6% gli studenti sul totale dei maschi).
La quota dei giovani che dichiarano di aver interrotto gli studi è pari al 16% (valore che sale al 23% all’Isola d’Elba e scende all’11% in Val di Cecina); la percentuale è leggermente più alta tra i maschi (19%). Nel 75% dei casi si è trattato di interruzioni avvenute nel corso della scuola superiore (soprattutto nella zona livornese: 83%); consistente, comunque, appare anche la percentuale di giovani che ha interrotto nel corso delle medie inferiori (13% – con un picco all’Isola d’Elba: 17%).
Gli studenti intervistati appaiono complessivamente soddisfatti della propria esperienza scolastica: “abbastanza” il 65%, “molto” il 14%, “poco” il 18%, per niente solo il 3%. Accanto a questo dato, si deve evidenziare il fatto che il 53,4% si dice soddisfatto delle scelte fatte relativamente allo studio, e il 27,4% addirittura “molto soddisfatto”. Solo il 20% si dichiara “poco” o “per nulla” soddisfatto. Da questi dati si delinea una situazione per la quale gli studenti sembrano vivere la propria esperienza scolastica in modo positivo, stante l’adeguatezza tra le scelte compiute e le proprie aspettative, nonché la risposta della struttura scolastica. L’area del disagio scolastico sembra riguardare una quota di giovani oscillante attorno al 20%.
27 ISTAT, Rapporto Annuale 1996, Roma, 1997, p. 190. 28 Si offrono in questa sede alcune informazioni che derivano da questa indagine, che più
direttamente si collegano a quanto visto in precedenza. Si rinvia alla lettura del Report dell’indagine: A. Salvini. F. Ruggeri (a cura di), Essere giovani a Livorno. La cittadinanza sociale dei giovani. Report 2002, Livorno, 2002.
L’esperienza scolastica dei giovani livornesi
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
46
Si deve segnalare che nella zona elbana e in Val di Cecina si riscontra un livello di minor soddisfazione sulle scelte compiute rispetto a quanto non accada nelle altre due zone, sebbene i valori non si discostino in modo decisamente consistente.
Un ultima notazione riguarda il livello informativo degli studenti circa le strutture esistenti sul territorio che si occupano di orientamento scolastico e professionale. Solo il 6% dei giovani intervistati si ritiene “molto informato”, ma il 38% si dichiara “abbastanza informato”. Il 46% è “poco informato” e il 9,8% “per nulla informato”.
I valori relativi ad una maggiore disinformazione si riscontrano nell’area livornese (52,7%), mentre all’Isola d’Elba si registrano le percentuali più alte di elevato livello informativo (11,7%).
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
47
L’inserimento di una riflessione specifica sul funzionamento del mercato del lavoro in Provincia di Livorno all’interno del capitolo sui luoghi della cittadinanza, si giustifica per il fatto che l’accesso alla risorsa–lavoro costituisce una dimensione fondamentale per lo sviluppo della capacità di agire degli individui, oltre che per il raggiungimento di livelli sempre più elevati di qualità della vita all’interno di una comunità territoriale.
I processi strutturali che hanno caratterizzato alcuni passaggi delle sviluppo socio–economico livornese – almeno quelli più direttamente collegati con le trasformazioni della struttura sociale –, sono stati già descritti nel primo capitolo. In questa sede si ricostruiranno gli esiti più recenti del mercato del lavoro nella Provincia di Livorno, in modo da verificare quali siano le condizioni attuali dell’accesso alla risorsa lavoro, soprattutto nell’ottica dei giovani e delle donne 29.
Negli ultimissimi anni, in termini generali, gli indicatori di accesso al
mercato del lavoro sono relativamente migliorati rispetto alla situazione di cinque anni fa. In quel periodo – siamo nella metà degli anni ’90 – la congiuntura economica presentava un aspetto assai paradossale, poiché mentre da una parte si assisteva ad una ripresa, in alcuni casi anche piuttosto consistente, dei principali indicatori dell’economia, dall’altra non si apprezzava alcun miglioramento corrispondente all’interno del mercato del lavoro. Fino al termine degli anni ’90, in Toscana e soprattutto nella Provincia di Livorno, gli indicatori del lavoro segnalavano processi di stallo e di sofferenza, soprattutto con riguardo al fenomeno della disoccupazione giovanile e femminile.
D’altra parte proprio in questo periodo si prende coscienza della rilevanza ricoperta dai processi di sotto–occupazione e di forme lavorative “sommerse” – che peraltro costituiscono modalità improprie d’inserimento lavorativo sempre più frequentate dalla popolazione giovanile. Si deve segnalare inoltre che sempre in questo lasso di tempo prendono avvio e si sviluppano le forme flessibili di lavoro inteso sia come modalità di attivazione di lavoro autonomo, sia come lavoro interinale.
A partire dalla fine degli anni ’90 il mercato del lavoro in Toscana ha dato segni di particolare dinamismo e vivacità, cui ha notevolmente contribuito l’andamento particolarmente favorevole della situazione costiera, livornese
29 I dati di questa parte sono derivati dalla documentazione disponibile presso la
Provincia di Livorno, all’interno dell’Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro. Si tratta, in gran parte, di elaborazioni compiute sui risultati delle rilevazioni sulle forze di lavoro compiute dall’ISTAT a livello provinciale. Si deve segnalare con decisione che queste sono le uniche informazioni disponibili che consentono di stimare i tassi ufficiali di occupazione e di disoccupazione; purtroppo, queste stime restano indisponibili a livello comunale, per via della ridotta rappresentatività statistica dovuta alla natura stessa della rilevazione.
Gli unici riferimenti territoriali sub–provinciali possono essere compiuti attraverso l’analisi dei dati dei Centri per l’Impiego a livello zonale, sebbene questi dati rappresentino soltanto approssimazioni delle misure principali che riguardano il lavoro (occupazione – disoccupazione).
L’accesso al lavoro
L’andamento del mercato del lavoro in Provincia di Livorno
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
48
in particolare. Negli ultimi due anni il mercato del lavoro locale e regionale ha consolidato il processo di riequilibrio strutturale cominciato proprio a partire dal 1999; ciò si traduce, numericamente, in un aumento del tasso di occupazione in valore assoluto e percentuale, nonché in una riduzione dei tassi di disoccupazione generico e specifico.
Tabella 32. Tasso di occupazione e tasso di disoccupazione nelle province toscane - Medie 1998, 1999, 2000
Tasso di disoccupazione Tasso di occupazione30 2000 1999 1998 2000 1999 1998 Arezzo 6,5 5,9 5,0 60,1 60,1 59,4 Firenze 5,6 6,2 7,0 60,9 60,0 58,2 Grosseto 8,8 9,1 8,4 55,5 54,5 54,5 Livorno 8,4 11,3 13,3 55,3 51,7 49,0 Lucca 4,8 5,5 7,1 57,1 57,1 56,1 Massa 11,9 11,6 12,9 52,4 49,7 46,2 Pisa 4,8 8,0 8,2 62,5 58,5 58,3 Pistoia 5,6 7,0 7,7 60,2 60,8 59,9 Prato 5,2 8,2 7,5 65,1 62,3 62,8 Siena 3,4 3,3 5,3 65,5 64,7 63,3 TOSCANA 6,1 7,2 7,8 59,8 58,4 57,1
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT da parte dell’Osservatorio Provinciale sul Mercato del lavoro
Due sono stati i processi concomitanti che hanno contribuito a definire
questa inversione di tendenza: il decremento del tasso di disoccupazione femminile (dal 13,1 del 1995 al 9,0 nel 2000) e di quella giovanile (dal 25,3 del 1995 al 19,8 del 2000), e i miglioramenti che si sono registrati, appunto nelle zone costiere della regione.
In particolare al Livorno, nel 2000, la disoccupazione cala di circa tre punti percentuali rispetto al 1999 (dall’11,3 al’8,4), mentre il tasso di occupazione sale dal 51,7 al 55,3. Nel 2001 la Provincia consolida sostanzialmente questi livelli, senza mostrare risultati di rilievo pari a quelli dell’anno precedente, ma un leggero incremento occupazionale e una stabilità del tasso di disoccupazione. Il tasso di occupazione sale a 55,8, mentre il tasso di disoccupazione si attesta all’8,5. I corrispettivi valori a livello regionale (61,1 e 5,1) mostrano ancora l’esistenza di uno scarto piuttosto notevole da colmare per avvicinarsi alle tendenze medie toscane. Tuttavia, com’è stato fatto notare, “nel triennio della nuova ripresa occupazionale, il tasso medio annuo di incremento degli occupati nella provincia livornese rimane circa il doppio di quelli regionali”31.
L’incremento dell’occupazione femminile nella Provincia nel quinquennio 1995–2000 è stato pari al 23% (in termini di variazione percentuale), in corrispondenza ad un calo della disoccupazione specifico
30 Si tratta del rapporto tra gli occupati e la popolazione in età 15–64 anni 31 Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, Rilevazioni sulle forze di lavoro
ISTAT – Media 2001. Nota di sintesi, Provincia di Livorno, febbraio 2002.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
49
dal 21,3% al 12,0%. I dati relativi al 2001 mostrano un dato congiunturale in relativa controtendenza, poiché nell’ultimo anno l’occupazione femminile flette del 3,4%; in calo anche i valori dell’occupazione giovanile – processo che Livorno condivide, peraltro, con molte altre province toscane – dal 27,9 al 23,0.
Per comprendere, dunque, i cambiamenti in atto all’interno del mercato del lavoro provinciale, si deve focalizzare l’attenzione su tre aspetti caratterizzanti:
§ i lavoratori con contratto a tempo indeterminato costituiscono
ancora la parte predominante dell’occupazione provinciale complessiva, sebbene con caratteristiche diverse da quella di venti–trenta anni fa (maggiore mobilità e flessibilità).
§ Le nuove normative sul lavoro flessibile ha introdotto nuove modalità di ingresso e di svolgimento dei ruoli lavorativi, che vengono utilizzati dai giovani come canale di primo inserimento lavorativo, ma anche dal segmento femminile, che necessita forme di maggior conciliazione dei tempi di lavoro – tempi familiari. In particolare assumono particolare rilievo le posizioni dei lavoratori parasubordinati (i cosiddetti co.co.co: collaborazioni coordinate e continuative).
§ I livelli di disoccupazione manifestano un deciso calo a livello generale e specifico mentre resta praticamente stabile il tasso di occupazione – effetto forse della riduzione della base delle forze di lavoro. Se si fa riferimento ai cambiamenti sopra delineati, e in qualche modo evidenziati dai dati del collocamento che si descriveranno di seguito, l’area di confine tra disoccupazione ed occupazione tende gradatamente a sfumarsi e a tradursi in una molteplicità di posizioni lavorative transitorie e parziali. Questo processo, se da una parte introduce elementi di maggior dinamismo della dinamica di domanda–offerta di lavoro, dall’altra può condurre ad una sorta di “precarizzazione strutturale” dei segmenti più deboli della forza lavoro.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
50
Tabella 33. Tassi di occupazione e di disoccupazione per età e sesso nelle province toscane - Media 2001
TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE
15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 15-24 15-29 30-64 15-64 Totale
Maschi
TOSCANA 34.6 78.3 78.7 72.2 58.0 13.5 8.1 1.8 3.1 3.0
Massa 25.4 67.0 79.6 69.2 55.8 15.8 10.4 1.7 3.4 3.4
Lucca 33.2 86.0 81.2 73.8 61.4 12.3 7.3 1.3 2.5 2.5
Pistoia 40.1 71.1 76.8 70.9 56.5 11.8 7.5 1.9 2.9 2.9
Firenze 36.8 80.8 76.4 71.7 55.5 9.6 6.9 2.4 3.3 3.2
Livorno 24.0 72.5 76.1 69.0 58.3 30.8 15.6 2.7 5.0 4.8
Pisa 29.7 76.2 79.5 71.2 56.9 19.1 9.3 1.3 2.8 2.8
Arezzo 38.9 74.9 78.0 71.6 57.4 4.1 4.1 1.7 2.2 2.1
Siena 39.0 81.7 82.2 76.5 60.3 11.1 6.6 0.3 1.6 1.6
Grosseto 30.0 80.8 80.3 73.2 58.3 25.6 12.8 1.3 3.7 3.7
Prato 45.5 83.2 83.5 77.1 65.0 10.0 6.2 2.1 3.0 3.0
Femmine
TOSCANA 28.8 57.5 53.0 50.1 36.6 20.8 17.0 5.3 8.0 8.0
Massa 25.4 44.2 45.1 41.9 30.0 37.0 27.6 7.6 12.1 11.9
Lucca 28.9 49.7 44.7 42.7 31.5 15.6 15.7 5.5 7.9 7.9
Pistoia 27.8 59.2 54.3 51.3 39.5 28.1 20.9 4.8 8.6 8.5
Firenze 30.4 61.2 54.4 52.3 35.9 15.6 12.2 3.7 5.5 5.5
Livorno 22.1 51.4 46.0 43.2 33.6 37.0 25.8 9.6 13.6 13.6
Pisa 16.1 55.2 58.4 52.3 37.4 22.5 18.7 3.0 5.8 5.8
Arezzo 36.3 64.3 56.9 54.6 39.9 14.6 14.6 5.5 8.0 8.0
Siena 30.0 61.2 62.3 56.7 42.9 7.8 10.7 3.4 4.9 4.9
Grosseto 28.2 51.6 49.8 47.0 34.9 27.6 21.3 9.2 12.2 12.1
Prato 42.9 66.3 55.7 54.8 43.1 16.6 15.5 7.3 9.5 9.7
Maschi e femmine
TOSCANA 31.7 68.0 65.8 61.1 46.8 16.9 12.2 3.3 5.2 5.1
Massa 25.4 57.8 62.0 55.6 42.2 27.8 17.9 4.0 6.9 6.8
Lucca 31.2 68.7 63.0 58.4 45.8 13.8 10.7 2.8 4.6 4.5
Pistoia 34.1 64.4 65.3 60.9 47.6 19.1 14.3 3.1 5.5 5.4
Firenze 33.7 71.3 65.3 62.0 45.3 12.3 9.2 3.0 4.2 4.2
Livorno 23.0 61.1 61.0 55.8 45.3 34.1 20.7 5.4 8.6 8.5
Pisa 23.6 65.8 68.9 61.9 46.8 20.1 13.1 2.0 4.1 4.0
Arezzo 37.6 69.2 67.7 63.1 48.3 9.4 9.6 3.3 4.8 4.7
Siena 33.8 72.5 72.2 66.5 51.4 9.5 8.4 1.7 3.1 3.0
Grosseto 29.1 65.5 64.7 59.8 46.0 26.6 16.7 4.6 7.3 7.2
Prato 44.2 75.2 69.3 65.9 53.7 13.2 10.5 4.3 5.8 5.9
Fonte: ISTAT, rilevazione sulle Forze di Lavoro, Media 2001
Come si è detto in precedenza, l’analisi della situazione del mercato del lavoro a livello sub–provinciale è consentita soltanto ricorrendo ai dati dei Centri per l’Impiego, che svolgono la propria attività nell’ambito degli
L’attività dei Centri per l’Impiego
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
51
avviamenti e delle cessazioni al lavoro degli iscritti ma anche in iniziative specifiche di incontro della domanda e dell’offerta di lavoro.
Gli iscritti al Centro per l’Impiego di Livorno costituiscono circa il 58% del totale provinciale (si tratta di 18293 iscritti nella prima classe)32; qui si verifica una sostanziale stabilità nell’entità degli iscritti, sebbene venga sottolineato l’incremento – rispetto all’anno precedente – della fascia di giovani adulti e di adulti con più di 30 anni e una flessione della componente giovanile. Si è verificata una crescita simultanea degli avviamenti e delle cessazioni al lavoro, con un conseguente calo del rapporto tra i due flussi, fenomeno che non sembra deporre per un’attuale fase di espansione della domanda di lavoro nell’area territoriale considerata.
Nell’area del Centro per l’Impiego di Piombino–Val di Cornia si sono verificate dinamiche relativamente più positive in presenza di una contrazione degli avviamenti e di una più ampia contrazione delle cessazioni (rispettivamente –8,9 e –21,2%); questa situazione viene valutata positivamente date le potenzialità espresse dal territorio negli ultimi anni, anche se permangono ambivalenze che rendono ancora incerta la lettura interpretativa dei fenomeni.
Anche nell’area del Centro per l’Impiego di Rosignano si assiste, come negli altri, ad un aumento degli iscritti della fascia adulta, ma si verifica anche un incremento delle persone in cerca di prima occupazione. Il rapporto tra avviamenti e cessazioni, pur non essendo particolarmente dinamico, si mantiene su livelli positivi (107 su 100).
Nell’area del Centro per l’Impiego di Portoferraio è possibile notare una riduzione nelle iscrizioni che attraversa tutte le fasce d’età, ma soprattutto tra i giovani e tra i disoccupati; secondo gli osservatori questa tendenza è dovuta dalla debolezza della domanda di lavoro che spiega un minor ricorso al mercato del lavoro ufficiale e, dunque, al collocamento33.
Come si nota dalla tabella, l’attività svolta dai Centri per l’impiego è molto consistente, soprattutto sul piano dell’incontro da domanda e offerta di lavoro. In particolare, oltre ai dati sull’utenza complessiva, appaiono significativi i dati sulle consulenze effettuate alle imprese e sui colloqui individuali; interessante, invece, è il dato relativo alla estrema differenza che si riscontra tra il numero di richieste di lavoratori da parte delle imprese private e il numero degli avviati sulla base di tali rischieste, soprattutto se confrontati con il rapporto tra richieste ed avviati che si riscontra per gli enti pubblici.
32 Ivi, p. 27 33 Ivi, p. 31.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
52
Tabella 34. Attività specifiche dei Centri per l'impiego per la richiesta di lavoro, per la raccolta delle richieste di lavoro, per l'incontro della domanda - offerta - Anno 2001
Attività specifiche dei Centri per l’impiego per la richiesta di lavoro, per la raccolta delle offerte di lavoro, per l’incontro di domanda / offerta Anno 2001
C.I. Livorno
C.I. Piombino
C.I. Rosignano
C.I. Portoferraio
Raccolta curricula
Presso il Centro per l'impiego 612 994 135 233Presso privati convenzionati Totale 612 994 135 233
Bilancio di competenze
Percorsi di gruppo 70
Utenti 610
Bilanci di competenze individuali 358 499 62Utenti 358 499 680
Dati sull'utenza complessiva
Aziende/Enti che si sono rivolti al C.I. 15000 1949 2400 3150Cittadini che si sono rivolti ai C.I. 38500 4820 22368 16100
Attività di orientamento
Colloqui effettuati 529 914 480 711
Utenti 568 914 503 1870
Stages
Stages 27 27 27 27
Utenti 27 27 27 27
Voucher
Colloqui effettuati 164 52 39Utenti 331 80 49
Postazioni Internet
Postazioni 1 4 1Utenti 720 467 65
Consulenze alle imprese
Imprese contatte n. 5620 262 847
Consulenze effettuate n. 5620 95 2100 2150
Aziende private
Aziende che hanno effettuato richieste 750 160 378 1009
Lavoratori richiesti 2200 215 612 1216Avviati al lavoro su dette richieste 205 208 63 Enti Pubblici
Enti che hanno effettuato richieste 4 80 6 7Lavoratori richiesti 122 291 148 44Avviati al lavoro su detta richiesta 130 215 221 55Fonte: Centri per l’impiego – Provincia di Livorno
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
53
Nell’idea di cittadinanza è sottesa la prassi della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nella determinazione delle prassi progettuali ed operative per realizzare livelli sempre più avanzati di coesione sociale all’interno della comunità territoriale (welfare community). La costruzione di reti sociali che consentano di praticare il senso di corresponsabilità sociale circa le modalità di individuazione dei problemi sociali territoriali e di coinvolgimento delle risorse più adeguate per la loro soluzione, costituisce un processo indispensabile per raggiungere quell’obiettivo.
Nei più recenti studi sulla cittadinanza, inoltre, il senso di appartenenza e di identificazione nella realtà territoriale viene considerato come un motore indispensabile per la realizzazione del coinvolgimento dei soggetti individuali e collettivi nella costruzione dei processi di inclusione e di promozione della collettività.
In questo quadro si inserisce la riflessione sulla presenza del volontariato e del terzo settore nella realtà territoriale provinciale e sui livelli di partecipazione sociale e politica dei propri abitanti. I riferimenti normativi regionali e nazionali in materia di assistenza sociale e di politiche sociali richiamano costantemente l’idea di sviluppare reti di sostegno in cui le diverse componenti della società civile locale contribuiscano all’attivazione di interventi sociali integrati e coordinati al fine di realizzare più elevati livelli di qualità.
In particolare, viene considerato strategico il coinvolgimento del volontariato e del terzo settore non solo in fase di realizzazione esecutiva degli interventi, ma anche nella loro progettazione. Assieme alle famiglie, il terzo settore costituisce uno dei cardini attorno ai quali ruota il meccanismo di attivazione delle politiche sociali sul territorio, per cui le organizzazioni del privato sociale sono considerate risorse irrinunciabili cui rivolgersi nello sviluppo e nella promozione della cittadinanza attiva e per il sostegno del sistema dei servizi sociali professionali che operano sul territorio.
D’altra parte, negli ultimi anni si è assistito all’aumento della domanda sociale sulle istituzioni del welfare locale e, di conseguenza, sulle stesse organizzazioni di volontariato. Questa domanda ha la duplice caratteristica di orientarsi verso l’ente locale, ma anche di farsi portatrice di istanze non tradizionali – come ad esempio quelle che provengono dall’area dell’immigrazione, dei senza fissa dimora, dei malati di AIDS, della prevenzione del disagio giovanile –, per le quali effettivamente non si hanno procedure di intervento né istituzionalizzate né, comunque, consolidate in una prassi verificabile. Sia l’ente locale che il terzo settore sono, dunque, chiamati a dare risposte innovative in termini di offerta mediante la realizzazione di risposte di intervento flessibili, la definizione di nuove professionalità sociali operanti sul territorio, la sperimentazione di percorsi progettuali effettivamente realizzabili e verificabili in termini di qualità delle prestazioni e degli esiti.
La rappresentazione attuale dell’azione volontaria - soprattutto di quella organizzata - descrive un universo eterogeneo e complesso di processi, di
La cittadinanza come partecipazione
Il Terzo settore nella welfare community
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
54
fenomeni e di organizzazioni, che si pongono come manifestazione delle molteplici modalità di espressione non tradizionali dei fermenti presenti nella società civile - potremmo dire delle possibilità della società civile.
In quella stessa rappresentazione, vi sono degli elementi costitutivi ormai acquisiti e consolidati, che costituiscono le ragioni della forza attuale del volontariato; questi punti di forza sono stati ben caratterizzati in un passato recente, e vale la pena enuclearli ulteriormente:
“Nella percezione comune il volontariato: 1 - ha dimostrato di essere in grado di identificare e di accogliere i bisogni
con una tempestività che le strutture statuali, per tante ragioni, sono ben lungi dal permettere;
2 - ha dato prova di selezionare le domande per risposte il più possibile adeguate alla classe di bisogno;
3 - ha posto in atto un’opera efficace sia di tipo tecnico che di tipo simpatetico;
4 - è sostanzialmente al di fuori dei circuiti lucrativi e quindi incline ad un’etica del rapporto che altre istituzioni non contemplano;
5 - tende a ricostruire, nella versione più generale, quel tessuto di solidarietà che la società odierna sembra rendere sempre più lacerato e separato;
6 - ha assunto un valore testimoniale e antagonistico rispetto ai processi di scambio, introducendo la variabile del ‘dono’ senza pretesa di remunerazione;
7 - è stato ed è una reazione ai processi di alienazione sia dei portatori dei bisogni che degli operatori sui bisogni, costituendo una base di resistenza alla massificazione;
8 - ha convogliato una domanda inespressa da parte di molti di partecipazione e di impegno sociale che conseguiva proprio ai fallimenti della partecipazione istituzionale;
9 - ha portato una diversa istanza politica nel sociale, di tipo pragmatico e riformatore, diffusa al di là delle strategie partitiche e delle intenzioni generalizzanti delle ideologie;
10 - ha convogliato volontà generiche entro alvei di virtuale formazione di competenze, contribuendo, per la massa di volontari, ad un’opera di specializzazione, ed aumentando il loro ‘tasso’ di personalizzazione”34.
Nella situazione attuale di sviluppo delle politiche sociali, per le
organizzazioni di terzo settore è sempre più necessario attrezzarsi in modo adeguato per “interfacciare” le aree di bisogno sociale su cui, per statuto o per vocazione, è stato deciso di intervenire e per relazionarsi in modo adeguato con i referenti pubblici sia a livello progettuale che operativo.
34 M.A. Toscano, Volontariato e rete dei servizi territoriali , Relazione presentata alla II
Conferenza Nazionale del Volontariato,
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
55
Sfide consistenti a tale capacità/possibilità di interfacciamento provengono costantemente dalla rapidità con cui i bisogni sociali cambiano, si articolano, si segmentano, inducendo continue operazioni di adattamento nelle organizzazioni, sia di tipo strutturale che progettuale
L’inesauribile domanda di “servizi alla persona” e le sfide che essa pone in termini di specifiche competenze da sviluppare nei confronti – in primo luogo – dell’utente, sta conducendo i soggetti del Terzo Settore ad articolare ulteriormente la propria struttura organizzativa, ad amplificare e moltiplicare le dinamiche di aggiornamento-tirocinio-formazione e a sviluppare continuamente significative virtù progettuali, al fine di garantire sempre più elevati livelli di “stabilità”, “affidabilità” e possibilità di ulteriori implementazioni e miglioramenti nell’intervento sociale.
Le forme di partecipazione sociale nella Regione Toscana manifestano
caratteri di particolare dinamismo e intensità se confrontate con quanto accade in altre aree del Paese; sebbene in Toscana si stia assistendo ad leggero declino della partecipazione volontaria in associazioni, essa condivida la tendenza con altre regioni del Paese e comunque si colloca tra le quattro regioni (insieme a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) con i valori più elevati di partecipazione sociale.
Tabella 35. Persone di 14 anni e più che hanno svolto attività gratuita per associazioni di volontariato in alcune regioni - Anni 1993 - 1999 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa regione).
Regioni (scelte per confronto) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TOSCANA 9.1 9.3 9.4 9.0 8.5 7,8 8,4
Lombardia 8.8 10.1 9.6 11.2 9.5 11,1 10,1
Veneto 11.0 11.4 10.3 12.3 12.3 12,1 11,5
Emilia-Romagna 8.4 7.7 11.1 10.0 9.5 9,6 9,1
Campania 4.0 4.0 4.3 4.9 4.1 5,3 3,5
Sicilia 2.3 3.8 4.2 4.4 3.6 4,3 4,5
ITALIA 6.9 7.2 7.6 7.9 7.3 7,9 7,5
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana – anni 1993 – 1999
Facendo riferimento ai dati resi disponibili dalla Regione Toscana al
marzo del 2002, raccolti dall’Osservatorio Sociale Provinciale 35, le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale del volontariato sono 2088, di cui 203 nella Provincia di Livorno. Dal punto di vista dei valori assoluti, le province con maggior numero di organizzazioni sono Firenze (20% circa sul totale delle organizzazioni) e Lucca (18,2%). La provincia di Livono si colloca in una fascia intermedia assieme ad Arezzo, Pisa, Siena, con valori oscillanti attorno al 10% sul totale delle
35 Cfr. Osservatorio Sociale Provinciale, U.O.C. Servizio Sociale, Associazioni di volontariato nella Provincia di Livorno, Livorno, 2002, a cui si rinvia per gli opportun approfondimenti.
Le associazioni di volontariato in Toscana e nella provincia di Livorno.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
56
organizzazioni regionali. Diverso è il ragionamento se si rapporta il numero di organizzazioni con
la popolazione residente; la maggiore incidenza sulla popolazione si verifica a Lucca – a Livorno si trovani circa 5 organizzazioni ogni 10.000 abitanti.
La maggior parte delle organizzazioni di volontariato iscritte opera nei settori sanitario e sociale: in particolare il 30,4% nel settore sanitario, il 26% nel settore sociale e il 24% in quello socio–sanitario; attorno al 5% si collocano le organizzazioni che svolgono attività nel campo della protezione civile ed ambientale, nonché della tutela dei beni culturali.
Nella provincia di Livorno l’incidenza del settore sanitario si colloca al di sotto della media regionale, mentre appare assai consistente l’incidenza del settore sociale, pari al 33% sul totale delle organizzazioni provinciali. In questo settore, il territorio livornese presenta la percentuale più elevata rispetto a tutte le altre province. Negli altri settori, l’incidenza percentuale si orienta generalmente attorno alla media regionale con lievi scarti per l’ambito dei beni culturali.
Sulla base di queste informazioni è possibile notare che il fenomeno del volontariato in Toscana costituisce un dato rilevante nel contesto sociale sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo: il radicamento territoriale, la presenza di associazioni fin da tempi remoti, la propensione verso la cultura mutualistica e solidaristica costituiscono tratti tipici non sempre riscontrabili in altre aree del Paese. La distribuzione delle organizzazioni sul territorio segue e si modella sulle caratteristiche demografiche e strutturali della Regione; il fenomeno appare particolarmente diffuso nelle aree urbane, ma anche nei piccoli paesi è sempre presente un certo numero di organizzazioni che garantiscono una presenza consistente e capillare su tutto il territorio.
Inoltre si deve rilevare la spiccata tendenza delle organizzazioni di volontariato ad orientare le proprie attività principali nei settori più “tradizionali” dell’impegno sociale; si deve peraltro ricordare che i dati sopra presentati sono probabilmente “connotati” dal fatto che ci si sta riferendo ad organizzazioni iscritte al registro regionale. Ciò significa che molta parte del volontariato toscano è impegnato in attività rivolte all’offerta di beni e servizi verso specifiche fasce d’utenza portatrici di bisogni di estrema rilevanza sociale e sanitaria; si conferma, dunque, il ruolo cruciale svolto dal volontariato nella progettazione e realizzazione delle politiche sociali a livello territoriale 36.
Nell’anno 2000, oltre alle 172 organizzazioni di volontariato, operavano
36 Per ulteriori approfondimenti sulla situazione del volontariato in Toscana, si rinvia alle
informazioni diffuse o rese disponibili delle principali fonti di dati sul tema. Tra queste ci si limita a segnalare: ISTAT, Le organizzazioni di volontariato in Italia. Struttura, risorse ed attività, Roma, 1999; R. Frisanco, C. Ranci, Le dimensioni della solidarietà. Secondo rapporto sul volontariato sociale in Toscana, FIVOL, Roma, 1999; A. Salvini, Identità e bisogni del volontariato in Toscana, CESVOT, Firenze, 1999. Si deve peraltro ricordare che il Centro Nazionale del Volontariato, con sede a Lucca, cura e possiede la più ampia banca dati sul terzo settore relativamente alla Toscana e all’Italia.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
57
in provincia di Livorno 103 associazioni e 28 cooperative sociali. Rispetto a queste ultime si deve dire che esse si concentrano soprattutto in area urbana – dove più elevata è la necessità di concorrere alla realizzazione degli interventi sociali, specie se si tratta di servizi alla persona e servizi di tipo educativo: se ne registrano 14 a Livorno e 4 a Piombino; se ne trovano, però, anche in aree diverse come Rosignano Marittimo (5), Cecina e Collesalvetti.
Per ciò che concerne le associazioni, ve ne sono 3 ogni 10000 abitanti nel territorio provinciale (valore inferiore, dunque, rispetto alle organizzazioni di volontariato); esse si concentrano soprattutto nella zona livornese, sia in termini assoluti che relativi.
La maggior parte delle associazioni (ci si sta riferendo anche in questo caso alle associazioni iscritte all’albo provinciale dell’associazionismo) opera nel campo culturale (52%) e, di queste, si riscontra una maggiore presenza nella Val di Cornia e nella zona livornese. Seguono poi le associazioni che operano in campo sportivo (attorno al 35%%); esse sono concentrate soprattutto nell’area della Val di Cecina, dove il livello di presenza è assai più ampio rispetto alla media provinciale (sempre con riferimento al settore sportivo).
Seguono poi, piuttosto distanziate, le associazioni nel settore sociale e in quello ambientale .
Si concentrerà ora l’attenzione sulle organizzazioni di volontariato iscritte
all’albo regionale; intanto si dovrà notare che nella Provincia di Livorno, l’insieme dei tre settori di tipo sociale e sanitario coinvolge il 75,8% delle organizzazioni iscritte.
Facendo riferimento ai dati disponibili presso l’Osservatorio Sociale Provinciale, riferiti al 2000, le organizzazioni erano pari a 168, con una maggiore concentrazione nelle aree urbane (Livorno, Piombino, Portoferraio, Cecina e Rosignano); nei comuni al di sotto dei 1.000 abitanti, in linea generale, non si riscontra la presenza di organizzazioni di volontariato. Se si considera l’incidenza del numero di organizzazioni sulla popolazione residente, si nota che i tassi più elevati si riscontrano in diversi comuni elbani mentre a Livorno si registra la minor incidenza di organizzazioni rispetto ai comuni maggiormente urbanizzati.
Si deve ulteriormente notare che le associazioni iscritte al registro comunale sono assai più numerose di quelle iscritte al registro regionale; ciò si spiega sostanzialmente con la maggio re facilità con cui è possibile accedere al registro a livello locale, e con un miglior “saldo” tra costi che devono essere sostenuti per l’iscrizione (per esempio da un punto di vista burocratico) e ritorno in termini di visibilità e legittimazione della propria presenza. Tuttavia, si sa che un gran numero di organizzazioni di volontariato non risulta ancora iscritto ad alcun registro, e ciò costituisce un dato significativo per comprendere la tipologia dei rapporti e delle rappresentazioni che si instaurano tra volontariato ed ente locale. D’altra parte, si deve segnalare il fatto che esistono ancora ampi ambiti di incertezza
Caratteri delle associazioni di volontariato in Provincia e nelle zone socio–sanitarie
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
58
sulle modalità di definizione (e, quindi, di individuazione) dei diversi soggetti che operano nel terzo settore – come ad esempio tra organizzazioni di volontariato e associazioni.
Tabella 36. Numero di associazioni iscritte ai registri provinciale e comunale per
comune
Comune N. associazioni iscritte al Registro Prov.le
N. associazioni iscritte al Registro
Com.le
Bibbona 2 0
Campiglia M.ma 3 0
Campo Nell'Elba 1 2
Capoliveri 2 0
Castagneto C.cci 3 42
Cecina 14 14
Collesalvetti 8 25
Livorno 76 176
Marciana 3 0
Piombino 17 26
Porto Azzurro 4 11
Portoferraio 15 38
Rio Marina 6 1
Rosignano M.mo 10 60
San Vincenzo 1 6
Sassetta* 1 0
Suvereto 2 20
168 421
Fonte: Osservatorio Sociale Provinciale, U.O.C. Servizio Sociale
Tabella 37. Numero di associazioni per zona socio-sanitaria
Zona Socio-sanitaria N. Associazioni
Bassa Val di Cecina 29Elba 31Livorno 84
Val di Cornia 24Fonte: Osservatorio Sociale Provinciale, U.O.C. Servizio Sociale
La distribuzione delle organizzazioni per zone mostra, com’è ovvio, una
prevalenza della concentrazione nella zona livornese, anche se si deve notare una consistente presenza nella zona elbana, specie se il dato viene rapportato con la popolazione residente (qui, infatti, vi sono ben 10 organizzaioni ogni 10000 abitanti, mentre nell’area livornese se ne registrano poco meno di 5). Nelle altre zone, la presenza di organizzazioni si colloca lievemente al di sotto della media provinciale.
È interessante notare che ben il 33% delle organizzazioni iscritte al 2000,
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
59
si è costituito nei cinque anni precedenti all’anno di riferimento, il 34% tra il 1985 e il 1994, mentre il resto delle associazioni si è costituito prima del 1985. Ciò significa che la percezione dell’importanza dell’iscrizione al registro regionale è assai più diffusa tra giovani generazioni di organizzazioni, piuttosto che in quelle più anziane. Inoltre, questo dato consente di ricordare come, in effetti, la diffusione del fenomeno del volontariato possa esser ricondotto a metà degli anni ’80, quando la crisi della partecipazione politica secondo il modello tradizionale ha provocato una sorta di fioritura di forme innovative di partecipazione sociale.
Tabella 38. Organizzazioni di volontariato secondo il periodo di nascita
Periodo di nascita Numero associazioni Val. %
prima 1975 25 15,21976–1985 29 17,71985–1994 56 34,1
1995–2000 54 32,9Fonte: Osservatorio Sociale Provinciale, U.O.C. Servizio Sociale – Anno 2000
Tabella 39. Organizzazioni di volontariato per settore di attività
Settori di attività Numero associazioni Val. %
Ambiente 21 6,7Cultura 49 15,7Protezione civile 41 13,1Sanitario 87 27,8
Sociale 115 36,7Fonte: Osservatorio Sociale Provinciale, U.O.C. Servizio Sociale – Anno 2000
In linea generale, le organizzazioni di volontariato non orientano le
proprie attività in ambiti monosettoriali, ma dichiarano diversi campi di intervento, dimostrando una capacità – spesso notevole – di differenziare la propria “vocazione” operativa. Quasi il 37% delle organizzazioni opera in campo sociale, mentre il 28% in campo sanitario; in campo culturale opera il 15% delle associazioni, in quello della protezione civile il 13% e, infine, in quello ambientale il 7%.
Anche nel territorio provinciale di Livorno il terzo settore costituisce una
realtà piuttosto consistente ed attiva; il totale dei soggetti operanti sul territorio, nel 1999, assommavano a circa 1200 unità, anche se all’interno di questa cifra devono essere considerati tutti i soggetti che normalmente fanno parte del Settore – anche quelli non iscritti ad alcun registro. Uno dei temi più frequenti che attraversano la questione del terzo settore è se esso sia in grado di costituire un bacino di sviluppo occupazionale, oltre che un terreno fertile per la diffusione della partecipazione sociale.
Secondo i dati emersi da una ricerca compiuta nel 1999 dalla Provincia di
Terzo settore e prospettive occupazionali nel territorio livornese
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
60
Livorno 37, il terzo settore costituisce un bacino occupazionale soprattutto per le funzioni ed i profili professionali più “tipici” o “tradizionali”, che hanno a che fare con l’assistenza alla persona e alle fasce deboli della popolazione, l’assistenza sanitaria e il sostegno educativo. L’attuale configurazione occupazionale in settori più “innovativi” – la tutela ambientale e culturale, dei diritti e la cooperazione internazionale – sembrano assumere i conterni di un’area minoritaria.
Tra le altre indicazioni, l’indagine ha consentito di mettere in luce i seguenti aspetti del terzo settore in provincia di Livorno:
• il Terzo Settore costituisce un universo assai articolato di organizzazioni e differenziato al proprio interno, che offrono un contributo altrettanto diversificato alla creazione e alla strutturazione del bacino occupazionale del Terzo Settore stesso;
• le risorse su cui si basa la possibilità di “sopravvivenza” e di sviluppo del Terzo Settore sono costituite, prevalentemente, da fonti pubbliche di entrata per le imprese sociali come le cooperative e il lavoro gratuito per il volontariato e l’associazionismo. L’esistenza parallela di diversi canali di finanziamento fa sì che in quest’ultimo segmento sia presente lavoro retribuito meno stabile e più flessibile, mentre il lavoro dipendente a tempo parziale è maggiormente presente nel settore della cooperazione e degli altri enti;
• la quota maggioritaria di occupati si riscontra nell’area di attività socio-assistenziale e socio-sanitaria che fanno registrare nel contempo una presenza di personale dipendente assai rilevante e una relativa stazionarietà nei processi di crescita negli ultimi due anni; di converso, ne lle aree di attività che abbiamo definito “innovative” del Terzo Settore, si verifica un trend di crescita dell’occupazione assai consistente, sebbene le dimensioni quantitative siano sempre piuttosto contenute in valore assoluto;
• inoltre, si verifica un trend evolutivo complessivo più dinamico con riferimento al personale retribuito piuttosto che con riferimento al personale volontario, che cresce relativamente meno; ciò prefigura una maggiore propensione delle OTS ad acquisire personale retribuito – cioè maggiormente qualificato e “professionalizzato”, rispetto alle “diffidenze” o ai vincoli operanti fino a qualche tempo fa. Questa maggiore “propensione” dipende sicuramente da fattori che non è stato possibile “controllare” pienamente da questa indagine – stanti le sue più circoscritte finalità analitiche – come l’evoluzione culturale interna al Terzo Settore, la necessità oggettiva di far fronte a funzioni gestionali e tecniche sempre più complesse e la
37 Cfr. R. Andreini, A. Salvini, G. Tomei (a cura di), Prospettive occupazionali e
fabbisogni formativi nel settore non profit nella provincia di Livorno, Provincia di Livorno, 1999.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
61
consapevolezza di dover corrispondere ai propri compiti interni ed esterni con un maggior grado di efficacia ed efficienza.
Il terzo settore costituisce una realtà connotata da forte dinamismo e
ancora in fase di strutturazione nella Provincia Livornese, i dati segnalano il ruolo importante svolto nel campo dell’offerta di servizi socio–assistenziali e dei servizi alla persona. Sono questi gli ambiti in cui, attualmente, si verificano le dinamiche più rilevanti nel senso dell’incremento occupazionale. Sullo sfondo, tuttavia, si delineano i tratti di un’interessante evoluzione nel campo della tutela dei beni ambientali e culturali, anche se la rilevanza quantitativa è circoscritta. Inoltre, si deve aggiungere che la possibilità di partecipare al segmento di mercato del lavoro tipico del terzo settore è ancora fortemente segnata da scelte soggettive dove la dimensione motivazionale ed etica ricopre una valenza significativa.
Rispetto ai livelli occupazionali provinciali, i dati disponibili mostrano che all’interno del campione considerato nell’analisi, gli occupati nel terzo settore costituiscono circa l’1,1% del totale degli occupati in tutti i settori, percentuale che si eleva all’1,53% se si considerano gli occupati alle dipendenze 38.
L’indagine Excelsior condotta quasi contemporaneamente nella Provincia di Livorno, aveva peraltro previsto un flusso di entrata nel mercato del lavoro territoriale pari all’8,9% sul totale degli occupati nei settori presi in considerazione da quell’indagine39. Dai dati dell’indagine sul terzo settore si evidenza che, stesso periodo, le organizzazioni intervistate avrebbero previsto un’entrata complessiva pari al 10% del totale degli occupati nello stesso settore. Ciò significa che, scontando le diverse metodologie di ricerca adottate, il terzo settore si muove ad una velocità che sembra leggermente superiore a quella dell’intero sistema occupazionale provinciale.
Riproporre oggi la questione della partecipazione sociale degli anziani
consente di mettere a fuoco una serie di questioni concettuali che assumono una rilevanza autonoma per il contributo che possono offrire all’avanzamento degli studi sull’impatto sociale dei processi di invecchiamento nel nostro Paese, e, più in generale, sul rapporto tra soggettività sociale e risposte sistemiche con riferimento ai temi delle forme odierne dell’inclusione e dell’esclusione.
La questione della partecipazione sociale (degli anziani), infatti, chiama direttamente in causa la capacità/possibilità dei soggetti–attori di realizzare compiutamente le loro possibilità di gestire i problemi e le condizioni che sono loro pertinenti (capacità di agire) rapportandosi adeguatamente con le opportunità offerte dal contesto in cui essi si muovono (risorse sociali, istituzioni). La possibilità reale di agire tale capacità in stretto rapporto con
38 Secondo i dati medi provinciali della rilevazione sulle Forze lavoro dell’ISTAT nel 1998.
39 Nei due anni successivi all’indagine. Si deve peraltro ricordare che l’indagine Excelsior non prendeva in considerazione il terzo settore come campo d’indagine.
La partecipazione sociale degli anziani
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
62
le condizioni sociali, oltre che ai vincoli soggettivi (ad esempio, le condizioni di salute), è determinante ai fini della comprensione e individuazione sia dei processi reali di inclusione/esclusione, sia di eventuali nuove dimensioni della coscienza collettiva che prefigurano forse una transizione verso forme non scontate di definizione della sfera pubblica.
Riflettere sulla partecipazione sociale degli anziani significa, dunque, entrare direttamente all’interno della questione del significato sociale più generale della presenza degli anziani nella società, cercando di comprendere appieno se tale significato non sia sottoposto a un processo di depotenziamento per il modo stesso in cui funziona la sfera pubblica.
D’altra parte, le stesse modalità della presenza sociale degli anziani non dipendono solo dalle possibilità di riconoscimento offerte dagli agenti istituzionali, ma anche dalle specificità psico–sociali dell’essere anziani; si tratta allora di studiare il problema ,ancora una volta, dal punto di vista del rapporto tra capacità soggettiva e possibilità oggettiva di agire la partecipazione sociale come fattore di inclusione, di integrazione ed eventualmente, di coesione sociale.
Nonostante la moltiplicazione delle esperienze organizzative degli anziani negli ultimi anni, anche nella Provincia livornese, l’appartenenza ad associazioni da parte della popolazione anziana nella nostra provincia è contenuta attorno al 18%.
Tabella 40. Partecipazione degli anziani ad attività associative per zona socio-sanitaria
- Anno 2001
Fa parte di una o più associazioni? Livornese Val di Cecina Val di Cornia Elba Totale
Si 13,7 43,2 26,5 8,8 18,0
Lo sono stato in passato, ma adesso non più
11,3 2,7 6,5 10 9,0
No 75 54,1 67 81 73,0
Totale 100 100 100 100 100,0
Fonte: OPS, Rilevazione sugli anziani ultrasessantenni L’appartenenza associativa è strettamente collegata con un più elevato
tasso di istruzione, con la più giovane età, con le migliori condizioni di salute e di reddito. Inoltre appare collega ta anche con una migliore rappresentazione del sé sia da un punto di vista psicologico (l’età non è un peso da sopportare) che da un punto di vista intersoggettivo (essere anziani non è considerata un’età inutile). Infine, mostra una maggiore propensione alla partecipazione sociale chi può già disporre di un substrato significativo di reti sociali primarie e secondarie.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
63
Tabella 41. Anziani appartenenti ad associazioni per settore di attività, per zone socio-sanitarie - Anno 2001 - Composizione percentuale
Zone socio–sanitarie Se si, a che tipo di
associazioni appartiene? Livornese Val di Cecina Val di Cornia Elba Totale
Culturale 29,4 18,8 14,8 20 20,2
Ambientalista 2,9 0 5,6 20 5,9
Civile 14,7 12,5 22,2 0 16
Sportivo–ricreativa 11,8 25 25,9 20 21
Religiosa 11,8 0 3,7 6,7 5,9
Socio–assistenziale 29,4 43,8 27,8 33 31,1
Totale 100 100 100 100 100
Fonte: OPS, Rilevazione sugli anziani ultrasessantenni Anche nel caso degli anziani, le forme di partecipazione sociale
prefigurano l’esistenza di dinamiche selettive fondate sia su criteri ascrittivi (i maschi più delle donne, i più giovani rispetto ai più anziani), ma soprattutto di tipo acquisitivo (istruzione, reddito, reti).
La distribuzione degli anziani che partecipa ad attività associative per zone socio–sanitarie, mostra una più alta consistenza in Val di Cecina e in Val di Cornia, mentre nell’area livornese e nella zona elbana la partecipazione degli anziani è molto più contenuta. In linea con quanto già detto in precedenza, l’appartenenza si concentra soprattutto nelle associazioni che svolgono attività di tipo socio–assistenziale, ma si registrano percentuali significative di appartenenza anche alle associazioni culturali e sportivo–ricreative40. In Val di Cornia si regis ta una maggiore appartenenza ad associazioni civili rispetto alle altre zone, mentre nella Val di Cecina è più elevata l’appartenenza ad associazioni di tipo socio–assistenziale. Infine dai dati dell’indagine è possibile evidenziare che le motivazioni più ricorrenti che spingono alla partecipazione negli anziani, sono costituite dalla volontà di rendersi utili agli altri e alla comunità (più della metà delle risposte), e dalla possibilità di mantenersi attivi e informati.
Sono due le dimensioni fondamentali che sostengono la scelta della partecipazione sociale negli anziani: una è quella solidaristica, legata al rendersi utili alla comunità, l’altra è quella più soggettivamente correlata con un bisogno psico–sociale di mantersi attivi, ma soprattutto di sent irsi attivi. Si deve peraltro tener conto delle differenze che emergono a seconda della zona socio–sanitaria considerata: nell’area livornese, infatti, si nota anche la rilevanza assunta dalla voce “conoscere nuove persone”, mentre in quella elbana viene particolarmente enfatizzato l’impegno a risolvere alcune lacune dei servizi pubblici.
40 La domanda D.13 del questionario rivolto agli anziani nella ricerca dell’OPS si
riferiva, in effetti, alla appartenenza associativa in genere – non limitata, ad esempio, alle sole organizzazioni di volontariato.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
64
Tabella 42. Anziani che appartengono ad associazioni per motivazione alla partecipazione, per zone socio-sanitarie - Anno 2001 - Composizione percentuale
Zone socio–sanitarie
Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a partecipare? Livornese Val di
Cecina Val di
Cornia Elba Totale
Voglia di fare qualcosa per gli altri e per la comunità
54,3 57,1 41,2 72,2 51,7
Risolvere alcune carenze dei servizi pubblici
2,9 0,0 7,8 11,1 5,9
Conoscere persone nuove 11,4 0,0 3,9 5,6 5,9
Mantenermi informato e attivo
17,1 28,6 29,4 5,6 22,0
Accrescere la mia cultura 8,6 7,1 3,9 0,0 5,1
Ottenere un riconoscimento sociale
0,0 7,1 5,9 0,0 3,4
Altro 5,7 0,0 7,8 5,6 5,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: OPS, Rilevazione sugli anziani ultrasessantenni Lo stesso tipo di informazioni circa la partecipazione sociale possono essere tratte con riferimento alla popolazione giovanile della Provincia di Livorno. I livelli di tale partecipazione, nei giovani, si collocano non molto al di sopra di quelli visti per la popolazione anziana, cioè attorno al 24%; questi livelli sono più elevati nella zona della Val di Cornia.
Tabella 43. Giovani 15-24 anni per partecipazione ad attività associative, per zona
socio-sanitaria - Anno 2002 - Composizione percentuale
Zona Elba Zona livornese Zona Val di Cecina
Zona Val di Cornia Totale
Si 22,57 21,95 22,86 29,2 23,91 Lo sono stato in passato,
adesso no 4,87 3,66 6,29 4,38 4,46
No 72,57 74,39 70,86 66,42 71,64
Al l 100,00 100 100 100 100
Fonte: OPS, Rilevazione sui giovani Diversamente da quanto emerso per gli anziani, tra i giovani prevalgono
le forme associative di tipo sportivo (39,2%, soprattutto nelle zone elbana e della Val di Cornia), seguite a ruota dal volontariato sociale (22,5%, soprattutto nella Zona livornese e nella Val di Cecina); a due cifre ancora le percentuali relative all’associazionismo culturale (rilevante nella zona elbana). Come si vede, l’associazionismo giovanile è piuttosto diverso da quello degli anziani, poiché maggiormente finalizzato ad attività sportive – ricreative; tuttavia si conferma il radicamento nella provincia del volontariato sociale, anche dal punto di vista della partecipazione giovanile.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
65
Tabella 44. Giovani che svolgono attività associative, per settore di attività e zona socio-sanitaria - Anno 2002 - Composizione percentuale
Zona Elba Zona livornese Zona Val di Cecina Zona Val di Cornia Totale
Culturale 25,45 9,73 4,65 15,85 13,65
Ambientalista 5,45 5,31 4,65 4,88 5,12
Civile 7,27 1,77 2,33 1,22 2,73
Sportiva 40 30,97 39,53 50 39,25
Religiosa 1,82 4,42 13,95 1,22 4,44 Volontariato sociale 16,36 36,28 18,6 9,76 22,53
Politica Partitica 1,82 4,42 2,33 7,32 4,44
Altro 1,82 7,08 13,95 9,76 7,85
Totale 100 100 100 100 100
Fonte: OPS, Rilevazione sui giovani Tra le possibili motivazioni che hanno spinto i giovani a partecipare alle
attività associative, c’è, come del resto negli anziani, la voglia di fare qualcosa per gli altri e per la comunità. Tuttavia, questo riferimento resta abbastanza poco caratterizzato, se si pensa che i riferimenti al miglioramento dei servizi o al cambiamento della società sono offerti da percentuali piuttosto basse di giovani. Se, dunque, si affianca il motivo “altruistico” a quello riferito al farsi nuovi amici, è possibile interpretare l’impegno associativo più come orientato alla costruzione dell’identità individuale e sociale che al raggiungimento di finalità pubbliche a vasto raggio – che comunque raccolgono il 10% circa delle indicazioni.
Anche la voce “altro” è significativa, così come si deve segnalare quel 7% di giovani che pensano che l’esperienza associativa possa contribuire all’acquisizione o all’affinamento di abilità professionali.
Tabella 45. Giovani che svolgono attività associative per motivazione alla partecipazione e zona socio-sanitaria - Anno 2002
Zona Elba Zona livornese
Zona Val di Cecina
Zona Val di Cornia Totale
Voglia di fare qualcosa per gli altri e la comunità 24,07 40,18 33,33 27,16 32,53
Tentare di risolvere alcune carenze dei servizi pubblici 3,7 2,68 2,38 1,23 2,42
Partecipare attivamente a un gruppo che lavora per cambiare la società
9,26 6,25 11,9 8,64 8,3
Possibilità di conoscere Persone che contano
7,41 2,68 2,38 2,47 3,46
Farsi nuovi amici 27,78 25,89 33,33 22,22 26,3 Per migliorare le mie conoscenze Professionali e culturali 1,85 8,04 2,38 12,35 7,27
Ottenere un riconoscimento sociale 1,85 0,89 -- -- 0,69
Facilitarmi l’inserimento nel lavoro 1,85 -- -- 4,94 1,73
Altro 22,22 13,39 14,29 20,99 17,3
Totale 100 100 100 100 100
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
66
Al centro dell’interesse delle riflessioni del capitolo conclusivo, si colloca
il modo in cui le trasformazioni strutturali che attraversano la realtà sociale livornese – e, con essa, quella toscana – si coniugano con le situazioni di benessere/malessere dei cittadini e dei soggetti sociali, in funzione della loro capacità di gestire la propria esistenza in uno scenario di sempre più ampie compatibilità con quelle stesse trasformazioni.
L’impoverimento della capacità d’azione degli individui può essere fonte di disagio e di malessere, entrambi connaturati con le dinamiche sociali che contribuiscono a produrle: “si tratta di capire come le trasformazioni socio–economiche” alterino le possibilità degli attori individuali collettivi di realizzare il proprio benessere, producendo impoverimento delle abilità individuali ed atrofia delle formazioni sociali”41. D’altra parte, le cause del disagio sociale si inseriscono all’interno di interstizi strutturali e di vuoti relazionali di cui è sempre più complesso cogliere l’intima connessione con il malessere dell’esistenza in termini generali e con la sofferenza biografica in termini particolari.
In questo capitolo, dunque, ci si soffermerà sulla descrizione dei luoghi di “debolezza” della realtà sociale territoriale, sulla loro consistenza, ma soprattutto sulla loro qualità, tenendo presente che in questo ambito conoscitivo si dispone di una scarsa quanto frammentaria dotazione informativa, dovuta alla natura stessa dei fenomeni da indagare.
Ma ci si soffermerà anche sulle risposte socio–istituzionali che vengono prodotte per fronteggiare i percorsi di fragilizzazione e di indebolimento della capacità di agire dei singoli e dei gruppi sociali, nel quadro più complessivo del ruolo strategico assunto dai servizi pubblici e dalle reti sociali di sostegno nella costruzione e promozione del benessere della collettività.
Il riferimento a debolezza è uno dei modi possibili per descrivere i punti di criticità nella realtà territoriale, la cui misurazione consente di stimolare costantemente l’attenzione verso la verifica degli interventi condotti in termini di politiche sociali, e di provocare l’individuazione ulteriore di percorsi innovativi da intraprendere in termini di sostegno e promozione.
Le due forme sociali attraverso cui si manifestano i percorsi di fragilizzazione sono quelle del disagio e dei bisogni.
Per “disagio” si intende generalmente uno stato di sofferenza in cui si possono trovare i soggetti in funzione della assenza-carenza-insufficienza, percepita e dichiarata dai soggetti stessi, di specifiche risorse che sono ritenute generalmente congruenti rispetto alle normali condizioni di esistenza del segmento di popolazione cui appartengono.
A questa definizione “operativa” è possibile collegare due “corollari”: il primo riguarda il fatto – solo apparentemente scontato –, che il disagio è relativizzato rispetto ai cicli di vita che si prendono in considerazione,
41 Cfr. F. Ruggeri (a cura di), Progetto per la costituzione di un Osservatorio per le
Politiche Sociali nella Provincia di Massa–Carrara , 1999, p.77.
Cap. 3
Percorsi di fragilizzazione sociale e risposte socio–istituzionali
I bisogni sociali e le risposte dei servizi
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
67
assumendo caratteri propri, dunque, all’interno delle diverse fasce d’età (minori, giovani, anziani) e delle condizioni sociali che attraversano i diversi segmenti di popolazione. Il secondo corollario, di pari importanza ai fini conoscitivi, riguarda la considerazione che ogni soggetto sperimenta la propria condizione di disagio in modo diverso dagli altri anche all’interno di uno stesso segmento di popolazione; tuttavia, una volta individuati i caratteri che connotano gli stati di sofferenza (ad esempio, il disagio economico, quello legato alla salute, la solitudine, ecc...), l’intensità del disagio sofferto sarà direttamente proporzionale al numero di aree (i caratteri, o meglio, secondo la definizione data in precedenza, le risorse) di cui si denuncia la carenza o la insufficienza.
Questa considerazione è importante non solo per finalità definitorie, ma anche e soprattutto per comprendere quanto sia difficile, sul piano dell’intervento, agire sulle cause degli stati di malessere sociale, dato il loro radicamento in processi e situazioni multiproblematiche. La presenza simultanea di più stati di sofferenza genera un processo di rafforzamento reciproco da cui deriva un aumento di intensità della situazione di disagio.
Se il disagio costituisce la dimensione “statica” della fragilità sociale sociale, la sua descrizione sintetica ed “istantanea”, il bisogno implica un processo di identificazione, da parte del soggetto, della causa specifica (o delle cause) della propria sofferenza 42.
Sul piano fenomenico, tra gli ambiti nuovi o di nuova forma attraverso cui si esprimono i bisogni sociali occorre ricordare, per finalità classificatorie:
1. la persistenza della povertà intesa nelle sue modalità di deprivazione delle condizioni materiali di esistenza (fenomeno che in Italia colpisce circa due milioni di famiglie)43;
2. il consolidamento delle cosiddette “nuove povertà” e delle “nuove forme di emarginazione”: le difficoltà economiche e relazionali della popolazione anziana, il disagio adolescenziale e giovanile, le diverse manifestazione delle “dipendenze (alle sostanze illecite, all’alcool, al gioco d’azzardo), l’AIDS, sono divenuti indicatori stabili che segnalano radicate insicurezze sociali;
3. l’emergere di fasce articolate di popolazione che rappresentano un universo eterogeneo di istanze non immediatamente riconducibili
42Sulla definizione di “bisogno” e sulle problematiche connesse alla misurazione dei “bisogni” si veda L. Doyal, J. Gough, Una teoria dei bisogni umani, F. Angeli, Milano, 1999.
43 La fonte principale di informazioni che consente di stimare la povertà di tipo tradizionale è costituita dalla rilevazione sui consumi realizzata dall’ISTAT, che però, data la complessità dell’indagine, non restituisce dati disaggregati a livelli territoriali fruibili per la programmazione locale. Altri esperienze empiriche di recente realizzazione costituiscono forme di approssimazione conoscitiva, che peraltro si concentrano più sugli aspetti qualitativi del fenomeno, piuttosto che su quelli quantitativi. Cfr., ad esempio, ORML, Analisi della povertà in Toscana: stima del menomeno e costruzione di un modello di macrosimulazione per politiche alternative di intervento regionale, FlashLavoro Quaderni n°21, Firenze, 1993 e ORML, Il disagio sociale in Toscana. Ricerca esplorativa per il monitoraggio e le nuove politiche, FlashLavoro Quaderni, n°57, Firenze, 1998.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
68
a deprivazioni materiali o relazionali, ma che sono accomunate da una debolezza negoziale nelle possibilità di acquisizione dei diritti di cittadinanza; qui il riferimento va, ad esempio, alla consistente presenza di immigrati extracomunitari, ma anche ad altre fenomenologie sociali di minor rilievo statistico, come quella dei senza fissa dimora.
Ovviamente i punti descritti non esauriscono il panorama del disagio
sociale, ma sono sufficienti per descrivere l’esistenza di un processo di differenziazione dei bisogni e di una corrispondente frammentazione delle aree di insicurezza e di debolezza. Una tale configurazione – che è dotata, peraltro, di un notevole dinamismo interno – pone costantemente una serie di sfide alla capacità dell’intervento sociale non tanto – e non solo di fronteggiare queste dinamiche per ridurne gli effetti disgregativi sul piano individuale e sociale, ma per prevenirle e per riorientare gli stessi interventi verso forme più consistenti di promozione sociale.
Nonostante tutte le difficoltà attuative ed organizzative ancora in atto,
nella Regione Toscana le politiche sociali sono state caratterizzate dal passaggio graduale dall’impostazione adattivo–riparativa a quella legata alla gestione dei rischi sociali e della promozione sociale. Si dovrà ricordare, ad esempio, il fatto che per sostenere la progressiva de–istituzionalizzazione di alcune aree di disagio (malattia mentale, vecchiaia, infanzia) si è proceduto per rafforzare la responsabilità sociale e comunitaria della presa in carico dei singoli, tentando di sviluppare forme sempre più avanzate di integrazione sia settoriale (integrazione socio–sanitaria) che sociale (costruzioni di reti sociali di sostegno)44.
Un ulteriore elemento da evocare è quello relativo alla territorializzazione della funzione programmatoria (zone socio–sanitarie e piani di zona) e del progressivo decentramento delle funzioni di assistenza, al fine di consentire risposte sempre più adeguate alla configurazione territoriale e locali dei bisogni e forme di coinvolgimento più capillari dei soggetti potenzialmente deputati all’intervento sociale.
Le attuali misure di politica sociale sembrano caratterizzate da un percorso di progressivo “avvicinamento” ai bisogni sociali sia in senso territoriale (decentramento della programmazione e dei servizi) che in quello del contenuto delle risposte (personalizzazione degli interventi).
Da un punto di vista attuativo, i Piani di Zona delle diverse sub–are provinciali del territorio livornese testimoniano di un accentuato dinamismo sia sul piano della capacità progettuale dei soggetti pubblici e del terzo settore, sia su quello del contenuto di innovazione all’interno delle modalità d’intervento.
44 Cfr. i contenuti innovativi già presenti nella legge regionale n°72 del 1997 – che si
ritrovano nella recente legge quadro sull’assistenza sociale n°328 del 2000.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
69
Il tratto comune che connota tutti i documenti di programmazione, è il richiamo al rafforzamento della responsabilità sociale e comunitaria per fronteggiare non solo le forme più consolidate, anche tipologicamente, di esclusione sociale, ma anche per valorizzare forme di “protezione sociale attiva” che si pongano come modalità di “accompagnamento” di tutte le persone che si trovano in situazioni potenzialmente rischiose.
Le dimensioni della fragilizzazione sociale sono descritte, in questo capitolo, ricorrendo soprattutto alla prospettiva offerta dai servizi socio–sanitari per valorizzarne, in parallelo, le capacità e le potenzialità informative. Si tratta di un punto di osservazione particolarmente significativo poiché rende conto, da una parte, della estrema articolazione dei fenomeni e dei soggetti che manifestano esplicitamente situazioni di disagio, dall’altra del cospicuo impegno in termini di risorse e di servizi, che vengono impiegati nell’ambito delle risposte socio–istituzionali a quelle situazioni.
Non si rinuncerà, peraltro, a valorizzare il patrimonio informativo che proviene da altre fonti, come quelle dei soggetti del Terzo Settore, variamente impegnati nell’offerta di servizi rilevante dal punto di vista socio–sanitario; si dovrà solo precisare che tali informazioni costituiscono spesso un sottoprodotto dell’attività delle organizzazioni, per cui non è sempre possibile effettuare controlli di attendibilità e di affidabilità delle informazioni.
D’altra parte, queste prospettive conoscitive possono acquistare senso solo se si inserisce il loro contributo informativo all’interno delle coerenze concettuali e metodologiche offerte dall’Osservatorio Sociale Provinciale.
Il quadro conoscitivo risultante viene qui presentato seguendo un’articolazione coerente con gli ambiti di intervento sociale consolidati, cioè gli anziani, i minori, le famiglie, le disabilità e le dipendenze. A questi ambiti se ne aggiungerà un altro in cui si ricostruirà il fenomeno della presenza degli immigrati extracomunitari e quello della “emarginazione grave”.
L’invecchiamento della popolazione, come si è visto nel Capitolo 1, costituisce senza dubbio uno dei processi strutturali più consolidati nella società italiana e provinciale, con conseguenze non soltanto nel cambiamento della configurazione demografica della popolazione, ma anche nel modo di vivere, negli stili di vita45, nella genesi dei bisogni sociali e nelle forme della loro soddisfazione.
Le ricerche più recenti a livello nazionale e locale, ci restituiscono un quadro informativo che sottolinea le opportunità che possono esser colte anche all’interno dei processi di invecchiamento in termini di riconfigurazione dell’identità individuale e in termini di nuovi significati della presenza sociale dell’anziano. Un recente Rapporto dell’ISTAT
45 Cfr., per gli opportuni approfondimeti, F. Ruggeri (a cura di), Necessità e risorsa. Le coordinate della presenza anziana, F. Angeli, Milano, 1993. Il quadro dei cambiamenti nell’ottica territoriale è stato descritto anche in Ruggeri, Salvini, Anziani a Livorno, op. cit..
Anziani
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
70
sull’età anziana nel nostro Paese, ad esempio, ha messo in evidenza i caratteri di un’età attiva, caratterizzata da buoni livelli di salute almeno nelle età più giovani, da forme di sostegno informale di cui gli stessi soggetti anziani si fanno portatori (supporto alle famiglie dei figli, “essere nonni”, ecc…), da nuove forme di associazionismo e partecipazione sociale. Questi caratteri sono stati confermati anche nell’indagine sugli anziani compiuta in ambito provinciale, tanto da consentire la diffusione dell’idea che quella stessa presenza sociale debba essere considerata, per molte ragioni, una risorsa sociale.
Tuttavia, è noto anche che nell’età anziana si manifestano con una certa rilevanza, situazioni e percorsi biografici connotati da livelli consistenti di disagio e di esclusione. Questi fenomeni non sono tanto, o non solo, correlati con il processo di invecchiamento biologico, ma assumono rilievo in quanto prodotto del modo di essere e di funzionare della società, a livello locale e sovralocale. Le elaborazioni che l’ISTAT diffonde annualmente sulla povertà, descrivono una situazione critica all’interno dell’età anziana, dove in effetti si concentra percentualmente il maggior numero di persone al di sotto della soglia di povertà. Inoltre, assai diffusa, specie nelle realtà urbane e periferiche, la situazione di solitudine e di isolamento di molti anziani, specie donne. Le cause di queste forme di sofferenza sociale sono senz’altro assai articolate e complesse, poiché vi confluiscono fattori di tipo soggettivo (condizione di salute, carattere, ecc…) e oggettivo (condizioni materiali d’esistenza, reti sociali e familiari, ecc…); quello che qui interessa sottolineare è che all’interno del segmento di popolazione anziana si manifestano bisogni piuttosto rilevanti da un punto di vista socio–sanitario, sia sul piano quantitativo che qualitativo.
Un primo sguardo complessivo alle eventuali forme di disagio degli anziani a Livorno, ci offre la possibilità di osservare che per la stragrande maggioranza degli anziani intervistati nell’indagine più volte citata, l’abitazione è considerata adeguata rispetto alle proprie esigenze. Inoltre, acquista particolare rilievo l’indicazione per la quale il disagio abitativo è sensibilmente superiore ai valori medi quando gli anziani vivono in abitazioni isolate e in piccoli gruppi di case lontane spazialmente da paesi o centri urbani; tale indicazione, oltre a descrivere eventuali carenze di tipo strutturale, richiama la coazione tra situazione abitativa e situazione relazionale. In particolare, gli anziani che abitano nelle aree periferiche denunciano maggiori difficoltà abitative. Nella zona livornese i valori di disagio sono leggermente superiori a quelli che si riscontrano in altre zone.
Gli anziani che segnalano una situazione economica soddisfacente (“più che sufficiente” e “adeguata”, nel questionario), costituiscono il 15% del campione. Per il 26% il reddito familiare è considerato “appena sufficiente” rispetto alle proprie esigenze, e dunque si tratta di persone esposte ai rischi di una certa precarietà economica, che obbliga ad una strategia accorta – laddove possibile – nell’utilizzo delle risorse monetarie. Infine, per il 6% degli intervistati, la propria situazione economica è percepita in modo decisamente inadeguato. Le donne segnalano in modo leggermente più
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
71
evidente le difficoltà materiali rispetto ai maschi, così come i soggetti che si collocano nella fascia d’età 75-84. Appare di rilievo il fatto che quattro anziani su dieci all’Isola d’Elba dichiarano di trovarsi in difficoltà economiche, soprattutto se confrontato con il dato livornese, che invece riguarda 2,5 anziani su 10.
Data l’età, può destare qualche perplessità il fatto che solo il 17% del campione denuncia effettive forme di disagio fisico (l’8% dichiara di stare male, il 9% lamenta le “non buone” condizioni di salute). Tuttavia si deve ricordare qui che l’indagine ISTAT Multiscopo del 1998 su “Famiglia e soggetti sociali” ha fornito l’informazione secondo cui il 57,9% degli anziani ultra sessantacinquenni italiani dichiara un buono stato di salute46
Dal punto di vista del disagio relazionale, il 24% del campione di anziani dichiara di passare le proprie giornate prevalentemente da solo, il 35% in compagnia dei familiari e il 40% in altre situazioni relazionali. Ancora una volta, le donne soffrono il problema con un’intensità molto più elevata rispetto agli uomini (rispettivamente il 29% di rispondenti sono prevalentemente sole nel gruppo delle donne e il 18% dei rispondenti sono soli nel gruppo degli uomini).
La condizione di solitudine è più frequente tra gli anziani della fascia 60-74 (14%) rispetto a quanto non accada per le due fasce d’età successive che si attestano sui seguenti livelli: rispettivamente 25% e 20%).
Nel Report di ricerca “Anziani a Livorno” è descritto un indice sintetico di disagio che descrive in forma sintetica, appunto, i valori espressi dagli intervistati nei campi che sono stati appena ora passati in rassegna. In primo luogo si deve osservare che solo per quasi 1/3 della popolazione anziana intervistata (31,1%) si registra un livello di ISD47 inesistente, mentre la metà circa degli intervistati (53%) si colloca nel livello basso; il 10% si colloca nel livello “medio” e il 4,5%48 in quello “alto”.
Una quota significativa di anziani sperimenta la compresenza di almeno tre forme di disagio tra quelle considerate in quell’indagine. Sommati tra loro, questi valori descrivono un quadro secondo cui poco meno del 15% degli anziani intervistati denuncia un livello di ISD medio-alto, per cui si troverebbe in condizioni di disagio socio–economico e relazionale piuttosto consistente.
La differenziazione per genere dei dati ci mostra come le donne denuncino in maggior misura rispetto agli uomini i valori medio-alti di ISD, con una differenza che tocca i 9 punti percentuali. Nell’area delle “città”, i
1 46Il metodo utilizzato dall’ISTAT per misurare la percezione dello stato di salute è quello di far assegnare agli intervistati un voto da 1 a 5 allo stato di salute stesso, considerando 1 come la peggiore condizione e 5 come la migliore. La percentuale citata del 57,9% riguarda gli anziani di 65 anni e più che hanno indicato i voti “4” e “5”.
47 ISD = Indice Sintetico di Disagio. Si rinvia alla lettura di quel Rapporto per la descrizione della metodologia attraverso cui è stato costruito l’indice. 2 48Anche per questo valore segnaliamo la notevole vicinanza con quanto emerso nella ricerca lucchese, nella quale il livello “alto” di ISD era registrato dal 4,3% del campione, mentre nella ricerca massese tale valore era pari al 16,5%.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
72
valori medio-alti dell’ISD sono inferiori rispetto a quelli che si registrano nella zona elbana.
Ancora più consistente è la differenza che si verifica tra soggetti con basso livello di istruzione (o senza titolo di studio) e coloro che hanno anche solo la licenza di scuola media inferiore; la differenza in termini percentuali raggiunge i 12 punti in questo caso e 15 punti tra le due polarità previste per i titolo di studio (senza alcun titolo – laureati).
Tra le persone che vivono da sole i livelli “alti” sono condivisi dal 27% circa dei soggetti, valore assolutamente più elevato di quanto si registra nel caso di coloro che vivono con altri parenti e con il nucleo familiare (9,3%). Si dovrà osservare, dunque, che il trovarsi in famiglia costituisce una condizione che permette la riduzione del rischio di disagio cumulato. La conferma a questo dato deriva dall’analisi dei risultati suddivisi per stato civile, secondo i quali i livelli “alti” di ISD sono consistenti per chi sia divorziato/a (50% sul totale di anziani divorziati) e per chi sia celibe/nubile o vedovo/a (rispettivamente 18% e 24%). Per chi è coniugato, il valore scende a 9% (si ricorda che i valori alti di ISD sono denunciati complessivamente dal 4,6% di anziani). La famiglia nella sua struttura “di base”, quella nucleare e tipica del ciclo di vita subito precedente all’età anziana garantisce effettivamente – dal punto di vista materiale, psicologico, fisico, ecc... – il mantenimento della persona anziana a livello di qualità della vita ancora generalmente accettabili. Le difficoltà aumentano quando il nucleo familiare – anzi, si dovrebbe dire il vincolo di coppia – si spezza; le percentuali di ISD “medio-alto” per gli anziani che vivono con i figli non sposati, con la famiglia del figlio o della figlia, subiscono un incremento considerevole. La rottura del “legame familiare originario”, il trasferimento della propria esistenza in famiglie che non sono la propria, sono uniformità che si riscontrano frequentemente nel caso di anziani con disagi cumulati; la famiglia cessa di costituire il luogo della riduzione del disagio – potremmo definirla, in positivo, la sfera privilegiata del benessere, e diventa, nella sua formazione acquisita e non naturale, un luogo di dipendenza per l’anziano. Questi dati, per sintetizzare, ci permettono di osservare come la probabilità di trovarsi in una condizione di disagio “multi-combinato” (4-5 forme di disagio) aumenta nel caso degli anziani più “vecchi”, delle donne, con titolo di studio basso e che sperimentano situazioni relazionali povere o comunque nelle quali si sperimenti un ruolo di tipo secondario. D’altro canto la famiglia “di base” costituisce un efficace deterrente alla caduta in una condizione articolata e, dunque, grave, di disagio. A questo livello dell’analisi, dunque, l’ISD sembra sensibile alle differenziazioni territoriali: se si eccettuano lievi diversità tra zona livornese e quella della bassa Val di Cecina, nella zona elbana i valori elevati raggiungono il 18,5%.
La risposta dei servizi sociali tende a “coprire” i versanti del disagio più
consistenti, come quello degli anziani non autosufficienti e degli autosufficienti non completamente indipendenti, ma anche quelli che
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
73
favoriscono livelli sempre più elevati di inclusione (sostegno economico e non solo economico alle famiglie, situazione abitativa, ecc…) e di integrazione sociale (promozione delle attività di partecipazione socio–culturale, ricreativa, ecc…). Le persone anziane con più di 65 anni che vivono da sole in Provincia di Livorno sono 20248, di cui quasi la metà nel Comune capoluogo (9243); circa 2/3 è formata da donne.
Tabella 46. Persone anziane che vivono sole, per sesso, comune di residenza e zona socio-sanitaria, Anno 2001
Femmine Maschi Totale Livorno 7353 1890 9243 Collesalvetti 483 129 612 Capraia Isola 14 23 37
Zona livornese 7850 2042 9892 Rosignano M.mo 1741 529 2270 Cecina 1324 295 1619 Castagneto Carducci 411 161 572 Bibbona 0 0 0
Zona Val di Cecina 3476 985 4461 Piombino 2001 452 2453 Campiglia M.ma 493 140 633 San Vincenzo 450 280 730 Suvereto 396 307 703 Sassetta 0 0 0
Zona Val di Cornia 3340 1179 4519 Campo nell' Elba 234 85 319 Capoliveri 0 0 0 Marciana 0 0 0 Marciana Marina 129 34 163 Porto Azzurro 173 72 245 Portoferraio 211 86 297 Rio Marina 197 46 243 Rio nell' Elba 92 17 109
Zona Elbana 1036 340 1376Fonte: OPS, aggiornamento BIS su dati delle anagrafi comunali
In applicazione del principio di de–istituzionalizzazione, nelle zone
socio–sanitarie livornesi si verifica la tendenza a decentrare sempre più i servizi sul territorio, garantendo comunque, livelli di sostegno domiciliare e operando per la riattivazione dei legami familiari e sociali. Tuttavia, le Residenze Sanitarie Assistenziali costituiscono le strutture mediante cui si
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
74
tende a dare risposta alle situazioni più difficili in termini di non autosufficienza o di limitata indipendenza, affiancati dai centri diurni.
Dai dati della Base Informativa Statistica dell’OPS, si apprende che al 31.12.1999, le strutture di ospitalità per anziani erano complessivamente 23, per un totale di 1235 presenze sui 1289 posti disponibili.
Tabella 47. Posti disponibili e presenze in strutture residenziali per anziani - Anno 1999
Posti residenziali Presenze al 31/12
Autosufficienti Non
autosufficienti Totale Autosufficienti Non autosufficienti Totale
Bassa Val di Cecina 181 294 475 179 283 462
Val di Cornia 20 2 112 7 86 93
Elba 34 8 42 37 4 41
Livornese 355 305 660 342 297 639
Totale 590 699 1.289 565 670 1.235
Fonte: OPS, Base Informativa Statistica Se si rapportano i posti disponibili alla popolazione anziana all’interno
delle diverse zone socio–sanitarie, si nota come queste strutture garantiscano 17 posti ogni 1000 anziani nella zona livornese, 27,3 posti in Bassa Val di Cecina, 8 in Val di Cornia e 6,6 all’Elba.
L’indice generale di dotazione strutture per anziani mostra che la copertura di posti garantita dalle RSA e dai centri diurni è pari all’1,8% degli anziani ultrasessantacinquenni nella zona livornese, l’1,0% all’Elba, lo 0,9% in Val di Cornia e il 2,7 in Val di Cecina.
L’altro caposaldo tra gli interventi nei confronti della popolazione anziana è costituito dall’Assistenza Domiciliare Integrata, che si sviluppa in intensità anche diverse all’interno delle zone socio–sanitarie.
Il dato che emerge in alcune zone è che la domanda di inserimento definitivo all’interno delle RSA è in aumento e che, comunque, anche le forme di ADI non riescono a coprire le esigenze di supporto reale agli anziani – anche per le oggettive difficoltà di offrire una risposta continuativa e completa considerando le modalità organizzative dei servizi.
Come si vede dalla tabella sottostante, nelle diverse zone viene garantita una copertura oscillante tra l’1,3% e il 3,0% sul totale della popolazione anziana residente.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
75
Tabella 48. Numero soggetti assistiti con ADI per zona socio-sanitaria
n. di soggetti assistiti % sul totale
zone socio sanitarie Indiretta Diretta Sociale Totale Indiretta Diretta Sociale Totale
Incidenza ADI su 1000 anziani residenti
Bassa Val di Cecina 25 256 89 370 6,8 69,2 24,1 100,0 21,3 Val di Cornia - 319 103 422 - 75,6 24,4 100,0 30,1 Elba 43 14 71 128 33,6 10,9 55,5 100,0 20,7 Livornese 113 276 110 499 22,6 55,3 22,0 100,0 13,0
Fonte: OPS Base Informativa Statistica Di conseguenza, le politiche di decentramento dei servizi necessitano di
un ulteriore spinta verso una duplice forma di integrazione: da una parte l’integrazione nella natura degli interventi (il sociale e il sanitario), dall’altra l’integrazione tra i soggetti che realizzano quegli stessi interventi (servizi professionali e terzo settore). Lo sviluppo delle reti territoriali formali e informali è indicato come un fattore da rafforzare nell’offerta di servizi agli anziani.
Non si deve peraltro dimenticare che è sempre più massiccio il ricorso, da parte degli anziani e delle loro famiglie, a “persone di fiducia” che garantiscano loro una permanenza più ampia e continuativa all’interno dell’abitazione con funzioni di compagnia e sostegno in termini di servizi “leggeri” (pulizia casa, preparazione pasti, cura della persona, ecc…). Questo fenomeno, ovviamente deve essere considerato secondo diverse prospettive – la verifica delle opportune garanzie in termini di competenza, affidabilità, ecc…, il coordinamento tra gli operatori professionali e le “persone di fiducia”, la tutela del lavoro di queste ultime, per il fatto che nella gran parte dei casi si tratta di lavoratori e lavoratrici extracomunitari.
Secondo un’indagine realizzata dalla Comunità di Sant’Egidio sul territorio comunale livornese49, il 10,2% degli anziani intervistati riceve aiuto ed assistenza da parte di una persona straniera – pur in presenza, per molti di essi, di parenti che si occupano di loro. Si tratta soprattutto di anziani al di sopra degli ottant’anni e non autosufficienti, che nel 77,2% ricevono un’assistenza continuativa con la presenza ad orario continuato. Gli immigrati che assicurano questo servizio sono in larga misura donne (90%) e spesso in situazione irregolare rispetto al permesso di soggiorno.
È molto probabile che la domanda di assistenza a casa, come già si era detto in precedenza, sia destinata a salire, stante anche il fatto che gli interventi di assistenza domiciliare non sono sufficienti a coprire le esigenze della popolazione anziana.
Si deve infine accennare al fatto che la stessa configurazione del territorio costituisce un motivo di insorgenza dei bisogni e, nel contempo di ostacolo
49 Questi dati sono stati pubblicati in un documento dal titolo “ho bisogno di te”, nel quale si sostiene l’esigenza di favorire, a livello di politiche pubbliche, l’incontro tra la domanda di assistenza dell’anziano (di tipo personale, a casa), con l’offerta di lavoro da parte di persone extracomunitario – come del resto già avviene (il fenomeno delle cosiddette “badanti”). L’indagine è stata realizzata su un campione di 1254 anziani e viene assicurata la rappresentatività statistica per età e territorio.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
76
all’offerta di servizi: il riferimento va al carattere estremamente frammentato del territorio e degli insediamenti, soprattutto nelle aree rurali, che contribuisce ad accentuare l’isolamento, le difficoltà di spostamento, di trasporto, di informazione e di fruizione dei servizi, dunque di partecipazione e di effettivo esercizio della cittadinanza.
L’ambito dei minori e delle famiglie costituisce un settore piuttosto
dinamico e cospicuo nel territorio provinciale livornese – come del resto in tutta l’area vasta –, stante l’ampio numero di inziative e di interventi che vengono attuati da parte sia dei servizi (soprattutto sul versante socio–assistenziale), sia dalle reti territoriali rappresentate dalle sinergie tra organizzazioni di terzo settore e tra queste e istituzioni (soprattutto sul versante socio–educativo).
Questo particolare dinamismo può essere spiegato ricorrendo ad una serie di fattori tra cui si deve senz’altro ricordare:
§ le caratteristiche dell’età presa in considerazione: si tratta dell’età – piuttosto ampia, in verità, poiché comprende l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza – che per definizione si trova a percorrere i sentieri, spesso accidentati, delle diverse forme di socializzazione (primaria e secondaria): familiare, scolastica, lavorativa; su quest’età si concentrano, dunque, forme di disagio derivanti dal modo in cui quei percorsi si strutturano a livello territoriale e si riflettono effetti perversi di condizioni di sofferenza sociale non direttamente collegabili alle caratteristiche dei singoli soggetti (ad esempio: l’incapacità genitoriale, il disagio economico familiare (per l’infanzia), le difficoltà di integrazione nell’ambiente scolastico, le controverse relazioni tra pari, la scarsa possibilità di fruizione del territorio come luogo di espressività, di partecipazione, di comunicazione e di identificazione, gli ostacoli nell’inserimento lavorativo, l’esposizione a comportamenti a rischio (per gli adolescenti e per i giovani).
§ l’impulso offerto dalla recente legislazione (come la 285 del 1997 e la legge 22 del 1999);
§ la trasversalità delle problematiche coinvolte: intervenire sui bisogni dei minori significa costruire processi di sostegno e di supporto in termini di recupero e di riduzione del danno, ma soprattutto percorsi di prevenzione delle cause del disagio e di promozione del benessere rivolte in via diretta ai minori, ma anche agli adulti, soprattutto in termini di valorizzazione e rafforzamento delle proprie abilità in termini di relazionalità e di responsabilità nei confronti delle generazioni più giovani. D’altra parte nella questione dei minori sono implicate anche istituzioni rilevanti come la famiglia, la scuola, il mercato del lavoro, che impongono la predisposizione di interventi di carattere sistemico volto alla creazione o al rafforzamento di reti territoriali di accompagnamento dei soggetti (minori) nell’affrontare i compiti
Famiglie e minori
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
77
di sviluppo connessi con l’età (ed i rischi oggettivi che ne derivano).
Si deve peraltro osservare che la legge 285/97 afferma con forza il
principio di considerare il bambino (e, per esteso, l’adolescente e il giovane) come soggetto attivo del proprio percorso di crescita; posizione che implica l’attribuzione di un riconoscimento sociale particolare, quanto meno diverso rispetto al passato, ai bambini e agli adolescenti. In primo luogo, tale riconoscimento non postula solo una questione di metodo (coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in forme di progettazione), ma anche una questione sostanziale, in base alla quale essi sono a tutti gli effetti soggetti sociali in grado di porsi come interlocutori significativi rispetto alle diverse sfere sociali. In secondo luogo, quello stesso riconoscimento presuppone il cambiamento di alcuni tratti culturali che hanno caratterizzato sin qui il modo attraverso cui la società si rapporta ai bambini e agli adolescenti. In altri termini, viene posta in questione l’immagine di soggetti che dipendono in tutto e per tutto dagli adulti (senza margini di “costruzione” di alcuna reciprocità nelle relazioni intersoggettive) e che attraversano un periodo di “moratoria” che serve per prepararli a divenire “adulti” (attraverso la scuola, il sostegno familiare quasi senza condizioni, ecc…).
Lo stesso termine che viene utilizzato all’interno dei servizi per individuare quella fascia d’età (minori), se ineccepibile da un punto di vista giuridico (poiché senza dubbio si tratta di persone che non hanno formalmente raggiunto la maggiore età), dal punto di vista sociologico e della considerazione del valore sociale della presenza dei bambini e dei giovani (quindi anche delle politiche sociali) rischia di essere quantomeno contraddittorio.
Le aree di criticità e di fragilizzazione che si riscontrano nell’area dei
minori e delle loro famiglie possono essere particolarmente estese; attraverso l’indagine sui giovani dell’OPS si possono acquisire informazioni su alcune di queste zone di criticità, sebbene riferite agli adolescenti e ai giovani (anche maggiorenni, fino a 24 anni).
In primo luogo si dovrà ricordare che il 9% degli intervistati vive in una famiglia monogenitoriale – valori leggermente superiori alla media provinciale si riscontrano in Val di Cecina –, e non si registrano differenze tra le due fasce d’età.
In linea generale, le condizioni abitative sono considerate adeguate (94% circa) e il 6% dichiara invece condizioni appena sufficienti o inadeguate (anche in questo caso non si riscontrano differenze rispetto all’età).
Rispetto alle condizioni economiche , il 6% dei giovani dichiara che il reddito familiare è assolutamente insufficiente (1,1%) o appena sufficiente (ma non si è in grado di far fronte ad eventuali emergenze(5%); le difficoltà economiche sono relativamente più frequenti, sebbene non di moltissimo rispetto alla media provinciale –, soprattutto nell’area livornese (7,7%) e in quella elbana (7%).
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
78
Accanto a queste informazioni di carattere strutturale, è interessante affiancare anche alcune informazioni di tipo relazionale e soggettivo, che si riferiscono ai bisogni che gli intervistati esprimono circa la percezione del proprio stato di benessere e l’opinione relativa ai problemi principale che vengono vissuti dai giovani.
In primo luogo, si deve dire che il 60% dei rispondenti valuta abbastanza positivamente la propria situazione (“tutto sommato va bene così”); il 10% non è soddisfatto del modo in cui impiega il tempo libero e il 9% della situazione scolastica/lavorativa. Tra le situazioni più critiche si deve segnalare il fatto che l’1,2% dichiara di star esagerando con l’assunzione di stupefacenti (i più esposti sono i maschi rispetto alle femmine, senza particolari differenze tra età) e il 2,2% con l’assunzione di alcolici. Il 4% segnala una condizione di disagio in famiglia, che assume contorni più rilevanti tra gli adolescenti (5,7%) e tra le femmine (5,03%).
Le problematiche emerse dai vissuti riguardano sostanzialmente la relazionalità genitoriale ed amicale, l’insoddisfazione scolastica–lavorativa e quella legata all’impiego del tempo libero. Non irrilevante è la percezione di rischio elevato che si corre attualmente con le sostanze alcoliche e stupefacenti(sommate riguardano il 3,5% dei giovani intervistati). Rispetto a queste ultime problematiche spicca il dato della zona elbana (6,7% dei giovani) mentre per quelle relazionali nella zona livornese i valori sono leggermente al di sopra della media provinciale.
Per quanto concerne i problemi principali di un adolescente – giovane, gli intervistati segnalano con una certa decisione il fatto di non avere ideali e punti di riferimento (32,2%); si tratta di un’indicazione che implica l’esistenza di un sostanziale disorientamento nei processi di costruzione dell’identità dei giovani e della corrispondente assenza del mondo adulto. Il dato assume maggior rilievo se si considera che esso è segnalato in maggior misura dai giovani della fascia d’età più alta e dai maschi. Secondo il 20% dei rispondenti, le problematiche principali riguardano l’assenza di sicurezze sul piano lavorativo ed economico; qui non si registrano differenze di genere, ma forti differenze d’età: la voce è segnalata dal 29,5% di giovani della seconda fascia e dall’9% di quelli della prima fascia. D’altra parte, questo è comprensibile data la diversa configurazione dei “compiti di sviluppo” e dei ruoli sociali che distinguono i due gruppi di giovani.
Vale la pena sottolineare, poi, quel 12,5% di giovani che denunciano il fatto di non essere capiti dagli adulti; una distanza generazionale segnalata soprattutto dagli adolescenti (18%) piuttosto che dai giovani, e il 9,6% di coloro che indicano il conflitto con i genitori (che sono adulti), problema sentito di più dagli adolescenti e dalle femmine. Infine, si segnalerà un 7,4% che denuncia la solitudine dei giovani – non si notano differenze per genere, ma per età, dato che tra gli adolescenti il valore di questa voce arriva al 9,1%. Se si “forza” la lettura del dato relativo all’assenza di punti di riferimento, nel senso della percezione indiretta dell’assenza degli adulti (in quanto effettivi punti di riferimento o “portatori” dei valori), si nota che le problematiche principali che vengono comunicate dai giovani riguardano
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
79
effettivamente il rapporto con le generazioni adulte, soprattutto da coloro che svolgono una funzione educativa. Le situazioni di incomprensione, di conflitto, di indifferenza, di incomunicabilità tra giovani e adulti sono considerate cause del malessere giovanile e adolescenziale, accanto alla più generale insicurezza che connota l’affacciarsi dei giovani al mercato del lavoro. Da una parte, dunque, è bene ricordare che ben il 60% degli intervistati dichiara di essere soddisfatto della propria condizione personale e sociale; dall’altra, si notano punti di estrema criticità che riguardano fattori strutturali (abitativi ed economici: 6% di rispondenti) e soggettivo–relazionali (insicurezza, incertezza, esposizione al rischio, disorientamento), che si incardinano nelle difficili relazioni tra giovani e adulti.
Gli interventi di carattere socio–assistenziale rivolti alla fascia dei
bambini nella provincia livornese riguardano in particolar modo il sostegno alle famiglie e i percorsi di affidamento; si potrebbe sostenere che la famiglia costituisce il centro dell’attenzione dei servizi, stante la rilevanza del contesto familiare nei processi di crescita. Nel primo caso, si tratta sostanzialmente di famiglie che devono fronteggiare uno stress improvviso, contingente e di più varia natura (economico, relazionale, ecc…) e che non riescono a gestire ricorrendo alla proprie risorse interne; nel secondo caso si tratta di situazioni in cui le famiglie esprimono stati di disagio più radicati, riferiti alla presenza di soggetti problematici o di situazioni a rischio, che sono tali da compromettere lo sviluppo psico–fisico del bambino.
Gli obiettivi degli interventi sono orientati a superare l’istituzionalizzazione dei minori, a prevenire le forme di maltrattamento e di abuso dell’infanzia, ma soprattutto a recuperare e a promuovere la capacità genitoriale; senza una particolare attenzione alla genitorialità, al contenimento della conflittualità familiare e alla sua gestione, anche lo strumento dell’affido, per esempio, perde molta parte della sua efficacia e della sua valenza sociale.
Secondo alcuni dati forniti dalla Regione Toscana, si ricava questo schema di sintesi circa gli utenti–interventi per zona socio–sanitaria nell’anno 2000:
Tabella 49. Utenti-interventi per minori e per zona socio-sanitaria - Anno 2000
Minori affidati Utenti dei
presidi semi–ridenziali
Minori presenti in presidi
Minori vittime di maltrattamenti e
abusi Bassa Val di Cecina50 20 50 11 20
Elba 11 0 5 12 Livornese 62 0 17 23 Val di Cornia 6 1 7 6 Totale 99 51 40 61
50 La fonte non distingue tra quella “livornese” e quella “pisana”.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
80
(segue Tab. 49)
Utenti con provvedimenti
pervenuti ai servizi
dall’autorità giudiziaria
Assistenza economica
Assistenza educativa
domiciliare
Mediazione familiare per nuclei con
minori
Bassa Val di Cecina51 24 44 6 10
Elba 0 52 14 60 Livornese 46 118 33 0 Val di Cornia 10 78 11 1 Totale 80 292 64 71
Gli interventi di carattere socio–educativo coinvolgono un vasto orizzonte di obiettivi volti a ridurre il disagio e favorire i processi di socializzazione a livello territoriale. In primo luogo si deve ricordare la crescente importanza assunta dalle strutture educative per l’ infanzia, come gli asili nido – la cui domanda è in continua crescita – e le ludoteche, per favorire la diffusione della funzione educativa del gioco.
Nella provincia livornese queste strutture sono piuttosto diffuse, e si coniugano con una molteplicità di interventi progettuali sostenuti e promossi anche dalle associazioni del terzo settore, mediante i quali si sperimentano forme anche innovative di attività sul piano metodologico e contenutistico (come quelle legate al lavoro di strada in); significative, anche per il valore sociale che assumono, sono le esperienze costruite attorno ai consigli comunali dei ragazzi, sperimentati in diversi comuni, e i laboratori per la continuità educativa.
Ma dal quadro presentato nei piani di zona, il lavoro sociale per i minori e le famiglie costituisce comunque uno degli ambiti più consistenti sul piano del coinvolgimento territoriale, delle risorse impiegate, della progettualità e della realizzazione. Da questo quadro appare chiaro l’orientamento secondo cui difficilmente questi interventi potranno modificare strutturalmente le cause del disagio se non verrà contestualmente intrapreso un più ampio cammino di adeguamento del territorio alle esigenze dell’infanzia e dell’adolescenza (e non viceversa).
La condizione di disagio espressa nell’area della disabilità, riconducibile
all’interno della vasta categoria dell’handicap psico–fisico, è di natura sostanzialmente sanitaria; tuttavia vi sono forti componenti di svantaggio sociale connesse con la presenza di fattori che ostacolano le capacità individuali dei soggetti disabili. Per questo, gli obiettivi degli interventi sociali sono orientati alla promozione dei processi di autonomizzazione dei soggetti, attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e favorendo il raggiungimento di sempre maggiori livelli di possibile autonomia fisica,
51 La fonte non distingue tra quella “livornese” e quella “pisana”.
Disabilità
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
81
psicologica e sociale. Da un punto di vista operativo, gli interventi presuppongono un protocollo di presa in carico e di realizzazione piuttosto articolato, a tutela del rispetto globale dei bisogni dei disabili; il quadro degli interventi si completa con le attività volte all’integrazione scolastica, con le varie misure di supporto alle famiglie, con l’attivazione di reti di collaborazione tra diversi soggetti istituzionali (scuole, servizi, centri diurni, associazioni di volontariato).
I soggetti portatori di handicap nella Provincia di Livorno 52 costituiscono il 6,2‰ circa sul totale della popolazione residente, cioè 2142 persone, di età compresa tra 0 e 64 anni; l’incidenza è leggermente superiore nella Val di Cornia (7,2‰) e all’Isola d’Elba (9,5‰). Gli accertati secondo la legge 104 si distribuiscono in modo un po’ diverso all’interno delle diverse zone socio–sanitarie, secondo percentuali – sul totale delle persone portatrici di handicap – che vanno dal 68% all’Isola d’Elba all’84,7% nella zona livornese.
Si tratta di persone che sono portatrici soprattutto di handicap psichici (55,8% in Bassa Val di Cecina, 35% in Val di Cornia e 38% nell’area livornese – non vi sono dati per l’area elbana), poi di handicap fisici (rispettivamente 27%, 38%, 23%); più circoscritti i casi di handicap sensoriale e i soggetti portatori di handicap plurimi, anche se nell’area livornese raggiungono il 32% sul totale dei soggetti.
All’interno dell’area complessiva della disabilità, si deve collocare la domanda di salute mentale nei confronti dei servizi sanitari e socio–sanitari, domanda che negli ultimi anni è andata crescendo. Le riflessioni condotte all’interno del Dipartimento di salute mentale della Ausl n.6, sulla base del proprio sottosistema informativo53, hanno individuato alcune delle ragioni che sono alla base di questa crescita. Accanto ad alcuni fattori di carattere strutturale (come la chiusura degli ospedali psichiatrici), agiscono processi di carattere culturale legati alla riduzione dei pregiudizi e della stigmatizzazione verso i soggetti, al modo in cui vengono intese, definite e, quindi, riconosciute socialmente le forme psicopatologiche 54.
In effetti, i dati degli utenti venuti in contatto con l’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti dell’AUSL n.6, segnalano un aumento in valore assoluto dal 1997 al 2000, per poi stabilizzarsi nel 2001.
52 I dati sono tratti dalla Base Informativa Statistica dell’OPS e riguardano il 1999. 53 I dati di questo sottisistema informativo sono stati messi a disposizione per la
realizzazione di questo rapporto. Si tratta di una documentazione assai ricca di cui potremo riportare qui solo alcuni spaccati.
54 Queste riflessioni sono contenute all’interno della documentazione giunta all’OPS a corredo dei dati statistici. Si coglie l’occasione per ringraziare il Responsabile del Dipartimento di Salute mentale, Dr. Serrano, anche per queste indicazioni interpretative. Per completare il quadro delle trasformazioni alla base dell’incremento della domanda di salute mentale ai servizi si deve inoltre dire, sempre prendendo spunto da quelle riflessioni, che si sono modificati i vissuti personali rispetto, ad esempio, alle soglie di tolleranza del disagio e dei processi di costruzione dell’identità, e si è parallelamente indebolita la capacità di riferimento offerta dalle reti informali (legami familiari, vicinato, lavoro, ecc…).
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
82
Nella tipologizzazione dell’utenza si deve segnalare il fatto che la percentuale delle donne utenti è relativamente più alta rispetto a quella degli uomini, e che l’età media si colloca attorno ai 50 anni (tende a decrescere leggermente con il passare degli anni; è più alta di qualche anno in Val di Cornia rispetto alle altre zone; è più alta per le femmine piuttosto che per i maschi).
Tabella 50. Utenti UF Salute Mentale Adulta per zona socio-sanitaria - Anni 1997 -
2001
Utenti Zona Livornese Zona Val di Cornia Zona Elbana Zona Val di
Cecina55 1997 2262 1014 528 505 1998 3521 1121 561 645 1999 3545 1115 614 945 2000 3709 1217 737 1075 2001 3453 1357 869 1018
Fonte: UF S.M.A. AUSL 6 Il fenomeno della tossicodipendenza costituisce una realtà in lenta ma
decisa trasformazione, sia con riferimento alla tipologia di consumatori, sia con riferimento alle diverse sostanze assunte. Dal punto di vista dei consumatori, si deve segnalare la diffusione delle cosiddette “nuove droghe” all’interno della realtà giovanile, che non sembrano creare forme di dipendenza e causare effetti deleteri nell’immediato.
In particolare, all’interno del segmento dei giovanissimi, il consumo sembra piuttosto diffuso, specie nelle occasioni di impiego del tempo libero nelle discoteche e nei locali. Le particolari caratteristiche disinibitorie, in grado di influire sulla relazionalità, sulle performance psico–emotive, rappresentano un’attrazione anche per ragazzi e ragazze che non presentano forme di malessere accentuate. Il consumo di queste sostanze si inserisce, per così dire, all’interno delle strategie di gestione delle modalità espressive e relazionali di molti giovani, e della loro capacità di gestione dei rischi.
D’altra parte, non viene meno la dimensione quantitativa delle forme di dipendenza più consolidate e note, come dimostrano i dati diffusi dal Dipartimento Tecnico Dipendenze della AUSL n.6 nella relazione sanitaria 2000–200156.
55 Si ringrazia la Responsabile dell’U.F. S.M.A. di Cecina, Dr.ssa M.L. Piazza, per aver
fornito i dati relativi alla Zona della Val di Cecina. Non sono indicati 316 utenti per i quali manca il riferimento all’età.
56 Relazione a cura dell’Osservatorio Epidemiologico del febbraio 2002.
Le dipendenze
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
83
Tabella 51. Utenti dei Ser.T AUSL n.6 per zona socio-sanitaria
SER.T 1997 1998 1999 2000 2001 Livorno 726 817 865 851 950 Cecina 145 178 216 228 241 Piombino 104 125 181 170 168 Elba 109 108 110 146 162
Gli utenti complessivi dei quattro Ser.T presenti sul territorio provinciale,
negli ultimi cinque anni sono in aumento quasi costante; si tratta di un aumento del 31% a Livorno, del 49% circa all’Isola d’Elba, del 66% a Cecina e del 61% a Piombino.
Tabella 52. Utenti dei Ser.T dell'AUSL n.6 per tipologia di dipendenza e zona socio-
sanitaria - Anni 1997-2001
Ser.T Livorno Ser.T Cecina Ser.T Piombino Ser.T Elba TD ALC GAM TD ALC GAM TD ALC GAM TD ALC GAM 1997 660 66 – – – – – – – – 1998 740 77 – – – – – – – – 1999 738 127 – 167 49 – 148 33 – 93 17 – 2000 726 122 3 174 54 – 139 31 – 128 18 – 2001 798 146 6 186 55 – 128 40 – 142 20 –
La crescita riguarda sia l’utenza tossicodipendente, sia quella
alcoldipendente; quest’ultima fascia di utenti costituisce, nei quattro Ser.T rispettivamente il 15%, il 22%, il 23,8% e il 12% sul totale degli utenti. Si segnala la presenza, tra gli utenti del Ser.T livornese di un certo numero di persone in trattamento rispetto alla dipendenza dal gioco d’azzardo (gambling).
È interessante notare, inoltre, che nel corso degli ultimi anni, l’età media degli utenti si sia gradualmente innalzata, attestandosi nel 2001 tra i 35 e i 36 anni. Si tratta di persone che sono utenti da molti anni e che dunque hanno alle spalle una biografia di dipendenza che è del tutto diversa da quella sperimentata dai giovanissimi. Con riferimento, però, al gruppo degli alcolisti, si deve dire che l’età media è più alta, attestandosi attorno ai 45–46 anni.
Tabella 53. Età media degli utenti dei Ser.T per zona socio-sanitaria - Evoluzione 1997-
2001
SER.T 1997 1998 1999 2000 2001 Livorno 33,3 34,2 34,7 35,7 36,1 Cecina – – 34,5 35,5 35,2 Piombino – – 33 34,1 35,4 Elba – – 34 34,2 36,3
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
84
La tossicodipendenza costituisce ancora un fenomeno prevalentemente maschile, come dimostra la tabella sotostante, anche se in alcuni Ser.T è possibile notare un leggerissimo aumento dell’utenza femminile
Tabella 54. Utenti dei Ser.T dell'AUSL n.6 per sesso - composizione percentuale ed
evoluzione negli anni 1999-2001
Ser.T Livorno Ser.T Cecina Ser.T Piombino Ser.T Elba Maschi Femm Tot Maschi Femm Tot Maschi Femm Tot Maschi Femm Tot 1999 78,8 21,2 865 75,5 24,5 216 80,7 19,3 181 79,1 20,9 110 2000 77,8 22,2 851 75,4 24,6 228 81,2 18,8 170 81,5 18,5 146 2001 76,9 23,1 950 78,8 21,2 241 81 19 168 81,5 18,5 162
Infine, l’andamento dell’utenza per età mostra come le fasce più
numerose siano quelle 20–29 e 30–39, in coerenza con l’andamento delle età medie già visto. È da segnalare, nelle strutture di Livorno e Cecina, l’aumento della fascia dei giovanissimi.
Tabella 55. Utenti dei Ser.T per fasce d'età e zona socio-sanitaria - Evoluzione 1999-2001
Fasce età 1999 2000 2001 15–19 7 8 16 20–29 250 201 215 30–39 394 406 422
Ser.T di Livorno
Oltre 40 214 236 297 15–19 5 7 11 20–29 56 59 60 30–39 107 101 95
Ser.T di Cecina
Oltre 40 48 61 75 15–19 5 10 4 20–29 57 52 45 30–39 91 69 73
Ser.T di Piombino
Oltre 40 28 39 46 15–19 5 6 1 20–29 27 38 39 30–39 58 74 75
Ser.T dell’Elba
Oltre 40 20 28 47
Le attività delle strutture pubbliche e private per fronteggiare il fenomeno
sono numerose, considerando anche gli impegni progettuali di vario genere – dalla prevenzione, al recupero, all’inserimento lavorativo –, realizzati da organizzazioni del terzo settore. Accanto alle presenze nelle comunità terapeutiche e al trattamento scalare attraverso la somministrazione di sostanze come il metadone, si deve segnalare una gran quantità di iniziative sul territorio provinciale che perseguono diverse finalità come:
ü favorire la messa in rete di servizi ü coprire emergenze abitative di utenti
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
85
ü favorire l’inserimento lavorativo ü sportelli/consultori sulle nuove droghe ü attività formative – educative di prevenzione ü lavoro con gli stranieri e i carcerati TD ü ricerca–azione sull’alcolismo ü laboratori teatrali–musicali ü educazione alla salute – alimentazione
Il fenomeno immigratorio nella realtà provinciale, come attestano le
statistiche, deve considerarsi ormai stabile e consolidato; sebbene conservi elementi di elevata dinamicità, la presenza di stranieri extracomunitari costituisce un dato strutturale della nostra società, relativamente irreversibile.
Questo fenomeno, prima di far emergere situazioni di bisogno legate all’accoglienza e all’integrazione, costituisce effettivamente un tratto del divenire delle società, poiché la stessa presenza degli immigrati agisce come un potente fattore di messa in gioco e di ridefinizione delle identità sociali. D’altra parte sulle società locali ricade gran parte della responsabilità operativa di risoluzione dei problemi quotidiani che tale presenza fa emergere. Ed è proprio nella quotidianità che si intersecano i fattori, per così dire, oggettivi, dell’integrazione sociale (il lavoro, la casa) con quelli soggettivi (il progetto migratorio, le relazioni che si costruiscono con la realtà circostante).
Nella realtà provinciale livornese, l’immigrazione è cresciuta con tassi di incremento notevoli: il numero di permessi di soggiorno passa da 3721 nel 1991 a 6249 nel 1999, un aumento del 67%. Anche la popolazione straniera residente cresce considerevolmente, passando da 3153 a 5550 tra il 1992 e il 1999, con un aumento complessivo del 43,2%.
Purtuttavia, l’incidenza della popolazione straniera residente sul totale della popolazione residente è assai circoscritta, pari all’1,7 nel 1999. Questo valore sale a 2,0 nella Bassa Val di Cecina e a 3,1 nella zona elbana; la presenza straniera è particolarmente consistente in alcune aree della provincia, soprattutto nell’area centro–meridionale, come Sassetta (incidenza pari al 20,4%), Capoliveri (8,4%) e Bibbona (3,9%).
La stabilità dei flussi migratori si traduce nella maggiore propensione al ricongiungimento familiare, che a sua volta introduce sul territorio nuovi fenomeni come l’inserimento scolastico dei figli degli immigrati, e la necessità di nuovi servizi come la promozione di politiche interculturali e la promozione e gestione di forme di mediazione culturale tra i gruppi di immigrati e la popolazione locale (ma anche tra gruppi di immigrati stessi).
Il 13,5% tra gli stranieri residenti è composto da minori, che si trovano in misura maggiore nell’area di Collesalvetti, e nel centro–sud della provincia (Bibbona, Sassetta, Portoferraio, Rosignano). A livello di zona socio–sanitaria, comunque, non si notano eccessive differenze (i valori sono compresi tra l’11% dell’Elba e il 14% dell’area livornese). Tuttavia, se
ImmigImmigrazione
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
86
raffrontati ai minorenni residenti complessivi, la maggior incidenza percentuale si riscontra nell’area elbana (2,3%) e in quella cecinese (1,9%).
Nel 1999 si sono avuti, in provincia, 55 nati (a fronte di 10 individui deceduti) e 1029 iscrizioni anagrafiche (a fronte di 503 cancellazioni). La popolazione straniera residente presenta, dunque un certo dinamismo, soprattutto sul fronte del saldo migratorio. Tuttavia, la popolazione straniera residente presenta caratteri piuttosto diversi dalla popolazione straniera cui normalmente ci si riferisce in quanto “immigrati extracomunitari”. Se, da una parte, tra i residenti si possono trovare situazioni regolarizzate di persone provenienti da paesi a forte pressione migratoria (Marocco, Albania, Senegal, Filippine), dall’altra troviamo anche una forte presenza di cittadini europei che si insediano in alcune delle aree più suggestive della provincia; troviamo infatti una nutrita presenza di tedeschi, svizzeri, francesi e inglesi sia in Bassa Val di Cecina che in Val di Cornia, ma soprattutto all’Isola d’Elba.
Se si considerano, invece, i permessi di soggiorno con riferimento al 31.12.2000 e agli individui extracomunitari, notiamo che l’incidenza percentuale sul totale della popolazione residente si riduce all’1,3% – valori che si mantengono elevati soprattutto nei comuni della Val di Cecina e della Val di Cornia.
Naturalmente, le ragioni del rilascio dei permessi di soggiorno riguardano essenzialmente il lavoro (57,5%) e la famiglia (29,2%). È all’Isola d’Elba che si riscontrano valori assai elevati riferiti ai ricongiungimenti familiari, come il 62,5% a Rio Marina, il 60,9% a Marciana Marina, il 51% a Porto Azzurro. Nelle zone urbane e a vocazione agricola – turistica si riscontrano percentuali più elevate rispetto alla media provinciale riferite ai motivi di lavoro (Sassetta: 64,1%, Portoferraio, Piombino, Livorno: 59%).
Non si deve dimenticare, peraltro, che quello degli immigrati costituisce un universo eterogeneo ed articolato, assai differenziato e segmentato al proprio interno, situazione che oggettivamente introduce elementi di complessità anche in fase di intervento sociale. Vi sono alcune nazionalità per cui è evidente che il progetto migratorio si fonda solamente sul lavoro; è il caso, ad esempio, dei senegalesi (98,9% del rilascio dei permessi di soggiorno per ragioni di lavoro), dei/delle filippine (84,5%), dei marocchini (76,4%); percentuale più elevate relativamente ai motivi familiari si riscontrano tra gli individui della Repubblica Dominicana, (60%), di Cuba (79,7%) – sebbene questi ultimi siano numericamente circoscritti.
I servizi per gli immigrati si distribuiscono attorno alle due esigenze
principali che sono richiamate dalle caratteristiche del fenomeno migratorio, cioè quelle dell’accoglienza e dell’integrazione. Sul territorio provinciale sono attivi diversi sportelli per la prima accoglienza e l’orientamento, e sono operanti anche diversittivi progetti per favorire l’integrazione e le occasioni di incontro con il territorio locale.
Attraverso queste strutture è possibile spesso acquisire informazioni che colmano una lacuna conoscitiva evidente circa le caratteristiche dei livelli di
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
87
inserimento e di integrazione della popolazione immigrata, che le statistiche ufficiali non sempre riescono a colmare.
Il Centro Servizi per gli Immigrati “Oltrefrontiera” ha recentemente rilasciato una serie di dati interessanti riferiti agli utenti del Centro e alle attività di informazione, consulenza e accompagnamento che sono state svolte, per il periodo giugno–dicembre 2001.
Si tratta di 245 utenti (il dato è parziale perché non tutti hanno acconsentito a compilare le schede di rilevazione), di cui 174 femmine e 71 maschi, con prevalenza nell’età da 31 a 40 anni e da 41 a 50. Si tratta, dunque, di un’utenza soprattutto femminile e adulta–matura. Le aree di bisogno espresse da questi utenti riguardano la ricerca del lavoro, la regolarizzazione del permesso di soggiorno e la partecipazione a corsi di formazione; non secondarie sono le istanze legate alla condizione abitativa e alle condizioni socio–sanitarie. Sono stati realizzati 407 interventi, di cui 149 di tipo informativo, 202 di intermediazione, 27 di consulenza legale, 26 di accompagnamento e 3 di traduzione. Sono giunte al Centro 38 offerte dirette di lavoro (soprattutto nel campo dei servizi di assistenza agli anziani) a fronte di 131 richieste effettive di lavoro.
Gli utenti appartengono a 36 nazionalità, tra cui spiccano quella italiana, quella marocchina, la peruviana e l’albanese. Alcuni dati di struttura aiutano a comprendere i caratteri fondamentali dell’utenza: si tratta di persone che, in larga parte, posseggono un livello di istruzione medio, alloggiano in affitto o come ospiti, sono in cerca di lavoro, hanno un permesso di soggiorno regolare (anche se vi sono alcuni irregolari).
Dai dati disponibili e presentati, emergono i contorni di un fenomeno che,
pur in evoluzione verso maggiori livelli di presenza quantitativa e verso caratteri che segnalano il relativo consolidamento del flusso migratorio, conserva le problematiche legate alla prima accoglienza e all’inserimento socio–lavorativo. Le problematiche più strettamente collegate ai percorsi dell’integrazione sociale (convivenza tra culture, integrazione scolastica dei bambini, ecc…), pur esistenti, giocano un ruolo di secondo piano rispetto ai bisogni di tipo primario (alloggio, condizioni materiali di esistenza, lavoro); d’altra parte, il modo in cui tali bisogni si presentano e si manifestano dipendono da molte variabili da verificare di volta in volta, come il progetto migratorio degli immigrati, la coesione interna tra i gruppi appartenenti alla medesima nazionalità, le condizioni di partenza.
Questa articolazione della struttura dei bisogni all’interno dell’universo degli immigrati influisce necessariamente sul modo di articolare gli interventi ed impone la costruzione di un monitoraggio conoscitivo specifico, magari valorizzando la capacità osservativa dei diversi “centri” o sportelli che operano sul territorio, come dimostra l’esperienza del Centro Oltrefrontiera, di cui ci sono pervenuti i dati.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
88
Da qualche tempo anche i servizi sociali, in stretto raccordo con alcune organizzazioni di volontariato, stanno assegnando crescente attenzione alle situazioni di povertà ed emarginazione estrema, soprattutto all’interno dei Piani territoriali per il contrasto delle povertà.
In particolare, al centro di tale attenzione si collocano tutti quegli individui che vengono collocati nella categoria dei senza fissa dimora, cioè di quelle persone che vivono in una condizione–limite, all’interno della quale la situazione di grave povertà rappresenta un effetto perverso di processi di esclusione o di scelte di autosclusione.
I soggetti che si definiscono spesso anche “emarginati totali” sono persone che, in sintesi, hanno spezzato o reso esilissimi i legami con il proprio reticolato di rapporti sociali, ed in particolare con i gruppi primari di origine e di riferimento, situazione che determina effetti di tipo psicologico soggettivo, ma anche una oggettiva esclusione da alcuni “centri” significativi (lavoro, abitazione, servizi, istruzione, ecc…).
La figura del “clochard” francese o del “lonesome hobo” statunitense non trova più corrispondenza nelle biografie dei senza fissa dimora che caratterizzano oggi l’emarginazione estrema.
I senza fissa dimora di passaggio compiono un transito secondo tempi molto variabili (per esempio a seconda delle risorse reperibili in città) e costituiscono un fenomeno difficile da affrontare sia dal punto di vista osservativo che da quello dell’intervento sociale. La condizione di vita e di salute dei SFD è spesso piuttosto precaria: l’alcol, l’alimentazione irregolare e insufficiente, le condizioni igieniche sono causa di frequenti malesseri e di disagi, talvolta anche di morte.
Nei singoli percorsi di vita dei SFD è possibile ricostruire un passato in cui i traumi soggettivamente vissuti come determinanti delle scelte di rottura sono riconducibili a:
§ disgregazione della famiglia di origine (specie tra i giovani) e disadattamento complessivo, che ha condotto ad un lento ma graduale distacco, e poi a un rifiuto dell’ambiente originario (spesso accompagnato da assunzione di sostanze stupefacenti, da alcolismo, da microdelinquenza);
§ brusca rottura con la famiglia di elezione (separazione/divorzio, morte del/della coniuge);
§ interruzione di rapporti di lavoro più o meno stabili, forte disagio economico, mancanza (o perdita) di vincoli affettivo relazionali.
Tutto ciò può anche portare cumulativamente ad esperienze di turbamento e squilibrio psicologico, se non addirittura a patologia mentale.
La misura quantitativa del fenomeno dell’emarginazione grave e dei
senza fissa dimora, può essere costruita solo attraverso le stime che provengono dalle strutture che lavorano quotidianamente nell’offerta di servizi, in particolar modo le mense ed i centri d’ascolto.
Ovviamente, data la natura stessa del fenomeno, si tratta di misure approssimative ma comunque rilevanti, anche per il fatto che all’interno di
L’emarginazione grave: il caso dei senza fissa dimora e degli utenti dei Centri di ascolto
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
89
queste strutture si comincia a porre un’attenzione particolare alla metodologia di acquisizione, archiviazione e trattamento dei dati57.
Due di queste strutture hanno reso disponibili i propri dati sull’utenza: si tratta dell’Osservatorio sulle Povertà di Livorno 58 e dei Centri d’Ascolto della Caritas Diocesana di Piombino.
Attraverso questi luoghi di osservazione (oltre che di intervento) sul territorio, è possibile ricostruire uno spaccato assai interessante sulle situazioni di bisogni estremo che si manifestano sul territorio. Ai Centri di Ascolto della Caritas livornese59, nel corso del 2000, si sono rivolte 711 persone, di cui 271 italiani e 440 stranieri; per più della metà (428) si tratta di “primi passaggi”, mentre per altri il ricorso alla Caritas costituisce una sorta di “afferenza” continuativa nel tempo: 137 hanno usufruito di servizi dal 1999 e 120 dal 1998. Si tratta di più di 250 persone che nel corso di due – tre anni si sono riaffacciati ai Centri di Ascolto, segnalando, così, la propria difficoltà a fuoriuscire dalla condizione di bisogno.
Naturalmente, la stessa configurazione dei servizi offerti dalla Caritas, in qualche modo, condiziona anche la “domanda”; in linea generale si rivolgono a questa organizzazione persone che manifestano bisogni di tipo primario, che dunque sono alla ricerca di un sostegno soprattutto di tipo economico. In totale sono stati compiuti ben 2774 interventi, mediante la distribuzione di 9126 buoni pasto, 681 buoni doccia e 2450 buoni guardaroba.
Si tratta, dunque, di persone che vivono in situazione di precarietà esistenziale, sia che si tratti di individui stanziali che di passaggio; si tratta soprattutto di individui maschi, dato che le femmine incidono, sia tra gli italiani che tra gli stranieri, per circa un quarto. È interessante notare, inoltre, che tra gli stranieri sono prevalenti le persone d’età piuttosto giovane (soprattutto 26–35 anni), mentre tra gli italiani vi è un maggior equilibrio di presenze tra le diverse fasce d’età.
Molti di questi individui sono dichiaratamente senza fissa dimora (32% tra gli italiani, 18% tra gli stranieri), mentre una quota attorno al 30% dichiara di avere un domicilio (è piuttosto elevata, su quest’informazione, la percentuale di non risposta – intorno al 40%).
57 Si deve peraltro ricordare che in occasione del recente Censimento della popolazione
del 2001, nella notte tra il 20 e il 21 ottobre scorso si è realizzata una rilevazione ufficiale sui senza fissa dimora all’interno di ogni comune.
58 L’Osservatorio sulle Povertà è un progetto nato in collaborazione tra la Caritas Diocesana e l’Osservatorio ecclesiale con lo scopo di monitorare le situazioni di povertà presenti nel territorio della Diocesi di Livorno. Le modalità di raccolta, di archiviazione e di trattamento dei dati rendono le informazioni rese disponibili attendibili ai fini della comprensione di uno spaccato significativo dell’emarginazione in ambito livornese. In generale la Caritas costituisce un organismo che non solo è legittimamente riconosciuto tra i più credibili ed attivi nel fronteggiamento della povertà, ma anche nell’offerta di informazioni e di punti di osservazione rilevanti sulle modalità di configurazione del fenomeno.
59 I dati che si riportano di seguito sono di fonte Osservatorio sulla Povertà della Diocesi di Livorno.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
90
Sebbene sia alto il numero di persone che transita per una sola volta ai Centri d’Ascolto – soprattutto tra gli stranieri (239, 130 gli italiani) è interessante notare che più di cinquanta persone tra gli italiani e 30 tra gli stranieri, costituiscono frequentatori ricorrenti e spesso “assidui”) dei Centri d’Ascolto. Si tratta di una caratteristica che, in primo luogo, caratterizza gli “stanziali”; ma a questo aspetto si deve aggiungere il fatto che il ricorso alla Caritas è visto come elemento “strategico” nei processi di fronteggiamento della propria situazione di bisogno (talvolta questa strategia si può tramutare in una sorta di cristallizzazione mentale che genera dipendenza assistenzialistica). Il 45% degli utenti italiani ha la propria residenza a Livorno (quindi la “stanzialità” della povertà estrema è un fenomeno piuttosto diffuso), mentre il resto si distribuisce nelle tre ripartizioni geografiche nazionali principali. Tra gli stranieri, ben il 46% si trova in condizione di clandestinità (senza permesso di soggiorno); il 41% proviene dal nord–africa, il 26% dai paesi slavi, il 10% circa dall’est europa e altrettanti dal sud–america.
Infine si dovrà accennare al fatto che dal 1998, i passaggi ai Centri d’Ascolto livornesi sono aumentati considerevolmente, passando da 318 a 470 del 1999, a 711 del 2000 (ed anche gli interventi sono passati da 1750 a 2774 nello stesso periodo di tempo).
Nei due Centri d’Ascolto della Caritas piombinese, i dati mostrano un andamento discontinuo dei passaggi: 114 nel 199660, 113 nel 1997, 84 nel 1998; si tratta, soprattutto, di persone residenti e di immigrati.
Nel 2000, nelle tre strutture d’ascolto piombinesi si sono rivolte 98 persone, di cui 64 stranieri (una delle tre strutture è un ufficio per immigrati, che ha accolto 19 persone). Come si nota, nell’area piombinese nel corso del tempo si è avuta un ribaltamento quantitativo nei passaggi, compiuti più da immigrati e stranieri che non da individui residenti; si tratta soprattutto da persone provenienti dal Marocco, dai paesi slavi e dall’est europeo.
I dati che sono stati presentati offrono uno spaccato interessante del fenomeno dell’emarginazione grave, soprattutto con riferimento alla sua composizione tipologica, all’andamento nel tempo e alla “ricorrenza” del ricorso ai servizi. Purtroppo, dalle informazioni rese disponibili non si è in grado di conoscere più approfonditamente quali siano le caratteristiche socio–economiche e culturali delle persone, e quale sia il contesto di disagio più complessivo all’interno del quale si manifestano i bisogni espressi nei Centri d’Ascolto.
Un ulteriore tassello informativo nel mosaico complessivo che può
consentire la conoscenza del fenomeno dell’emarginazione estrema, è offerto da alcuni dati resi disponibili dall’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno; sono 60 i beneficiari del servizio mensa
60 Vengono inclusi anche i dati del Centro d’ascolto di Follonica, che pur facendo parte della Provincia di Grosseto, appartiene alla stessa Diocesi cui appartiene anche Piombino. Si tratta di dati resi disponibili dalla stessa Caritas Diocesana di Piombino, con l’avvertenza che si tratta, per il periodo 1996–98 di dati parziali.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
91
(adulti a rischio sociale) e di pasti caldi a domicilio (per anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti), mentre 175 sono gli utenti di derrate alimentari crude, segnalate dai vari distretti socio–sanitari comunali.
Si deve notare, in conclusione, che le informazioni attualmente disponibili
per la comprensione del fenomeno dell’emarginazione grave sono ancora parziali e, soprattutto, eterogenee e difficilmente confrontabili, se non all’interno della stessa fonte; inoltre, si integrano difficilmente con il quadro complessivo delle informazioni sul disagio sociale più complessivo.
È importante, dunque, che a partire dalle esperienze positive condotte dalle organizzazioni cui si è fatto riferimento, si possa progettare, in futuro, una forma più completa e pertinente di acquisizione di informazioni, per esempio attraverso attività di formazione avanzata sul piano metodologico e concettuale61.
61 Tenendo ovviamente presente che la finalità principale di queste organizzazioni non è
quella di acquisire dati, ma di offrire servizi. Tuttavia, dovrebbe essere abbastanza chiaro come la raccolta di informazioni sull’utenza possa ben servire al miglioramento della qualità degli stessi servizi offerti.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
92
La breve disamina delle situazioni di bisogno e delle risposte che sono realizzate dai servizi, evidenzia la estrema vitalità della provincia rispetto al ruolo istituzionale nella progettazione – esecuzione degli interventi. In ogni zona, a seconda anche delle specificità emerse esistono servizi di base che, da un punto di vista tipologico, sono in grado di “coprire” l’estrema articolazione dei bisogni e delle istanze sociali.
Vi sono, peraltro, alcuni aspetti per i quali viene richiesta, a livello istituzionale (ad esempio nei “punti di debolezza” previsti nei piani di zona), maggiore attenzione e su cui si richiama ad un maggior sforzo applicativo.
In particolare, si richiama ad un maggior impegno nella realizzazione dei servizi nell’ottica della costruzione di reti di supporto che integrino le risorse che tutti i soggetti coinvolti sul piano territoriale possono offrire. In primo luogo, dunque, si richiede di operare verso maggiori livelli di integrazione non solo con riferimento alla natura settoriale degli interventi (il sociale e il sanitario), ma anche alla co–progettazione degli interventi stessi e al coordinamento operativo. Ferma restando la funzione di governo espressa dagli enti locali, la strategia indicata è quella della creazione di una “comunità competente” in grado di effettuare il monitoraggio delle manifestazione delle sofferenze sociali, ed anche individuarne le cause, per poi attivarsi in processi di “fronteggiamento” partendo dalla valorizzazione delle proprie risorse.
In questo quadro di nuove sfide da raccogliere, l’organizzazione dei servizi sociali a livello territoriale costituisce un punto di riferimento irrinunciabile per l’avvio di nuovi modelli di sperimentazione di intervento e il consolidamento di quelli già intrapresi. Tra le attività innovative che devono essere annoverate all’interno della prassi quotidiana del servizio sociale c’è quella di garantire la costruzione di un assetto documentario in grado di monitorare con sempre maggior attenzione e puntualità l’insieme degli utenti che ad esso si rivolgono, e dei loro bisogni, in modo da approntare politiche sociali e di intervento coerenti.
L’Osservatorio Sociale Provinciale ha da tempo avviato la promozione e la sperimentazione di un sistema di documentazione per la realizzazione di tale monitoraggio mediante la predisposizione di alcune schede intese come strumenti di supporto informativo all’attività degli operatori sociali, finalizzate alla più generale costituzione di un sistema informativo sull’utenza dei servizi sociali. Attualmente, è stato possibile raccogliere sistematicamente ed elaborare le schede utilizzate dai servizi sociali della zona dell’Isola d’Elba62.
Per offrire una prima descrizione della situazione elbana e per favorire una riflessione sulle effettive potenzialità di tali strumenti, si riportano di seguito alcuni dati di una prima elaborazione di tali schede, in attesa di compiere una riflessione più approfondita nelle prossime settimane.
62 Si coglie l’occasione per ringraziare i servizi sociali dell’Isola d’elba per la sensibilità
e la disponibilità dimostrate.
Il monitoraggio degli accessi al servizio sociale: l’esperienza dell’Isola d’Elba
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
93
Si tratta, in primo luogo, di 132 schede relative ad altrettanti utenti che hanno fatto ricorso ai 7 distretti dell’Isola d’Elba, in particolare a quello di Portoferraio, dove si è concentrato il 37% degli accessi. Si deve tener presente che siamo in presenza di “primi accessi” nella gran parte delle situazioni, limitandosi a 10 i casi di utenti per i quali sono già in atto forme di sostegno.
La maggioranza di questi utenti è originaria di aree territoriali esterne all’Isola (53,5%), ma solo 23 sono gli utenti stranieri; vi è equilibrio tra maschi e femmine (si tratta di 67 donne e 63 uomini), mentre piuttosto differenzia ta è la distribuzione degli utenti secondo l’età:
05
10152025303540
Classi di età
Fino a 24 Da 25 a 44 Da 45 a 64 65 ed oltre
Figura 1. Distribuzione per età degli utenti dei servizi sociali dell'Isola d'Elba
Come si noterà, la richiesta che proviene da (o è diretta verso) persone
anziane è piuttosto consistente, ma colpisce anche l’intensità della fascia dei giovani–adulti, che dimostra come a certe condizioni le difficoltà di inserimento a pieno titolo nella vita sociale siano, per una ragione o per l’altra, particolarmente consistenti.
Tra gli utenti prevalgono livelli di istruzione piuttosto bassi, che si riflettono nella attuale situazione lavorativa, che si dispone secondo una tipologia in cui prevale la condizione di disoccupato/a, di pensionato/a, di studenti, di inoccupati, di lavoratori saltuari, di lavoratori autonomi (immigrati).
Solo il 58 casi si registrano condizioni di salute buone, in 31 si segnalano gravi malattie croniche, in 6 malattie gravi non croniche e il 17 malattie non gravi. Si noterà come esistono legami assai consistenti, di cui andrà studiata con maggior attenzione la direzione causale, tra condizioni economiche, condizioni socio–culturali e condizioni di salute – a prescindere dalla condizione, per così dire, anagrafica.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
94
Ancora, 59 utenti (64%) presentano una situazione abitativa idonea, mentre nel 35% dei casi si è in presenza di una condizione abitativa inidonea (vi sono molti valori mancanti); l’inadeguatezza è dovuta sostanzialmente alla mancanza di servizi essenziali, alla presenza di barriere architettoniche, alla ristrettezza, al sovraffollamento.
Ogni caso presenta una particolare situazione di bisogno che viene espressa e puntualmente registrata sulle schede. Ma vi sono alcuni utenti per i quali tale bisogno si radica in una condizione di svantaggio o disagio ulteriore rispetto alla contingenza: si tratta di circa un terzo di utenti per i quali si registrano aspetti ulteriori di problematicità, come l’indigenza, la dipendenza da alcool o stupefacenti, la condizione di clandestinità, l’essere senza fissa dimora, la posizione familiare, ecc…
I problemi che accompagnano l’accesso degli utenti ai servizi ed i bisogni espressi portano con sé caratteri di unicità difficilmente aggregabili in categorie più ampie, senza correre il rischio di una certa genericità. Poiché le schede riportano tali problemi nel dettaglio, e poiché essi hanno caratteristiche individuali, non possono essere qui riportate. Tuttavia si può dire, in prima istanza, che al di là della situazione di svantaggio dovuto ad una disabilità fisica, la gran parte delle situazioni problematiche di contesto sono di natura relazionale ed evidenziano conflittualità matrimoniali – genitoriali, dinamiche familiari difficili sia per ragioni economiche (povertà, indigenza), che per stati particolari di alcuni membri (tossicodipendenza, alcolismo, ecc…).
I bisogni espressi sono riconducibili nelle aree del sostegno economico, dell’assistenza domiciliare, del supporto socio–educativo, di istituzionalizzazione, di miglioramento delle condizioni abitative e lavorative. Al di là di ogni singola storia o bisogno espresso – rispetto ai quali i servizi sono impegnati nell’offerta di risposte il più possibile personalizzate – vi è la configurazione di istanze che segnalano l’esistenza di debolezze strutturali, cui i servizi socio–assistenziali possono dare risposte solo parziali, non per incapacità, ma per la stessa natura delle istituzioni coinvolte, che non nascono per dare risposte alle debolezze strutturali ma a quelle contingenti e individuali.
Tali debolezze sono state incontrate nel corso di questo rapporto, anche se, in realtà, nella descrizione della realtà sociale livornese sono emerse peculiarità e condizioni di segno spesso positivo, soprattutto nell’area della vitalità delle istituzioni pubbliche e della società civile. Si tratta di una vitalità che fonda la propria ragione d’essere proprio sulla capacità di fronteggiare le difficoltà strutturali (si pensi alla situazione economico–lavorativa) mediante la costruzione di reti sociali di solidarietà e di supporto, in grado di realizzare legami strategici tra soggetti diversi.
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
95
Martinelli, A., Chiesi, A.M., La società italiana, Laterza, Roma–Bari, 2002.
Doyal L,. Gough. J, Una teoria dei bisogni umani, F. Angeli, Milano, 1999.
Frisanco R., Ranci C., Le dimensioni della solidarietà. Secondo rapporto sul volontariato sociale in Toscana, FIVOL, Roma, 1999.
Gasperoni G., Diplomati e istruiti. Rendimento scolastico e istruzione secondaria superiore, il Mulino, Bologna, 1996.
ISTAT, Le organizzazioni di volontariato in Italia. Struttura, risorse ed attività, Roma, 1999.
ISTAT, Rapporto Annuale 1996, Roma, 1997. Marshall T.H, Cittadinanza e classe sociale, UTET, Torino, 1976. Messeri A.,. Ruggeri F (a cura di), Quale cittadinanza? Esclusione ed
inclusione nella sfera pubblica moderna, FrancoAngeli, Milano, 2000. Morcellini M., Passaggio al futuro. La socializzazione nell’età dei mass–
media, Angeli, Milano, 1992. ORML, Analisi della povertà in Toscana: stima del menomeno e
costruzione di un modello di macrosimulazione per politiche alternative di intervento regionale, FlashLavoro Quaderni n°21, Firenze, 1993.
ORML, Il disagio sociale in Toscana. Ricerca esplorativa per il monitoraggio e le nuove politiche, FlashLavoro Quaderni, n°57, Firenze, 1998.
Orsi M., Educare alla responsabilità nella globalizzazione. Società della conoscenza e sfide per la scuola, EMI, Bologna, 2002.
Osservatorio Sociale Provinciale, U.O.C. Servizio Sociale, Associazioni di volontariato nella Provincia di Livorno, Livorno, 2002.
Ruggeri F. (a cura di), Progetto per la costituzione di un Osservatorio per le Politiche Sociali nella Provincia di Massa–Carrara, 1999.
Salvini A., Identità e bisogni del volontariato in Toscana, CESVOT, Firenze, 1999.
Salvini, A., Famiglie e fonti statistiche ufficiali. Elementi di sintesi, in M.A.Toscano (a cura di), Ambigui lari. Viaggio nelle penombre della famiglia, Jaca Book, Milano, 1999.
Saraceno C., Le politiche per la famiglia, in Barbagli M., Saraceno C. (a cura di), Lo stato delle famiglie in Italia, il Mulino, Bologna, 1997.
Tomei G., Città, cittadinanza e welfare municipale. Primo rapporto sulle politiche sociali nel Comune di Viareggio”, Mauro Baroni Editore, Viareggio, 2001.
Toscano M.A., Volontariato e rete dei servizi territoriali, Relazione presentata alla II Conferenza Nazionale del Volontariato.
Bibliografia minima
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
96
Questo Rapporto è stato realizzato, come si è detto nell’introduzione, attingendo ai dati raccolti nel corso del tempo dall’Osservatorio per le Politiche sociali della Provincia di Livorno attraverso le diverse forme di rilevazione di informazioni. Tuttavia, la possibilità di acquisire ed elaborare conoscenze su cui riflettere si è concretizzata attraverso la disponibilità e la collaborazione di moltissimi soggetti che operano sul territorio a vario titolo, e che in virtù di tale operatività producono informazioni di vitale importanza per l’OPS. A questi soggetti va il ringraziamento degli estensori del Rapporto e, nel contempo, l’invito a continuare e a consolidare tale collaborazione, sperando che questo prodotto conoscitivo possa stimolare anche altri soggetti a instaurare significative forme di collaborazione con l’OPS stesso. Si elencheranno di seguito i soggetti e gli enti che hanno collaborato, a diverso titolo, alla realizzazione di questo Rapporto attraverso la fornitura di dati e informazioni: ü anziani soli : Uffici Statistica dei Comuni della Provincia di Livorno ü famiglie per componente: Uffici Statistica dei Comuni della
Provincia di Livorno ü istruzione: Uff. Istruzione, Settore 4, Prov. Li ü turismo: Osservatorio turistico prov.le, Prov LI ü competenze residue assistenziali: Uff. Servizi Sociali, Prov. LI ü Inps: sede di Livorno ü Inpdap: sede di Livorno ü Ricerca immigrati – Centro Oltrefrontiera: Centro Servizi per gli
Immigrati Oltrefrontiera ü Centri per l’impiego: Servizio lavoro, settore lavoro e formazione
professionale Prov. LI ü Tabelle immigrati: Ricerca provinciale condotta da CESDI e
Coordinamento delle comunità straniere a Livorno ü Ricerca Terzo Settore: Uff. Servizi Sociali Prov. LI ü Dati Osservatorio Povertà: dati raccolti dal Centro Ascolto Caritas
ed elaborati dall'Osservatorio Ecclesiale della Diocesi di Livorno ü Dati ricerche anziani della Comunità di Sant’Egidio di Livorno ü Modello OPS3 : Uffici Servizi Sociali, Tributi, Istruzione dei
Comuni della Prov. ü Piani Sociali Zonali: Zone socio-sanitarie Provincia di Livorno ü Dati Centri di ascolto Caritas Piombino: Osservatorio della Caritas
Diocesana di Massa Marittima- Piombino ü Dati psichiatria: Sistema informativo Salute mentale adulti, ASL 6 ü Dipendenze: Relazione Sanitaria 2000-2001 SERT ü Imprese ed economia: Ufficio Statistica della CCIAA di Livorno ü Dati del Centro affidi: Centro Affidi del CIAF Edda Fagni, Comune
di Livorno
Elenco delle fonti utilizzate
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
97
Introduzione Capitolo 1 Caratteri e dinamiche strutturali della società livornese Caratteri della struttura sociale
La struttura sociale nelle zone socio – sanitarie Processi recenti Le graduatorie del benessere provinciale
Dinamiche della struttura demografica
La popolazione residente nelle zone socio–sanitarie I processi di invecchiamento L’invecchiamento nelle zone socio–sanitarie
Capitolo 2 Processi e soggetti della cittadinanza sociale Le trasformazioni della famiglia
La graduale disaffezione verso l’istituto matrimoniale La nuclearizzazione delle famiglie Le famiglie nelle zone socio–sanitarie L’adolescenza prolungata e i progetti familiari in Provincia di Livorno
I processi formativi
La scuola nei processi di amplimanto della cittadinanza sociale La fruizione scolastica in Provincia di Pisa La regolarità del percorso scolastico L’esperienza scolastica dei giovani livornesi
L’accesso al lavoro
L’andamento del mercato del lavoro in Provincia di Pisa L’attività dei Centri per l’Impiego La transizione al lavoro
La cittadinanza come partecipazione
Il Terzo settore nella welfare community Le associazioni di volontariato in Toscana e nella provincia di Livorno Caratteri delle associazioni di Terzo Settore in Provincia e nelle zone
socio–sanitarie Terzo Settore e prospettive occupazionali nel territorio livornese La partecipazione sociale degli anziani e dei giovani a Livorno
Indice
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
98
Cap. 3 Percorsi di fragilizzazione sociale e risposte socio–istituzionali I bisogni sociali e le risposte dei servizi
Anziani Famiglie e minori Disabilità Dipendenze Immigrazione L’emarginazione grave: il caso dei senza fissa dimora e degli utenti dei
Centri d’ascolto Brevi note conclusive
Bibliografia minima Elenco delle Fonti utilizzate Elenco delle tabelle
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
99
Tabella 1. Evoluzione della popolazione della provincia di Livorno per
posizione nella professione .................................................................. 10 Tabella 2. Graduatoria del benessere per le province di area vasta........... 12 Tabella 3. Evoluzione della popolazione residente per comune e zone socio-
sanitarie. Valori assoluti anni 1951-2001 ........................................... 14 Tabella 4. Evoluzione della popolazione residente in Provincia di Livorno:
dettaglio per zone socio-sanitarie - Anni 1951 - 2001 - Valori assoluti.............................................................................................................. 15
Tabella 5. Evoluzione della popolazione residente nella Provincia di Livorno: dettaglio per zone socio-sanitarie. Variazioni percentuali Anni 1951-2000.................................................................................... 15
Tabella 6. Movimento della popolazione residente per zona socio-sanitaria al 1999.................................................................................................. 16
Tabella 7. Tassi demografici dell'andamento della popolazione residente per zona (per 1000 abitanti) - Anno 1999 ........................................... 16
Tabella 8. Popolazione residente per alcune classi di età e zona socio-sanitaria - Anno 2000 .......................................................................... 17
Tabella 9. Alcuni indici demografici della struttura per età della popolazione residente per zone socio-sanitarie - Anno 2000 .............. 18
Tabella 10. Popolazione per alcune classi di età e indici demografici per comune di residenza. Anno 2000 ......................................................... 19
Tabella 11. Evoluzione del tasso di nuzialità* nelle Province toscane dal 1993 al 1998......................................................................................... 22
Tabella 12. Evoluzione dell'indice di instabilità familiare* dal 1992 al 1996 nelle province toscane.......................................................................... 22
Tabella 13. Andamento dell'indice di separazione e dell'indice di divorzialità nelle province toscane - Anni 1992-1996 ......................... 23
Tabella 14. Famiglie per tipologia in alcune regioni d'Italia e in Toscana - Anno 1998 – Dati in migliaia............................................................... 24
Tabella 15. Famiglie per tipologia in alcune regioni d'Italia e in Toscana - Anno 1998 - Composizione percentuale – per 100 nuclei familiari della stessa zona............................................................................................ 24
Tabella 16. Nuclei monogenitore per sesso in alcune regioni e in Toscana, di 65 anni e più - Anno 1998 - Dati in migliaia ................................... 24
Tabella 17. Nuclei monogenitore in alcune regioni e in Toscana per sesso - di 65 anni e più - per 100 nuclei monogenitore della stessa regione .. 25
Tabella 18. Persone sole per sesso, di 65 anni e più in alcune regioni e in Toscana - Dati in migliaia ................................................................... 25
Tabella 19. Persone sole per sesso, di 65 anni e più in alcune regioni e in Toscana - per 100 persone sole della stessa regione .......................... 25
Tabella 20. Coppie con donne in età compresa tra 15 e 34 anni per condizione dei partner e alcune regioni - Anno 1998 - Dati in migliaia.............................................................................................................. 26
Elenco delle tabelle
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
100
Tabella 21. Coppie con donne in età compresa tra 15 e 34 anni per condizione dei partner e alcune regioni - per 100 coppie della stessa zona ...................................................................................................... 26
Tabella 22. Evoluzione del numero di famiglie residenti per Comune e zona socio-sanitaria - Anni 1993-2001 ........................................................ 27
Tabella 23. Dimensione media delle famiglie per comune zone socio-sanitarie - Anni 1993-2001 .................................................................. 28
Tabella 24. Variazione percentuale della dimensione media delle famiglie per zona socio-sanitaria - Anni 1993-2001 ......................................... 28
Tabella 25. Coppie con figli per numero di figli ed alcune regioni - Anno 1998 - Dati in migliaia......................................................................... 31
Tabella 26. Coppie con figli per numero di figli ed alcune regioni - Anno 1998 - per 100 coppie con figli della stessa regione ........................... 31
Tabella 27. Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per sesso ed alcune regioni - Anno 1998 - Dati in migliaia.............................................................................................................. 32
Tabella 28. Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per sesso ed alcune regioni - per 100 giovani dello stesso sesso, classe di età e regione - Anno 1998........................................... 32
Tabella 29. Percentuale degli iscritti alla scuola media inferiore sul totale dei ragazzi dello stesso anno d'età - per zona socio-sanitaria - Anno scolastico 1998-99. .............................................................................. 41
Tabella 30. Percentuale di iscritti alla scuola media superiore sul totale dei ragazzi dello stesso anno di età - per zona socio-sanitaria - Anno scolastico 1998-99 ............................................................................... 41
Tabella 31. Distribuzione degli iscritti per tipologia di scuola superiore e per zona socio-sanitaria. Valori assoluti e composizione percentuale 42
Tabella 32. Tasso di occupazione e tasso di disoccupazione nelle province toscane - Medie 1998, 1999, 2000 ....................................................... 48
Tabella 33. Tassi di occupazione e di disoccupazione per età e sesso nelle province toscane - Media 2001 ............................................................ 50
Tabella 34. Attività specifiche dei Centri per l'impiego per la richiesta di lavoro, per la raccolta delle richieste di lavoro, per l'incontro della domanda - offerta - Anno 2001............................................................ 52
Tabella 35. Persone di 14 anni e più che hanno svolto attività gratuita per associazioni di volontariato in alcune regioni - Anni 1993 - 1999 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa regione).............................. 55
Tabella 36. Numero di associazioni iscritte ai registri provinciale e comunale per comune .......................................................................... 58
Tabella 37. Numero di associazioni per zona socio-sanitaria..................... 58 Tabella 38. Organizzazioni di volontariato secondo il periodo di nascita.. 59 Tabella 39. Organizzazioni di volontariato per settore di attività............... 59 Tabella 40. Partecipazione degli anziani ad attività associative per zona
socio-sanitaria - Anno 2001................................................................. 62 Tabella 41. Anziani appartenenti ad associazioni per settore di attività, per
zone socio-sanitarie - Anno 2001 - Composizione percentuale........... 63
Provincia di Livorno – OPS Dipartimento di Scienze Sociali Rapporto Sociale
101
Tabella 42. Anziani che appartengono ad associazioni per motivazione alla partecipazione, per zone socio-sanitarie - Anno 2001 - Composizione percentuale........................................................................................... 64
Tabella 43. Giovani 15-24 anni per partecipazione ad attività associative, per zona socio-sanitaria - Anno 2002 - Composizione percentuale .... 64
Tabella 44. Giovani che svolgono attività associative, per settore di attività e zona socio-sanitaria - Anno 2002 - Composizione percentuale ....... 65
Tabella 45. Giovani che svolgono attività associative per motivazione alla partecipazione e zona socio-sanitaria - Anno 2002 ............................ 65
Tabella 46. Persone anziane che vivono sole, per sesso, comune di residenza e zona socio-sanitaria, Anno 2001 ...................................... 73
Tabella 47. Posti disponibili e presenze in strutture residenziali per anziani - Anno 1999.......................................................................................... 74
Tabella 48. Numero soggetti assistiti con ADI per zona socio-sanitaria .... 75 Tabella 49. Utenti-interventi per minori e per zona socio-sanitaria - Anno
2000...................................................................................................... 79 Tabella 50. Utenti UF Salute Mentale Adulta per zona socio-sanitaria -
Anni 1997 - 2001.................................................................................. 82 Tabella 51. Utenti dei Ser.T AUSL n.6 per zona socio-sanitaria ................ 83 Tabella 52. Utenti dei Ser.T dell'AUSL n.6 per tipologia di dipendenza e
zona socio-sanitaria - Anni 1997-2001................................................ 83 Tabella 53. Età media degli utenti dei Ser.T per zona socio-sanitaria -
Evoluzione 1997-2001.......................................................................... 83 Tabella 54. Utenti dei Ser.T dell'AUSL n.6 per sesso - composizione
percentuale ed evoluzione negli anni 1999-2001 ................................ 84 Tabella 55. Utenti dei Ser.T per fasce d'età e zona socio-sanitaria -
Evoluzione 1999-2001.......................................................................... 84