Percorso tematico Intelligenza · ideogrammi cinesi: se l’individuo che e` nella stanza non ha...
Transcript of Percorso tematico Intelligenza · ideogrammi cinesi: se l’individuo che e` nella stanza non ha...
1
PERCORSO TEMATICO
Intelligenza artificialee filosofia della mente
Nascita dell’I. A.La nascita
dell’I. A.La sigla «A. I.» (Artificial Intelligence), o «I. A.» (Intelligenza artificiale), come si usa scrivere
in italiano, e stata adottata dalla comunita scientifica nel 1956, in occasione di uno storico
seminario interdisciplinare svoltosi nel New Hampshire e promosso da John McCarthy
(1927-viv.), per riferirsi alla progettazione di macchine capaci di prestazioni paragonabili a
quelle umane nello svolgimento di attivita intelligenti, per esempio la risoluzione di pro-
blemi o la comprensione del linguaggio naturale.
I precursori La nascita ufficiale dell’I. A. e stata pero preceduta da un lungo periodo di gestazione. Le
indagini sull’intelligenza artificiale affondano le loro radici nelle tesi filosofiche sostenute gia
da Thomas Hobbes (1588-1679) e da Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), secondo cui
l’intelligenza umana risiederebbe nella capacita di compiere operazioni di calcolo e quindi
meccanizzabili, cioe eseguibili anche da una macchina. Per Hobbes «ragionare non e
nient’altro che calcolare», sommare e sottrarre non numeri ma nomi. Anche Leibniz aveva
sognato di ridurre ogni ragionamento (di qualunque natura, non solo matematico) a un
calcolo, in modo che, per risolvere un problema, diventasse sufficiente prendere la penna e
dire: «calculemus!» («calcoliamo!»). Il filosofo tedesco cerco di trasformare le proposizioni
usate nei ragionamenti in equazioni espresse in un linguaggio simbolico (detto «characte-
ristica universalis»), simile a quello usato dall’algebra, e di fissare delle regole di calcolo
logico («calculus ratiocinator»). Tali studi sono alla base della nascita della logica mate-
matica, avvenuta tra Ottocento e Novecento grazie all’opera di logici come George Boole
(1815-64), Gottlob Frege (1848-1925) e Bertrand Russell (1872-1970). Questa logica,
espressa in un linguaggio simbolico analogo a quello matematico, e diventata poi la logica
utilizzata dai computer.
La macchinadi Turing
AA T1
Nel Novecento un importante passo verso lo sviluppo dell’I. A. e compiuto con l’affermarsi
della cibernetica o scienza degli automi, nata intorno al 1943 grazie agli studi di Norbert
Wiener (1894-1964). Un progetto significativo in questa direzione e rappresentato anche
dalla cosiddetta «macchina di Turing», una macchina astratta, cioe teorizzata ma non creata
dal matematico inglese Alan Mathison Turing (1912-54) nel 1936, in grado di obbedire a
ordini espressi sotto forma di programmi. Composta da una scatola nera capace di eseguire
alcuni compiti, quali scrivere e leggere simboli scritti su fogli, e dotata di una memoria
interna, la macchina di Turing e rivoluzionaria: le macchine calcolatrici progettate fino ad
allora erano costruite per svolgere solo le attivita specifiche per le quali erano state pensate,
quella di Turing invece e una macchina universale, grazie alla quale, per eseguire un nuovo
compito, basta scrivere un nuovo programma.
Il computer non e altro che la realizzazione pratica della macchina di Turing, attuata a
partire dal 1945 da John von Neumann (1903-57), che riuscı a esprimere le istruzioni di un
programma mediante formule proposizionali sintetizzabili tramite circuiti elettrici.
2
L’I. A. forte e l’I. A. deboleI compitidell’I. A.
L’I. A. si occupa della dimostrazione di teoremi, del riconoscimento del linguaggio naturale
scritto e parlato, dell’interpretazione di immagini, della robotica (scienza che cerca di svi-
luppare metodiche che permettano a una macchina di eseguire incarichi specifici), dei
giochi e dei sistemi esperti (sistemi capaci di svolgere compiti diversi come diagnosi, con-
sigli, pianificazioni ecc). Resta tuttora problematico riuscire a dotare le macchine «intel-
ligenti» di «senso comune», ossia di quell’insieme di idee e di credenze, quel background
culturale da cui dipende il nostro concreto rapporto con il mondo.
Il testdi Turing
Gli studiosi di I. A. hanno cercato di stabilire sotto quali condizioni si possa dire che un
calcolatore e simile alla mente umana. Secondo il «test di Turing», un calcolatore e para-
gonabile a una mente umana se, stabilita un’appropriata serie di domande per saggiare le
capacita mentali, una persona esperta non e in grado di distinguere tra le risposte date dal
calcolatore e quelle di un essere umano.
L’I. A. forte Riguardo al significato filosofico dell’intelligenza artificiale, il filosofo statunitense John
Roger Searle (1932-viv.) ha distinto due diverse interpretazioni dell’I. A., una forte e una
debole. Secondo l’I. A. forte, sostenuta da Allen Newell (1927-92) e Herbert A. Simon (1916-
2001), un calcolatore che superi il test di Turing, cioe che imiti i processi tramite i quali gli
esseri umani, ragionando, giungono a fornire determinate risposte a specifici problemi,
sarebbe dotato di una mente vera e propria. Partendo dalla premessa che il pensiero sia una
semplice manipolazione di simboli, i teorici dell’I. A. arrivano cosı a sostenere la possibilita
di creare macchine pensanti.
L’I. A. debole L’I. A. debole, sostenuta da Searle, ritiene al contrario che un calcolatore che abbia superato
il test sia soltanto un ottimo strumento per controllare i nostri ragionamenti, per stabilire in
modo rapido se sono giusti o sbagliati, non una mente che pensa.
Le macchine non pensano poiche non sono in grado di dare un significato ai simboli che
connettono. In particolare, Searle nega che si possa parlare di linguaggio umano a proposito
della macchina, perche questa e solo un ente sintattico (cioe capace di eseguire regole
formali) e non semantico (in grado di comprendere il significato degli atti che compie).
Secondo Searle, il computer puo simulare il pensiero umano, ma non replicarlo.
Il test della stanza cineseL’esperi-
mentomentale
di Searle
AA T2
Per confutare le tesi dell’I. A. forte, Searle ha ideato un singolare esperimento mentale: il test
della stanza cinese. Secondo la tesi forte, il fatto di non essere in grado di distinguere il
comportamento di un computer da quello di un uomo dimostrerebbe che il computer pensa
come un uomo. Per contraddire quest’assunto, Searle suppone che un individuo, che non sa
il cinese, sia chiuso in una stanza. Dall’esterno, alcune persone gli passano dei simboli in
cinese e delle regole – scritte nella sua lingua – che a certi insiemi di simboli ne fanno
corrispondere altri. In base a queste regole, l’uomo restituisce agli individui che stanno fuori
nuovi ideogrammi. L’individuo chiuso nella stanza ignora che i segni ricevuti sono delle frasi
in cinese e che quelli che lui fornisce sono delle risposte appropriate a quelle frasi. Tuttavia,
se segue le regole, il suo comportamento linguistico e esteriormente indistinguibile da quello
di un normale parlante cinese.
Il computernon e
autocosciente
Nel caso descritto dall’esperimento mentale non si puo sostenere che l’uomo chiuso nella
stanza conosca davvero la lingua cinese. L’uomo in questione si limita a eseguire pre-
scrizioni che non capisce. In modo analogo, non si puo dire che conosca davvero il cinese
PERCORSI TEMATICI Intelligenza artificiale e filosofia della mente
3
una macchina che disponga di programmi simili
alle regole che l’uomo segue nella stanza del-
l’esperimento ideato da Searle. Non e vero,
quindi, come pensano i seguaci dell’I. A. forte,
che «se un computer si comporta come se ca-
pisse il cinese, allora il sistema capisce davvero il
cinese». Searle afferma che una macchina, la
quale si limiti a una manipolazione formale di
simboli senza avere coscienza dei loro si-
gnificati, non puo essere considerata identica a
un essere pensante, anche se lo sono le sue
prestazioni esteriori: i computer non sono delle
menti, in quanto privi di coscienza e di capacita
di comprensione.
Il computerpuo
simulare manon replicare
«Nessuno crede che la simulazione al computer
di un incendio fortissimo (five alarm) – scrive
Searle – brucera tutto il vicinato, o che la si-
mulazione di una tempesta ci lascera fradici.
Perche ci dovrebbe essere qualcuno che sup-
pone che la simulazione al computer della
comprensione in realta comprenda qualcosa?
[...] L’errore e sempre la confusione tra simula-
zione e replicazione» (Menti, cervelli e pro-
grammi. Un dibattito sull’intelligenza artificiale, a cura di G. Tonfoni, Milano, Clup-Clueb,
1984, p. 323).
L’esperimento mentale della stanza cinese ha suscitato un ampio dibattito, e sono state
mosse a Searle numerose obiezioni da parte dei sostenitori dell’I. A. forte: per esempio che
nell’esperimento della stanza cinese e l’intero sistema – la stanza piu il suo contenuto – e
non l’individuo a comprendere il cinese. Searle ha pero replicato che non c’e alcun modo
grazie al quale il sistema nel suo complesso possa passare alla reale comprensione degli
ideogrammi cinesi: se l’individuo che e nella stanza non ha nessuna maniera di com-
prendere il significato dei simboli, di conseguenza non l’ha nemmeno l’intero sistema.
Il rapporto mente-corpoMente
e corpoLo sviluppo dell’I. A. ha indotto i filosofi ad affrontare in modo nuovo il problema del
rapporto mente-corpo. Per spiegare tale relazione, ogni epoca ha elaborato le sue metafore:
l’attivita mentale e stata paragonata a una secrezione del cervello, al vapore di una loco-
motiva, a una centrale telegrafica o telefonica e, infine, appunto, a un computer.
Le possibilisoluzioni
L’indagine intorno a questo rapporto e inaugurata dalla filosofia di Platone (427-347 a. C.),
che, nel dialogo Fedone, ha elaborato una concezione dualista secondo la quale l’uomo
sarebbe diviso, appunto, in anima e corpo. In epoca moderna la teoria dualista e stata
ripresa da Cartesio (1596-1650) e, in forme diverse, da Nicolas Malebranche (1638-1715) e
da Leibniz. La questione e stata risolta anche negando il dualismo e ammettendo che esista
una sola sostanza: o soltanto lo spirito (come per gli idealisti da Berkeley a Ficthe, Schelling
e Hegel), o soltanto la materia (come per i materialisti da Democrito a Hobbes e agli
illuministi francesi La Mettrie, Cabanis e d’Holbach). Entrambe le posizioni, idealista e
materialista, implicano pero un’assunzione metafisica difficilmente giustificabile.
Intelligenza artificiale e filosofia della mente PERCORSI TEMATICI
R. Hausmann, Tatlin a casa, 1920, collage(Stoccolma, Moderna Museet).
4
Il dualismo: il dualismo interazionista e l’epifenomenismoIl dualismo
interazio-nista
di Popper-Eccles
AA T3
Nel Novecento, l’ipotesi dualista viene ripresa nella versione interazionista, che ritiene la
mente autocosciente un’entita distinta dal cervello con cui pero interagisce. Tale versione e
sostenuta da John Carew Eccles (1903-97), premio Nobel per la fisiologia e la medicina nel
1963, e dal filosofo della scienza Karl Popper, nel saggio L’io e il suo cervello (1977).
La teoria della mente di Popper ed Eccles si fonda sulla concezione popperiana dei tre
Mondi (il Mondo 1, quello degli organismi viventi e degli oggetti fisici; il Mondo 2, degli
stati mentali; e il Mondo 3, della cultura e delle produzioni intellettuali umane) e afferma
un dualismo fra cervello (che appartiene al Mondo 1) e mente autocosciente (del
Mondo 2). Secondo i due autori l’uomo e la combinazione di queste due entita. La mente
autocosciente, centro della totalita delle nostre esperienze coscienti, controlla i cambia-
menti che si verificano di continuo nelle molecole del nostro corpo e la molteplicita dei
centri del cervello attivi, mantenendo in ogni istante la consapevolezza della propria
identita.
La trascen-denzadell’io
Tuttavia, non sembra che ci sia una parte ben determinata del cervello che corrisponda a
questo io unitario e non e stata ancora sviluppata una teoria neurofisiologica che spieghi
come eventi cerebrali diversi (le singole azioni di innumerevoli neuroni riuniti in «moduli»)
vengano sintetizzati in un’esperienza cosciente unitaria a carattere globale. Eppure l’unita
dell’esperienza cosciente esiste. Secondo i due studiosi, non resta altro che postulare la
trascendenza dell’io rispetto al suo organo materiale, cioe al cervello. Tale soluzione, per
Eccles (ma su questo argomento Popper e piu dubbioso), giustifica l’esistenza dell’anima
anche dopo la morte, svincolandola dalla dipendenza corporea.
L’interazionetra l’io
e il suocervello
La mente, dunque, si distingue dal cervello. Quest’ultimo e solo il tramite grazie al quale essa
comunica con il corpo e con il mondo esterno. Il cervello, appartenente al Mondo 1, e la
mente, appartenente al Mondo 2, interagiscono, attraversando in entrambe le direzioni la
«frontiera» che divide i due mondi. Il dualismo suggerito da Popper ed Eccles non e un
dualismo di sostanze, come in Cartesio, bensı fra due tipi di stati o eventi che entrano in
relazione, dove l’«evento», rispetto alla «sostanza», esprime un maggiore dinamismo, capace
di giustificare meglio l’interazione tra forze diverse.
Le obiezioniall’intera-zionismo
L’interazionismo di Popper ed Eccles e stato accusato di violare la prima legge della
termodinamica, e cioe il principio di conservazione dell’energia. Infatti, l’energia fisica
sembra scomparire dal mondo fisico quando un evento fisico produce un evento mentale,
e comparire nel mondo fisico quando un evento mentale produce un evento fisico. Per
rispondere a tale critica, Popper ed Eccles hanno avanzato due possibili argomenti: se-
condo il primo, la perdita o il guadagno energetico che si verificano in un determinato
punto del cervello sono controbilanciati da un guadagno o da una perdita nelle zone
circostanti; la seconda soluzione prevede, invece, che la prima legge della termodinamica
sia valida non in assoluto, ma solo statisticamente, cosı da giustificare la fluttuazione
dell’energia. Nei suoi ultimi scritti, Eccles ha ipotizzato che la mente immateriale intera-
gisca con la materia tramite fenomeni di natura quantistica, che operano nel pieno ri-
spetto della legge di conservazione dell’energia. I processi indeterministici dei quanti
lascerebbero spazio all’intervento di cause mentali.
L’epifeno-menismo
Un’altra teoria dualista del rapporto mente-corpo e l’epifenomenismo, sostenuto in passato
da Thomas Huxley (1825-95) e oggi da Frank Jackson (1943-viv.) e da Thomas Nagel (1937-
viv.). Gli epifenomenisti pensano che i fenomeni mentali siano delle entita distinte dai
fenomeni materiali. La cosa sperimentata e una realta fisica, ma il fatto di essere speri-
PERCORSI TEMATICI Intelligenza artificiale e filosofia della mente
5
mentata – e cioe l’evento mentale – non lo
e: e un fatto soggettivo, vissuto, relativo a
un punto di vista particolare. Pur essendo
qualitativamente diversi da quelli materiali,
gli eventi mentali sono causati da questi
ultimi: il dolore, per esempio, e provocato
da una lesione dei tessuti. Questo rapporto
causale non va, pero, nella direzione in-
versa: nessun evento mentale puo dare
origine a un evento fisico. La mente e un
«epifenomeno», e qualcosa cioe che in
nessun modo influenza il corpo. Cio si-
gnifica che la capacita di sollevare una
mano (e cioe di agire sull’organismo) e
un’illusione, e un’azione puramente fisica,
solo in apparenza causata dal pensiero.
Huxley ha definito l’epifenomenismo la
dottrina del «fischio della locomotiva»: cosı
come il fischio e causato dal lavoro di una
locomotiva, ma non ha alcuna influenza sul
suo macchinario, analogamente un evento
mentale e causato da un evento materiale,
ma non puo retroagire sulla realta fisica.
Secondo Popper, questa teoria e in contrasto con quella darwiniana dell’evoluzione, la
quale afferma che una struttura si evolve soltanto se contribuisce alla sopravvivenza del-
l’organismo. Ma, se le esperienze coscienti non possono produrre alcun effetto sulla realta
fisica, non lo possono nemmeno sul comportamento adattivo dell’uomo, e cosı non svol-
gono alcuna funzione biologica, sono «inutili». Eppure la coscienza umana si e evoluta, un
fatto che nella prospettiva epifenomenista resta del tutto inspiegabile.
Comportamentismo e teoria dell’identitaIl comporta-
mentismoIn eta contemporanea e stata riproposta anche la soluzione materialista del problema
mente-corpo, nelle forme del «comportamentismo» e della «teoria dell’identita».
Secondo i comportamentisti, gli stati mentali interni non esistono: ogni proposizione in
cui compaiono termini mentali puo essere tradotta in un enunciato formato da vocaboli
riferiti solo a comportamenti fisici oggettivamente osservabili. Come sostiene il comporta-
mentista Gilbert Ryle (1900-76), provare dolore significa avere una tendenza a trasalire, a
gemere, a piangere o urlare. Essere irritati significa avere una disposizione a gridare, a
battere i piedi e a rispondere a chi ci interpella in modo maleducato (vedi Modulo 3, p. 235).
A questa concezione si puo obiettare che non e in grado di distinguere tra una persona che
prova davvero dolore e una che simula di provarlo. Inoltre, riducendo tutti gli eventi mentali
a disposizioni di comportamento, il comportamentismo ignora la straziante sensazione ef-
fettiva del dolore, distinta dalle sue manifestazioni esteriori.
La teoriadell’identita
Un’altra soluzione al problema del rapporto mente-corpo di stampo materialista e la co-
siddetta «teoria dell’identita», sostenuta da Ullin Place (1924-2000) e Jack Smart (1920-
viv.), che afferma la coincidenza degli stati mentali e cerebrali, di mente e corpo. In altri
Intelligenza artificiale e filosofia della mente PERCORSI TEMATICI
Uomo con maschera per esperire la realta virtuale.
6
termini, il pensare si identificherebbe con la particolare attivita che si svolge fra i neuroni,
per esempio credere che piovera coinciderebbe con l’essere in un certo stato neurofisiolo-
gico. Mentre per il dualismo gli enunciati «io spero che tu arrivi presto» (che descrive uno
stato mentale) e «io sono in uno stato cerebrale cosı e cosı» (che descrive uno stato corporeo)
si riferiscono a qualcosa di realmente distinto, a due oggetti diversi (la mente e il cervello),
cosı come rimandano a due oggetti diversi le parole «sedia» e «tavolo», per il materialista si
tratta di due proposizioni che concernono la stessa cosa, cosı come le espressioni «acqua» e
«H2O» si riferiscono al medesimo liquido. Per i sostenitori della teoria dell’identita ci sono
due linguaggi, uno mentalistico e uno fisicalistico, ma un solo oggetto di cui si parla in
entrambi i casi: il cervello.
Le obiezionialla teoria
dell’identita
La principale critica mossa alla teoria dell’identita fa notare che stati mentali e stati ce-
rebrali non possono essere identificati perche non presentano esattamente le stesse pro-
prieta. Vi sono proprieta degli stati fisici che gli stati mentali non possiedono, e viceversa.
Per esempio, gli stati cerebrali sono localizzati spazialmente, nel cervello, mentre gli stati
mentali non lo sono. Un pensiero su mia madre non e situato da qualche parte, come
invece lo stato cerebrale che corrisponde ad esso. Ancora, gli stati mentali sono veri o falsi,
gli stati cerebrali no.
Funzionalismo e connessionismoIl funziona-
lismoGrazie all’analogia mente-computer, si e
diffusa anche una nuova teoria circa il
rapporto mente-corpo, il «funzionalismo»,
sostenuto da Daniel C. Dennett (1942-viv.)
e, per un certo periodo, da Hilary Putnam
(1926-viv.). I materialisti, identificando gli
stati mentali con gli stati cerebrali, esclu-
dono la presenza di stati mentali in tutto
cio che e diverso da noi, dai computer fino
a eventuali esseri alieni di un altro pianeta.
Secondo i funzionalisti, invece, ritenere che
solo gli esseri umani siano in grado di
pensare e una forma di antropocentrismo
discutibile. Per sostenere la tesi che esseri
diversi dall’uomo possano avere stati
mentali, i funzionalisti non identificano gli
stati mentali dell’uomo con quelli cerebrali,
ma con «stati funzionali», cioe con una
certa funzione, un certo processo, in par-
ticolare con la capacita di manipolare
simboli. Una funzione puo essere svolta da
sistemi diversi; per esempio, la capacita
che ha una pompa di spostare liquidi puo
essere messa in opera da una pompa a pi-
stone, oppure da una pompa a ingranaggi,
o ancora da una pompa a pale ecc. Analo-
gamente, la funzione del pensare puo es-
sere eseguita da supporti differenti: da un
PERCORSI TEMATICI Intelligenza artificiale e filosofia della mente
Nell’arte contemporanea il corpo umano e ibrido,contaminato dalla tecnologia, corpo come materiapronta a una metamorfosi permanente.
7
cervello umano, dai circuiti elettronici di un computer, e – perche no? – da un’anima spi-
rituale o da ipotetici cervelli marziani diversi dal nostro.
L’analogiamente-
computer
Per i funzionalisti gli stati mentali sono paragonabili al software (cioe al programma) di un
computer, mentre il nostro cervello e paragonabile all’hardware (ossia alla macchina).
Come i programmi di un calcolatore si possono installare su macchine diverse, cosı le
funzioni mentali non sono intrinsecamente legate a un determinato supporto materiale,
quale il cervello umano con i suoi neuroni (come invece pensano i sostenitori della teoria
dell’identita). Se gli stati mentali dipendono dal modo in cui qualcosa e organizzato, e non
dalla natura di quel qualcosa, allora possono essere prodotti da strutture diverse dal cer-
vello, anche da un’energia spirituale.
Il connessio-nismo
Un’altra recente soluzione del problema del rapporto mente-cervello e presentata dal
connessionismo o teoria delle reti neurali, esposta nel saggio Parallel distributed processing.
Explorations in the microstructures of cognition, scritto da David E. Rumelhart (1942-viv.) e
James L. McClelland (1948-viv.) nel 1986. Secondo il connessionismo, e vero, come pensano
i funzionalisti, che gli stati mentali sono stati funzionali, cioe programmi simulabili anche da
una macchina, ma, d’accordo con la teoria dell’identita, si devono tenere presenti le ca-
ratteristiche fisico-biologiche del cervello umano. I processi cognitivi possono essere ade-
guatamente simulati solo da una macchina la cui struttura sia analoga al nostro cervello, in
cui esiste un elevato numero di connessioni tra le unita neurali, e in cui l’elaborazione dei
dati avviene in parallelo, e non in sequenza (un passo alla volta) come accade invece nei
normali computer. In altre parole, perche una macchina possa riprodurre davvero i nostri
stati mentali, occorre che i suoi processi di elaborazione delle informazioni avvengano
contemporaneamente, interagendo gli uni con gli altri.
Naturalmente, i filosofi spiritualisti negano che una tale macchina, qualora fosse real-
mente costruita come sperano i connessionisti, potrebbe diventare anche autocosciente, in
quanto sostengono l’esistenza di un salto insuperabile, un abisso, tra la materia e lo spirito.
Il dibattito sul rapporto mente-corpo, come ogni genuino problema filosofico, resta
dunque aperto a una molteplicita di possibili soluzioni.
Intelligenza artificiale e filosofia della mente PERCORSI TEMATICI
8
PERCORSI TEMATICI Intelligenza artificiale e filosofia della mente
TESTI A CONFRONTO
Turing: Il test di TuringIl matematico inglese Alan Mathison Turing, nell’articolo Macchine calcolatrici e intelligenza
(1950), propone una verifica pratica che diverra nota con il nome di «test di Turing»: si puo dire
che una macchina pensi quando un interlocutore, che conversi con essa a distanza e per iscritto,
non si accorge che le risposte non sono date da un essere umano. Il test di Turing e il dibattito che
ne e seguito avranno un ruolo notevole nelle riflessioni condotte sull’intelligenza artificiale.
L’opinione di Turing, espressa nel 1950, e che per la fine del secolo i progressi della tecnologia
renderanno naturale parlare di macchine pensanti.
M i propongo di considerare la domanda: «Possono pensare le macchine?». Si
dovrebbe cominciare col definire il significato dei termini «macchina» e
«pensare». Le definizioni potrebbero essere formulate in modo da riflettere il piu
possibile l’uso normale delle parole, ma questo atteggiamento e pericoloso. Se il
5significato delle parole «macchina» e «pensare» deve essere trovato esaminando le
parole stesse attraverso il loro uso comune e difficile sfuggire alla conclusione che
tale significato e la risposta alla domanda «Possono pensare le macchine?» vadano
ricercati in una indagine statistica del tipo delle inchieste Gallup1. Cio e assurdo.
Invece di tentare una definizione di questo tipo sostituiro la domanda con
10un’altra, che le e strettamente analoga e che e espressa in termini non troppo
ambigui. La nuova forma del problema puo essere descritta nei termini di un gioco,
che chiameremo «il gioco dell’imitazione». Questo viene giocato da tre persone, un
uomo (A), una donna (B) e l’interrogante (C), che puo essere dell’uno o dell’altro
sesso. L’interrogante viene chiuso in una stanza, separato dagli altri due. Scopo del
15gioco per l’interrogante e quello di determinare quale delle altre due persone sia
l’uomo e quale la donna. Egli le conosce con le etichette X e Y, e alla fine del gioco
dara la soluzione «X e A e Y e B» o la soluzione «X e B e Y e A». L’interrogante puo far
domande di questo tipo ad A e B: «Vuole dirmi X, per favore, la lunghezza dei suoi
capelli?». Ora supponiamo che X sia in effetti A, quindi A deve rispondere. Scopo di
20A nel gioco e quello di ingannare C e far sı che fornisca una identificazione errata.
La sua risposta potrebbe percio essere: «I miei capelli sono tagliati a la garconne, e i
piu lunghi sono di circa venticinque centimetri». Le risposte, in modo che il tono di
voce non possa aiutare l’interrogante, dovrebbero essere scritte, o, meglio ancora,
battute a macchina. La soluzione migliore sarebbe quella di avere una telescrivente
25che mettesse in comunicazione le due stanze. Oppure le domande e risposte po-
trebbero essere ripetute da un intermediario. Scopo del gioco, per il terzo giocatore
(B), e quello di aiutare l’interrogante. La migliore strategia per lei e probabilmente
quella di dare risposte veritiere. Essa puo anche aggiungere alle sue risposte frasi
come: «Sono io la donna, non dargli ascolto!» ma cio non approdera a nulla dato
30che anche l’uomo puo fare affermazioni analoghe.
Poniamo ora la domanda: «Che cosa accadra se una macchina prendera il posto
di A nel gioco?». L’interrogante dara una risposta errata altrettanto spesso di
quando il gioco viene giocato tra un uomo e una donna? Queste domande so-
stituiscono quella originale: «Possono pensare le macchine?».
1. Gallup: associazione fondata nel 1947 cui partecipano cinquanta societa demoscopiche in altrettanti Paesi, che conduce ricerched’opinione e di mercato su scala mondiale.
TT 1
" Le macchi-ne possono
pensare?
" Il giocodell’imita-
zione
" Entra ingioco unamacchina
9
Intelligenza artificiale e filosofia della mente PERCORSI TEMATICI
35[...] Sara piu semplice per il lettore che io spieghi in primo luogo le mie opinioni
in materia. Consideriamo per prima la forma piu precisa della domanda. Credo che
entro circa 50 anni sara possibile programmare calcolatori con una capacita dı
memorizzazione di circa 109, per fare giocare loro il gioco dell’imitazione cosı bene
che un esaminatore medio non avra piu del 70% di probabilita di compiere l’i-
40dentificazione esatta dopo 5 minuti di interrogazione. Credo che la domanda ini-
ziale: «Possono pensare le macchine?», sia troppo priva di senso per meritare una
discussione. Cio nonostante credo che alla fine del secolo l’uso delle parole e l’o-
pinione corrente si saranno talmente mutate che chiunque potra parlare di mac-
chine pensanti senza aspettarsi di essere contraddetto.
(A. M. Turing, Macchine calcolatrici e intelligenza,
in V. Somenzi - R. Cordeschi [a cura di], La filosofia
degli automi. Origini dell’intelligenza artificiale,
Torino, Boringhieri, 1986, pp. 157-58)
Searle: La stanza cineseIn Menti, cervelli e programmi (1980) il filosofo statunitense John Roger Searle attacca il pro-
gramma dell’I. A. forte, cioe di quella corrente di pensiero che non si limita a considerare il
computer come un utile strumento di studio della mente umana, ma sostiene che, se opportu-
namente programmato, esso e una mente vera e propria, e puo, per esempio, comprendere un
linguaggio. Searle sostiene che le macchine sono in grado di manipolare sintatticamente simboli,
ma non di interpretarli (cioe di comprenderne il significato, o di attribuirgliene uno): solo il
cervello umano e capace di questa attivita definita «intenzionale». L’argomentazione di Searle e
suffragata da un esperimento mentale ormai famoso e molto discusso, quello della «stanza
cinese», esposto qui di seguito.
S upponiamo che mi trovi chiuso dentro una stanza e che abbia un grande blocco
con degli ideogrammi cinesi. Supponiamo inoltre, cosa che per altro e vera, che
io non conosca il cinese ne scritto ne parlato, e che non mi senta neanche molto
sicuro di poter riconoscere ideogrammi cinesi in quanto tali e distinti, diciamo, da
5ideogrammi giapponesi o da scarabocchi senza significato. Supponiamo adesso che
dopo questo primo blocco di ideogrammi cinesi, mi venga dato un secondo blocco
di scritte cinesi e, con questo, un insieme di regole per correlare il secondo blocco
con il primo. Le regole sono in italiano ed io capisco queste regole come le capi-
rebbe qualunque altro parlante madrelingua italiano. Esse mi permettono di cor-
10relare un insieme di simboli formali con un altro insieme di simboli formali, e qui
«formale» non significa altro che io posso identificare i simboli esclusivamente
mediante la loro forma. Supponiamo ora che mi venga dato un terzo blocco di
simboli cinesi assieme con alcune istruzioni, di nuovo in italiano, che mi mettono
in grado di correlare gli elementi di questo terzo blocco con quelli dei primi due, e
15queste regole mi istruiscono anche su come rispedire indietro certi simboli cinesi
con una certa forma, in risposta a certi tipi di forme datemi nel terzo blocco. A mia
insaputa, le persone che mi stanno dando tutti questi simboli, chiamano il primo
blocco «una scrittura», il secondo blocco «una storia» ed il terzo blocco «domande».
Inoltre, i simboli che rimando indietro in risposta al terzo blocco li chiamano
20«risposte alle domande», mentre l’insieme delle regole in italiano che mi hanno
dato viene detto «il programma». Tanto per complicare un po’ la faccenda, im-
" Alla finedel
Novecentonasceranno
le macchinepensanti
TT 2
"Dentrola stanza
cinese
10
PERCORSI TEMATICI Intelligenza artificiale e filosofia della mente
maginiamoci che queste persone mi diano anche delle storie in italiano che io
capisco, e mi pongano delle domande in italiano su queste storie, ed io gli dia delle
risposte in italiano.
25Supponiamo inoltre che dopo un po’ di tempo io diventi cosı bravo nel seguire le
istruzioni per manipolare i simboli cinesi ed i programmatori cosı bravi nello
scrivere i programmi che, dal punto di vista esterno, ossia dal punto di vista di
qualcuno al di fuori della stanza dove sono rinchiuso, le mie risposte alle domande
siano indistinguibili da quelle che darebbe un parlante madrelingua cinese. Nes-
30suno, osservando le mie risposte, potrebbe dire che io non parlo una sola parola di
cinese. Supponiamo anche che le mie risposte alle domande poste in italiano siano,
come senza dubbio sarebbero, indistinguibili da quelle di qualunque altro parlante
madrelingua italiano, per la semplice ragione che io sono un parlante madrelingua
italiano. Dal punto di vista esterno, dal punto di vista di qualcuno che legge le mie
35«risposte», le risposte alle domande in cinese e quelle alle domande in italiano sono
egualmente valide. Ma nel caso del cinese, a differenza di quello dell’italiano,
produco le risposte manipolando simboli formali non interpretati. Per cio che ri-
guarda il cinese, mi comporto semplicemente come un computer: eseguo opera-
zioni computazionali su elementi specificati formalmente. Per cio che riguarda il
40cinese, io sono semplicemente una istanziazione del programma per computer.
Ebbene, le affermazioni fatte dall’intelligenza artificiale forte sono che i com-
puter programmati comprendono le storie e che il programma, in un qualche
senso, spiega la comprensione umana. Siamo ora nella condizione di poter esa-
minare queste affermazioni alla luce del nostro esperimento ideale.
45Per quanto riguarda la prima affermazione mi sembra ovvio che nell’esempio io
non capisco una sola parola delle storie raccontate in cinese. Ho degli input e degli
output che sono indistinguibili da quelli di un parlante madrelingua cinese, e potrei
avere qualunque programma formale volete, ma non capiro ancora nulla. Per le
medesime ragioni, il computer di Schank1 non comprende nulla di qualunque
50storia, sia essa in cinese, in italiano, o in un’altra lingua qualsiasi, poiche nel caso
del cinese questo sono io; e nel caso in cui il computer non sono io, il computer non
ha nulla di piu di quanto non avessi io nel caso in cui io non capivo niente.
Per cio che concerne la seconda affermazione – che il programma spiega la
comprensione umana – possiamo vedere che il computer ed il suo programma non
55forniscono condizioni sufficienti al comprendere, in quanto computer e pro-
gramma funzionano ma non c’e alcuna comprensione. Ma il programma fornisce
almeno una condizione necessaria o un contributo significativo al comprendere?
[...] Posso ammettere tutto questo come possibilita empirica, ma sino ad ora non ho
avuto la benche minima ragione per supporre che cio sia vero, poiche quello che e
60stato suggerito – anche se non dimostrato dall’esempio – e che il programma per
computer non e pertinente con la mia comprensione della storia. Nel caso del
cinese, ho tutto quello di cui l’intelligenza artificiale puo fornirmi sotto forma di
programma, ma non capisco nulla; nel caso dell’italiano capisco tutto quanto, e al
punto in cui siamo non c’e alcuna ragione che ci porti a supporre che la mia
65comprensione ha qualcosa a che fare con i programmi per computer – cioe, con
operazioni computative su elementi specificati in via puramente formale.
(J. R. Searle, Menti, cervelli e programmi. Un dibattito sull’intelligenza artificiale,
a cura di G. Tonfoni, Milano, Clup-Clueb, 1984, pp. 48-50)
1. R. C. Schank: studioso americano dei problemi dell’intelligenza artificiale. Tra le sue opere, ricordiamo Il computer cognitivo (Firenze,Giunti, 1989).
" Il paragonecon un
computer
11
Intelligenza artificiale e filosofia della mente PERCORSI TEMATICI
Eccles: Il dualismo interazionistaNell’ambito della filosofia della mente, il neurofisiologo australiano John Carew Eccles ha scritto
con il filosofo austriaco Karl Popper il saggio in tre volumi L’io e il suo cervello (1977), in cui e
ripresa, in termini nuovi, l’ipotesi cartesiana del dualismo mente-corpo. Nel saggio riportato qui
di seguito, La meraviglia di essere uomo (1984), Eccles riassume le tesi sostenute nell’opera. La
mente autocosciente e ritenuta da Eccles un’entita indipendente dal cervello. La mente controlla
la molteplicita dei centri attivi nell’emisfero cerebrale dominante, cercando di realizzare in ogni
istante l’unita dell’esperienza cosciente. Quest’ultima, infatti, non deriva, come ritengono i
materialisti, da una sintesi finale svolta dal meccanismo dei neuroni del cervello, ma, appunto,
dall’azione integrativa della mente.
[a] Ciascuno di noi fa continuamente esperienza di essere una persona dotata di
autocoscienza, non solo consapevole, ma che sa di sapere.
Per definire la persona voglio citare due affermazioni mirabili di Kant: «Una
persona e un soggetto che e responsabile delle proprie azioni»; e: «Una persona e
5qualcosa che e consapevole in tempi diversi della identita numerica del suo io».
Queste affermazioni, minimali e fondamentali, possono essere enormemente svi-
luppate.
[b] I danni al cervello possono colpire la personalita umana? Quando consideriamo
il cervello come la sede della personalita consapevole, vediamo che grandi parti di
10esso non sono essenziali. Per esempio, la rimozione del cervelletto rende molto
difficoltoso il movimento, ma la persona non ne e colpita sotto altri aspetti. La cosa
e ben diversa per la parte principale del cervello, i due emisferi cerebrali; essi sono
intimamente correlati alla consapevolezza della persona, ma non in modo eguale.
Nel 95% delle persone c’e una dominanza dell’emisfero sinistro, che e l’emisfero del
15linguaggio. Tranne che nell’infanzia, la sua rimozione da luogo a una distruzione
quasi radicale della personalita umana, ma non al suo totale annullamento. D’altra
parte, la rimozione dell’emisfero minore (di solito il destro) e accompagnata da una
perdita di movimento della parte sinistra (emiplegia) e dalla cecita dell’occhio si-
nistro (emianopia), ma la personalita non ne risulta danneggiata gravemente.
20Danni ad altre parti del cervello possono ugualmente colpire in modo grave la
personalita umana, potendo dar luogo alla rimozione degli input neurali che nor-
malmente costituiscono l’attivita base necessaria per gli emisferi cerebrali. L’e-
sempio piu tragico e il coma vigile, nel quale una persistente profonda incoscienza
e causata dal danneggiamento del mesencefalo1.
25[c] Potrebbe sembrare che una spiegazione esauriente dello sviluppo della persona
umana sia fornibile esclusivamente in termini di cervello umano. Esso e costruito,
dal punto di vista anatomico, in base a istruzioni genetiche e si sviluppa dal punto
di vista funzionale attraverso l’apprendimento delle influenze ambientali. Una
spiegazione puramente materialista sembrerebbe pertanto sufficiente, definendo le
30esperienze consapevoli come derivati del funzionamento del cervello.
[d] Ma e un errore ritenere che sia il cervello a far tutto e che le nostre esperienze
consapevoli siano semplicemente un riflesso delle attivita del cervello, il che rap-
presenta oggi un punto di vista filosofico. Se cosı fosse, il nostro io consapevole non
sarebbe altro che uno spettatore passivo delle attivita svolte dai meccanismi neurali
1. mesencefalo: segmento intermedio dell’encefalo che, nei vertebrati, presiede alla coordinazione dei movimenti associati degli occhi e altono muscolare.
TT 3
" Il concettodi «persona»
" La spiega-zione mate-
rialista
12
PERCORSI TEMATICI Intelligenza artificiale e filosofia della mente
35del cervello. Il ritenere che possiamo realmente prendere decisioni e che siamo in
grado di esercitare un controllo sulle nostre azioni non sarebbe, di conseguenza,
altro che illusione.
[e] Naturalmente sono in circolazione innumerevoli forme di sottile dissimulazione
da parte dei filosofi per velare una asserzione cosı esplicita: ma essi non vogliono
40arrivare alle estreme conseguenze. In realta tutti, ed anche i filosofi materialisti, si
comportano come se avessero almeno qualche responsabilita per le loro azioni.
Sembra che la loro filosofia sia per gli altri, non per loro stessi, come acutamente
affermo Schopenhauer. Queste considerazioni mi portano all’ipotesi alternativa
interazionista dualista, che e stata ampiamente sviluppata da Popper e Eccles in
45The Self and its Brain. E proprio il senso comune a dire che siamo una combina-
zione di due cose o entita: il nostro cervello da una parte e il nostro io cosciente
dall’altra. L’io (o se) e il centro della totalita delle nostre esperienze coscienti, come
persone, per tutta la durata dell’esistenza consapevole. Lo leghiamo nella memoria
fin dalle iniziali esperienze consapevoli. L’io ha una esistenza subconscia durante il
50sonno, tranne che per i sogni, mentre nella veglia riemerge cosciente e viene legato
al passato dalla continuita della memoria. Ma per la sola memoria, noi non esi-
steremmo come persone nell’atto dell’esperienza cosciente.
[f] Incontriamo qui lo straordinario problema che fu formulato per la prima volta da
Cartesio: come possono avere rapporti la mente cosciente e il cervello? Questa
55domanda e ancora un grande enigma. Come asserisce Popper, non e necessario che
l’interazione [...] sia in conflitto con la prima legge della termodinamica2.
Il flusso di informazione nei moduli neurali3 puo aver luogo grazie ad un in-
cremento e decremento di energia bilanciati in microposizioni diverse ma adia-
centi, cosı che non si verifica nel cervello alcuna variazione nella energia. La prima
60legge della termodinamica a questo livello puo essere valida solo statisticamente.
(J. C. Eccles, La meraviglia di essere uomo, in «Synesis», I, ottobre 1984, 2/3, pp. 163-67)
J Lo sviluppo argomentativo
2. prima legge della termodinamica: nota anche come principiodella conservazione dell’energia, afferma che l’energia puo esseretrasformata da una forma all’altra, ma non puo essere ne creata nedistrutta.
3. moduli neurali: gruppi di cellule del sistema nervoso che rac-colgono informazioni e le trasmettono ad altre cellule dell’organi-smo.
[a] Eccles, rifacendosi a quanto Immanuel Kant (1724-1804)
asserisce nella prima edizione della Critica della ragion
pura, sostiene che puo dirsi «persona» chi ha coscienza di
se stesso (o autocoscienza) in tempi diversi, ossia chi
mantiene la consapevolezza nel tempo della propria
identita. Esiste un’unita mentale che si percepisce sog-
gettivamente come una continuita attraverso il tempo. Ed
e questa la base del concetto del se o persona.
[b] I danni alle parti del cervello possono colpire in modo
grave la personalita umana.
[c] I sostenitori della teoria filosofica materialista ritengono
che le esperienze consapevoli siano dei derivati del fun-
zionamento del cervello.
[d] Eccles respinge l’interpretazione dei materialisti. Infatti,
se le nostre esperienze consapevoli fossero semplicemente
un riflesso di quanto avviene nel cervello, il nostro io non
sarebbe altro che uno spettatore passivo delle attivita
svolte dai meccanismi neurali. Invece, e un fatto che il
nostro io sia in grado di esercitare un controllo sulle nostre
azioni, selezionando di continuo in modo attivo, a suo
piacimento, quegli aspetti dell’esperienza sui quali intende
focalizzare la sua attenzione.
[e] Eccles ribadisce l’ipotesi alternativa interazionista dua-
lista, ampiamente sviluppata insieme a Popper. Secondo i
due autori, l’uomo e la combinazione di due entita: il
cervello e l’io cosciente. L’io (o se) e il centro della totalita
delle nostre esperienze coscienti, come persone, per tutta
la durata dell’esistenza consapevole.
[f] L’ipotesi dualista fa pero riemergere il problema che fu
formulato per la prima volta da Cartesio: come possono
avere rapporti la mente cosciente e il cervello? Eccles
confessa che questa domanda e ancora un grande enigma.
" L’io e il suocervello
" Il dualismomente-corpo
13
Intelligenza artificiale e filosofia della mente PERCORSI TEMATICI
LAVORO SUL TESTO
& | T1-T2 Turing sostiene la possibilita di una macchina pensante, nel senso definito dal-
l’omonimo test. Searle, invece, si oppone drasticamente all’idea che un computer, anche
se adeguatamente programmato, possa essere una mente vera e propria: ogni calcolatore
rimane un semplice strumento perche non sara mai in grado di comprendere e attribuire
un significato a quello che fa.
O Illustra in che cosa consiste il cosiddetto «test di Turing» descritto in T1, e spiega perche tale test
presupponga un’interpretazione forte dell’intelligenza artificiale, nell’accezione specificata da Searle
in T2. Confronta, quindi, le posizioni dei due autori.
2 | T2 Relativamente all’uso dei simboli, Searle distingue un piano sintattico e un piano
semantico per sostenere che una macchina puo e potra muoversi solamente nell’ambito
del primo.
O Chiarisci l’interpretazione debole dell’I. A. Specifica il senso dell’esperimento mentale di Searle della
stanza cinese e illustra perche rappresenta un’argomentazione contro l’interpretazione forte dell’I. A.
3 | T3 Eccles giustifica una concezione dell’uomo che interpreta in termini nuovi il dualismo
cartesiano, contro ogni forma di materialismo.
O Che cosa intendono Kant ed Eccles per «persona»?
O Perche l’interpretazione materialista del rapporto mente-corpo e respinta da Eccles?
O Eccles spiega in che modo la mente interagisca con il cervello?
O Quale difficolta emerge dal dualismo interazionista di Eccles?
Noi sappiamo che la mente interagisce con il cervello, ma
non siamo in grado di spiegare come cio avvenga. L’ipotesi
interazionista proposta da Popper e da Eccles puo sem-
brare in contraddizione con la prima legge della termodi-
namica, e cioe con il principio di conservazione del-
l’energia. Infatti, secondo l’interazionismo, l’energia fisica
scompare dal mondo fisico quando un evento fisico pro-
duce un evento mentale, e compare nel mondo fisico
quando un evento mentale produce un evento fisico. Per
risolvere la difficolta, Popper ed Eccles prospettano due
possibili soluzioni: la prima consiste nel supporre che la
perdita o il guadagno energetico che si verificano in un
determinato punto del cervello siano controbilanciati da
un guadagno o da una perdita nelle zone circostanti.
L’altra ipotesi, invece, consiste nel supporre che la prima
legge della termodinamica sia valida non in assoluto, ma
solo statisticamente, in modo da giustificare la fluttuazione
dell’energia.
14
PERCORSI TEMATICI Intelligenza artificiale e filosofia della mente
FARE FILOSOFIA
Gli stati mentali qualitativiRiscontra nel brano qui riportato alcune delle tesi sostenute dall’epifenomenismo.
TT 4 Salucci: Spiegazione scientifica ed esperienzasoggettivaUna delle maggiori difficolta incontrate da coloro che, seguendo la teoria dell’identita, pensano
che i fenomeni mentali si identifichino completamente con i fenomeni cerebrali, e rappresentata
dal problema dei cosiddetti qualia o stati qualitativi, che riguarda il mistero di come un colore,
ad esempio il rosso, si origini nel cervello, un organo nel quale si possono osservare fenomeni
elettrici ma non certo i colori. Secondo l’autore, bisogna riconoscere che si apre una distanza
incolmabile fra la spiegazione scientifica del mondo e quella fornitaci dalla nostra esperienza
soggettiva e quotidiana.
I l termine qualia e un’abbreviazione di
«stato mentale qualitativo» cioe quegli
stati mentali come la percezione dei colori,
dei sapori, del dolore e simili tali che, come
dice T. Nagel1, faccia un certo effetto averli.
L’attuale discussione sulla coscienza, ri-
proponendo l’argomento di Nagel e di F.
Jackson2, si riallaccia dunque alla di-
scussione sugli stati qualitativi da sempre
presente nel filosofia della mente, almeno
fino dagli anni Sessanta. Il nucleo del di-
battito, tanto allora quanto oggi, e dunque
sempre lo stesso: come e possibile che, per
esempio, il colore rosso si origini nel cer-
vello, un organo nel quale si osservano fe-
nomeni elettrici e chimici ma non il colore
rosso? A ben guardar pero, il problema ha
origini ancora piu antiche: esso puo essere
retrodatato fino alla distinzione fra qualita
secondarie e qualita primarie, gia consape-
vole in Boyle, Galileo e Locke. Freud ne ha
dato una volta una formulazione concisa e
perspicua: «La nostra coscienza fornisce solo
delle qualita, mentre la scienza naturale ri-
conosce solo delle quantita» (Progetto di una
psicologia, 1895). Abbiamo qui a che fare
con una lacuna (gap) della spiegazione:
quella fra la spiegazione scientifica del
mondo e l’immagine della realta che ci e
fornita dalla nostra esperienza soggettiva e
quotidiana. [...] C. McGinn, per esempio,
pensa che gli esseri umani non abbiano le
capacita cognitive per risolvere il problema:
«abbiamo cercato per molto tempo di ri-
solvere il problema mente-corpo, ma esso ha
ostinatamente resistito ai nostri sforzi mi-
gliori. Credo che sia giunto il momento di
ammettere candidamente che non potremo
mai risolvere il mistero» (C. McGinn, The
Problem of Consciousness, Blackwell, Oxford,
1991, p. 349).
(M. Salucci, La coscienza nella filosofia
della mente, in «Nuova Secondaria»,
XIX, 2002, 8, p. 92)
I Che cosa sono esattamente i qualia?
I Perche rappresentano un problema per una spiegazione scientifica delle relazioni mente-corpo?
I Quale rapporto esiste fra il problema dei qualia e la distinzione fra qualita primarie e qualita secondarie
che risale a Boyle, Galilei e Locke?
1. Nagel: T. Nagel, Che effetto fa essere un pipistrello?(1974), in Questioni mortali, Milano, il Saggiatore, 1986,pp. 162-76.
2. Jackson: F. Jackson, Epiphenomenal Qualia, in «Phi-losophical Quarterly», XXXII, 1982, pp. 127-36.
15
Intelligenza artificiale e filosofia della mente PERCORSI TEMATICI
Che cos’e l’uomo?Rifletti sulla possibile linea di confine che separa la mente degli uomini dalle forme di I. A., e su
come le recenti ricerche tecnologiche diano nuovo impulso all’indagine relativa a cio che rende un
essere umano tale.
TT 5 Carotenuto: Il confine tra cyborg, androide e uomoLo psicoanalista junghiano Aldo Carotenuto affronta alla luce dell’I. A. tematiche filosofiche
classiche che riguardano l’essenza dell’uomo. Le nuove figure fantascientifiche che affiancano
l’uomo costringono a riaprire la discussione intorno a cio che lo costituisce come tale e alla
possibilita che forme di intelligenza artificiale possano divenire da lui indistinguibili.
L’esistenza del cyborg solleva il problema
dell’essenza dell’uomo, di cio che lo
costituisce. L’immagine del cyborg, ad esem-
pio, induce a domandarci a che punto della
trasformazione egli cessi di essere uomo, ov-
vero, qual e la parte del corpo che non do-
vrebbe mai essere sostituita, pena la perdita
dell’identita individuale. La presenza del cy-
borg impone dunque la domanda: cos’e
l’uomo? Un interrogativo cui rimanda anche
la tematica dell’androide, al centro della
narrativa di Philip K. Dick1. E piu umano cio
che e vero o viceversa? Sotto le spoglie di
quello che noi riteniamo essere un uomo
potrebbe invece celarsi una macchina priva di
passioni? Fino a che punto l’androide e scevro
di passioni umane; e quanto invece l’uomo
agisce come se fosse programmato? Che ruolo
ha il corpo nell’identita di un uomo?
(A. Carotenuto, L’ultima Medusa. Psicologia
della fantascienza, Milano, Bompiani, 2001,
pp. 192-93)
I Cosa puoi rispondere alle domande inquietanti poste in questo brano?
I Quali film di fantascienza ti sembrano affrontare i temi della presunta (o possibile) «umanita» dei robot
e degli androidi?
1. Philip K. Dick: autore del romanzo Il cacciatore diandroidi (1968, il cui titolo originale e, in realta, DoAndroids Dream of Electric Sheeps?, ovvero Gli androidisognano pecore elettriche?), da cui il regista Ridley Scottha tratto il film Blade Runner (1982). Dick ha anche
scritto il racconto di fantascienza Minority Report(pubblicato nel 1956 sulla rivista «Fantastic Universe»),da cui e liberamente tratto il film omonimo del 2002,diretto da Steven Spielberg.



























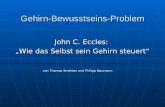



![R] ] ] R] ]uo ] 1.Gün › kullaniciDosyalari › egiticiegitimlink › Sunu 1.pdf · Eccles WD, Arsal G (2015): 67$1'$5725](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f1065c37e708231d448e934/r-r-uo-1gn-a-kullanicidosyalari-a-egiticiegitimlink-a-sunu-1pdf.jpg)


