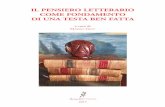Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
-
Upload
federico-virgilio -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
1/11
11
LO SGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICUR: INTRS!IONI
Articoli/1
di Chiara Chinello
Articolo sottoposto a peer-review. Ricevuto il 10/03/13. Accettato il 18/04/13
This article aims to investigate the dialectical tension between the smbol and the cogitoin the role Ric!ur attributes to them" the beginning o# philosophi$ing. This approach alsoreveals the comple% dnamic interpla which occurs between two philosophical viewpoints"
hermeneutics and re#lection. Their dialogue creates a hori$on which can host the aporiao# this dual beginning. This comple% dialectical interpla which develops between thesmbol and the cogito can be read as a hermeneutic circle capable o# generating meaning.&owever' it is a new (ind o# hermeneutic circle' with two actors who derive meaning#rom each other and who #ind their ultimate meaning in each other. The cogito and thesmbol are the two poles o# a magnetic #ield capable o# generating lines o# #orce which(eep them in constant connection but also in perennial reciprocal tension. Ric!ur)shermeneutics consists in the stud o# metaphor and narrative te%t' and his re#lection mustrespond to the challenge to the cogito posed b the so called masters o# suspicion. *n theend a new concept o# identit is inspired b this double movement" the narrative identit.
+++
,)analisi del cominciamento del #iloso#are nel pensiero di aul Ric!ur
un percorso di indagine che ci permette di porre in eviden$a una delle
costanti della ri#lessione #iloso#ica di uesto pensatore #rancese' ovvero il
suo carattere volutamente con#littuale ed aporetico' carattere che non deve
essere inteso come l)inevitabile risultato di una specula$ione sulle uestioni
pi spinose della ricerca #iloso#ica' ma che deve essere considerato come
una vera e propria assun$ione metodologica.
,)aporia' ben lungi dall)essere un ostacolo che rende di##icoltoso il
procedere della ri#lessione #iloso#ica' uando non ne impedisca del tutto
lo svolgimento' obbligandola ad arrestarsi di #ronte alle sue di##icolt'
rappresenta invece per Ric!ur il cuore della scoperta #iloso#ica' il centro
pulsante dell)attivit di pensiero' ci2 che permette alla #iloso#ia di preservare
la sua struttura dinamica e produttiva. ,)aporia in Ric!ur assurge a vera
e propria scelta metodologica' volutamente e costantemente preservata
come stimolo al pensare e ri#iuto della possibilit di indugiare in solu$ioni
considerate de#initive. ssa o##re una chiave di lettura del suo percorso
#iloso#ico complessivo' poich egli sceglie di restare nella contraddi$ione
e si s#or$a di tenere insieme interpreta$ioni contrastanti' non cercando
tra loro una media$ione de#initiva' ma ponendole in dialogo e tentando
costantemente di preservarne il con#litto' vera #onte di ricche$$a per la
#iloso#ia.
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
2/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
12
Chiara prova di questa scelta metodologica la decisione di partiredal simbolo, che costituisce nella prospettiva del filosofo francese il luogodel cominciamento del pensiero filosofico. Il simbolo si offre alla riflessionefilosofica come suo cominciamento perch esso provoca il pensiero,
invitandolo a farsi carico delle contraddizioni di cui portatore.d a pensare1, con questa celebre espressione Ricur sottolinea il caratterefecondo e donativo del simbolo, che si d! come stimolo al pensiero, essendoportatore di un duplice contenuto. "a un lato, infatti, il simbolo possiedeun senso immediato e primo, dall#altro questo senso primo veicola un sensosecondo a cui possiamo avere accesso solo attraverso il senso primo, che necostituisce l#unico mezzo di espressione. $er tale ragione il simbolo necessitasempre di un#interpretazione.
%gni interpretazione, per&, traduce il simbolo e cos' facendo ne riduce laportata, limitandone il significato, ma non ne esaurisce mai completamente
la ricchezza. %gni traduzione in parte un tradimento( per questo, da unaparte permane l#aspirazione a delineare una tecnica di interpretazione chesi avvicini il pi) possibile alla possibilit! di offrire una lettura univoca delsimbolo, dall#altra evidente che la plurivocit! contenuta nel simbolo nonpu& essere eliminata e che anzi la fonte della sua ricchezza. *a possibilit!del darsi di pi) interpretazioni possibili, a volte in contrasto tra loro etutte ugualmente valide, va preservata come costante offerta di un nuovoinizio per il filosofare. Il simbolo assicura il perenne permanere di questapossibilit!. +a che significato ha il simbolo per Ricur
Io do alla parola simbolo un senso pi) ristretto che non gli autori, comeCassirer, i quali chiamano simbolica ogni apprensione della realt! fatta per mezzodi segni- dalla percezione al mito, all#arte, fino alla scienza( ed un senso pi) ampiodegli autori i quali, a partire dalla retorica latina o dalla tradizione neoplatonica,riducono il simbolo all#analogia. Chiamo simbolo ogni struttura di significazionein cui un senso diretto, primario, letterale, designa per sovrappi) un altro sensoindiretto, secondario, figurato, che pu& essere appreso soltanto attraverso il primo2.
Il simbolo per Ricur una relazione dal senso al senso. $ropriamente,il simbolo si colloca gi! sempre nel linguaggio, che per Ricur costituisceil veicolo di ogni esperienza umana. olo se si gi! situati nel livello deldiscorso, le parole possono assumere un significato simbolico.
/ulla simbolico prima che l#uomo parli, anche se la potenza del simboloaffonda le sue radici pi) nel profondo, nell#espressivit! del cosmo, nel voler0dire deldesiderio, nella variet! immaginativa dei soggetti. +a, ogni volta, nel linguaggioche il cosmo, il desiderio, l#immaginario, provengono alla parola.
Il simbolo per la filosofia la chiave di accesso verso quegli ambiti chene costituiscono la fonte di senso- il sacro, l#onirico, il poetico. Il linguaggio
1 $. Ricur, , +ilano 133, p. 45( cfr.
pensare, 6rescia 2442, p. .2 , p. 27. Id.,Della interpretazione. Saggio su Freud, +ilano 173, p. 28.
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
3/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
1
diventa ivi equivoco e portatore di duplici significazioni( caratterizzatoda un movimento di nascondimento e rivelazione. Il simbolo dona dunqueun senso, ma cos' facendo dona anche da pensare, offre la possibilit! diun#attivit!, di una ricerca.
*a filosofia fin da subito chiamata a pensare criticamente i contenutidel simbolo- la filosofia inizia dal simbolo, ma ci& di cui il simbolo portatore offerto ad un cogito affinch sia pensato. 9: partire dalla donazione, laposizione;5.
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
4/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
15
per recuperare le tracce pulsionali e regressive insite nella forma simbolica eper farne emergere il contenuto inconscio. *o scavo archeologico, di matricefreudiana, rintraccia l#origine del significato di un simbolo nel desiderio, chesolo tramite il simbolo pu& giungere ad espressione. +a da questo movimento
si sviluppa contemporaneamente un movimento parallelo e contrario dicostruzione di un senso a posteriori, orientato al futuro- un movimentoteleologico di struttura hegeliana. *#aporia data dunque dalla paritariacoesistenza nel simbolo di una spinta analitica e di un#esigenza sintetica,che vanno preservate nella loro conflittualit!. = questa conflittualit! che siritrova anche nel cogito. Buesta scoperta fondamentale fatta in quello che ormai considerato un classico- il testo degli anni 74Della interpretazione.
Saggio su Freud. $er comprendere quali siano le pretese legittime che laragione possiede nel dire >io?, Ricur procede in un#analisi delle due radicicostitutive della conoscenza antropologica- il desiderio e la sua espressione
linguistica, veicolata dal simbolo e dalla metafora. :l di l! della decostruzionedel cogito operata dalla psicanalisi freudiana che, insieme alle teorie diCopernico e "arDin, ha inferto all#orgoglio del cogito una ferita mortale,per cui Ricur ha coniato l#espressione cogito bris, ci che a Ricur pareinnovativo in Freud il radicare lesperienza umana nel desiderio. Freud
scopre il carattere arcaico del desiderio.
*a psicoanalisi indagata a partire dal rapporto tra forza e senso cheessa instaura, poich in essa il linguaggio capace di portare ad espressioneil desiderio, che si manifesta e si nasconde nel simbolo. Il movimentodialettico, invece, individua l#origine del senso non pi) dietro il simbolo, ma
davanti ad esso, teleologicamente dispiegato dalle figure posteriori. Il sensodell#esistenza racchiuso nelle opere che oggettivano la vita dello spirito.
:ttraverso l#appropriazione del senso contenuto nel simbolo il cogito provocato a riappropriarsi di ci& che costituisce la sua essenza, cio lo sforzo diesistere e il desiderio di essere. 9a ri!lessione lappropriazione del nostros!orzo per esistere e del nostro desiderio di essere, attraverso le opere che
testimoniano di "uesto s!orzo e di "uesto desiderio;E. Il riempimento di cuinecessita il cogito, per Ricur, quello della propria esperienza concreta,nelle opere in cui la sua essenza hegelianamente si manifesta. Il divenires implica un compito etico ed ermeneutico insieme, non un#acquisizioneprevia. "unque il cogito ritrova nel simbolo la sua essenza, quello di esseredesiderio di essere e sforzo per esistere.
Buesto complesso gioco dialettico che si instaura tra simbolo e cogitopu& essere letto come l#esplicarsi di un circolo ermeneutico capace digenerare senso. +a un circolo ermeneutico di tipo nuovo, con due attoriche traggono significato l#uno dall#altro e che trovano l#uno nell#altro ilproprio senso ultimo. Il cogito e il simbolo sono i due poli in tensione di uncampo magnetico capace di generare linee di forza che li mantengono incostante connessione ma anche in perenne tensione reciproca. Il cogito
E Id.,Della interpretazione. Saggio su Freud, cit., p. 7, Fcorsivo dell#autoreG.
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
5/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
15
una riconcilia$ione tra la libert e la natura' tra il volere e le sue condi$ioni
di radicamento' cos6 come il simbolo insieme libero e legato.
7n)ultima tensione dialettica ed aporetica resta da richiamare' uella
tra ri#lessione ed ermeneutica. el testo ' Ric!ur
individua un nuovo compito per la ri#lessione' messa in scacco dai maestridel sospetto che svelano gli inganni della coscien$a immediata. 9i tratta di
recuperare l)ego dell)ego cogito' tramite una riappropria$ione del nostro
s#or$o per esistere che sia al contempo coniugata insieme al nostro desiderio
di essere. on si pu2 non sentire l)in#luen$a del pensiero di 9pino$a in uesta
a##erma$ione' in#luen$a che si #ar via via pi decisiva per la ri#lessione di
Ric!ur nel corso degli anni. *l cogito il porsi contemporaneo di un essere
e di un atto' di un)esisten$a e di un)opera$ione di pensiero. ,)esisten$a
che esso implica non deve essere perduta col porre l)accento sull)attivit
ra$ionale che esso dispiega. Altrimenti essa sarebbe un)intui$ione cieca'
vera ma vuota. ssa invece scopre un contenuto' il desiderio' gra$ieall)unica chiave di accesso a disposi$ione per dischiudere la dimensione
pulsionale' altrimenti irraggiungibile dalla ra$ionalit" il simbolo. :ui si
trova uno dei nodi nevralgici dell)imposta$ione #iloso#ica di aul Ric!ur"
in essa permane una residua' seppur debilitata' #iloso#ia del soggetto ed
proprio uest)esigen$a di salvare il cogito' potremmo dire' a di##eren$iare
la sua ermeneutica da uella heideggeriana. *l lavoro sui simboli non basta
alla #iloso#ia' esso deve essere preceduto da un #ondamento ultimo' il cogito
appunto' che c)' anche se deve essere riempito ;erfllt' dice Ric!ur< dal
lavoro dell)interpreta$ione. ,)antropologia che emerge da uesto cammino
si delinea a partire da due centri" il simbolo d da pensare che il cogito dentro l)essere e non viceversa e svela il desiderio alla radice dell)umano=
tuttavia rispetto ai #iloso#i di imposta$ione ermeneutica Ric!ur individua
nel soggetto un principio di verit da cui non si pu2 prescindere" nonostante
l)opera dei maestri del sospetto il cogito persiste. ,a loro opera critica stata
utile a smascherarne la #alsa immediate$$a' ma non preclude il darsi di un
momento ricostruttivo" il cogito rimane il centro gravita$ionale dell)identit
umana ma' parimenti' non si d comprensione di s che non sia mediata
attraverso segni' simboli' testi.
on sono solo ueste due ermeneutiche ad essere in con#litto nel
simbolo. Ric!ur anali$$a anche il contributo scienti#ico ed oggettivamente
dello strutturalismo su ueste problematiche. ,o strutturalismo consente
di liberarsi della #alsa coscien$a autore#eren$iale e chiusa su di s' ma che
rischia a sua volta di #are del linguaggio un sistema chiuso e privo di contatti
con l)esterno. sso' in#atti' indaga il #un$ionamento di un insieme di
strutture linguistiche e sociali sovraindividuali e dotate di un)inten$ionalit
autonoma' capaci di #ornire regole generali che permettono di deci#rare e
classi#icare il comportamento umano' ma perde cos6 di vista il soggetto e la
re#eren$a al mondo esterno.
,)ermeneutica' per Ric!ur' deve invece #arsi carico di un compito
etico" simboli e meta#ore sono anche uno strumento per la ridescri$ione del
mondo. ssi dischiudono' gra$ie alla re#eren$a seconda resa possibile dal
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
6/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
16
metaphorein, nuovi significati. Ma, perch questa referenza seconda possadarsi, necessaria una distanziazione interpretativa dal mondo e dai suoisignificati usuali. Questo allontanamento reso possibile dal testo quandose ne mostri lautonomia dal suo autore, dai lettori, dal contesto in cui
stato prodotto e al quale fa in primo luogo riferimento a questo punto esso in grado di donare una nuova rifigurazione al mondo della prassi.
!roprio perch luomo gi" da sempre si trova ad agire allinterno diun orizzonte di cui ha gi" da sempre precomprensione, si rende necessariauna momentanea presa di distanza che permetta fenomenologicamente almondo di dispiegare la sua ricchezza di senso, che sfugge ad ogni previadelucidazione. #a metafora offre questa presa di distanza dallimmediataapprensione della realt", offrendo ospitalit" ad eventi di senso sempre nuovi.$e ci fosse una perfetta coincidenza tra la realt" e la nostra apprensione diessa, nessuna etica sarebbe possibile, secondo %ic&ur.
'ellessere come della metafora le cose possono essere viste primache siano fissate nel loro essere atto( esse si danno ancora come possibili.#immaginazione produttiva di tipo )antiano offre questapertura sulpossibile e permette il dispiegarsi dellespressione e della rappresentazionedel desiderio, grazie alla metafora, con la quale il discorso libera il potereche ha di ridescrivere la realt". 'el testo una funzione analoga svolge lamimesis praxeos, che sospende il significato letterale degli avvenimenti perdischiuderne di nuovi, grazie al circolo ermeneutico di origine gadameriana.Questo consente di far emergere aspetti non accessibili alle formulazionidel linguaggio puramente descrittivo e che possono essere raggiunti solo
con la sospensione e la trasgressione del significato abituale delle parole. #afinzione e la poesia mostrano lessere non pi* sotto la modalit" dellesseredonato, come portavano a concludere le ultime analisi heideggeriane, masotto quella del poter essere per questo consentono lemergere di significatiinediti dellesistente. #a scelta del linguaggio narrativo non casuale( esso,infatti, non fermo su di s, non autoreferenziale, ma si apre allambitodellazione umana grazie alla mimesis, che non unattivit" di sempliceimitazione, una copia, ma un procedimento che consente una nuovariorganizzazione a livello pi* alto del significato degli avvenimenti.
La necessit di partire dal simbolo
+isogna forse aver provato il disinganno che comporta lidea di filosofia senzapresupposti per accedere alla problematica che stiamo evocando. l contrario dellefilosofie del punto di partenza, una meditazione sui simboli parte dal pieno dellinguaggio e dal senso gi" da sempre posto parte dal centro del linguaggio che gi"ha avuto luogo e dove tutto in qualche modo gi" stato detto6.
Quella di partire dal simbolo una necessit" epocale( noi siamo i figlidella modernit", dice !aul %ic&ur, di una modernit" intesa come lepoca
delloblio del sacro, della riduzione del senso dei simboli al linguaggio univoco6 -d., , cit., pp. /0/.
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
7/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
12
della logica e di contemporanea ricerca di una pienezza del linguaggio.!er questo un preliminare discorso sul simbolo diviene indispensabile.!otremmo dire che, per %ic&ur, il simbolo svolge in filosofia la stessafunzione che la bellezza rivestiva nella concezione platonica della conoscenza.
3 una scintilla che accende la curiosit" intellettuale e apre le porte ad unosguardo diverso sul mondo, poich una chiave di accesso che per la suastessa natura mette in contatto due universi paralleli, limmaginario e larealt", la rappresentazione e il concetto. -l simbolo esso stesso mediazionee lanalisi del simbolo costituisce la risposta ric&uriana al problema delcominciamento in filosofia( la filosofia non inizia da nulla, giacch, dice%ic&ur, essa si colloca nel plenum del linguaggio ma, altres4, essa iniziada s, poich pone il problema del senso e del suo fondamento. -n questo,la filosofia e il simbolo sono assimilabili. -l sovrappi* di senso, contenutonel simbolo, richiede una scienza dellinterpretazione. !oich esso dona da
pensare, la forza da cui scaturisce lesigenza stessa del filosofare inoltre,consente al filosofare lincontro con il suo altro. $e la filosofia non si riduceunicamente ad un arido deserto di astrazioni e non autoreferenziale, maha ancora da dire sul mondo, questo avviene, per %ic&ur, grazie allincontrocon il simbolo prima, con la metafora viva e con il testo poi, che offrono alpensiero la possibilit" di pensare di pi e altrimenti
5-l simbolo d" a pensare( questo aforisma che mi affascina dice due cose( ilsimbolo d"( io non pongo il senso ma il simbolo lo offre ma ci7 che questo offre 5dapensare, offre di che pensare. partire dalla donazione, la posizione( laforisma
suggerisce insieme che tutto gi" detto in enigma e tuttavia che bisogna semprecominciare tutto e ricominciare nella dimensione del pensiero. 89: !oich tale lasituazione. ;a una parte tutto stato detto primadella filosofia, attraverso segnied enigmi, secondo il senso della parola di .
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
8/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
18
comprendere gli ambiti dellinconscio, del sacro e del ptico, che il simbolo
rende abitabili. Esso offre uno sguardo sullaltro da s dal quale avviare la
riflessione e non costituisce un universo irrazionale e acritico: la modernit
ha ormai irrevocabilmente abbandonato lingenuit con cui nelle societ
arcaiche si ricorreva al simbolismo mitico per spiegare i fenomeni dellanatura o il senso dellesistenza delluomo. !l piano del razionale sembra non
lasciare spazio allimmaginazione nella descrizione del reale: contrappone
alluniverso simbolico e vivente abitato dalluomo medievale un universo
naturale che " scritto in formule. !nesorabile risuona anche per noi questo
monito galileiano:
#orse stima che la filosofia sia un libro e una fantasia dun uomo, comel e lOrlando furioso, libri ne quali la meno importante cosa " che quelloche vi " scritto sia vero. $ignor $arsi, la cosa non ist cos%. &a filosofia " scritta
in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi'io dico luniverso(, ma non si pu) intendere se prima non simpara a intender lalingua, e conoscer i caratteri, ne quali " scritto. Egli " scritto in lingua matematica,e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi" impossibile a intenderne umanamente parola* senza questi " un aggirarsivanamente per un oscuro laberinto8.
+a il simbolo non esce sconfitto da questa disamina critica ad opera
della ragione. !n realt gli studiosi di epistemologia contemporanea
propendono sempre di pi a considerare come fondamentale lapporto che
la metafora offre allo sviluppo delle scienze contemporanee, non solo come
orpello di utilit didascalica, ma come strumento significativo di scoperta.$econdo lepistemologo -od, la metafora aiuta il linguaggio ad aderire alla
struttura causale del mondo: permette alle nostre categorie linguistiche di
tagliare /il mondo in corrispondenza delle sue articolazioni0. 2uhn non
concorda con questidea di -od: per lui il contributo che offrono le metafore
" quello di localizzare alcune articolazioni, ma questa scelta sarebbe stata
differente nel caso si fosse utilizzata una differente immagine metaforica.
3ome che sia la questione, che non " possibile approfondire in questa sede,
ci) su cui entrambi gli autori concordano " che in quello che definiamo con
4opper il contesto della scoperta15non " pi sufficiente luso univoco del
linguaggio e la sua cristallizzazione in definizioni e assiomi immutabili, n sirivela appropriata unimpostazione legalistica del linguaggio: lutilizzo di un
linguaggio sottoposto a leggi rallenta, se non impedisce del tutto, la scoperta
in campo scientifico, poich essa " il frutto di una ridescrizione del reale che
infrange le regole precedentemente in vigore, quando non spalanca universi
completamente vergini, in cui non vale alcuna regola precedentemente
adottata. !l ragionamento scientifico che vuole essere davvero euristico
non pu) essere confinato ad un procedimento dimostrativo. 6i nuovo la
metafora, dunque. 4er comprendere nella sua pienezza la natura della
8 7. 7alilei, , in Opere di Galileo Galilei, vol. !, orino 185, pp. 91;9
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
9/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
1?
metafora, tuttavia, non possiamo non procedere dal simbolo, facendocicarico anche della critica che esso ha ricevuto nellambito del sacro, suoprincipale contesto di utilizzo. Questa disamina non di valenza meramenteepistemologica, ma rimette in discussione la costituzione stessa del soggetto,
come vedremo fin da subito.=ol simbolo ci collochiamo nella regione del senso duplice( un senso
altro si d" alluomo unicamente per il tramite di un senso primo che lo veicola.-l linguaggio diventa dunque equivoco e portatore di duplici significazioni.Questo linguaggio simbolico proprio del sogno ma anche del mito e, infatti,per %ic&ur i miti sono dei sogni collettivi e il sogno una mitologia privata.
nche il sacro caratterizzato da questa duplicit" di nascondimento erivelazione. . +isogna ricollocarsi nel cuore del linguaggio, dunque, per averaccesso alla dimensione dellumano, come accaduto nel caso del pensieroheideggeriano, dove ad unnalitica delDaseinsi sostituisce nella secondafase della sua produzione una filosofia del linguaggio.
nche il percorso filosofico ric&uriano sembra procedere da unafilosofia del soggetto ad una filosofia dellesser detto( infatti, %ic&ur, dopoaver iniziato la sua produzione filosofica col grande programma fondativodella Filosofia della volont, sviluppa nella fase centrale del suo pensierouna serie di studi dedicati al linguaggio. -n realt", il movimento duplice.$e vero che la filosofia ric&uriana si sposta dallidealismo trascendentaleallermeneutica dei testi, altrettanto vero che pu7 essere evidenziato11 M. @eidegger, Was heisst Denken?, ABbingen 1?21, p. ?C.1> !. %ic&ur, , cit., p. >C.
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
10/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
>/
un movimento opposto che mira a tracciare una risposta della filosofiariflessiva a quello che %ic&ur definisce dfi de la smiologie. -l cogito dellafilosofia riflessiva, infatti, simile allessere della logica hegeliana, tanto vuotoquanto astratto e instabile, fin da subito trasceso nellanalisi ric&uriana
in un cogito incarnato, in costante tensione tra i due poli del volontario edellinvolontario, quello che %ic&ur ha analizzato gi" dalla Filosofia dellavolont. -n seguito, dopo la trasformazione della via breveheideggeriana, incui il comprendere un modo di essere, nella via lunga, dove il comprendere un modo di conoscere, dunque uno strumento per giungere alla propriaidentit", costituita dal riempimento che riceve dalle sue mediazioni nelmondo, litinerario diviene ermeneutico e lo scopo ontologico( si parte daisimboli, che offrono da pensare, per ritornare al soggetto. Questo soggetto,per7, di tipo nuovo. -n come un altro, infatti, messa in dubbio lacertezza cartesiana sulcogito.
$i presenta, ora, la questione di sapere se, in =artesio stesso, l5io esistopensando possa sostenersi in questa posizione di prima verit" immediatamenteconosciuta attraverso la riflessione sul dubbio. $arebbe questo il caso se, nellordinedelle ragioni, tutte le altre verit" procedessero dalla certezza del !ogito. Dra,lobiezione pronunciata da Martial Eueroult inDescartes selon l"ordre des raisons,continua a sembrarmi inevitabile. #a certezza del !ogito offre della verit" unaversione soltanto soggettiva, il regno del genio maligno perdura quanto al saperese la certezza possiede un valore oggettivo 89:1.
-n realt", per %ic&ur la certezza del cogito si regge sulla veracit" divina,
prima in termini di ordo essendi(
$embra, allora che si sia aperta unalternativa( o il !ogito ha valore difondamento, ma si tratta di una verit" sterile cui non si pu7 dar seguito senza unarottura nellordine delle ragioni oppure lidea del perfetto a fondarla nella suacondizione di essere finito, e allora la prima verit" perde laureola di fondamentoprimo1.
3 necessario, per orientarsi nelle problematiche postesi con lanalisidel cogito e per rendere conto delle obiezioni sollevate dai maestri del
sospetto, prospettare una nuova ermeneutica, quella che %ic&ur definisce(Funermeneutica del sG1C. -l s non un dato di partenza, ma un risultatoche si deve ottenere, la cui natura occorre, per cos4, dire imparare. !erriprendere il titolo del libro di +ernard $tevens,L"apprentissage des signes,i segni, intesi come simboli, metafore, testi16, consentono un apprendimento,e quello che si apprende la propria identit" e la propria collocazionenellesistente, il proprio radicamento nellorizzonte dellessere. -nfatti, notalautore, se vero che %ic&ur riprende il gioco linguistico di Hittgenstein,
1 -d., come un altro, Milano 1??, p. I.1 , p. IC.1C , p. ?>.16 +. $tevens, L"Apprentissage des ignes# Lecture de $aul %ic&ur, ;ordrecht, +oston,#ondon 1??1, p. >1.
-
7/25/2019 Paul_Ricoeur e Il Fondamento Del Filosofare
11/11
LOSGUARDO- RIVISTA DI FILOSOFIA- ISSN: 2036-6558
N. 12, 2013 (II) - PAUL RICOEUR: INTERSEIONI
21
che spodesta il primato di una rappresentazione del mondo puramente
ad opera di un linguaggio assiomatico in favore del profilarsi di un gioco
di linguaggi diversi, questa ripresa non resta confinata nellambito del
linguaggio medesimo, come avveniva in Wittgenstein, ma si d allinterno
del paradigma della soggettivit trascendentale.
Laccs ricurien la probl!matique du langage appara"t donc sous un#our ambigu $ dune part, il entend souligner la n!cessit! du passage qui mnede lambition logiciste et s!miologique la description s!mantique et empirique,et dans cette mesure il accr!dite le mouvement de retrait du fondement tel quenous lavons d!fini au d!but de notre !tude % mais dautre part, il entend fonderle langage dans la sub#ectivit! transcendantale, et dans cette mesure il effectue unnouveau tracement ou encore & dirions'nous en langage derridien & un re'trait dufondement !gologique1(.
)i* che un gioco ambiguo, credo che qui abbia luogo un gioco aporetico,in cui i due poli permangono in una tensione dialettica ininterrotta e, cos+
facendo, permettono il dispiegarsi di una nuova, pi* completa identit,
che si riconosce fondata e attraversata dalla diversit, mai raggiunta
completamente ma sempre in processo di costruzione e in uno stato di
tensione perenne verso il totale raggiungimento di s!.
1( , p. 2-.