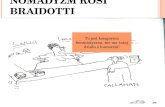PARTE II 3 4 8cespes.unipg.it/index_htm_files/183-184-185-186-2003.pdfassessori regionali Gaia...
Transcript of PARTE II 3 4 8cespes.unipg.it/index_htm_files/183-184-185-186-2003.pdfassessori regionali Gaia...
1n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
��������
2 PRESENTAZIONE
3 PARTE IATTICONVEGNO NAZIONALE"SCUOLA PROMOTRICE DI SALUTE"Perugia, 8 novembre 2002
4 SALUTI DELLE AUTORITÀRuggero Rossi, Gaia Grossi, Adriana Carola,Anna Maria Dominici, Carmela Lo Giudice Sergi
8 CONTRIBUTIPOLITICHE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI
GIOVANI IN EUROPA: RISULTATI ED ESPERIENZE
Vivian RasmussenSCUOLA PROMOTRICE DI SALUTE: IGIENE DEL
LAVORO SCOLASTICO
Lamberto BriziarelliIL LAVORO SCOLASTICO: ORGANIZZAZIONE E
METODI PROMOTORI DI BENESSERE
Luciano Corradini
23 TAVOLA ROTONDAUN MODELLO DI AZIONE: FILOSOFIA, SCOPI,OBIETTIVI E RISULTATI DI UNA RICERCA.PAROLA AI PROTAGONISTI E COMMENTI
Maria Antonia Modolo, Patrizia Fioretti, AntonioDe Angeli, Walter Orlandi, Paolo Quintaliani
40 DISCUSSIONEFelice Piersanti, Gianfranco Tarsitani, GonarioGuaitini
42 CONCLUSIONIMaurizio Rosi
43 PARTE IIRISULTATI"SCUOLA PROMOTRICE DI SALUTE"RICERCA INTERVENTO PER LA SPERIMENTAZIONE DI
UN MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA SCUOLA
44 RAGIONI E OBIETTIVI DI UNA RICERCAPaola Beatini, Maria Antonia Modolo
48 DA UNA SCUOLA CHE PARLA DI SALUTEA UNA SCUOLA CHE LA COSTRUISCE.PUÒ LA MATEMATICA PROMUOVERE LA SALUTE?Paola Beatini, Anna Lisa Ferrante, Maria AntoniaModolo
61 DAL SEMINARIO DI FORMAZIONE "SCUOLA PROMOTRICE DI SALUTE"
68 UN OBIETTIVO DI SANITÀ PUBBLICACONDIVISO: UN SISTEMA INTERISTITUZIONALE PER
UNA SCUOLA PROMOTRICE DI SALUTE
a cura di Gonario Guaitini e Anna Tosti
76 I DETERMINANTI DI UNA SCUOLAPROMOTRICE DI SALUTE.INDICATORI PER VALUTAREa cura di Anna Beltrano
83 PARTE IIITESTIMONIANZE
84 DAI DIARI DI BORDO
88 DALL'ESPERIENZA CONDOTTA NELLAREGIONE TOSCANA
90 DALLA SCHEDA DI ANALISI PER LADOCUMENTAZIONE DELL'ESPERIENZA
94 DAMMI UN AGGETTIVO E UNAMOTIVAZIONE DEL PERCHÈ LO HAISCELTO...
99 DAI MODULI DISCIPLINARI
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 20032
�����������������������
“Può la matematica promuovere lasalute?” questa la domanda che cisiamo posti in partenza. Promuoverela salute innanzitutto con unsoddisfacente “lavoro scolastico”. Lalunga esperienza scolastica di relazionie di apprendimento contribuisce allaformazione delle basi dell’equilibriosalute. La salute come equilibrio,dell’individuo, del soggetto, dellapersona, le basi biologiche, lacostruzione del sé nei rapporti con gliambienti, l’apparire di fronte agli altri,essere guardati e giudicati. Le basiche derivano dal misurarsi con laconoscenza delle più diverse disciplinee dalle esperienze di rapportinumerosi, durante il lavoro scolastico.Le basi che consentono di conoscersi,di saper decidere. Le modalità con cuisi giuoca l’evento insegnamento/apprendimento. Ciò comprende ancheconoscere il proprio corpo e le sueesigenze e reazioni, favorevoli osfavorevoli. Prima, comunque, èindispensabile che la scuola siaun’esperienza favorevole. "Scuolapromotrice di salute" come indicatonelle raccomandazioni dell’OMS cheabbiamo scelto a nostra guida. Con ilsupporto del sistema sanitario, con isuoi strumenti di ricerca e la comunità,con le sue decisioni politiche.
Maria Antonia Modolo, responsabilescientifico della ricerca
La pubblicazione che viene presentatasta a testimoniare l’interesse el’impegno della Regione Umbria versoil benessere del più importantepatrimonio della nostra Comunità: lenuove generazioni. La Scuola deveessere al centro delle nostre attenzioni,assieme alla famiglia, due reti cheassolvono al compito fondamentaledella formazione dei bambini e deiragazzi della nostra Regione.La ricerca, condotta con la parteci-pazione di molti soggetti e coordinatadagli uffici regionali, ha reso possibileindividuare la struttura di uno dei Pattiper la salute, inseriti nel PianoSanitario Regionale 2003-2005, il checonsentirà di passare dai risultati dellaricerca stessa alla applicazione nellapratica.L’interesse fondamentale del lavorofatto è nell’avere individuato iprotagonisti che dovrebbero esserecoinvolti in un’azione che aiuti laScuola a essere produttrice di salute,orientando i numerosi progetti che sirivolgono alla Scuola a un finecomune, in un piano organico,consolidato, capillare e continuo. Sitratta di una politica per la salute taleda offrire la possibilità di dimostrareefficacia nel raggiungimento delbenessere dell’intera comunitàscolastica.
Maurizio Rosi, Assessore alla Sanità,Regione dell'Umbria
Il presente volume riporta i risultatidella ricerca "Scuola Promotrice diSalute" coofinanziata dal Ministerodella Salute, promossa e condottadalla Regione dell'Umbria, incollaborazione con la RegioneToscana, e con la responsabilitàscientifica dell'Università degli Studidi Perugia (Dipartimento di Igiene eCentro Sperimentale perl'Educazione Sanitaria).Scopo della ricerca era lo studio diun modello di integrazione dellestrategie di intervento per la"Promozione della salute" nelcontesto della scuola e del lavoroscolastico.Il presente volume riporta nellaprima parte i lavori del ConvegnoNazionale "Scuola Promotrice diSalute", tenutosi a Perugia l'8novembre 2002, nella seconda lelinee principali dei risultati dei treobiettivi della ricerca. La terza eultima parte, brevi sintesi delletestimonianze dei percorsi svolti dainsegnanti e studenti, commenti eindicazioni dei protagonisti dellaricerca.
�����������������������
3n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
������������� ������
������� ������ � ��� ����� Perugia, 8 novembre 2002
Aula Magna dell'Università degli Studi di Perugia
���������
ore 9.00 Saluto del Magnifico Rettore dell'Università degliStudi di Perugiaprof. Francesco Bistoni
ore 9.15 Apertura dei lavoriprof. Gaia GrossiAssessore alla Formazione, Università, Ricerca ePolitiche Socali e del Lavoro, Regione dell'Umbria
dott. Bruno CampioneUfficio IV Ricerca Sanitaria, Ministero della Salute
dott. Anna Maria DominiciDirettore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionaledell'Umbriadott.ssa Carmela Lo Giudice SergiDirettore Generale M.I.U.R.
ore 9.45 Una scuola promotrice di salutedott.ssa Vivian RasmussenWorld Health Organization Tecnichal AdviserPromotion of Young People's Health
ore 10.10 Scuola promotrice di salute: igiene del lavoroscolasticoprof. Lamberto BriziarelliOrdinario di Igiene, Università degli Studi di Perugia
ore 10,35 Il lavoro scolastico: organizzazione e metodipromotori di benessereprof. Luciano CorradiniOrdinario di Pedagogia, Università degli Studi di Brescia
ore 11.00 Break
ore 11.15 TAVOLA ROTONDA
Un modello di azione: filosofia, scopi, obiettivi erisultati di una ricercaCoordina: prof.ssa Maria Antonia ModoloUniversità degli Studi di Perugia
PER LA SCUOLA
dott.ssa Patrizia FiorettiUfficio Scolastico Regionale per l'Umbria
prof. Alberto StellaDirigente Scolastico, ITAS Perugia
PER LA SANITÀ
dott.ssa Anna Maria GiannoniAssessorato alla Sanità, Regione Toscana
dott. Antonio De AngeliDirettore U.O. Educazione Sanitaria, ASL Massa Carrara
dott. Walter OrlandiDirettore Generale, ASL Perugia
PER LA COMUNITÀ
dott.ssa Maria Pia BruscolottiAssessore Pubblica Istruzione, Provincia di Perugia
arch. Giuseppe ChianellaAssessore Pubblica Istruzione, Provincia di Terni
ore 12,30 Discussantprof. Sergio PoliMinistero della Pubblica Istruzione
dott. Francesco CicognaMinistero della Pubblica Istruzione
dott. Piernatale MengozziA.N.C.I., Federsanità
dott. Gonario GuaitiniServizio Prevenzione e Sanità Pubblica, Regionedell'Umbria
ore 13.00 Conclusionidott. Maurizio RosiAssessore alla Sanità, Regione dell'Umbria
Università degli Studi di PerugiaDipartimento di Igiene
Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria
Regione dell'UmbriaDirezione Regionale Sanità
e Servizi Sociali
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 20034
�����������������������
������� � �� � �������
Ruggero ROSSI
Rappresentante del Magnifico Rettore dell’Universitàdegli Studi di Perugia
Dopo avere portato il saluto del Magnifico Rettore,assente per impegni fuori sede e ringraziato gliassessori regionali Gaia Grossi e Maurizio Rosi, ildirettore dell'Ufficio Scolastico Regionale,professoressa Dominici, e il CSESi per la realizzazionedella Ricerca e del Convegno, e, soprattutto, ilMinistero della Salute per avere concesso il contributoper la realizzazione della Ricerca, sottolinea come illavoro svolto lo interessi anche come presidenteregionale del CONI, come rappresentante, quindi, delcampo dello sport.
“Ritengo che il problema della promozione della salutenell’ambito della scuola sia oggi un elemento fondamentale,cui indubbiamente l’università è più che interessata, perchévuole collaborare con la scuola; quindi rivolgo il mio messaggioa tutti i componenti del mondo della scuola, perché è da lì chesi inizia, è da lì che si può ricostruire un cammino nuovo rispettoalla cultura della salute”.“Posso fare un piccolo esempio che chiede a noi di essere ingrado di dare ai giovani, e ai giovani di essere in grado dipartecipare attivamente, insieme alle famiglie: è il messaggiodella lotta contro il doping - parliamo di salute - perché è unmomento veramente particolare, ed è il momento giusto percominciare ad agire. Solo con la formazione e con l’informazionepossiamo ottenere risultati, fare comprendere che la salutenon è un corpo diverso o una gara da vincere... È una piccolaparentesi, ma qui oggi ci sono, credo, tanti problemi interessantiche verranno affrontati.”
Gaia GROSSI
Assessore alla Formazione, Università, Ricerca,Politiche Sociali e del Lavoro - Regione dell’Umbria.
Nel sottolineare l’interesse del suo assessorato per laformazione, per le politiche sociali, per la ricerca, perle politiche del lavoro, porge il benvenuto al direttoredell'Ufficio Scolastico Regionale, professoressaDominici. E indica nel tema del convegno un puntoimportante per le politiche generali della Regione.
“…. è un tema che ci è particolarmente caro, perché laRegione dell’Umbria, in questi ultimi anni, ha affrontato unpercorso difficile, un percorso di cambiamento culturale,soprattutto rispetto alle sue politiche sociali.La Regione, infatti, ha cercato di costruire politiche socialiintese non più come cura e rimedio al malessere, ma comepromozione del benessere. Quindi, si comprende comerimediare a un disagio - cosa che per altro continuiamo a fare- paradossalmente è più facile che promuovere il benessere,perché il disagio ha "un’etichetta", ha una cura: si fa quellacosa lì; ha un destinatario, per così dire. È una malattia - anchese noi diciamo che non esistono le malattie, ma esistono i ma-lati -, comunque abbiamo questa facilità a "mettere etichette".Il benessere è una questione molto più complessa, perchésignifica la persona, la salute, la formazione, il lavoro, la qualitàdella vita, la qualità delle relazioni, la vita nelle città. Quindisignifica mettere in campo politiche molto complesse, chetoccano tutti questi temi; politiche che hanno bisogno diintegrazione”.“Allora, se vogliamo dare opportunità alle persone, alle singolepersone, vuol dire che dobbiamo costruire progetti di sostegno,
�����������������������
5n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
politiche sociali,complesse, articolate, fatte di tante politiche”.“Per prevenire il disagio giovanile, cosa serve? Serve unarete scolastica che funzioni, una rete di supporto allefamiglie, servono centri di aggregazione, centri di salute,servono università aperte al mondo, servono politiche dellavoro che non chiudano le persone per tutta la vita in undestino. In particolare, certo, l’integrazione nel settore socio-sanitario è un punto cruciale, perché tutti i percorsi cheprevedono prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento,sono percorsi che di necessità vedono un’integrazione, ma nonun’integrazione soltanto tra le amministrazioni. E tuttaviavoglio ricordare che questo convegno arriva in un momentoparticolarissimo, quello della scrittura del Piano Sanitario, dovec’è un capitolo importante dedicato proprio all’integrazionesocio-sanitaria”.“Voi capite che se noi ci proponiamo obiettivi di costruzione delbenessere, l’integrazione non significa più quello che significavaprima: a valle, quando il problema è esploso, decidiamo chi fache cosa; significa un’altra cosa: a monte, per evitare che ilproblema esploda, programmiamo insieme che cosa fare. È unpunto di vista completamente diverso e difficile, che prevedeintegrazione non soltanto tra attori istituzionali, delleamministrazioni, ma tra tanti attori”.“Io credo che il ruolo della scuola in questo sia assolutamentefondamentale, intanto perché dal punto di vista delle politichegiovanili la scuola è un punto di osservazione privilegiato, doveemergono segnali che in famiglia non è che non si vedano, manon emergono. Quindi il punto di integrazione con la scuola pernoi è assolutamente cruciale. È cruciale anche perché lascuola è posta al centro di un altro snodo che è quello conl’università, con la formazione professionale, quello del costruirestrutture che servano alla formazione integrata. Se non sicostruiscono nella scuola le strutture di metodo per imparare,le persone poi non sono in grado di cogliere le successiveopportunità o le opportunità collaterali”.“E mi domando, a proposito del disagio giovanile, quanto lascuola sia importante. Ad esempio, il problema della dispersionescolastica; badate, nella nostra regione è un problemaacutissimo, perché in Umbria praticamente il 100% dei giovanisi iscrive alla scuola secondaria superiore, eppure ne esceesattamente la percentuale delle altre regioni; dunque significache abbiamo una dispersione scolastica più alta. Quanto iproblemi del disagio, e quanto i problemi della salute incidonoanche su questo tema?”Conclude sostenendo che bisogna accettare la sfidaposta dalla complessità dei problemi, che induce allacollaborazione di più attori, certa che questo incontro sial’inizio di legami organici.
Adriana CAROLA
Ministero della Salute e Ricerca Sanitaria.Dipartimentoricerca sanitaria. In sostituzione di Bruno Campionedello stesso ufficio
Nell’indicare gli obiettivi del progetto che hannostimolato la Commissione del Ministero ad attribuire ilcontributo per la ricerca, sottolinea la coerenza con gliobiettivi generali indicati dal suo dicastero:
“- vigilare sui requisiti igienici e di sicurezza delle strutture;- promuovere stili di vita che gli adolescenti adottino (il progettoè rivolto ad adolescenti delle scuole medie);- promuovere anche la salute psico-fisica degli operatori dellascuola (di cui veramente si parla poco) cioè degli insegnanti edel personale non docente, per evitare lo stress da lavoro equindi fenomeni di burn out;- promuovere le relazioni di cooperazione tra scuola, famigliae territorio, e mi sembra che in questo caso l’obiettivo sia statoraggiunto pienamente.Questi quattro obiettivi generali, ambiziosi e importanti, hannofatto decidere la Commissione Nazionale di Ricerca a finanziareil progetto. Volevo sottolineare brevemente che lo svolgimentoe la conclusione del progetto ha visto come collaboratori, oltreal Ministero della Salute, ovviamente, come finanziatore, laRegione Umbria, attraverso l’Università e il Provveditorato, eanche la Regione Toscana, attraverso il Comune di MassaCarrara. Questo vuol dire che, quando si vuole collaborare traenti istituzionali, si può fare, è importante farlo e ci si riesce”.“L’attività istituzionale è stata strutturata nel 1995 dal Ministero,quindi da pochissimi anni. Nel 1995 sono stati finanziati 6progetti finanziati, in tutta Italia, su una quindicina; nel 2002sono stati presentati 614 progetti - approvati circa la metà -, diprogetti solo regionali ne sono stati ammessi a finanziamento98. Quindi dai 6 del ‘95 siamo passati a 98 progetti”.Nel sottolineare come il Ministero tramite i suoi ufficipratichi un monitoraggio di tutte le ricerche esprime lapropria soddisfazione nel partecipare a convegni comequesto, in cui uno di questi progetti è stato concluso. Sicomplimenta vivamente con chi l’ha svolto, poiché si èconcluso nei tempi giusti, finanziato nel ‘99, è iniziato nel2000 e si è concluso nel 2002, cosa che accade assai dirado.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 20036
�����������������������
Anna Maria DOMINICI
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionaledell’Umbria
Nel porgere il saluto alle autorità e a tutti i presenti,esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto fruttodi una reale integrazione tra il mondo della scuola, laRegione, il Ministero dell’Istruzione, dell'Università edella Ricerca, il Ministero della Salute, gli Enti locali,l’Università.
“Credo che sia davvero questa la strada che si deve intrapren-dere, se vogliamo raggiungere risultati positivi, soprattutto nelcammino di crescita dei nostri ragazzi. E sono per questoconvinta che la reale integrazione delle risorse - professionali,umane, economiche - rappresenti proprio la chiave di volta peroffrire un servizio qualificato a una comunità che abbiadavvero a cuore la promozione di una scuola che sia promotricedi salute. È importante che, come è stato detto, della salute siparli a scuola, ma soprattutto, oltre che parlarne, si assumanoda parte degli alunni, aiutati certamente da tutto il contestocircostante, stili di comportamento che possano contribuirealla crescita di un adulto sano e soprattutto integrato”.“Credo che proprio i fatti di cronaca ci impongano diparlare di questi temi, sollecitandoci una riflessione:l’assoluta importanza che i giovani vengano accolti in unascuola che sia al tempo stesso, oltre che, come solitamentesi pensa, un luogo di trasmissione di saperi, della didat-tica tradizionale, anche un luogo carico di significato, in
grado di sviluppare nei ragazzi il senso di appartenenza,il senso di benessere; un luogo che sia fonte di attribuzionedi ruolo, di attribuzione di identità, e anche di sensostorico. Quindi, una scuola che sia capace di lavorare propriosui livelli di motivazione degli studenti, per far emergere le loropassioni, oltre che le loro competenze e le loro inclinazioni,verso discipline che, per citare Bruner, sono anche modi dileggere e di ordinare il mondo”.“Credo che uno dei meriti di questa ricerca sia stato proprioquello di essersi posta come obiettivo principale il migliora-mento della qualità del far scuola quotidianamente; quindirintracciare, attraverso la ricerca, quegli elementi che devonofavorire gli apprendimenti efficaci nelle varie discipline, tuttoquesto per garantire il successo formativo dei nostri ragazzi.E l'attenzione - questo ho riscontrato, positivamente - è stataposta allo studente, nella sua integrità e nella sua complessitàcome persona, quindi con il diritto di ricevere un’educazioneche in un certo senso lo guidi nel suo percorso di crescita”.“Elemento qualificante di questo progetto credo sia stato ilsuperamento di quegli interventi specifici che ci sono spessonel mondo della scuola da parte di operatori sanitari, e anchedegli stessi docenti, rispetto a tutti i temi legati all’educazionealla salute, rispetto all’abuso di sostanze stupefacenti, all’alcol,all’alimentazione e quant’altro, che, seppur fondamentali eimportanti nella loro specificità e nella loro significatività, senon vengono inseriti in un contesto globale, come mi pareinvece sia stato fatto in questo progetto, rischiano di essereconfigurati come occasioni sporadiche, e frammentarie, men-tre il merito di questa ricerca credo sia stato quello di avercostantemente cercato nella didattica ordinaria situazioni diconfronto e di studio per realizzare anche un approccio ai temidel disagio giovanile in genere e per migliorare nei nostriragazzi anche il modo di stare a scuola, che poi è il modo distare in famiglia, il modo di stare nella società”.“Quindi mi sento davvero di condividere la proposta cheemerge dai risultati della ricerca rispetto alla costruzione di unservizio permanente, se così possiamo dire, sul territorio, chesia finalizzato alla promozione della salute; un servizio, quindi,che non lavori solo sull’emergenza, solo sui rischi, ma che sioccupi in maniera costante di promuovere stili di vita sani; unservizio che lavori in modo integrato, che rafforzi la rete, la reteper la cura delle nuove generazioni”.“Mi sembra importante raccogliere le sollecitazioni del-l’Assessore Grossi e del prof. Rossi, affinché Comuni, Province,Regione, Aziende Sanitarie, scuola e famiglia lavorino tuttiinsieme per creare una coalizione locale per lo sviluppoindividuale dei nostri ragazzi e della società nel suo complesso.In questo, naturalmente, l’Università ha un ruolo davverofondamentale, per cui ringrazio tutti coloro che hannopartecipato, con grande competenza e passione, a questoprogetto”.
�����������������������
7n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Carmela LO GIUDICE SERGI
Direttore Generale Ministero dell'Istruzionedell'Università e della Ricerca (M.I.U.R)
Nel sottolineare il suo interesse al Convegno per averepartecipato in qualità di Direttore Regionale - neglianni della ricerca - al lavoro svolto, richiamal’attenzione sul momento storico che stiamo vivendo,nel quale terrorismo e guerra producono interrogativie incertezze e al contempo si moltiplicano le sfide delmondo moderno nel cuore dell’educazione. Unmomento in cui appare tuttavia possibile costruire, siapur faticosamente, per i giovani e con i giovani, unulteriore e policentrico stadio della storia. Richiamal’attenzione sulla complessità dei problemi posti dairischi alla salute attuali nei nostri Paesi e anche, esoprattutto, nel Paesi in via di sviluppo, dove AIDS,tubercolosi e malaria, le tre grandi piaghe dei Paesipoveri, si ampliano investendo e minacciando oraanche i Paesi ricchi.
“Cosa fare? Dobbiamo solo difenderci, chiuderci a riccio, oinvece affrontare il problema, educare i giovani, i bambini,facendo loro capire la strategica importanza della saluteindividuale e collettiva, della salute del corpo e della psiche,compresa la psiche collettiva, che determina e condiziona icomportamenti sociali? La scuola, dopo, o meglio, insieme allafamiglia, è il luogo e la struttura sociale dove può e deve essereperseguito l’obiettivo della salute e della formazione dell’identitàpersonale. I processi di formazione dell’identità nell’etàevolutiva fanno emergere, ad un tempo, crescenti e fondamentaliesigenze di guida e sostegno nei primi anni di vita, accanto abisogni di autonomia e di indipendenza nella fase dello sviluppoadolescenziale, richiedendo comunque un mix adeguato epersonalizzato”.“Ma ciò che sta radicalmente cambiando in questi ultimi anniè un problema di identità, che investe anche l’adulto, e in modonon del tutto secondario. Chi si basa sulla certezza, sullainamovibilità della propria identità adulta è strutturalmentemeno disposto a cogliere, ad ascoltare, comprendere, ancheempaticamente, le incertezze che caratterizzano lo sviluppo inetà evolutiva, mentre la consapevolezza dell’identità plurale
dell’adulto e le incertezze ancora attuali nella maturitàconsentono di comprendere ed interpretare necessità edesigenze dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.Questa nuova consapevolezza può contribuire a finalizzare almeglio sia la formazione de-specializzata che è possibileoffrire, e che abbiamo offerto, ai genitori, soggetto centrale estrategico del sistema famiglia del quale bambini e adolescentifanno parte, sia la formazione specializzata - anche questal’abbiamo data - che coinvolge tutte le figure professionali diriferimento del bambino, dagli insegnanti agli operatori sociali,dal personale sanitario a quello operante nella giustizia...”.“Nella scuola abbiamo configurato due diverse modalità diarricchimento esperenziale e formativo: da un lato, l’opportunitàdi essere protagonisti della stessa gestione dei servizi perl’infanzia, dall’altro il supporto previsto da parte di tutti glioperatori dei servizi al fine di favorire un miglioramento delcontesto relazionale e di cura della famiglia, con un beneficioindubbio per bambini ed adolescenti”.“Credo che sia superfluo ribadire che il quadro di riferimentodei ruoli parentali e del rapporto tra generazioni è in costantemutamento. La nuova centralità del rapporto padre-figli, lapermanenza prolungata dei post adolescenti e dei giovani nelnucleo familiare, la compresenza, per la prima volta nella storiaumana, di tre, quattro e perfino cinque generazioni diverse, lariscoperta della memoria, con la necessità di ripensare unnuovo ruolo dell’anziano nei nuclei familiari allargati, sono statielementi indispensabili per orientare gli interventi verso realipolitiche di prevenzione”.“La sfida per la scuola, le istituzioni e la sanità è di raccoglierequeste tensioni e trasformarle in educazione alla cittadinanza- per questo è vigente una Convenzione con il Consiglioregionale dell’Umbria -, promuovere il senso di responsabilità,la capacità di prendersi cura, la ricerca del bene comune e lapartecipazione alla vita collettiva, l’impegno per la legalità.In sostanza, la scuola promotrice di salute si dirige versol’ambizione di ristabilire il valore dei fondamenti immutabilidella vita”.“Una scelta culturale e politica per la diversità, la relazionalità,lo scambio; questa è la prospettiva su cui continuare il nostrolavoro, con lo scopo di far riappropriare i ragazzi e gliinsegnanti di quelle scelte personali di qualità della vita volte aperseguire il proprio benessere, oltre al benessere sociale.Anzi, per il futuro propongo che ci si occupi in particolare di unproblema sino ad oggi trascurato: lo stress nel lavoro educativo,nella professione insegnante, come riconoscerlo e prevenirlo.“Scuola promotrice di salute”, deve raccogliere anche questofilo nascosto dell’intricata matassa dei problemi della qualitàdella vita umana, tenendo conto del fatto che nell’epoca in cuiviviamo la dimensione spirituale tende sempre più a isterilirsi,a uscire da ogni ambito della cultura: prima dalla ricercascientifica, poi dalla politica, dall’arte, dalla filosofia...”.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 20038
�����������������������
���������
Health 21
Il quadro politico Salute per tutti nellaregione Europea, interpreta la promo-zione della salute e del benessere deigiovani con un approccio globale o olisticoin un processo che si sviluppa lungo tuttala vita. E sollecita un’azione che 1)aumenti il senso di coerenza e appar-tenenza nei giovani, 2) riorienti e sviluppii servizi per la salute in favore dei giovani,3) promuova stili di vita sani e 4) vadaincontro ai bisogni dei gruppi giovanilimarginalizzati.Sono molti i fattori che all’interno del piùampio ambiente sociale ed economicopossono essere sfruttati per migliorarela salute e lo sviluppo dei giovani. Basticonsiderare alcuni esempi: politichenazionali e locali specifiche per lapromozione della salute (politiche sullapubblicità e vendita del tabacco edell’alcool); orientamenti sociali e normein vari settori, da quelle legate al senso di“associazione” a quelle relative alleprospettive per il futuro (politiche dipromozione dell’occupazione e coesionesociale); relazioni con famiglia, amici ealtri adulti ( politiche di promozione dellacomprensione, cooperazione e sostegnotra le generazioni).Di fronte a queste spinte per costruirecambiamenti favorevoli alla salute,tuttavia, attraverso il cinema, latelevisione, i mezzi di comunicazione
��������� � ��� ������ ���� ������ ��������� �� ������� ��������� � ����������Vivian RASMUSSEN
Technical Adviser Promotion of Young People’s Health,World Health Organization, European Office, Copenhagen
internazionale e la pubblicità per i giovani,senza tralasciare internet, vengonoofferte ai giovani immagini di un modernostile di vita legato alla ricchezza sfrenatae al più stridente consumismo
L’importanza di un approcciomulti settoriale
E’ sempre più evidente che la comples-sità dei determinanti della salute richiedeazioni congiunte nelle politiche pubblichenei campi dell’istruzione, degli affarisociali, della comunicazione, non solo alivello nazionale, ma anche interna-zionale. E’ necessario mettere in motoaltre forme di partenariato e a di attivitàintersettoriali. Sono lontani i tempi in cuisi poteva ritenere sensato e sufficientepromuovere la salute dei giovani conprogrammi e iniziative di singole agenzie.E’, invece, necessaria un’azionecoordinata su molti fronti al fine disviluppare e sostenere i livelli richiesti eraggiungere gli obbiettivi più validi.
Su queste linee si è mosso l’UfficioRegionale per l’Europa dell’OMS perpromuovere un approccio coordinato inmodo tale che i risultati possano avereun impatto evidente rispetto allaprotezione della salute delle giovanigenerazioni. L’obiettivo complessivo èquello di sviluppare un quadro coerentedi lavoro con bambini e giovani negli statimembri. In tale quadro si inserisce qualeelemento fondamentale la Rete Europeadelle Scuole Promotrici di Salute.
Rete Europea delle ScuolePromotrici di Salute
La Rete Europea delle Scuole Promotricidi Salute è un esempio concretodell’attività di promozione della saluteche ha con successo raggruppato tredelle maggiori agenzie europee nelperseguire congiuntamente i propriobiettivi per la promozione della salute ascuola. Sin dall’inizio, nel 1991, il progettoè consistito in una attività tripartita,
�����������������������
9n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
essendo stato lanciato dalla CommissioneEuropea (EC), dal Consiglio d’Europa(CE) e dall’Ufficio Regionale perl’Europa dell’Organizzazione Mondialedella Sanità (WHO/EURO).I risultati del lavoro fin qui svoltodimostrano che i determinanti di salute edell’educazione sono legati in manierainscindibile.La Rete Europea delle Scuole Promotricidi Salute ha indicato che l’attuazionepositiva di politiche di promozione dellasalute scolastica, nei principi e nei metodi,può contribuire in modo significativo alsuccesso della esperienza educativa ditutti i giovani che vivono e studianoall’interno di esse. E’ stato dimostratoche la promozione della salute a scuolaè un investimento sia per l’istruzione cheper la salute. Inoltre la Rete ha unimportante impatto positivo su tutti coloroche insegnano, amministrano, manten-gono e sostengono le scuole nella lorocomunità.La scuola che promuove la salute si basasu un modello sociale di salute, il cheenfatizza il coinvolgimento (e valoriz-zazione) dell’intera organizzazione dellascuola interessandosi allo stesso tempoall’individuo.
Il giovane
Al centro del modello c’è il giovane, cheviene visto come individuo nella suacompletezza all’interno di un ambientedinamico. Un tale approccio produce, ecomunque richiede, una struttura socialedi alto sostegno che influenzi i punti divista, le percezioni e le azioni di tutticoloro che vivono, lavorano, giocano eapprendono all’interno della scuola.Si produce un clima positivo che influiscesulle modalità di costruire le relazioni,sulla capacità di decisione da parte deigiovani e sullo sviluppo dei loro atteg-giamenti e dei loro valori.Se la scuola non è un luogo salutaredove vivere, apprendere e lavorare,gli investimenti nell’istruzione e nellasalute risultano compromessi.Le comunità scolastiche rispondono aun insieme di fattori dinamici che hannoun impatto sull’apprendimento deglistudenti. La salute degli studenti, degliinsegnanti e delle famiglie è un fattorechiave che influenza l’apprendimento.Le scuole necessitano di una strategia ingrado di fornire agli insegnanti, ai genitori,agli studenti e agli altri membri dellacomunità un insieme di principi e azioniche pongano attenzione sui fattori che
influenzano la salute fisica e mentale.Una strategia costruita nel quadro della“scuola promotrice di salute” possiedeun potenziale in grado di aiutare lecomunità scolastiche ad affrontarequestioni sociali e di salute, e può, diconseguenza, migliorare l’apprendimentoda parte degli studenti e accrescerel’efficacia della scuola.La scuola che promuove la salute, perciò,si concentra non solo sul curriculumeducativo alla salute, ma anche sui metodiin uso per l’insegnamento e l’appren-dimento, sull’ambiente fisico e socialedella scuola, sulle strutture direttive dellascuola e sul legame tra scuola, serviziscolastici sanitari, casa e comunità.
Curriculum
Il curriculum della scuola che promuovela salute fornisce opportunità ai giovaniper acquisire conoscenza, acume e capa-cità essenziali nella vita. Il curriculumdeve essere rilevante nei confronti deibisogni dei giovani, sia di quelli attualiche futuri, e, allo stesso tempo, devestimolare la loro creatività, incoraggiarliad apprendere e fornirgli gli strumentinecessari per l’apprendimento. Ilcurriculum della scuola che promuove lasalute è anche un motivo di innovazioneper gli insegnanti e per tutti coloro chelavorano all’interno della scuola.Costituisce anche uno stimolo per il lorosviluppo personale e professionale.
Ambiente
La scuola che promuove la salute poneuna particolare enfasi sull’ambientescolastico, sia fisico che sociale, qualefattore cruciale per la promozione e ilsostegno della salute. L’ambiente divieneun’ inestimabile risorsa per un’effettivapromozione della salute attraverso losviluppo di politiche che promuovono ilbenessere.Attenzione all’ambiente comprende siala attuazione di misure per monitorare lasalute e la sicurezza, sia l’introduzione di
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200310
�����������������������
appropriate strutture direttive eorganizzative.
Metodi di insegnamento
Alta priorità viene attribuita allo sviluppodei metodi di insegnamento e appren-dimento costruiti sulla base di approccidemocratici e di partecipazione, coinvol-gimento attivo e potenziamento perso-nale. L’uso di un’ampia gamma di metodiaiuta le persone a generalizzare il loroapprendimento, attraverso l’offerta dicontesti diversi nei quali mettere in praticale proprie competenze.Le attività includono le modalità per raf-forzare i propri valori, esercitare le capa-cità di affermazione, sviluppare capacitàcritiche e decisionali.
Partnership
A livello nazionale, i paesi partecipantihanno fornito un profondo contributo alprogetto, inclusa la cooperazione tra isettori educativi e sanitari, e tra questi ele scuole partecipanti. Al fine di prendereparte al ENHPS (European NetworkHealth Promoting Schools), ciascunpaese fornisce:- un impegno firmato dai dirigenti di alto
livello dei ministeri per l’istruzione edella salute;
- il nome ed il curriculum vitae delcoordinatore nazionale designato,approvato da ambedue i ministeri;
- una lista di 10-20 scuole pilota, cherappresentano ciascun livello d’istru-zione e che assicurano una equa rap-presentanza delle diverse parti delpaese;
- un piano progetto per un periodo dialmeno tre anni;
- un centro nazionale di sostegno per ilprogetto;
- piani di valutazione;- una strategia per l’incremento dei fondi.
Il valore della partecipazione
La partecipazione dei giovani ai processi
di formulazione delle politiche della salutee ai programmi educativi così come allosviluppo, implementazione e valutazionedei programmi è importante per diverseragioni.Non solo consente di adattare i messaggie gli approcci in modo mirato ma,verosimilmente, è anche in grado di por-tare allo sviluppo personale e sociale glistessi giovani attraverso la costru-zionedelle proprie capacità personali e altrimezzi.La partecipazione alle politiche disviluppo e programmazione può sfociarein una maggior sensibilità verso lecondizioni che direttamente influisconosulla salute e sul benessere delle comunitàlocali.Prove importanti dimostrano che lapartecipazione allo sviluppo della salutecomunitaria può incidere sul modo dipensare della popolazione, nel senso chesposta la preoccupazione dai problemi dimalattia individuale a una considerazionedell’importanza della salute dellacomunità e della capacità della comunitàdi controllare e migliorare le condizionilocali per una società più sana.
Tappe verso uno svilupposostenibile per tutte le scuole
Le risultanze suggeriscono che la
formulazione di una politica sarà possibile,dopo la fine della fase pilota del progetto,attraverso sei tappe ben identificabili,fino allo stadio finale il quale implica ladefinizione di una politica, la suaaccettazione a livello politico, e la suaattuazione.Stadio 1: immagine positivaL’intero processo inizia quando il progettoviene visto sotto una luce positiva.Le persone in posizione migliore perproiettare questa immagine positiva nondebbono essere le persone che prendonodecisioni o i politici, ma coloro che sonocoinvolti nelle scuole pilota, quali ilcoordinatore, membri del gruppo digestione del progetto, staff scolastico,ispettori e valutatori. Inoltre, possonogiocare un ruolo importante anche glialunni, i genitori e la comunità in sensolato.Stadio 2: informazioneI risultati suggeriscono che i coordinatorihanno raggiunto lo stadio dell’informa-zione attraverso un approccio che hacombinato un’ampia divulgazione conun’azione mirata verso i ministri dellasalute e dell’istruzione e i funzionari didetti ministeri.In aggiunta, i coordinatori si sonoimpegnati per il progetto e hanno prodottorapporti che documentano i loro progressie li hanno diffuso con vari mezzi.
�����������������������
11n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Stadio 3: credibilitàCaratteristiche distintive del terzo stadiosono l’offerta di informazioni agliamministratori con potere decisionale,sottolineando i benefici potenziali delprogetto, la conoscenza della suacredibilità ed interesse in alcune (o tutte)le sue caratteristiche.La ricerca ha rivelato l’importanzacruciale del settore dell’istruzione in taleprocesso.Stadio 4: rilevanzaRilevanza, in tale contesto, significa cheil settore dell’istruzione è stato convintodella necessità di sviluppare una politicadi promozione della salute a scuola.Tale politica può essere sviluppata inmodo isolato o, preferibilmente, con ilsupporto del settore della salute o di altripartner.Le politiche si differenziano inevitabil-mente tra le regioni e gli stati, ma ciascunaha in sè elementi essenziali quali ildesiderio di ogni scuola di essere capacedi adottare una filosofia di promozionedella salute, al fine di trarre beneficio daun supporto pratico (quale lo sviluppodelle capacità) e di portare avanti unmiglioramento delle proprie condizioni(ad esempio nell’ambiente fisico e nelcurriculum).Per dare rilevanza al progetto, dovrebbero
essere identificate le priorità, le proble-matiche, le politiche o i progetti checoloro che hanno il potere di estendere ilprogetto vorrebbero vedere presentate.Stadio 5: fattibilitàQuando i ministri e i dirigenti sono convintidell’importanza dell’approccio suggerito,per affrontare i loro temi prioritari,dovrebbero prendere in considerazionele modalità di estendere il progetto. Ciòimplica un’adeguata infrastruttura per losviluppo del lavoro e le risorse, sia per icosti iniziali che per quelli a lungo termineper il mantenimento dell’alta qualità deiprogetti scolastici.Una volta che tale livello è stato raggiuntosi dovrà sviluppare un’infrastruttura perun progetto più esteso con il settoredell’istruzione, qualche volta con l’aiutoed il supporto del settore della salute. Ilmodo in cui questi due settori sonoorganizzati, sia a livello locale cheregionale, e particolarmente il modo incui essi collaborano, influenza lo sviluppodella struttura.Ove possibile, il progetto dovrebbeintegrare il lavoro esistente (o pianificato)in questa area piuttosto che sostituirlo.Coloro che sono coinvolti nellapromozione della salute (come ilpersonale di organizzazioni volontarie egli operatori sanitari) devono giocare un
ruolo di primaria importanza; tuttaviadeve essere anche enfatizzato lo sviluppodelle strutture dell’istruzione necessarieper la promozione della salute a scuola.In questo modo sarà più semplice gestireun lavoro congiunto.I due principali indicatori in grado difornire prove dell’avanzamento di questostadio di fattibilità potrebbero essere:- una concertazione a livello politico
e decisionale sui diversi meccani-smi per l’estensione del progetto;
- l’identificazione di almeno una pos-sibilità di avanzamento.
A questo stadio si dovrebbe essereconsapevoli dei limiti di una azione che siaffida troppo ad una diffusione basatasulla scuola.Inoltre, le richieste di curriculum formalipossono essere troppo estese, mettendoin pericolo una strategia basata sullabuona volontà degli insegnanti diinformare le altre scuole. Gli insegnantispesso dicono che questo non è di lorocompetenza.Le uniche circostanze in cui questastrategia potrebbe funzionare in tal sensodovrebbero essere quelle in cui alpersonale viene concesso tempo dadedicare in maniera specifica in questaattività di supporto, con un distaccoformale dal lavoro di routine: è cioè,necessario, almeno nell’avvio, che questoimpegno venga ufficialmente ricono-sciuto come mezzo di sviluppo del pro-getto.Stadio 6: politicaUna volta che coloro che debbonoprendere le decisioni sono convinti dellafattibilità di un progetto esteso, lo stadiofinale è l’adozione di una politica che hacome fine quello di assicurare lo sviluppocomplessivo della promozione della salutenella scuola.Mentre la realizzazione dovrebbe venirein seguito, questo stadio si riferisce inmaniera specifica all’adozione di unapolitica con mezzi quali la legislazione,un curriculum nuovo o rivisto, ocambiamenti strutturali nel sistemaeducativo.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200312
�����������������������
Azioni future per il sostegnodella promozione della salutenelle scuole
Raggiungere lo stadio 6 non significache il lavoro sia stato completato. Aquesto punto, sarà necessario lavorareduro per sostenere lo sviluppo di unapromozione della salute nelle scuole dialto livello ed efficace, in un mondo incontinuo cambiamento. Il lavoro futurodovrà verosimilmente prevedere iseguenti punti:- Attuazione della politica prescelta, cosa
occorre fare a breve termine. Qualeprogrammazione è richiesta?
- Un secondo compito è quello diassicurarsi che vi siano standardqualitativi per la diffusione e lo sviluppofuturo, al fine di prevenire la dispersionedegli obbiettivi del progetto. Adesempio, la filosofia su cui si basa ilprogetto e l’internazionalità, dovreb-bero essere tematiche da sostenerecon continuità insieme con la diffusionedel progetto
- Terzo, pratiche di sviluppo dellapromozione della salute nelle scuoledovrebbero essere costanti.Qual è il miglior modo per organizzarecorsi di formazione per gli insegnanti ecome si possono formare i docentifuturi? Quale tipo di formazionenecessita il personale addetto alla salu-te? Quale ruolo possono giocare gliispettori scolastici?Focalizzarsi sui curricula di in-segnamento-formazione e sull’or-ganizzazione dell’aggiornamento,senza dimenticare i professionisti dellasalute.
- In seguito, cercare le opportunità perfar confluire la prevenzione e il benes-sere nell’approccio alla promozionedella salute nel lavoro scolastico.
- E’ importante, inoltre, valutare la qualitàdei livelli scolastici.
- Il compito finale potrebbe essere quellodi assumersi una responsabilitàcomplessiva nel progetto o per il suocoordinamento, e fornire un ritornoalle scuole, ai funzionari e ai politici.
Stato attuale di avanzamento
La Rete Scuole Promotrici di Salute haconcorso a facilitare i cambiamenti vitaliall’interno delle scuole. In particolare ha:- Ottenuto una buona reputazione come
importante investimento per lasalvaguardia e la promozione dellasalute e della sicurezza dei giovani;
- Ha fornito il giusto quadro per andareincontro alle necessità del personalescolastico docente e non docente nellapromozione della salute;
- Ha portato come risultato ad uno stilepiù democratico nella direzione enell’insegnamento nelle scuole;
- Ha ispirato gli insegnanti a trovarenuovi metodi di insegnamento in gradodi riflettere questo nuovo spiritodemocratico;
- Ha concorso a costruire consenso ecooperazione a livello europeo, dandoluogo ad un importante senso d’unità;
- Ha cominciato a mettere in agenda lapromozione dell’educazione e dellasalute, in modo congiunto.
�����������������������
13n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
BIBLIOGRAPHYAggleton, Peter, Thomas CoramResearch Unit, Institute of Education,University of London, PromotingYoung People’s Health - Towards aEuropean Strategy for the Promotionof Young People’s Health andDevelopment, Prepared for the WHORegional Office for Europe, October2000.
Barnekow Rasmussen, Vivian;Burgher, Mary Stewart; Rivett, David.The European Network of HealthPromoting Schools - the alliance ofeducation and health / WHO RegionalOffice for Europe / EuropeanCommission / Council of Europe.
Barnekow Rasmussen et al. Anexamination of two large-scaleapproaches for promoting healththrough schools. Maastricht,University of Maastricht, 1997.
Conference Resolution - FirstConference of the European Networkof Health Promoting Schools, “TheHealth Promoting School - aninvestment in education, health anddemocracy”, Thessaloniki-Halkidiki,Greece, 1-5 May 1997.
Denman, Susan; Moon, Alysoun;Parsons, Carl, Stears, David. TheHealth Promoting School – PolicyResearch and Practice. Routledge,2002.
European Commission, Council ofEurope, WHO Regional Office forEurope, Université Libre deBruxelles.Tracking down ENHPSsuccesses for sustainable developmentand dissemination. The EVA 2project. Final report.
European Commission, Council ofEurope, WHO Regional Office forEurope, Université Libre de
Bruxelles.Tracking down ENHPSsuccesses for sustainable developmentand dissemination. The EVA 2project. Final report.
International Union for HealthPromotion and Education, TheEvidence of Health PromotionEffectiveness. Shaping Public Healthin a New Europe. A report for theEuropean Commission, Brussels,1999.
Piette, D., Prévost, M., Roberts C.,Tudor-Smith, C., Tort i Bardolet, J.Self-assessment for sustainabledevelopment of school healthpromotion (Autodiagnosis). Guidelinesfor national and regional coordinatorsof the European Network of HealthPromoting Schools.
Weare, Katherine. ‘Promoting Mental,Emotional and Social Health: A WholeSchool Approach’, Routledge.WHO policy series: Health policy forchildren and adolescents Issue 1.International report.
Health and Health Behaviour amongYoung People. WHO Regional Officefor Europe, 2000.
WHO, HEALTH21: the health for allpolicy framework for the WHOEuropean region. European Health forAll series no. 6, WHO RegionalOffice for Europe, 1999.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200314
�����������������������
Dagli antichi strumenti allanuova realtà
La tradizionale igiene scolastica, evolutaattorno agli inizi degli anni sessanta inmedicina scolastica, ha quasi fatto il suotempo e richiede un considerevole aggior-namento, pur conservando una partedella sua validità, specie in particolaricondizioni.E non tanto perché siano migliorati ilocali e le infrastrutture scolastici (dimaggiore rilevanza per l’igienetradizionale), tanto da far divenire obsoletimolti degli strumenti utilizzati, quantoperchè altre sono le problematiche cheminacciano/affliggono i nostri giovani erichiedono qualche cosa in più, nuoviutensili di lavoro.Lo stato di salute dei giovani, qualerisulta dai dati epidemiologici e dallerelazioni che considerano maggiormentegli aspetti sociali, evidenzia infattiproblematiche totalmente diverse dalpassato, anche recente (3,7,9). Allevecchie patologie, di molto diminuite senon scomparse del tutto, se ne sonoaggiunte di nuove anche molto diversema soprattutto sono comparsi nuovifattori di rischio, più complessi e articolati.Si tende infatti a sostituire al concetto disalute, pur sempre legato al suo negativo,la malattia soprattutto fisica, quello piùampio e comprensivo di benessere. Suquesta tema sono state scritte già molte
cose, per cui non vale la pena in questasede di dire altro.Prendendo dunque in considerazione ilbenessere dei giovani a scuola - oltre latradizionale definizione di salutedell’OMS - dobbiamo mettere in campoun diverso approccio, che considera moltialtri elementi rispetto a quelli di solitoconsiderati. Un nuovo modello, moltointeressante, proposto da due autorifinlandesi (5) considera che il benesseresia determinato da quattro componenti(having, le condizioni della scuola;loving, le relazioni sociali; being, i mezzidi autorealizzazione; health, lo stato disalute) che sono influenzate dalla scuola(insegnare-imparare), dalla casa, dallacomunità e dal contesto.Numerose indagini condotte fra gli stu-denti sui fattori associati al benessere,riferito al modello sopra citato (6, 8, 9, 11,12) hanno evidenziato un ruolo moltoimportante di elementi diversi da quelligeneralmente presi a riferimento. Neciteremo solo alcuni, nello spazio che ci
è concesso, riferiti al background di pro-venienza ed all’ambiente scolastico.Secondo i giovani, hanno bassa importan-za le condizioni socio-economiche,mentre è di rilevantissima importanza lacoesione sociale della famiglia; “il parlarecon i genitori” appare molto più importan-te della struttura della stessa. Hanno unruolo rilevante le attività ricreative, ecerti comportamenti attinenti alla salute,specialmente il sonno. Curiosamente igiovani attribuiscono assai pocarilevanza all’uso di sostanze (alcol, droga,fumo…).Relativamente all’ambiente scolastico,hanno basso impatto le condizioni dellascuola, al contrario risultano moltoimportanti le relazioni sociali; di granderilevanza il sostegno dell’insegnante,meno importanti i modi gentili; sembre-rebbe che forse gli studenti vogliano unprofessore severo ma presente, che liaiuti nell’apprendere.I mezzi di autorealizzazione, nell’imma-ginario dei ragazzi, mostrano la più alta
������ ��� ������ � ������� ������ �������� ����������Lamberto BRIZIARELLI
Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Perugia,direttore del Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria
�����������������������
15n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
BENESSERE A SCUOLA
TEMPO
CASA
SCUOLA
BENESSERE
INSEGNAMENTO EEDUCAZIONE APPRENDIMENTO
situazione saluteindividuoaffetti
Condizionidella scuola- dintorni e microclima- organizzazione scolastica- tempi, ampiezza dei gruppi- punizioni, sicurezza- servizi, servizi sanitari- mensa
Relazioni sociali
- clima sociale a scuola- dinamiche di gruppo- relazioni insegnante-studente- relazioni con i pari- bullismo- cooperazione con la famiglia- management...
Mezzi perl’autorealizzazione- valorizzazione del lavoro dello studente- esistenza di: guida incoraggiamento- influenza sulla presa di decisioni- aumento dell’autostima- uso della creatività
Condizioni disalute- sintomi psicosomatici- malattie croniche gravi- disturbi lievi- infreddature, raffreddori- ……………….
Modello di benessere scolastico sedondo Konu e Rimpela, 2002
CO
NT
EST
O
CO
MU
NIT
A’
correlazione con il benessere, la proget-tualità per il futuro, l’avere un piano,come elementi principali.Quanto allo stato di salute, vengonosegnalati come molto importanti i piccolidisturbi, i comuni raffreddori; pocoinfluenti le malattie croniche o di lungadurata, verso le quali evidentemente ilservizio sanitario offre soluzioni che dannoun compenso soddisfacente.
Un nuovo approccio allamedicina nella scuola, l’Igienedel lavoro
Probabilmente occorre pensare ad unavisione più realistica, che rifiuti la versioneidilliaca della scuola, luogo gioioso egradevole, al quale ci si reca con piaceree trasporto, quasi con passione e laconsideri per quello che realmente è, unvero e proprio “luogo di lavoro”, unostrumento di autorealizzazione, dipianificazione del futuro.E in tal senso la scuola sarà contras-segnata da orari, disciplina, rigore e meto-do, produttività, al pari di un’azienda,produttrice non di beni ma di altri prodotti,alla quale, di conseguenza, va applicatoun vero e proprio approccio di igiene dellavoro.Tale approccio rappresenta un processo
di:a) analisi e conoscenza approfondita
delle varie componenti della scuola,umane e strutturali,
b) intervento per garantire che il lavoronon sia nocivo.
Uno strumento tecnico, inserito nel piùgenerale quadro della promozione dellasalute, che serve a “lavorare per pro-durre non per ammalarsi”.Si tratta di un’operazione ancora piùdifficile rispetto agli stessi luoghi “veri”della produzione, perché nella scuola glioggetti del produrre sono due, uno deiquali - concetto peraltro già percepito edintrodotto anche nelle fabbriche e in altriluoghi tradizionali di lavoro, sia pure nonin tutti - è rappresentato dal “lavoratorestesso”, lo studente.Quanto si fa a scuola, infatti, serve aprodurre- sapere, conoscenza, competenze,
capacità- lo sviluppo/la crescita dell’individuo in
quanto tale, a prescindere dalla quali-ficazione della scuola che frequenta.
Il secondo punto dovrebbe sembrarepleonastico ma troppo spesso ci sidimentica - talora lo si omette sciente-mente - del secondo, vero e proprio“bene” da produrre che, secondo me, èaltrettanto importante del primo, il quale,
di solito assorbe la maggior partedell’attenzione del corpo docente.È ovvio che la strategia “promozionedella salute” si applica anche ai lavoratori“propri” (insegnanti ed altro personale)che, in questo caso, per mantenere ilparallelo con i luoghi di produzionenormali, rappresentano la dirigenza e lostaff aziendale, che agiscono sulla forzadi lavoro bruta (gli studenti, ad un tempolavoratori e materiale su cui lavorare).Essi sono protetti dalla normativa chetutela tutti i lavoratori tipici e comunqueil ragionamento vale anche per tutelarela loro salute.
Igiene del lavoro: modellooperativo
Le componenti su cui l’Igiene del lavorosi applica sono due, l’ambiente e l’uomo,ciascuna delle quali a sua volta ècomposta di due parti, una strutturale eduna sovrastrutturale, anatomia efisiologia, corpo e psiche.Le ricordiamo brevemente, senza entrarenel dettaglio.L’ambiente comprende:a) per la struttura: locali, arredi, mac-
chine, utensili e materiali, che nel loroinsieme determinano i fattori di rischiodei primi tre gruppi1 e condizionano -alterano, come si diceva una volta - il“microclima”;
b) per la sovrastruttura: organizzazionedel lavoro - orari, tempi e metodi,tecnologie, processi (di insegnamento/apprendimento, relazionali ecc.), chedeterminano quello che possiamochiamare il “clima sociale”.
Per quanto riguarda l’uomo, di esso èimportante conoscere anatomia efisiologia, il corpo ed il suo funzionamento,somatico e psichico, la cultura, l’origineed il contesto di appartenenza, le abitudinie costumi, le credenze, la fede religiosa,come componenti strutturali e sovra-strutturali.1 Si fa riferimento alla classificazione dei
fattori di rischio in quattro gruppi, a tuttiben nota ed a cui si rinvia.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200316
�����������������������
Come si fa
L’espletamento dell’Igiene del lavoro ascuola comprende un duplice impegno,quello dei tecnici dell’igiene e di altrediscipline, quello degli insegnanti e deglialtri operatori scolastici.Trascuriamo quelli dei primi, non essendodiretto a loro il discorso di oggi e inquanto trattasi di competenze tecnicheche riguardano le componenti fisichedella scuola e quindi dell’ambiente per laparte strutturale. Diremo solo chedall’impegno dei tecnici dell’igiene,insegnanti e studenti dovrebbero ricevereil luogo del loro lavoro nelle miglioricondizioni possibili, libero da fattori dirischio.Ci occupiamo solo di ciò che fanno isecondi e solo dell’impostazione di unaparte di esso, la conoscenza e l’analisi dipartenza, da cui prende corpo il lavoroproduttivo, l’intervento sulla componentesovrastrutturale.L’analisi e la conoscenza degli allievi edel contesto di provenienza - nel sensosopra detto - non sono sempre compresenella loro piena accezione e sono pocosviluppate, per varie ragioni, tra cui losfavorevole rapporto discenti/docenti,l’alto numero di allievi per classe ed ilpoco tempo a disposizione per questiaspetti, rispetto agli adempimentiburocratici.Le cosiddette analisi d’ingresso - laddovepraticate - per lo più sono limitate algrado di istruzione ricevuta, al livello diconoscenza posseduta dagli allievi. Essedebbono essere obbligatoriamenteeseguite e nel modo più approfonditopossibile, in modo da fornire sin dall’iniziouna completa conoscenza di ogni studentee del suo ambiente di origine, come seogni insegnante si trasformase in unnovello Diogene,“ in cerca dell’uomoper realizzarlo al meglio”.Completato il processo di analisi si passaalla seconda parte dell’impegnoigienistico, che riguarda l’interventosull’organizzazione del lavoro. Esso,ancora più importante, riguarda l’insieme
degli eventi che costituiscono il rapportodello studente con la scuola e con gli in-segnanti,con i restanti operatori all’internodell’istituzione.Oltre gli orari, i turni, i compiti, gli zainettitroppo pesanti, l’articolazione dellematerie, i programmi - cose fin tropponote - debbono essere presi in considera-zione i processi relazionali tra insegnantie discenti, fra gli allievi, i modi dell’ap-prendere e dell’insegnare, il clima socialedella classe e della scuola, le relazioniscuola-famiglia, ecc. Insomma tutti queglielementi che la ricerca ha indicato esseremaggiormente correlati con il benesseredei giovani.Come tutto ciò debba essere fatto, nonritengo necessario di trattazione.Quanto sopra ricordato infatti, relativoall’applicazione di una corretta Igienedel lavoro scolastico, è il mestiere delbravo insegnante, parte integrante dellasua qualificazione professionale e nonvoglio entrarci, per non invadere unterreno riservato ed anche perché altrise ne occuperanno dopo di me.
Per concludere
Il discorso che abbiamo fatto, limitatoallo stretto ambito dell’Igiene dellascuola, rappresenta una parte - o se sipreferisce si dissolve all’interno - delprogetto generale cui è dedicato questoconvegno, la Promozione della salute, eva quindi letto facendo riferimento aiconcetti generali di essa, globalità eintersettorialità, onde evitare che siaconsiderato come un’altra operazionesettoriale. Al contrario ve collocata in unambito collettivo da parte di tutti glioperatori della scuola e debitamenteinserito nella programmazione dell’attivitàdella scuola.Per proseguire sulla strada del paragonecon il mondo del lavoro, si potrà prenderea riferimento la corposa elaborazioneesistente sullo specifico della promozionedella salute in quel contesto, che haavuto un evidente riscontro anche inattività di ricerca e intervento, a livelloitaliano ed internazionale, cui rinviamoper opportuno approfondimento (1, 2).
�����������������������
17n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
BIBLIOGRAFIA1. Breucker G. (a cura di): Towards
better health at work.successfuleuro-pean strategies. Essen,Bundesverband derBetriebskrankenkassen, 2000.
2. Briziarelli L., Masanotti G.,Notargiacomo A.,.et al. Lapromozione della salute nei luoghidi lavoro. Prevenzione oggi 12:3,2000.
3. Briziarelli L. Pocetta. G. L’Igienedel lavoro scolastico. In: Ambientee infanzia in Italia (a cura diTalamance e Mantovani).Verducied. Roma 2003.
4. Briziarelli L., Pocetta G., ColettiA., et al: Progetto Ambiente dellaConca Ternana 2, Indagine sullapercezione dello stato di salutenella scuola, 2002-2003, Cattedradi Igiene, Corso di Laurea inMedicina di Terni, 2003.
5. Konu A., Rimpela M.: Well-beingin schools: a conceptual model.Health Promotion Int.17:79, 2002.
6. Konu A.I.,Lintonen T.P., RimpelaM.K.: Factors Associated withschoolchildren’s general subjectivewell-being. Health Educ.Research 17:155,.2002.
7. ISTAT: Indagine “Aspetti dellavita quotidiana, 1999.
8. McCullough G., Huebner E.S.,Laughlin J.E.: Life events, self-concept, and adolescents’ positivesubjective well-being. Psychologyin the School 37:281,2000.
9. Opdenakker M.C., Van Damme J.Effects of school, teaching staffand classes on achievement andwell-being in secondary education:similarities and differences
between school outcomes. SchoolEffectiveness and SchoolImprovement 11:165, 2000.
10. Relazione sullo Stato Sanitario delPaese 2000, Ministero della salute,Roma, 2002.
11. Salmivalli C., Kaukiainen A. Self-evaluated self-esteem, peerevaluated self-esteem, anddefensive egotism as predictors ofadolescents participation inbullying situation. Personality andSocial Psychology Bulletin, 25:1268,1999.
12. Tynjala J., Kannas L., Levalathi E.et al. Perceived sleep quality andits precursors in adolescence.Health Promotion Int. 14,155,1999.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200318
�����������������������
Dopo la garbata e serena presentazionedei problemi da parte dell’igienista, pongouna domanda un po’ stravagante: leeducazioni sono di destra o di sinistra?Qualcuno ha voluto presentare anchecosì questa problematica. Pare, peresempio, che Maradiano e Vertecchisiano di sinistra, e gli educazionisti, comeil sottoscritto, siano di destra. Constatoche in passato la sinistra si è moltoimpegnata per l’educazione sessualenella scuola, arrivando fin quasiall’approvazione di un testo che poi nonè passato; constato che nel Governotecnico Dini-Lombardi si è arrivati ad untesto ricognitivo di tutto quello che erastato detto fino ad allora per le educazionial plurale nella scuola. Con una direttiva58, che ha per titolo: “Nuove dimensioniformative: educazione civica e culturacostituzionale”, si era cercato di vederecome l’essere fedeli alla Costituzionenon implicasse necessariamente esseredi destra o di sinistra, implicasse guardareavanti, verso quel tipo di popolazione, dipopolo italiano, di persone, di cittadini edi lavoratori senza i quali non si dàRepubblica.Infatti nell’Art. 3 si dice che “la Repub-blica rimuove gli ostacoli che, limi-tando di fatto la libertà e l’uguaglian-za dei cittadini, impediscono il pienosviluppo della persona umana” -l’espressione più pedagogica della Co-stituzione - e la partecipazione di tutti i
�� ������ ����������� �������������� � ���� ��� ����� � ���������Luciano CORRADINI
Ordinario di Pedagogia,Università degli Studi di Brescia
lavoratori all’organizzazione politica,economica e sociale del Paese. Dunque,la Repubblica che istituisce scuole èRepubblica che rimuove ostacoli, chepromuove lo sviluppo pieno della perso-na, nei suoi aspetti intellettuali, affettivi,etici, fisici, e la partecipazione, senza laquale non si dà Repubblica. Dunque lascuola è chiamata a produrre persone eRepubblica. O no? Che poi ci si orientiprevalentemente sui valori della libertà osui valori della solidarietà, queste sonoquestioni che attengono all’ordinato svi-luppo del Paese. Ma in ogni caso è ilvalore della persona e la vita umana chesono riconosciuti dalla Costituzione edalla Dichiarazione Universale dei Dirit-ti dell’Uomo; è condizione per poter faredecentemente il proprio mestiere di in-segnanti nella scuola.È un fatto che qualcuno pensa che tuttiquesti valori debbano essere inseriti nellascuola attraverso circolari, direttivespecifiche, progetti ad hoc, e qualcunaltro pensa invece che non se ne debba
parlare, perchè in questo modo sidisturberebbe il “manovratore”, cioèl’insegnante, che ha ricevuto inaffidamento dalla legge e dal contrattocollettivo l’insegnamento di una disciplina,in un certo numero di ore, per un certonumero di ragazzi. Allora c’è questatrasversalità, queste raffiche che arrivanodall’esterno, partendo per lo più dalleemergenze, dalla constatazione che lepersone soffrono, gli incidenti stradaliaumentano, le malattie si diffondono, icomportamenti a rischio e anche negativisono oggetto di considerazioni allarmate;insomma, arrivano le emergenze e ladomanda dei giornalisti di solito è questa:cosa fa la scuola? Per cui i Ministri diturno debbono dire: ci stiamo occupandodi queste cose. Ricordo che D’Onofriodisse: faremo l’educazione fiscale; forsequesto Ministro in qualche sede ha detto:faremo l’educazione antipedofilia, ancheDe Mauro si era preoccupato di questo.Però, quando poi si rivolgono agliinsegnanti, gli insegnanti, strutturati nelle
�����������������������
19n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
loro discipline, dicono: ma per carità! Macos’è tutta "questa roba?" Mica siamo alPaese dei Balocchi! Addirittura Berlin-guer ironizzava sul Club Mediterranée:cosa devono fare gli insegnanti? Gliintrattenitori, gli psicologi, gli animatori?No, devono fare gli insegnanti, giusto; èstato ricordato anche dall’igienista.Addirittura si dice: è una fabbrica. Mauna fabbrica per produrre che cosa? Perprodurre persone, cittadini e lavoratori.“Produrre” è un modo di dire, come si faa produrre una persona? Dal punto divista fisico lo si sa, ma "tirar su unbambino" non è mica una cosa semplice,e portarlo ad interiorizzare i valori, quellecose che ai miei tempi erano moltochiare..., perché io sapevo che c’eraDio, c’era il Duce, c’era il Re (nonsapevo bene cosa veniva prima e cosaveniva dopo), poi c’era la scuola, ilmaestro, la mamma, ed erano collegati.Adesso gli oggetti immensi sono moltoframmentati, l’immaginario collettivo èfrastagliato, ci sono guerre stellari datutte le parti. Ci sono ancora i buoni e icattivi, ma da che parte stiamo? E i buoniche cosa vogliono fare? Ci basta questopianeta, oppure dobbiamo andare acercarne degli altri? Nel-l’immaginariocollettivo ci sono di fatto dei bisogni,delle urgenze, delle impellenze, oggi,adesso, per procurarsi piaceri e per
eliminare fastidi e guai. Ciascuno ha ildiritto - perché il concetto di diritto èmolto passato - di affermare se stesso ei suoi piaceri, e non ha doveri, se nonpresentatigli da strani Grilli Parlanti, iquali fanno la fine di quello di Pinocchio:spiaccicato contro la parete. Perché?Ma perché deve parlare? Ma che cosavuole?Vedete, il rischio più grosso è che ci siaquesta frammentazione, che a scuola cisiano soltanto degli insegnanti che fannoi Grilli Parlanti e dei Pinocchi che seguonole strade loro, che cercano i Paesi deiBalocchi, i baracconi e così via.Questa è la situazione... Ne “LaRepubblica” di ieri c’è un testo in cuiun’insegnante, con una rara efficacia,dice: “Entro in classe già preoccupata dinon farcela a contenere 16 bambininevrotici, ansiosi, disorientati, eccitati,agitati, incontinenti; bellissimi, incapacidi aspettare anche per pochi secondi ilsoddisfacimento dei propri bisogni;bambini con mille domande sulla bocca,urlate sulla voce degli altri, e disinteressatialle risposte”. Ma questo succede anchenel Consiglio Nazionale della PubblicaIstruzione: tutti chiedevano la parola;poi, al momento di ascoltare, se neandavano. Si era deliberato - c’è già lalegge - di non fumare, ordine del giornoGigliotti, messo in approvazione all’unani-
mità, e poi tutti fumavano; tutti..., lametà.Dico: ma, scusate... In Parlamento:quando parlano i capi, stanno adascoltare, ma poi non ascolta nessuno,perché quello non si chiama “Ascol-tamento”, si chiama “Parlamento”, quindisi afferma il diritto del singolo di dire lasua, non il dovere di ascoltare.Si dice: ci vuole troppo tempo perascoltare, sono abituati ai quiz: sì, no.Bambini sicuramente amati dai genitori,ma non ascoltati, perché a casa non siparla; o si urla, o si tace, o si guarda laTV, o si gioca con la Play Station.Bambini accontentati, perché così nonrompono; puniti quando disturbano, manon perché abbiano fatto qualcosa; nonpuniti, invece, quando si dovrebbe.Bambini che arrivano a scuola senzalimiti, senza regole.Bisognerebbe educare ai sentimenti, alcontrollo delle emozioni, ad esprimersicon le parole e non con parolacce edaggressività; a dire “buongiorno”, perchéè bello salutarsi, ma loro si vergognano diessere gentili. Questa idea curiosa: lavita in periferia è difficile, è bene essereduri fin da piccoli.Io insegno il dialogo, il confronto civile, lacondivisione, l’amicizia, l’accoglienza deldiverso; si può continuare su questalinea.È chiaro, c’è una visione umana,umanistica, razionale, serena, salutista,se volete, dell’educazione: bisogna tiraresu delle persone equilibrate, perbene,sagge, eccetera, eccetera…Il contesto non spinge in questa direzione,spinge nella direzione opposta:l’affermazione di sé, nell’immediato; nonoffre criteri per differire la soddisfazionenel futuro, non offre criteri di proget-tualità.
ProgettareDa anni abbiamo parlato soltanto diprogetti. Che cosa vuol dire progettare?“Pro gettare”, buttare avanti; ma “pro”vuol dire anche “a vantaggio di qualcuno”,cioè bisogna avere dei fini importanti da
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200320
�����������������������
raggiungere, avere dei valori per i qualiimpegnarsi, avere qualcosa per cuisacrificarsi, sacra facere. Sacra facerevuol dire non solo rivolgersi all’Immenso,all’Eterno, al Divino, o alle proprie cose,ma vuol dire anche trovare una ragioneper rinunciare. E la ragione per rinunciareoggi la scuola sembra che non riesca adoffrirla, la vede solo come una morti-ficazione (far morire), anziché come uninvestimento. Pensate al gesto delseminatore che ha fame: il sacchettodelle sementi non lo tocca, lo butta perterra, perché deve seminare, perchébisogna campare anche l’anno prossimo.In fondo la salute è questa cosa: perchétanti ragazzi fumano?Io ho dal mio Rettore la delega a dare lamulta a chi fuma nelle sedi universitarie:ne ho data una. Fuma anche il mioPreside. Adesso arriva la legge, quellanuova, quella cattiva, quella precisa... eio voglio vedere poi cosa si farà. E isenatori... fumano. È evidente, fumanoi medici... Quindi è difficile riuscire agarantire alla nostra riverita specie unfuturo che sia caratterizzato dalriconoscimento che certi valori sonoimpegnativi, perché riconoscere che cisono valori e poi ciascuno fa quello chegli pare, alla fine è svalutare i valoristessi.Come a tavola dire: questa cosa ti fabene. Sì, ma a me non piace. Finito.Guarda questa cosa ti fa male. Sì, ma ame piace, però. Va bene, fai quello chevuoi, vai al frigorifero, piglia quel che tipare; vai al supermercato, guarda checosa ti dicono gli spot, ed è bell’e finita.Hai voglia a parlare in tutte le trasmissionisalutistiche, che sono ormai una regolacostante! Non ci sono più i predicatoriche predicano il venerdì di digiuno, laQuaresima. Ci sono quelli che dicono:guardiamo il colesterolo, e su questabase si pensa di venirne fuori.Purtroppo no, non è così, perché mancanogli organizzatori mentali, manca un idearioe un immaginario che siano adeguati allarappresentazione positiva di una personache è sana, intelligente, gentile, capace
di affrontare le situazioni, capace di faredei sacrifici senza disperarsi, senzadeprimersi, senza irritarsi; capace di starein situazione, di tenere la situazione."Carattere" indica questa capacità diessere dotati di autopercezione positiva.Qui c’è tutto il discorso di Albert Bandura,che è il discorso che sta facendo oggi lascuola, delle life skills, della peereducation: questo non è altro che losviluppo della legge 162, poi 309, inseritanel D.P.R. che raccoglie tutte le leggidella scuola italiana - del ‘96-97, mi pare- con due “articoloni”, che non è di fattopresente alla coscienza di nessuno, mapare neanche del Ministero, a questopunto, perché il Comitato ScientificoTecnico per l’educazione alla salute nonè stato ricostituito. È certo però che idiscorsi che fa il Ministro, quando sileggono anche sul “Corriere”, sonobellissimi. I tentativi che ha fattoBertagna, con queste bozze, sonopregevoli. È arrivato Galli Della Loggiae lo ha fatto fuori; poi ho tentato dirispondere, dopo qualche tempo: guardache questa educazione civile non è che
sia il frutto automatico del leggersi Dantee Galilei, perché Dante e Galilei sileggevano anche ai miei tempi, quandol’ethos era fascista; ci sarà pure unacurvatura della proposta educativa, dopola Costituzione. O è venuta per niente?E dopo tutto quello che in sedeinternazionale si è detto sul valore dellavita, sui rischi, sui pericoli, ci sarà purequalche curvatura.Nel 1974 non sono passati soltanto inostri decreti delegati, ma unaraccomandazione bellissima dell’UNE-SCO sui diritti umani, la libertà, lasolidarietà, il rispetto, l’antirazzismo; unbel testo. Ci si è rivisti nel ‘94, percelebrare il ventennale di questodocumento; sono state fatte delle riunioniintergovernative, come si fa di solitoall’UNESCO, quattro o cinque riunioni.Conclusione: si è ripresentato ildocumento del ‘74 tale e quale, conalcune note che dicevano come mai nonsi è riusciti a fare quelle cose e cosa sideve fare per non disperarsi, per nonrinunciare agli obiettivi soltanto perché èdifficile raggiungerli. Invece cosa
�����������������������
21n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
succede? Che ci sono obiettivi, sienunciano, poi si fa finta di niente, sisopravvive, si aspetta la prossimaemergenza: altra sottolineatura, altredichiarazioni, magari leggi, e poi ciascunova per conto suo.Questa idea del “rompete le righe”, pernon rompere, vuol dire poi “rompete leregole”, vuol dire poi: non è importanteniente, fate quel che vi pare, salvotrovarsi poi nei momenti drammatici diemergenza: le emergenze sanitarie, degliospedali, le emergenze dei tribunali, leemergenze delle carceri e così via, perchéquesto è l’esito della rinuncia a farsicarico dei fattori di realtà.
"Il senso delle cose"Accanto al principio del piacere e alprincipio di realtà, presentati in modorude da Freud, noi abbiamo cercato disviluppare il principio di valore.È qualcosa che non ti costringe aspiccicare il naso per terra: questa è larealtà, o mangi questa minestra o saltidalla finestra; ma neppure dice: ti piacequesto? Carino, sai, fai quello che ti pare,perché tanto la mamma ti vuol bene. No,caro, c’è questo riferimento al valore,che è frutto di una conquista, che è unitinerario. Allora gli insegnanti di tutte lediscipline, in quanto insegnanti ed
rispetto uno deve avere di se stesso,degli altri con cui vive in famiglia, di quelliche sono i suoi compagni nella classe, diquelli che sono nella scuola? Èresponsabile di quello che si fa sui muri,o no? Come si fa a comunicare?Finisco con una citazione. GiovannaBoda, che va in giro per l’Italia con le lifeskills e la peer education, erededell’educazione alla salute, di tutto quelgiro, dei progetti giovani., dice: “Abbia-mo fatto un esperimento: un’insegnanteleggeva un canto di Dante e i ragazzierano tenuti a scrivere quello chevolevano. Annotate, fate appunti”. Bene,quasi nessuno ha parlato di Dante, quasinessuno. Parlavano delle cose loro: leVeline, le cose che sentono, cose damangiare, i vestiti.Questo è sconvolgente, ecco perché miè anche difficile parlare di queste cose.Io ho dieci nipoti, di cui la maggiore fa ilprimo anno di Bocconi, quest’anno, el’ultimo sta per compiere due anni: questiqui hanno un mondo che è molto diversodal mio. Quando andavo al liceo, ricordoche ho fatto una trasgressione gravis-sima: ho scritto con la biro (erano leprime biro), sul banco, una “U”, che eral’Uno, perché avevo scoperto che Plotinomi dava una visione complessiva delmondo bellissima: l’Uno, centro,fondamento, trascendente, ma lì ci sonotutte le ragioni che non riesco a trovarequa, che poi diventa Logos, diventaRagione, l’Anima del Mondo; poi avevofatto una “S”, che era la Sandra, la miacompagna, con cui tentavo di cominciareun dialogo, passandoci i quaderni.Avevamo quindi una rappresentazionedella realtà, del futuro, del lavoro,dell’impegno, “che ci tirava su”. Adessofanno un’estrema fatica a trovarequalcosa che concentri l’attenzione.Dante per me era una cosa che miaiutava a pensare; la “selva oscura” laprovavo io, quando avevo idee confuse,quando avevo l’impressione di esserefallito a scuola, quando non riuscivo adessere all’altezza morale dei miei pensieri,sogni e così via. Ma l’idea che ci fosse
educatori presenti nella scuola dellaRepubblica, sono tenuti a partire dallecondizioni psicologiche, fisiche, mentali,sociali, familiari, di questi ragazzini. Masono tenuti dalla deontologiaprofessionale... brutta parola, da GrilloParlante, che però vuol dire che nonsono dipendenti soltanto dal paralle-logramma delle forze che ci sono lì, masono portatori di una convinzione, unaconvinzione che deriva loro da principiforti, cioè dal fatto che sono al servizio dialtri, al servizio di altri per aiutarli nonsolo ad acquisire le nozioni, le cono-scenze, le tecniche, le competenzealfabetiche, matematiche, che sononecessarie per inserirsi nel mondo dellavoro, ma devono aiutarli e metterli ingrado di avere delle ragioni per vivere edelle ragioni per morire.Devono riuscire ad aiutare i ragazzi atrovare senso nelle cose che fanno e atrovare degli organizzatori checonsentano di passare dalle prospettivegenerali di senso alle scelte quotidiane:cosa faccio oggi pomeriggio? Quali motiviho per spegnere la televisione o pertenerla accesa, per andare a trovarequell’amico, o per non andarci, perrispettare il programma che devo fare, oper stare su fino alle tre di notte, perchétanto poi faccio un’altra cosa? Che
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200322
�����������������������
un Virgilio, con la ragione che ti aiuta,che ti dà una mano, l’idea che ci fossequalcuno, le tre donne benedette che sidanno da fare per svegliare Virgilio, farequesto itinerario aveva una potenzasimbolica enorme. Il tema di maturitàche ho fatto era: “Se Dante avessesofferto meno, sarebbe stato menogrande”, questo tema mi hanno dato, e ioho preso 8, perché ho cominciato a direche la sua vita comincia nell’ora in cui isuoi occhi si incontrano negli occhi diBeatrice. Tra l’Impero, Arrigo VII diLussemburgo e la salvezza personalec’era un collegamento. Per me studiarevoleva dire crescere nella capacità diinterpretare il mondo, aiutarmi a scegliereun mestiere, tanto è vero che volevo faremedicina, perché mi sembrava che fossela professione più forte, quella che mimettesse in contatto più diretto con lagente e con i problemi veri delle persone.Poi ho fatto filosofia, ma con lo stessospirito: vedere come possiamo trovaredelle soluzioni che ci consentano di staremeglio al mondo; quindi la salute, per meè anche collegata in qualche modo con lasalvezza, poi ciascuno la vedrà per contosuo, ma questa è la strada.Il mio tema era altro: quali strumenti dicarattere metodologico e di caratteretecnico possono consentire all’inse-gnante di realizzare il benessere nellascuola? Allora mi faccio aiutare dal mioamico Francesco Rovetto, che ha scrittoun bel libro proprio sul modo di valorizzarel’esperienza educativo-scolastica perstare bene, cioè per avere la gioia diimparare, di crescere interiormente eper collegare il lavoro propostodall’insegnante, il curriculum scolasticotradizionale con la sua problematicaesistenziale, con la vita che fa ogni giorno.Quindi l’insegnante, ovviamente, devenon presentargli Dante come magari lopresenterebbe un Auerbach, che fa un’e-legantissima ermeneutica del testo perpochi raffinati, ma deve presentarlo -quelle parti che sono presentabili - inmodo tale che i ragazzi ci si trovinodentro. Deve sapere che Dante e don
Milani erano due fiorentini un po’ strani,che sono stati banditi dalla loro cittàperché politicamente le cose nonandavano e perché anche con la Chiesanon è che andasse tutto bene, però sonoriusciti entrambi a parlare al mondoproprio quando erano umanamente falliti.Allora, ci sarà pure qualche senso anchenel successo formativo di cui parla lascuola? Cosa vuol dire successoformativo? Vuol dire riuscire a fregare ilprofessore, a farti dare un buon voto epoi andare a fare un mestiere per il qualenon sei preparato, oppure successoformativo vuol dire che hai trovato delleragioni per cui sopporti anche leincomprensioni, ma non ti dai per vinto ealla fine quello che sai, quello che sei,riesci a farlo valere, perché hai delleesperienze che ti consentono di farlo ehai delle persone credibili di cui ti puoifidare? Queste sono le cose. Nella scuolasi riescono a stabilire questi intrecci? Sesì, allora poi vien dietro tutto: la salute, ilriposare adeguatamente, il sapereaffrontare lo stress, saperlo vincere, nonandare in depressione... .
�����������������������
23n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
������� �������
��� �� ���� ��� ����� �� ����������� ������� ��� ������ � ��������� ��
���� �� ���� ������ ��� ������������ � �� ���
Maria Antonia MODOLO
Università degli Studi di Perugia,Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria
La proposta di ricerca è stata costruita sull’analisi, condivisada funzionari della Regione Umbria e della Regione Toscanae dal Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitariadell’Università di Perugia, della congruità ed efficacia delleazioni di educazione sanitaria, o educazione alla salute, condottenella scuola, soprattutto nella scuola media di secondo grado,la scuola degli adolescenti.Queste azioni, come molti hanno osservato, si concentrano, dinorma, su progetti a termine, ispirati da fatti o richiestecontingenti. Manca un approccio organico, capace di inserirsiunitariamente nella formazione della persona, e, questo, anchequando il progetto si presenta nel quadro di una non megliodefinita “promozione della salute”, e si adottano metodi, ancheinnovativi, quali ad esempio la ricerca - azione. Riconosciamo,infatti, che alcuni di tali “progetti” possono essere portatori dinuove strategie e metodologie, contribuendo ad attivare nuovecollaborazioni con la scuola, ma, a nostro avviso, non hannogarantito, né lo possono per le caratteristiche proprie, lanecessaria continuità e integrazione nel processo formativoglobale.L’esperienza scolastica è così forte che di per se stessainfluisce sulle radici profonde di quegli atteggiamenti ecomportamenti che sono alla base di scelte, positive o negative,in grado di influire sullo stesso equilibrio salute della persona,nella fattispecie in età evolutiva - età nella quale si strutturanoi tratti della personalità che governano le modalità deicomportamenti, le abitudini e gli stili di vita - e sui problemi cheallarmano tutti noi quali fumo, droga, alimentazione scorretta,depressione, aggressione… .Abbiamo voluto confrontarci con l’ipotesi che la premessa piùsolida di una effettiva promozione della salute in etàevolutiva, e in particolare nell’adolescenza, si costruisce sullebasi delle motivazioni, sicurezze, soddisfazioni che si possonotrarre dalla vita di ogni giorno, rispetto alle aspettative di unapersona in “formazione”. Prima di tutto nei luoghi che incidonosulle conoscenze e sugli atteggiamenti: la famiglia e la scuola.La scuola in questa fase della vita del ragazzo ha un grandepeso nel processo di autonomia, anche come cassa di
compensazione nei confronti della famiglia. Questa premessapoggia sui principi della “scuola promotrice di salute”dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che insistono propriosulla organizzazione scolastica e del curricolo, sui metodi, sullaformazione degli insegnanti, sull’impegno della comunità.Corollario a questa ipotesi è che su queste basi le esperienzepositive possano favorire una equilibrata autostima e la capacitàdi decidere, i due anticorpi di difesa da comportamenti patogeni.E su queste basi possa inserirsi anche l’informazione checonduca, in modo organico, alla conoscenza effettiva delproprio corpo, delle sue esigenze, delle sue reazioni, rispettoalle problematiche che più preoccupano le campagnepreventive, ma anche rispetto al lavoro che si svolge a scuola.Nel redigere il piano di attuazione della ricerca, in collaborazionecon i vari soggetti aderenti alla unità di ricerca, abbiamoseguito i criteri sui quali sono formulati i tre obbiettivi portanti;la scuola promuove salute quando: 1) le metodologie sonocentrate sullo studente e sulle sue aspirazioni a imparare aesprimersi, a produrre e creare, e contribuire a costruire lapropria realtà, quando su questi scopi sono definiti programmi,metodi, capacità professionali dei docenti, 2) gli operatori sociosanitari supportano la scuola promotrice di salute quandocontribuiscono alla formazione del quadro di riferimentoconoscitivo delle caratteristiche dei ragazzi, dei requisiti dellasalute e della sua promozione, e forniscono gli elementi diverifica degli obiettivi raggiunti, 3) la comunità promuove lasalute quando si impegna a far confluire in un piano organicotutte le sue potenzialità e risorse economiche e tecniche,superando la settorialismo delle funzioni istituzionali.Ogni passaggio è stato condiviso e realizzato da e con coloroche dovrebbero essere i protagonisti della messa a regime diquanto si sarebbe dimostrato utile, a seguito dellasperimentazione.
Per l’individuazione di un sistema stabile di programma-zione e di intervento di azioni in favore di una scuolapromotrice di salute hanno collaborato in varie unità diricerca, coordinati di responsabile del settore sanità pubblicadella Regione Umbria, funzionari della Direzione Scolastica
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200324
�����������������������
Regionale, amministratori locali (Provincia e Comuni) dirigentie operatori dei servizi sanitari, docenti, dirigenti scolastici.Per favorire un piano organico e superare il settorialismo, sonostate analizzate leggi e disposizioni nazionali e locali, redigendoun documento per l’amministrazione regionale, che è statoaccolto nella stesura del Piano sanitario regionale 2003 -2005, uno dei risultati più rilevanti per l’azione futura.
Il lavoro, complesso e concreto della sperimentazionenelle scuole (primo biennio di sette scuole medie superiori èstato centrato sui seguenti elementi: a) lavoro e responsabilitàcondivisi: docenti e consulenti (ricercatori universitari eoperatori sanitari) hanno lavorato insieme per definire cometradurre le premesse in prassi nel lavoro scolastico, prendendoavvio dall’approfondimento del significato proprio del processoinsegnamento/apprendimento centrato sullo studente; b) sceltadelle metodologie: in coerenza con i principi della centralitàdello studente si è scelto di adottare le linee suggerite dal“metodo esperenziale”; c) due tipologie di moduli: il modulo“appartenenza” e i moduli disciplinari; il primo è consistito inun approfondimento delle procedure di “accoglienza” già inatto nelle scuole aderenti per gli studenti del primo anno; laseconda tipologia relativa alle discipline. Tutti gli interventisono stati condotti dai docenti di classe, con solo due occasionidi incontro dei consulenti con gli allievi.La valutazione di ogni passo del programma è stata realizzataimpiegando soprattutto “il diario di bordo”, redatto dagli studenti,ma anche dagli insegnanti, e, per alcuni passaggi, dai collaboratoriesterni. Si tratta di uno strumento molto adatto per aiutare adescrivere e sintetizzare quanto appreso, e a raccogliere lalibera espressione sulle esperienze e la loro efficacia.
Per quanto concerne l’obiettivo relativo alla definizionedelle modalità con cui valutare le situazioni, i processi, irisultati in termini di benessere, è stata messa a punto unagriglia di valutazione, ispirata ai documenti dell’OMS, articolatasu quattro macroaree, e una serie di strumenti di rilevazione,sperimentati e validati; anche questa parte della ricerca havisto la collaborazione di operatori delle aziende sanitarie edocenti.Le macroaree e rispettive aree definite sono : a)curriculum,insegnamento/ apprendimento (supporto professionale per gliinsegnanti, metodologia di insegnamento centrate sullo studente),
b) ambiente sociale (relazioni, partecipazione attiva), c)organizzazione scolastica (organizzazione del lavoro scolastico,offerta del servizio mensa), d) ambiente fisico (interventi peril miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza), e)cooperazioni (protocolli fra istituzioni).La ricerca ha messo in evidenza il riconoscimento da partedegli operatori sanitari di una carenza di linguaggio comunerispetto agli approcci relativi alla promozione della salute erispetto alla interpretazione dell’azione educativa, ancoratroppo legata alla metodologia informativa - sanitaria. E alcontempo la possibilità di riorientare in tale ottica alcuni servizi.Alla fine del primo e del secondo anno si è tenuto un incontrocollegiale di tutte le unità di ricerca e di tutte le classi per lapresentazione dei risultati del lavoro, e la messa in comune deiprincipi elaborati e delle esperienze, in modo costruttivo ecritico.
La collaborazione di coloro che hanno aderito a fare parte alleunità di ricerca è stata sempre produttiva. Nel corso dellarealizzazione, tuttavia, alcune Unità hanno trovato maggioridifficoltà nel costruire l’impegno alla partecipazione attiva.Per le amministrazioni locali, ad esempio, vi è stata difficoltànel definire l’assessorato da delegare, per le aziende sanitarienell’individuazione dei dipartimenti da impegnare, adimostrazione della carenza di una attenzione istituzionaleorganica verso la Scuola in generale. Per le scuole non è statosempre possibile impegnare interi consigli di classe, adimostrazione, a nostro avviso, che tali consigli a volte sonopiuttosto impegnati a formalizzare programmi e orari, che adefinire obbiettivi formativi concordati e coerenti con unaprecisa missione; “bisogna stabilire che tipo di scuola vogliamo”ha commentato a questo proposito un insegnante.
Per concludere ci sembra di potere dire che questa ricerca haaperto un certo numero di ipotesi, che, tuttavia, debbonoessere ancora completamente verificate. Innanzituttol’attenzione degli organismi di “governo” della collettivitàverso l’età evolutiva, che, non ci stancheremo mai di ripetere,è il settore di gran lunga più importante per l’evoluzione deglistili di vita, appare ancora scarsa, frammentata e orientata piùall’assistenzialismo e alla “correzione” che alla promozione.Le due reti famiglia e scuola non sono prese in considerazionecome co-attrici della promozione, e in tal senso sono lasciate sole.
�����������������������
25n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
I docenti sono consapevoli della necessità di modificheall’interno del lavoro scolastico, ma la trasformazione delpassaggio dalla didattica centrata sul trasferimento delleconoscenze disciplinari alla didattica centrata sullo studente,non è semplice, soprattutto per carenze di conoscenzerelativamente ai processi di apprendimento sui quali tagliare lescelte metodologiche.Gli studenti aspirano ad avere una maggiore voce in capitolo,vorrebbero contare di più, apprezzano lavorare per costruire,lavorare in gruppo, produrre, il che ci sembra legittimo efisiologico; tali aspirazioni favoriscono lo sviluppo di capacitàdi analisi delle situazioni attraverso l’apprendimento di saperi,ma rendono anche capaci di prendere decisioni e di misurarsicon esse.
E’ necessario da parte di tutti un approfondimento: l’approcciopromozionale richiede innovazioni culturali e tecniche, sianell’esame delle situazioni, che nei metodi di comunicazione,e nella ricerca di alleati e co-attori.Questa azione concertata richiede uno sforzo culturale epolitico per porre la scuola, la famiglia, i ragazzi, gli adolescentiall’attenzione delle azioni collettive per la promozione dellasalute, non solo rispetto agli interventi imposti da emergenze erischi.Richiede anche di disporre di risorse adeguate e organicamentefinalizzate alla promozione, per sostenere l’azione educativagenerale svolta dalle reti delle famiglie e della scuola.Il lavoro svolto con le classi ha offerto indizi di possibili azioniconcrete, ma ha anche fatto comprendere quanto questodipenda dalla organizzazione scolastica nel suo complesso enella formazione culturale e tecnica degli insegnanti sullenuove esigenze e tendenze.La fattibilità di un tale programma si prospetta chiara alla lucedelle numerose attività che si stanno svolgendo nella scuola,alcune eccellenti: molti insegnanti sono impegnati nella ricercadi nuovi modelli, che soddisfino meglio le loro aspirazioniprofessionali e quelli degli allievi.Si dimostra necessaria una maggiore attenzione proprio allepersone della comunità scolastica, dagli allievi ai docenti, ma
la strada sembra essere lunga, sarebbe necessario uncatalizzatore, un territorio che assuma una linea diversa versoquesta grande realtà, alla quale si affida il patrimonio reale delpaese.Ora si tratta o di mettere in atto quanto definito, per essere ingrado di produrre una casistica di buona pratica a favore di una“scuola promotrice di salute”.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200326
�����������������������
LE RAGIONI1.Attenzione alla età evolutivaetà evolutiva nell'ambito dellastrategia di promozione della salute: strutturazione ditratti della personalità che governano comportamenti,abitudini, stili di vita
2.Adozione del paradigma salute,paradigma salute, definito dall'O.M.S.,approccio globale e sistemico - realizzazione dialleanze interistituzionali
3.Individuazione di un sistemasistema che identifichi unmodello operativo, metodologico, organizzativo-gestionale per lo sviluppo di una scuola promotrice disalute
4.Individuazione di un sistema di verifica:verifica: indicatori diprocesso, soddisfazione, efficacia
prof. Maria Antonia Modolo, responsabile scientifico del progetto
OOBIETTIVIBIETTIVI
OBIETTIVO GENERALE
Identificare e sperimentareun modello
organizzativo/gestionale daapplicare nella scuola ingrado di promuovere la
salute
LA CONSULENZASCIENTIFICA
Università degli Studi di PerugiaDipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, Centro Sperimentale per
l’Educazione Sanitaria interuniversitario
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Filosofia
Secondo la metodologia dellaricerca-azione ha garantito
a)a) continuità della documentazionee della informazione sul processo,memoria del gruppo e tutela dei risultati
b)b) sostegno nei passaggi più complessi e,a volte, conflittuali
c)c) individuazione di metodologie estrumenti, aggiornamento rispetto alleinformazioni disponibili in letteratura
ATTUAZIONE
1. come raggiungere un accordo tra ivari livelli istituzionaliObiettivo Istituzioni
2. come individuare gli indicatori per laverifica e la sorveglianza dei processi dipromozione di salute nella scuola,Obiettivo Sanità
3. come realizzare un modello dimetodologia didattica all'interno dellavoro scolastico coerente con i principidella promozione della saluteObiettivo Scuola
LE UNITÀ DI RICERCA
Unità di ricerca per l’obiettivo Istituzioni:Regione Umbria Assessorato alla Sanità eDirezione Scolastica regionale (assessore efunzionari) in collaborazione con la RegioneToscana, Comuni di Perugia e Terni (assessori efunzionari), Province di Perugia e Terni(assessori e loro funzionari), Ex- Provveditoratiagli Studi di Perugia, Terni e Massa Carrara(rappresentanti delegati), USL n°2 e n° e USLn°4 (Perugia e Terni), USL di Massa e Carrara(direttori generali delle Aziende e i lorofunzionari delegatiLe Unità di ricerca dell’obiettivo Sanità:responsabili dei Dipartimenti competenti delleAziende USLLe Unità di ricerca dell’obiettivo Scuola:n. 6 gruppi - classe di scuole medie di II grado (idirigenti, i docenti e gli studenti) di Perugia,Terni, Massa Carrara
OBIETTIVI SPECIFICI:
Obiettivo Istituzionicostituzione di un modello organizzativo edi gestione interistituzionale (Scuola,Sanità, Enti Locali): rilevazione difunzioni, punti di contatto e risorse
Obiettivo Sanitàdefinizione di indicatori per un sistema dimonitoraggio continuo delle condizioni disalute del target
Obiettivo Scuolaanalisi di punti critici nei modelli diapprendimento-insegnamento erealizzazione di un modellometodologico/curricolare
I RISULTATI
Per l’obiettivo Istituzioni:
redazione di un Documento
programmatico per l'Assessorato alla
Sanità, per inserire un Piano Integrato per
la Salute e Scuola nei Piani pluriennali
della Regione.
Proposta di un Tavolo interistituzionale
e una Conferenza di Servizio
per consolidare gli obbiettivi comuni, le
risorse e le modalità operative.
I RISULTATI
Per l’obiettivo Sanità:
individuazione di indicatori e
strumenti,
in collaborazione
insegnanti e operatori sanitari.
Ipotesi di sviluppo: che il
sistema sanitario "riorienti", le
proprie strategie verso la
promozione della salute.La ricerca non ha individuato le modalità possibili
I RISULTATI
Per l’obiettivo Scuola:
la parte più complessa della ricerca in
termini di svolgimento, di soggetti
coinvolti, di risultati ottenuti.
Apprendimento, motivazione,
metodologie didattiche centrate sullo
studente, come richiesto in una scuola
promotrice di salute, sono state il
fulcro del lavoro.
�����������������������
27n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Patrizia FIORETTIUfficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Dopo avere sottolineato con quanto interesse haseguito la ricerca che ha dato risultato positivi perinsegnanti e allievi, sottolinea quanto già sostenuto inmerito alla continuità.
La mia breve comunicazione è centrata su tre punti essenziali.Il primo punto: il progetto si poneva come obiettivo prioritariola promozione del benessere degli attori principali della comunitàscolastica, studenti e docenti, insieme. Per fare questo, vistoche ci sono tanti studenti in sala, leggerò alcuni passi diun’esperienza di uno studente poi divenuto insegnante, chesintetizzano anche il percorso della ricerca.Il secondo punto è un salto di qualità, giacché, per fare salutea scuola, è necessario superare questa patologia della“progettite”, ma invece migliorare la qualità del rapportoinsegnamento/apprendimento nel fare scuola quotidiano, quindinell’insegnare le discipline.Il terzo punto: tutto questo, chiaramente, non può farlo uninsegnante da solo, ma l’insegnante lo deve fare supportato dauna rete, una risorsa per generare un cambiamento che siaefficace. Il progetto ha lavorato su due tipi di rete: ilpotenziamento e il consolidamento di una rete interna allascuola - infatti ha in qualche modo scelto di coinvolgere unintero consiglio di classe, e questo vedremo che è importante,perché poi lavorare come team docenti, insieme, significaconoscere meglio i ragazzi, significa dare un’impostazioneunitaria del sapere, significa anche valutare in modo unitario,e questo sicuramente genera benessere ai ragazzi - e una reteanche esterna, nel senso che la scuola, per affrontare questaimpresa così difficile, ha bisogno di un supporto che siaqualificato, che viene dal sapere scientifico, che viene ancheda una condivisione di intenti da parte del territorio sul quale cisi trova ad operare.
Relativamente al primo punto, promozione del benessere distudenti e docenti, un mio collega, insegnante di scuola superiore
dice: “L’immagine che rappresenta meglio il rapporto che hoavuto con la scuola, da studente, è quella dell’ospite. Quelluogo non mi era del tutto estraneo; ne riconoscevo le regole.Era proprio come la casa di altri, in cui non dovevo disturbaretroppo, mi dovevo adeguare alle volontà di chi gestiva quellacasa. All’università ho continuato ad avere la stessa sensazione.Poi, più tardi, però, ho imparato a prendere posizione, e sonopassato dal dire ‘io’ al ‘noi’, anche se, ora me ne rendo conto,dietro quel ‘noi’ c’era il rischio di celarsi e di nascondersi.Durante l’università ho deciso, con un gruppo di amici, diimpegnarmi; la scuola mi sembrava un luogo di libertà possibile,uno dei pochi. Allora la libertà che cercavo era la capacità didare importanza a quello che facevo, per il senso che io glidavo”.Questa è una cosa molto importante, a mio avviso, rintracciare,sia dal punto di vista degli studenti, che dal punto di vista deidocenti, il senso del perché insegniamo una certa cosa, delperché scegliamo una determinata strategia, del perchéscegliamo di dedicare attenzione a un particolare saperedisciplinare; credo che significhi formare alla consapevolezza.E se io sono consapevole di quello che faccio, sicuramentesono anche più contento, quindi sto anche meglio.“Sulla scuola di libertà si sono innestate la passione, che hovisto in alcuni miei professori dell’università, e la consapevolezzadell’importanza politica della scuola, la passione quindi ditrasmettere ciò che si sa agli altri, l’importanza della scuolacome luogo in cui i giovani sono insieme, e che possono quinditrasformare, facendolo proprio. Quando, alcuni anni dopo, hocominciato ad insegnare in un istituto tecnico - industriale, ledifficoltà erano tante. Mi sono trovato a combattere una sfidaquotidiana. Dall’università mi portavo anche l’amore per laconoscenza, e ai miei studenti volevo insegnare a provaremeraviglia, gusto per la comprensione, piacere dell’interrogarsi,accettazione dello scacco quando le risposte sonoinsoddisfacenti. Oggi chiamo tutto ciò passione per il processodel pensiero. Nell’attività di insegnante sono passato attraversofasi, sempre ricercando il senso dell’insegnare, un senso cherichiede di andare oltre, che non si accontenta mai del risultato
� � ��� ������
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200328
�����������������������
Alberto STELLA
Dirigente Scolastico Istituto Tecnico per le Attività Sociali,Giordano Bruno, Perugia
Mi sento un po’ “privilegiato”, perché questa esperienza equesta ricerca è stata svolta anche nella mia scuola, quindi miauguro che il modello che emerge dalla ricerca poi possatrovare effettivamente una diffusione ampia, una diffusionealle scuole della regione, alle scuole d’Italia, perché è unmodello che in una scuola ha dato dei risultati. Quindi faròbrevemente un elenco degli apprendimenti, dei mieiapprendimenti e degli apprendimenti che sono stati praticatidai colleghi, gli apprendimenti della mia scuola a partire dallaricerca; apprendimenti che in parte sono stati elementi dinovità, in parte sono stati anche elementi di conferma.
Da questo punto di vista, un merito della ricerca è stato quellodi non parlare soltanto ai docenti, ma di parlare ai docenti eascoltare i docenti, quindi raccogliere dall’esperienza diretta eoperativa di chi nella scuola lavora direttamente gli elementipositivi da poter trasferire in altri contesti. È comunque unasoddisfazione aver trovato, in una ricerca che convogliaforze di questo livello, anche conferme al nostro lavoroquotidiano; conferme, esplicitazioni, razionalizzazioni,formalizzazioni. Nella scuola ci sono molte risorse, qualchevolta non espresse, qualche volta non esplicitate; è bene chequeste risorse si esplicitino. Questa ricerca ha messo in campoalcuni elementi di novità, ma ha messo in campo anchel’esplicitazione di quello che, con la ricerca e con il buon senso,i nostri insegnanti fanno quotidianamente.Quali sono i miei apprendimenti, schematicamente?
Primo: un superamento dell’autoreferenzialità, che è uno deirischi più grandi nella vita della scuola. La scuola si confrontacon se stessa, e questo è giusto e va bene, ma la scuola deveconfrontarsi con altri soggetti, a partire dall’università, laRegione, gli enti di ricerca, il territorio (un termine generico)…Da sola la scuola non è in grado neanche di essere pienamentescuola.
Secondo: nel tempo siamo passati da una scuola del programma,centrata prevalentemente su saperi codificati, sui contenuti, auna scuola del curriculum, centrata su un processo, definizione
raggiunto, e si interseca con quello degli studenti; che non siaccontenta della promessa di un’utilità futura della scuola. Inquesta ricerca di senso ci sono sempre state persone dallequali ho imparato e alle quali sono grato. Quindi il leitmotiv cheha guidato la mia esperienza di insegnante è stato quello dicreare movimento, di creare pensiero, di provare a capirequello che succedeva in una realtà scolastica”.Questa è la sintesi - attraverso questa storia - del primo punto:raccogliere in qualche modo i bisogni che vengono dai ragazzi,bisogni che sono a volte mascherati; il “noi”, certe volte - forsei ragazzi ce lo possono dire - significa anche nascondersi,perché è difficile dichiararsi, è difficile mettersi in mostra, daadolescenti. Gli adulti, i docenti, devono essere in grado disostenere, questo processo di crescita e in qualche modoformare alla passione.
Però, dicevamo nel secondo punto, questo contesto diriferimento deve passare attraverso l’insegnamento dellediscipline. Questo mio collega insegnava chimica, e diceva:quando cominciavo il mio programma di lavoro annuale echiedevo ai miei ragazzi - cos’è la chimica per voi? - questiragazzi mi rispondevano: la chimica è una cosa moltoimportante, però per noi è una cosa quasi impossibile daraggiungere. Erano spaventati: invece di avvicinarsi allascienza, facevano un passo indietro, perché era troppo difficileda raggiungere. Quindi lo sforzo quotidiano, di tutti i giorni, èstato quello di rendere avvicinabile la chimica ai ragazzi, dimostrare che la chimica riguarda i fenomeni della vita di tuttii giorni.Quindi, attenzione alle discipline per poter in qualche modocreare apprendimenti che siano efficaci. Come dicevo prima,se fosse stato solo il collega di chimica, in quella scuola, a farequesto sforzo di attenzione, a calibrare la disciplina sui suoistudenti, forse non sarebbe riuscito nell’intento di creare unaclasse che veramente era motore, che era appassionata allaconoscenza. Quindi con l’aiuto dell’insegnante di lettere,dell’insegnante di matematica, con l’aiuto di tutto un Consiglioche condivideva questa idea forte del fare scuola, i risultati chequel mio collega ha ottenuto sono stati veramente importanti.
�����������������������
29n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
di obiettivi. Il passaggio che si è avviato adesso, e di cui ci dàconferma questa ricerca, è il passaggio ad una scuola centratasulle condizioni di apprendimento. Oggi la scuola devefondamentalmente costruire condizioni chi facilitinol’apprendimento degli studenti. La scuola è un ambiente diapprendimento. Da questo punto di vista, ricordo che quandoBruner parlava dell’istruzione faceva riferimento a due strutturedi cui l’attività di istruzione doveva costituire una sorta di ponte:la struttura dei saperi e la struttura cognitiva del soggetto inapprendimento. Dobbiamo aggiungere un’altra struttura, unaltro elemento: la struttura delle condizioni fisiche, spaziali,relazionali, motivazionali, cioè la struttura della scuola comeambiente, in cui intervengono una serie di elementi fisici e unaserie di elementi umani.Da questo punto di vista, è giusto che la ricerca si sia incentratasugli studenti e sugli insegnanti; ma, proprio perché la scuolaè un ambiente complesso, dobbiamo prendere in considerazioneanche gli altri soggetti della scuola. In una scuola complessa,anche dal punto di vista organizzativo, le figure dei cosiddettinon docenti, di coloro che lavorano nella scuola senza essereinsegnanti, sono figure che, in qualche modo, sono anche lorofigure educative, e altrettanto bisognerà tenere conto dell’altrasponda, quella dei genitori, su cui la ricerca in questa fase nonè intervenuta, ma che ha sempre tenuto come punto diriferimento.
Se la scuola, allora, è un ambiente, e dobbiamo costruire neitermini positivi questo ambiente per gli studenti, da questopunto di vista il costruire le condizioni perché gli studenti stianobene a scuola non è una concessione benevola dell’istituzioneagli studenti, è una condizione necessaria dell’apprendimento.Non dobbiamo costruire un scuola in cui si sta bene perché gliinsegnanti sono buoni; dobbiamo costruire una scuola in cui sista bene perché solo così si potrà veramente apprendere,perché solo così la scuola potrà essere veramente scuola.
Questa situazione comporta anche una ridefinizione del ruolodell’insegnante, che tende a essere sempre più un facilitatoredell’apprendimento, un soggetto che mette in discussione gli
studenti e nello stesso tempo è disponibile a mettersi e adessere messo in discussione, in un orizzonte che mantienesempre la distanza docente/studente, perché sono due ruoli edue figure diverse, ma che nello stesso tempo si costituiscecome un orizzonte di cooperazione, una scuola in cui i docentie gli studenti cooperano.La professoressa Modolo ha fatto anche un altro riferimento,che ritengo molto importante, lo riprendo, ma solo per citarlo,perché è uno degli elementi di apprendimento della mia scuola:superare gli interventi settoriali, superare gli interventi miratiesclusivamente a un obiettivo, il pensare che la formazionepossa essere parcellizzata in una molteplicità di progetti;pensare invece ad un sistema di progetti, secondo una logicacondivisa nella scuola, cioè pensare ad un sistema scuola,interno e esterno.
Penso che in questo sia implicita anche una riflessione sullafacilità o sulla difficoltà della scuola. Gli studenti che hannolavorato nel progetto, nella mia scuola, hanno lavorato conpassione, sicuramente, ma hanno lavorato con impegno, forsequalche volta con fatica, perché il messaggio che dobbiamomandare non è quello di una scuola solo flessibile, una scuolache si adatta esclusivamente ai bisogni, agli interessi, allecondizioni degli studenti; la scuola deve essere anche unostacolo che gli studenti si trovano davanti, che possonocontestare, che possono distruggere, superare, ma la scuoladeve mantenere la sua dimensione di flessibilità e di rigiditànello stesso tempo. La scuola deve essere, da questo punto divista, un ostacolo, perché confrontandosi con l’ostacolo, glistudenti riescono poi a crescere e a essere diversi.Gli altri elementi di apprendimento, nello specifico della ricerca,del progetto, fanno riferimento alla necessità di lavorareinsieme. La richiesta che gli studenti hanno fatto di lavorare ingruppo non è una richiesta casuale, perché sul lavoro di grupponon c’è una tradizione consolidata, né tra gli insegnanti, né tragli studenti, né nella scuola. La necessità di lavorare con unconfronto con soggetti interni alla scuola, e la necessità dilavorare con un confronto con soggetti esterni alla scuola.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200330
�����������������������
Le mie ultime due riflessioni fanno riferimento a quello chedicevo all’inizio, cioè alla ricchezza del lavoro che c’è nellascuola. La ricerca ha aggiunto molto al nostro lavoro quotidiano,ha anche formalizzato una parte considerevole del nostrolavoro, ci ha dato una conferma e ha sistematizzo una serie diorientamenti che erano qualche volta espliciti e qualche voltaimpliciti. Ma aver ricevuto una conferma da un’altra sede, esoprattutto aver potuto ipotizzare la stabilizzazione in unsistema organico di una serie di orientamenti che eranoconsolidati, ma non erano forse tra loro organizzati ed esplicitati,è stato un conforto notevole.
Nel concludere esprime apprezzamento per quantoofferto dalla relazione del prof. Briziarelli, che ha beninquadrato il suo lavoro, e si chiede perché proprio unigienista ha potuto offrire una descrizione della scuolacome ambiente con un’indicazione di metodo e dilavoro che dovrà essere approfondita e che potràessere utile.
Antonio DE ANGELI, Maddalena FREDDI, CarlotaJane COZZUPOLI
Regione Toscana, Azienda Sanitaria Locale 1 di Massa eCarrara, Unità Operativa di Educazione e promozionedella salute
La ricerca ha inteso sperimentare a Massa Carrara unmodello organizzativo - gestionale per la promozione dellasalute nella scuola tramite alleanze operative tra istituzioniterritoriali e scolastiche e una rete di collaborazioniinterscolastiche.Hanno partecipato, infatti, all’iniziativa la regione Toscana, ilCentro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli studi) diMassa Carrara, il Comitato esecutivo della Rete provincialedelle scuole promotrici alla quale aderiscono le amministrazionidella Provincia di Massa - Carrara, della Comunità Montanadi Lunigiana, i Comuni di Massa e Carrara e l’Azienda Usl 1di Massa e Carrara, gli Istituti “Enrico Fermi” di Massa, “LuigiEinaudi” di Carrara e “Leonardo Da Vinci” di Villafranca diLunigiana (Sezione di Pontremoli).Il Progetto è stato ideato e sostenuto metodologicamente efinanziariamente dalla Regione Umbria e dal Centrosperimentale interuniversitario per l’educazione sanitaria diPerugia.Il modello organizzativo - gestionale si è andato delineandoprogressivamente in un biennio di attività. Ha tratto ispirazionee orientamento dalla filosofia della promozione della salute
� � ��� ������
�����������������������
31n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
nella scuola così come presentata dalla OrganizzazioneMondiale della Sanità e dal Piano sanitario della regioneToscana.
L’attuale Piano sanitario della Toscana sollecita eraccomanda, in proposito, l’integrazione tra istituzioni erealtà territoriali (associazioni, volontariato) per farcrescere una comunità competente dove i cittadini sianoprotagonisti attivi della propria salute insieme ai servizi ealle organizzazioni demandate a produrre benessere(legge n. 328 / 2000).Si guarda alle reti della comunità e alle alleanze tra le istituzioniper le risorse di cui dispongono, per le competenze scientifichee tecniche riguardo alla conoscenza dei problemi, perl’individuazione delle priorità, per la scelta delle vie perrisolverli.Questo approccio riferito alla salute sta acquistando semprepiù un significato rilevante anche nell’opinione pubblica e siposiziona al di là della prevenzione tradizionale e della curadelle malattie.La promozione della salute considera i fattori ecologici, etici,culturali, economici, organizzativi, ma anche i modelli di vita edi consumo come determinanti per il mantenimento di buonecondizioni fisiche, psichiche, sociali (più tempo libero, concezioneglobale di benessere compatibile con i contesti ambientali,consumo compensatorio).Trae motivazione e impulso dallo spostamento di attenzionedai problemi di salute ai contesti (setting) dove le personestudiano, si incontrano, apprendono, ricercano, sperimentano,si confrontano, si scambiano conoscenze ed informazionianche rispetto a problemi di vita e di salute.
Secondo questa impostazione all’interno della scuola lapromozione della salute dovrebbe essere utilizzata per costruireambienti aperti dal punto di vista sociale, culturale, scientifico.Il contesto scolastico rappresenta una realtà complessachiamata per educare e formare ad interagire con genitori,famiglie, istituzioni pubbliche e private, mondo del lavoro,associazioni e volontariato, emittenti radiotelevisive, centri di
formazione professionale, servizi del territorio (biblioteche,musei, trasporti, ristorazione, bar, discoteche, sale di videogiochi,servizi sanitari e sociali), cittadini.Un modello interpretativo di tale contesto deve tener conto chela scuola ha una propria dimensione interna che, attraversovalori e norme, espliciti o impliciti, influenza fortemente leopinioni e gli stili di vita dei genitori, delle famiglie, oltre che leconoscenze, le modalità di apprendimento e di studio, lemodalità di lavoro, i tempi e i ritmi quotidiani della collettività,in genere gli atteggiamenti e i comportamenti sociali epersonali.
Per rendere evidenti e permeabili questi aspetti valoriali enormativi e aprirli alle esigenze di una società in rapidatrasformazione è essenziale che le istituzioni, interagenti conla scuola, conoscano profondamente la struttura di questa, lasua organizzazione, gli scopi, i percorsi formativi, i metodi dicomunicazione (piano dell’offerta formativa, curricoli,autonomia, processi di pianificazione, modalità di verifica evalutazione, il ruolo e le competenze dei consigli di classe, ledinamiche relazionali e le responsabilità dei collegi dei docenti,il significato della partecipazione dei genitori, i rapportiinteristituzionali, la struttura delle discipline, la cultura deigiovani, i legami generazionali e intergenerazionali).In altre parole fare in modo che la scuola sia un contesto chepromuove salute significa aiutare la scuola a svolgere al megliole proprie funzioni, ma anche ad allargare il suo sguardo nellacomunità, rendendo trasparente e comprensibile la propriaattività quotidiana, i percorsi di apprendimento, le modalità diinsegnamento. Ma significa anche consentire alla scuola dimettere il naso nell’organizzazione e gestione della realtàsociale e dei servizi (trasporti, viabilità, logistica, edilizia,sicurezza, sanità, assistenza sociale, biblioteca, palestra,associazionismo, volontariato).
"L'esperienza"In questa prospettiva la matematica ha suggerito alla scuola unmetodo per rivisitare e comprendere meglio le attività dieducazione alla salute realizzate in collaborazione con l’Aziendasanitaria. Si è costruito un itinerario di lavoro che ha collegato
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200332
�����������������������
l’osservazione della realtà, con le attività di intuizione,immaginazione, progettazione, ipotesi e deduzione, controllo,verifica, risoluzione dei problemi.Attraverso la riflessione si è cercato di mettere a punto criterie modalità sistematiche e organiche di lavoro, capaci disostenere iniziative e collaborazioni interistituzionali attente atutta la carriera scolastica degli studenti, e contribuire acostruire una comunità civile competente, capace di interagirecriticamente con i servizi pubblici sanitari e sociali, con altreagenzie accreditate, pronta all’innovazione dei processiculturali, all’attivazione di forme di collaborazione nella comu-nicazione e informazione finalizzate al cambiamento critico econsapevole dei modelli di vita e di consumo.Ecco perché l’orientamento verso la promozione della salute,rimarcato dai documenti regionali ma anche voluto a livello deipiani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche coinvoltenella ricerca, ha suggerito l’opportunità di sviluppare interventivolti anzitutto a modificare le strutture e gli ambienti nei qualile persone vivono e studiano.
Le modalità di convivenza (il lavoro in classe, lo spazioassicurato ai laboratori, la relazione con gli insegnanti, ilconfronto con gli operatori sanitari e sociali) e di collaborazionecontribuiscono in maniera determinante alla costruzione diidentità generazionali, all’arricchimento dei rapportiintergenerazionali, creando sostanziali condizioni chefavoriscono il miglioramento dello stato di salute dell’interacomunità.In fondo la promozione della salute orienta meglio di altreprospettive a coniugare insieme esigenze formative, valori,indirizzi culturali, che norme e prassi sociali hanno affidato finoad ora a settori separati della vita civile ed amministrativa:diritto allo studio, diritto alla salute, servizi sociali, organizzazionidel territorio, agenzie per la formazione e l’aggiornamentofacendo dimenticare l’unicità della persona per dare enfasi aistanze particolari di potere e di bottega.Quest’ottica è indispensabile per perseguire l’obiettivostrategico di costruire modelli di vita e di consumo, condivisi datutte le componenti sociali perché orientati al bene comunedelle persone, superando la logica organizzativa e gestionaleautoreferenziale ed autocentrata presente nei servizi pubblicisanitari e non sanitari.
Ogni intervento mirato a diffondere un migliore stato di saluteconsente di ottenere una più ampia ricaduta di benefici sociali,ambientali, economici a condizione che sia veramenteprogrammato nell’interesse della comunità.Una popolazione che gode di un migliore stato di salute puòfornire un importante contributo allo sviluppo globale, richiedeun minor sostegno sociale in forma di assistenza sanitaria eprevidenziale e riesce a condurre un’esistenza indipendente,ad evitare comportamenti che possono danneggiare l’ambientedi vita, di studio, di lavoro.In questo senso gli investimenti in salute possono migliorare lecondizioni sociali ed economiche e diffondere un miglior statodi benessere in generale, accresce l’interesse per il sapere ela cultura radicandoli nei vissuti esperienziali degli individui.Investire nella salute significa infatti: calibrare le politichepubbliche, le iniziative private e l’utilizzo delle risorse finanziarie,umane e ambientali per il miglioramento del benessere dellepersone; approfondire la conoscenza del ruolo dei fattorisociali, economici e ambientali che consentono di determinareil livello di salute delle persone e delle collettività; riconoscerel’importanza della salute nel tessuto sociale in quanto favorisceforme di comunicazione e responsabilizzazione che unisconosentimenti e ragioni di vita di una comunità; capire come ilricorso alle risorse umane ed esistenziali, cui possiamo attingerenel corso della nostra vita, può dotarci di strumenti necessariper affrontare nella solidarietà ogni cambiamento.
Riorientare i servizi sanitariCiò significa anche riorientare i servizi sanitari e socialirivolgendo una maggiore attenzione a tutte le persone senzadistinzione contribuendo ad alimentare un sistema socialeresponsabile e solidale.In tale senso va rivista l’organizzazione e l’operatività deipediatri di libera scelta, dei medici di medicina generale, deiservizi sanitari territoriali (consultori familiari, consultori peradolescenti, le forme di intesa e collaborazione tra scuola eterritorio nell’ambito dei CIC, i piani integrati d’area in ambitoeducativo, la normativa connessa con il diritto allo studio, laprogrammazione delle attività di educazione alla salute).Non è ancora chiaro del tutto, fra i molti fattori che determinanosalute, quali siano i più importanti e, soprattutto, come essi
�����������������������
33n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
interagiscano tra loro, al fine di comprendere più a fondo cometutelare al meglio il benessere delle persone in occasione dicomplessi e difficili eventi o cambiamenti sociali (lutti,separazioni, frustrazioni, insuccessi, violenza, aggressività,prepotenza, bullismo, vandalismo).L’attenzione perciò va posta all’insieme di azioni checontribuiscono a creare condizioni dove la salute possapenetrare con le proprie radici e far crescere un contestosociale competente.Ma come può un investimento in salute contribuire atrasformare la vita di comunità nella quale le diverse componentipercepiscono chiaramente di avere un futuro comune che tuttisono chiamati a difendere e a tutelare?
La verificaIl nostro lavoro ha avuto diversi pregi che lo hanno reso utilee significativo per conoscere la scuola e gli studenti di oggi.Abbiamo registrato tuttavia più di una lacuna.In particolare non ci ha permesso di conoscere a sufficienzaciò che i giovani pensano dei valori della vita umana, dellasalute, dell’affettività, della sessualità, aspetti che hannoun’incidenza assai vasta nel modo di pensare e di comportarsidelle persone di ogni età.Non sono mancate indicazioni indirette. Più volte abbiamoconstato, assieme agli insegnanti, come per i giovani la famigliarappresenti più che un valore, una sponda su cui poter contare,un’ancora di sicurezza, uno spazio che garantisce vantaggi. E’emersa la problematicità delle amicizia. Ai giovani anche isentimenti, gli affetti, sembrano avere un valore provvisorio,momentaneo, episodico, di piacevole “avventura” anche seintensa e coinvolgente.Lo stesso studio e l’impegno scolastico sono realtà importanti,ma vissuti prevalentemente come fattori di adeguamento adesigenze formali, più che vissuti qualificanti la crescitaresponsabile e autonoma degli individui.Questa mancanza di attenzione alla famiglia, agli affetti, allo
studio interpella la scuola, ma con essa le famiglie e lacomunità civile.Sarebbe gravemente ingiusto incolpare i giovani degli aspettinegativi che presenta oggi la loro condizione. I giovani sono lospecchio della società adulta e delle difficoltà che questaincontra nell’educare cioè “non tanto nel trasmettere e farapprezzare astrattamente i grandi valori della vita umana,inclusa la salute, ma nella capacità concreta di educare allosforzo, alla responsabilità, all’autonomia, all’impegno, allasolidarietà vissuta”.
I giovani riflettono nel modo di pensare, di sentire e dicomportarsi i valori e i modelli che offre loro la società adulta,in primo luogo la famiglia, poi la scuola, i mezzi di comunicazionedi massa, il complesso della società e non ultimi gli stessi servizisanitari e sociali (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali).La famiglia ha difficoltà a presentarsi come comunità educante.Per i motivi più diversi i figli si sentono distanti dai genitori.Materialmente non mancano di nulla (cellulare, motorino, playstation, integratori alimentari, tatuaggi, ), sono accontentati intutto, ma non sono propensi al dialogo, sono poco abituatiall’impegno e alla rinuncia, pensano di dover avere “tutto esubito”.
Le famiglie, talvolta, affrontano condizioni e fatti estremamentedolorosi per i figli. Chiedono con maggiore frequenza di esseresostenute nei processi educativi e relazionali attraverso ilconfronto, l’acquisizione di competenze, il dialogo con insegnanti,psicologi, medici. La risposta non può venire daun’organizzazione territoriale, sanitaria e sociale, scarsamenteintegrata e attenta alle nuove esigenze degli adulti o, peggioancora, incapace di modulare in maniera intersettoriale einterdisciplinare la ricerca e la risoluzione dei problemi connessicon il “bene-essere” delle persone.
La scuola è chiamata a ripensare in termini comunitari lapropria organizzazione. L’autonomia scolastica ha significatonell’interazione e nell’integrazione istituzionale e in funzionedella vita sociale.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200334
�����������������������
Negli ultimi decenni la scuola ha realizzato importanti sceltenella prospettiva educativa e formativa centrate sullarealizzazione di raccordi pedagogico - didattici in funzionedella continuità curriculare. E’ necessaria anche un’azione piùincisiva che permetta alla scuola di avere una propria fisionomiasociale che la ponga autorevolmente in condizione di dialogaree operare con le istituzioni del territorio e i cittadini.Ciò deve permettere di ripensare in termini comunitari ipassaggi e le scansioni del lavoro scolastico per renderlosignificativo in un contesto dove diplomi e licenze contanosempre meno e spesso consegnano alla società giovaniimpreparati a sostenere il confronto con i coetanei d’Europa.Ma la scuola deve anche farsi carico, assieme ad altreistituzioni, soprattutto del sostegno alle famiglie nella prospettivadell’educazione permanente e della solidarietà.
Quanto ai servizi sanitari la strada da percorrere è ancoralunga e tutta in salita. I valori che spesso vengono proposti nonsono ancora quelli del rispetto pieno della dignità e dei dirittidelle persone, della giustizia, della solidarietà. L’educazione ela prevenzione restano “le cenerentole” di un sistema che èalla ricerca di risposte unitarie e coerenti agli obiettivi basilaridi miglioramento di salute e benessere, di soddisfazione epartecipazione dei cittadini, di efficienza e sostenibilità.Occorre in questo valorizzare pienamente l’iniziativa isti-tuzionale. Gli enti locali sono sollecitati ad avviare un’iniziativapolitica, sociale, amministrativa, educativa, formativa, infor-mativa, che assicuri crescenti livelli di integrazione e inter-settorialità, ma anche organicità e sistematicità alla piani-ficazione sociosanitaria. L’Azienda sanitaria opera realisticamente per la salute sedimostra maggiore interesse per il miglioramento del sistemasociale ed ambientale complessivo (istruzione, formazione,educazione, lavoro, occupazione, uso del territorio, sviluppoagricolo), e non soltanto assicura servizi e prestazioni sanitariein funzione della malattia.Va posto alla base di queste azioni un modello di salute radicatosulla responsabilizzazione dell’intera comunità, sullapartecipazione diffusa di tutti i soggetti pubblici e privati, dellascuola in primo luogo, e sul coinvolgimento della cittadinanza
nei processi di decisione e di scelta.L’intervento sociosanitario deve essere pensato come unostrumento flessibile in grado di farci percorrere tutte le stradeutili e opportune per fronteggiare sia la stringente contingenzadei costi di gestione e del contenimento della spesa, sia ilsuperamento dell’esasperante logica delle prestazioni e deifragili meccanismi competitivi dimostratisi comunque incapacidi rendere visibile il cambiamento dell’organizzazione sanitarianel reale interesse di tutti i cittadini.Un’impostazione programmatica di questo tipo richiede unlavoro assiduo di tessitura che consenta di dare unaconnotazione e un’identità alla rete territoriale dei servizisociosanitari, ma anche modifichi atteggiamenti ecomportamenti propri della “cultura consumistica” sollecitandotutti i cittadini a riconoscere valori, ad adottare punti di vistaattenti al bene comune, oltre che alle evidenze scientifiche.La salute si difende e si promuove con questa diversaimpostazione che vuole fare della collettività un attore dellescelte di salute, portandola a comprendere il rapporto strettoche esiste tra politica dei servizi alle persone e politica socialeed economica più generale.
La comunitàSu questo terreno si realizza l’incontro tra le responsabilità ditutti i soggetti sociali, chiamando ciascuno a costruire ericonoscersi in un progetto comune che integri i diversi livellidi partecipazione (istituzionale, pubblica, privata) e ad operareper costruire stili di vita e di consumo sostenibili e maggiormenteattenti ai bisogni di tutti.In questa logica la comunità non rappresenta uno spazio fisico,ma piuttosto il luogo e il laboratorio di relazioni significative,dove si realizzano opportunità di conoscenza, si qualificanostrategie di partecipazione dove ciascuno prende coscienza diessere risorsa per sé e per gli altri, riconosciuto nella suaidentità, colto nella sua appartenenza ad una cultura e a unsistema di valori personali, sociali, politici, etici, culturali,storici, religiosi, civili.In tale contesto la sanità pubblica è chiamata nei fatti adimostrare la propria capacità di dotarsi di un’organizzazione
�����������������������
35n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
credibile, stabile, funzionalmente vicina alle esigenze piùprofonde dei cittadini, dove la dimensione umana rappresentiil valore aggiunto di tutta l’attività sanitaria.Sotto questo aspetto occorre imparare a svolgere in manieraattiva e convinta il ruolo di essere apertamente “alleati” dellasalute dei cittadini, dimostrando di saper cogliere e trattaretempestivamente la patologia senza andare verso unamedicalizzazione indiscriminata e non necessaria. L’interazionecon i servizi sanitari in momenti in tutti i momenti sensibili dellavita deve rappresentare un’utile occasione di educazione allasalute e di prevenzione.
La ricerca intervento ha permesso di definire meglio anche ilruolo della scuola nella promozione della salute.La scuola può valorizzare più di qualunque altra istituzione unodei tratti più caratterizzanti della condizione giovanile, l’amicizia.Questa costituisce una dimensione indispensabile perl’identificazione personale e l’individuazione dell’identità diogni individuo.Questo processo si presenta critico e travagliato in ogni faseevolutiva, dalla scuola dell’infanzia agli istituti superiori eall’università. Il gruppo - classe può assicurare esperienzeessenziali per aiutare i giovani ad imboccare la stradadell’autonomia e quindi della separazione dalla famiglia.E’ importante che la scuola e la comunità avvertano comecomponente essenziale della salute le motivazioni chesottostanno all’amicizia, come il confronto con esperienzediverse dalla propria, la condivisione dei problemi e modi dipensare di altri, l’opportunità di esprimere apertamente se
stessi, il passare il tempo.La scuola è uno dei contesti che spinge maggiormente i giovania ricercare amicizia, molto più che la famiglia, il quartiere,l’associazione sportiva, la discoteca.Nella scuola si può costatare come la dimensione di gruppospontaneo è preferita dai giovani a quella organizzata e comesotto questo aspetto sia ancora lunga la strada per garantirenella propria organizzazione un margine maggiore di libertà edi spontaneità e far uscire i giovani dall’inerzia e dalla noia.Da valutare è anche il rapporto tra salute, scelta di stile di vitae di consumo e vita affettiva. I giovani sono consapevoli chenella dimensione affettiva il gioco della vita diventa veloce enon lascia tempo di fermarsi per progettare piani elaborati,sanno che la storia e le storie che determinano oggi tanta gioia,pur avendo un futuro, sono comunque episodi ciascuno chiusoe separato dal passato e dal futuro.La scuola può operare di più favorire il consolidamento deirapporti tra i giovani e accrescere la loro responsabilitàguardando al futuro della comunità.In questo modo si affrontano anche le paure collettive eindividuali dei giovani: la guerra, la sofferenza interiore, ildolore fisico, le aggressioni fisiche e verbali, la morte, lasolitudine, l’incertezza, l’assunzione di responsabilità.La maggiore attenzione al sociale può tradursi in un realeimpegno nel campo della solidarietà, dove si contrastaefficacemente sia la paura dell’incertezza del futuro, che lapaura di dover assumere responsabilità e quindi la profondapaura di crescere.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200336
�����������������������
Walter ORLANDI
Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale di Perugia
Ringrazio gli organizzatori di questo convegno, la professoressaModolo in particolare, che ci ha dato l’opportunità di rifletterein base a una ricerca applicata, su come riorientare il nostrolavoro quotidiano.Si parla di promozione della salute: per noi la promozione dellasalute, la prevenzione, la terapia e la riabilitazione sono lamissione, il mandato.È chiaro che, in un aspetto così particolare come la promozionedella salute, l’intersettorialità è un elemento fondamentale.Ringrazio gli organizzatori anche perché, mentre parlavano,stamattina, mi hanno fatto tornare un po’ indietro, a quando erostudente di Igiene. Ricordo che, allora, da studente di medicina,in occasione di qualche seminario, sostenevo che gli interventidi prevenzione delle dipendenze a livello scolastico non sareb-bero stati efficaci. Si discuteva, allora, di antiproibizionismo edi proibizionismo… .Oggi siamo arrivati a parlare di interventi integrati e non più diprogettazione settoriale; ma è legittimo chiedersi: se nonavessimo fatto gli interventi sul tabacco, sull’alimentazione esulle malattie infettive, quale sarebbe stato l’attuale stato disalute della popolazione? Che, voglio ricordare, è uno stato disalute soddisfacente. Questa mattina, ho apprezzato le relazioni,sia del prof. Briziarelli che del prof. Corradini: da una parteun’illustrazione molto precisa di quello che occorre fare,dall’altra un disegno della complessità della problematica.Però occorre partire da alcune questioni importanti: gli indica-tori di salute della popolazione ci confermano che gli interventifinora fatti, a tutti i livelli, comunque hanno dato risultati. Poi èchiaro che il disagio e le nuove problematiche esistono, masono sempre esistite.Ma i giovani sono persone che in genere stanno bene e sonopronte ad apprendere, quindi per promuovere la salute nondovremmo seguire un processo troppo complesso.Nella nostra regione quando si parla di genitori, di studenti e diinsegnanti, si parla di quasi tutta la popolazione, oltre la metà.
Cerchiamo di sistematizzare la problematica, cominciamo aparlare di scuola e dell’azione con le altre istituzioni.
L’Unità Sanitaria Locale, il sistema sanitario, deve fare la suaparte in maniera molto precisa, con una programmazione e unimpegno che può derivare da questa convenzione, o patto,come lo si vuol chiamare, in cui sia chiaro qual’è il mandato.Attualmente, in effetti, nel nostro lavoro quotidiano, gli interventisono un po’ frammentari, sporadici, a volte con iniziative piùcomposte, altre con iniziative parziali; comunque le risorse cheabbiamo sono molte.Uno degli spunti proveniente da questa ricerca, che homolto apprezzato, è che occorre riorientare le risorse cheattualmente abbiamo.Innanzitutto, diceva il prof. Briziarelli, l’ambiente fisico:l’ambiente fisico non è così importante, però una parte ce l’ha;non vorrei che su questo abbassassimo la guardia, perché lasicurezza, il confort, la possibilità di vivere in ambienti, che poisono di vita e di lavoro, in regola con le normative e con irequisiti igienici essenziali, non credo sia da dimenticare. È uncompito dei nostri servizi, un compito sul quale dobbiamo,comunque, mantenere alta l’attenzione, cosa che poi serve dastimolo alle amministrazioni per risolvere problemi anchestrutturali.Abbiamo fatto qualche passo avanti. L’azienda sanitaria èorganizzata in nuclei operativi: i distretti e i dipartimenti diprevenzione e di salute mentale, a questi si aggiungono i medicidi medicina generale e i pediatri di libera scelta. Si tratta di ungrande potenziale di risorse, dobbiamo presentarci in modounitario allo studente, come istituzioni: Scuola e Unità SanitariaLocale.Ma non è semplice. È già molto difficile, per l’Unità SanitariaLocale, presentarsi unitaria in un approccio alla Scuola; basticonsiderare la difficoltà organizzativa all’interno delleburocrazie professionali - che sono quelle sanitarie, inparticolare, ma anche, forse, quelle scolastiche - dove ci sonoprofessionisti di un certo livello, organizzati in ambiti settoriali.Non è semplice riuscire a presentarsi in maniera unitaria aun’istituzione scolastica, per un assetto di istituzioni locali,
�����������������������
37n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
come i Comuni, la Regione o l’Università, non è sempliceaffatto.Quindi non vorrei lasciare pensare che realizzare un Piano oprogramma integrato sia di estrema facilità. Per esempio, ab-biamo fatto molta fatica a riorientare i dipartimenti diprevenzione, perché da una parte hanno un compito di vigilanzae controllo, dall’altra hanno un compito di promozione dellasalute, di indagine epidemiologica; e la burocrazia sanitariaancora è un elemento pregnante dei nostri servizi.Credo che dovremmo cercare di presentarci con un’offertaunitaria, sapendo ascoltare. Uno degli spunti viene dai nostrioperatori che sono andati nelle scuole: essi da sempre vannonelle scuole, ma in questa ricerca non solo si sono presentatifornendo un loro sapere, ma anche ascoltando, sia gli insegnantiche gli studenti.
Una cosa mi preme sottolineare: credo che siamo pronti per unnuovo patto interistituzionale tra le varie componenti. Possiamo,anche, da questo primo momento di ricerca, mettere adisposizione un ambito distrettuale dove sperimentare unnuovo modello applicativo, in modo da poter verificare evalutare.
Ho iniziato il mio ragionamento dicendo che non eravamoconvinti che interventi settoriali avessero portato a uncambiamento sostanziale, ma la verità è che noi non abbiamodavvero sistemi di indicatori e sistemi di verifica tali da potercifar monitorare i nostri interventi. Credo, quindi, che lo sforzodi avere individuato alcuni indicatori e degli strumenti diverifica e di monitoraggio ci permetta di orientare, o riorientare,nel corso del nostro lavoro, quello che stiamo facendo, in modotale da poter aggiustare in itinere anche le nostre performance.Diamo la nostra disponibilità, come Azienda Sanitaria, perchéquesta esperienza di ricerca si strutturi in un progetto attuativo.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200338
�����������������������
Paolo QUINTALIANI
Assessore Politiche Sociali, Provincia di Terni
Voglio partire da un assunto: cerchiamo di interpretare lascuola soprattutto per quello che è, cioè uno strumento diformazione, anzi, il primo strumento di formazione della nostravita. Quindi credo che, quando parliamo di insegnante,dovremmo intendere l’insegnante come formatore e noncome colui che molto settorialmente insegna e, quindi, trasmettesoltanto informazioni. E allora cominciamo a parlare, dentro lascuola, di formazione professionale, di formazione culturale, diformazione scientifica, di formazione sociale, di formazionecivica.
Questa mattina noi ragioniamo di formazione sanitaria. Sino adoggi, e questo si evince chiaramente dai testi che ci sono statisottoposti e dagli interventi che si sono finora susseguiti, laformazione sanitaria si è basata soltanto su una fase progettuale,certamente rilevante per qualità e quantità, ma non omogenea,e soprattutto, diciamo così, frutto di una spinta esclusivamentevolontaristica. Siamo di fronte, cioè, ad una serie di progettiche non sono concretamente integrati tra loro. Certo, dobbiamoanche tener conto, delle diverse realtà locali, perché, perquanto riguarda la nostra regione, che pure non è immensa, unprogetto messo in opera a Città di Castello non è applicabilenella stessa maniera ad Orvieto, però è altrettanto vero chel’impostazione metodologica di fondo deve essere legata inmaniera univoca, in modo da poter essere interpretabile, dachiunque la legga, alla stessa maniera.Lo ricordavano anche i relatori che mi hanno preceduto:
dobbiamo essere estremamente attenti a superare la fram-mentarietà, attraverso la creazione di una vera e propria retesociale di formazione sanitaria; una rete che va costruita, e sista costruendo, su due pilastri principali: la famiglia e la scuola.Questo, in sostanza, è il tema attorno al quale si è operato sinoad oggi e sul quale stamattina stiamo disquisendo; si trattaperò, non di un processo così semplice da realizzare, come aprima vista può sembrare. Non è semplice perché sononumerosissimi i fattori esterni che ne stanno cambiandol’essenza, quotidianamente, fattori esterni di cui dobbiamotener conto.
Per quanto riguarda la famiglia, sino ad oggi la famiglia è stataintesa - perdonatemi il termine - come una tribù, una tribù dipersone che insieme costituiscono quella che è la prima celluladella vita sociale e culturale. Questa tribù oggi si sta riducendodal punto di vista quantitativo: le famiglie come noi ce leimmaginiamo, e non esattamente il nucleo familiare, semprepiù sono composte da meno persone. Questo chiaramenterestringe lo scambio delle esperienze interpersonali e di fattostravolge anche quella che era una cultura molto diffusa, finoa qualche anno fa, sulla quale i giovanissimi e giovani venivanoeducati: la cultura del mutuo soccorso. Oggi sempre più questotipo di cultura è assente.
Nella scuola, invece, il fenomeno fortemente innovativo, e peralcuni versi anche strano dal punto di vista della lettura, è quellodell’immigrazione. L’immigrazione sta trasformando la sostanzadei rapporti tra gli stessi bambini, ma soprattutto sta cambiandoi rapporti con gli insegnanti: per la diversità di culture sorgonodifficoltà proprio per quanto riguarda l’educazione e laformazione alla salute. Dobbiamo quindi andare a costruireuna rete che tenga conto di questi aspetti che si stannomodificando giorno per giorno, una rete che dobbiamo costruire
� � ��� �������
�����������������������
39n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
con modernità intellettuale e sociale, partendo dalla letturaattenta degli effettivi bisogni e finalizzata comunque a darerisposte certe ed esaurienti a questi bisogni.
Ecco qual è il ruolo delle istituzioni, soprattutto. Le istituzioni,per quelle che sono le loro competenze - penso alla pubblicaistruzione, ai servizi sociali, alla formazione, alla cultura -devono essere i soggetti deputati a coordinare la costruzionee lo sviluppo di questo percorso. Chiaramente, però, si apre unragionamento estremamente delicato: con quali risorse?Soprattutto con quali risorse finanziarie? Oggi, sempre più, leistituzioni debbono fare i conti con la propria ragioneria. Siamotutti sottoposti a vincoli estremamente restrittivi, quali peresempio il patto di stabilità. Anche per l’immediato futuro c’èda essere preoccupati: basti considerare come è stata concepitala Finanziaria che ci costringe a tagliare soprattutto nel settoredella costruzione dei rapporti sociali.Quindi, quando leggo la scuola così come l’ho letta all’inizio, èovvio che devo pormi delle domande: facciamo una serie didiscorsi teorici, che tentiamo di mettere in pratica, poi,improvvisamente, tutti noi ci accorgiamo che non disponiamodelle risorse per l’attuazione. Su questo dobbiamo discutere inmaniera seria ed approfondita.
Per quanto riguarda l'Amministrazione Provinciale di Terni -fermamente convinta delle giuste premesse della Ricerca -stiamo lavorando per tentare di costruire un Osservatorioprovinciale delle politiche sociali. Tenteremo per il 2003 diintraprendere questo percorso insieme agli altri Assessorati,non solo quindi come Assessorato alle Politiche Sociali, perchéabbiamo bisogno di uno scambio di esperienze e di relazionisociali, anche qui costruendolo su questa forma: due gambe, larete da una parte, il sistema informativo dall’altra. Il soggettoche è, da una parte, immissario di notizie e di relazioni sociali:
l’Ente locale, le realtà che operano nel mondo del sociale, laScuola, le Aziende Sanitarie, dall’altra, diventa anche soggettoemissario, cioè acquisisce notizie attraverso la rete informativa,la rete di trasformazione dei rapporti sociali in dati.
Un ultimo passaggio: per quanto mi riguarda, oltre ad essereAssessore alle Politiche Sociali, sono anche Assessore alloSport per la Provincia di Terni. Ma lo sport è o non è unostrumento che all’interno della scuola diventa promotore disalute? A Terni abbiamo un bellissimo progetto, che stiamoportando avanti con la Medicina Sportiva, il Progetto “AmicoSport”: è un progetto che si basa sulla motorietà dei bambiniper accompagnarli fino alle scuole superiori. Purtroppo anchequi siamo di fronte a problemi di finanziamento.Un plauso però va alla Regione, in questo settore, per laresponsabilità che si è assunta quando è andata a ridisegnarei vincoli messi in campo dai LEA, i Livelli Essenziali diAssistenza, che tentano, o hanno tentato, di restringerel’assistenza sanitaria nazionale. Da questo punto di vista, laRegione è andata oltre i suoi compiti e gli stessi compiti dettatidalla legge nazionale, proprio rispetto all’età scolastica e pre-scolastica. I Livelli Essenziali di Assistenza avevano tracciatouna linea per la quale tutti i controlli di medicina sportiva peri bambini dovevano essere effettuati a pagamento. La Regione,con una propria delibera, ha fatto sì che per tre anni, comunque,questo servizio rimanesse un servizio gratuito. Voi comprendetel’importanza di tale decisione e la responsabilità che si èassunto il nostro maggiore Ente locale.Credo che, da qui in avanti, questo tipo di discussioni debbaviaggiare anche nel senso di assunzione di responsabilità perquanto riguarda il finanziamento di questi di progetti per nonvanificare la loro trasformazione in realtà.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200340
�����������������������
Felice PIERSANTI
Associazione Nazionale Comuni Italiani, Federsanità
Ho seguito con molto interesse il convegno, perché credo chel’argomento interessi fortemente i Comuni - qui parlo a nomedi Federsanità ANCI, una struttura dell’ANCI che si collegaanche alle aziende sanitarie e ospedaliere - , perché il Comuneè quel soggetto che dovrebbe rompere la separazione, lacristallizzazione delle varie posizioni e unificare le tematiche.Questo è il motivo per cui si parla non solo di prevenzione, maanche di promozione della salute. Su questa linea, a Romaabbiamo attuato alcune esperienze, cui accenno, perché vannonella linea dell’unire obiettivi e metodi.Una esperienza di educazione alimentare. I due Assessoratidel Comune, l’Assessorato alla Promozione della Salute el’Assessorato all’Istruzione, si sono uniti per intervenire nellescuole, per fare un discorso sull’educazione alimentare chenon fosse soltanto didattico e teorico, ma fosse invece undiscorso sulla mensa, sui cibi biologici (che entrano nellemense del Comune di Roma) anche attraverso interventi coni genitori su come nascono i menu e le mense, per fare in modoche questo problema fondamentale, l’alimentazione, diventielemento essenziale della promozione della salute.Una importante esperienza è stata fatta alcuni anni fa in dueAziende Sanitarie Locali sulle malattie cardiovascolaririvolgendoci alle scuole, lavorando non tanto sui problemisanitari - il colesterolo, l’ipertensione - ma sugli stili di vita chesono l’elemento fondamentale di queste malattie: l’alimentazio-ne, il muoversi, il camminare e così via, perché lavorando suglistili di vita, anche nella scuola, è possibile concretamentesuperare le contraddizioni.
Quindi, da questo punto di vista, credo che i Comuni, sia conFedersanità, sia con la rete “Città Sane”, debbano essere incondizioni di recepire questo vostro lavoro, di portarlo avanti,eventualmente di estenderlo ad altre parti d’Italia.Allora, se il problema è quello di lavorare sugli stili di vita pereliminare le disuguaglianze sociali, allora la scuola democratica,alla quale la Costituzione ha affidato il compito di superare ledisuguaglianze, lavora concretamente promuovendo la saluteintervenendo sugli stili di vita. E il compito non è soltanto quellodi lavorare su una serie di fattori fondamentali, ma è quello direndere i giovani protagonisti della propria salute, cioè non
oggetto di malattie che sopravvengono dal di fuori e che sonoaffidate ai medici, ma protagonisti della salute.Certo, è difficile, si tratta di dare un senso alla vita e anche allamorte, che è la fine della vita, ed è un problema fondamentalee importante. Quindi sono d’accordo con il prof. Corradini, chebisogna ritrovare le ragioni per vivere e le ragioni per morire.Sono tuttavia un po’ in disaccordo quando si tenta di pensareche un tempo ci fossero le ragioni per vivere e per morire, eoggi non ci siano. La mia età mi porterebbe ad essere unlaudator temporis acti, ma penso che questo sia un gravissimoerrore.Nella mia giovinezza c’è stato il genocidio di milioni di persone,perché ebrei, zingari, omosessuali.Quand’ero giovane, la donnaera subalterna, e c’era il mito della verginità della donna, nondell’uomo, che invece doveva essere bravo, doveva prepararsinelle “case chiuse”. Questi erano i valori di allora. Noiabbiamo superato queste cose, con le difficoltà e con la lotta,ma l’abbiamo fatto. È vero, quando io ero ragazzo, nella scuolami invitavano ai valori certi, che erano quelli del Re e diMussolini. Ma da questa educazione noi abbiamo tratto lalezione per abbattere quei valori certi e per trovare le ragionidi vivere nella lotta per la libertà, e le ragioni di morire, quandofosse necessario, per difendere la libertà.Abbiamo fatto molti passi avanti. Negli anni ‘50 noi dicevamoche la mortalità infantile dell’Italia era una vergogna, chebisognava superare, era una delle peggiori del mondo.Oggi la durata della vita, in Italia, è tra le più alte del mondo ecrea nuovi problemi, i problemi del rapporto con gli anziani, masono problemi positivi, che nascono dalla civiltà.Noi siamo stati educati a vedere nel tedesco un nemico, adessoviviamo in una comunità libera, in cui tutti si muovono, e igiovani sanno che l’Europa è una sola. Allora bisogna lottareperché non solo l’Europa, ma il resto del mondo abbia unaposizione di questo genere.
Credo che, quindi, promuovere la salute sia ridare la capacitàai giovani di trovare, pure in condizioni difficilissime, comepossono essere quelle odierne, un significato anche politicodella vita e comprendere quello che significa la grande politica.Dovendo fare una conferenza all’Istituto di Sanità, due anni fa,rilessi una serie di documenti e trovai il documento di Beveridge,il quale nel 1943 scriveva che bisognava assicurare un’assisten-za sanitaria gratuita a tutti, agli uomini e alle donne. In quelmomento Londra era ancora bombardata dagli aerei nazisti ea Roma eravamo durante l’occupazione nazista.In quel momento fare politica significava anche programmareil futuro, e il futuro è stato poi quello dei servizi sanitari nazionalidi questa nostra Europa, che sono punto di riferimento per ilmondo.Ecco, la scuola promotrice di salute è, secondo me, quella cheriesce a riferirsi a questi grandi valori, che sono i valori dellanostra Costituzione.
����������
�����������������������
41n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Gianfranco TARSITANI
Vice-Presidente della Società Italiana di Igiene, MedicinaPreventiva e Sanità Pubblica
Sono venuto a Perugia, oggi, per prendere e non per dare. Ilmio interesse - in qualità di Vice Presidente della SocietàItaliana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - èquello di costituire dentro la nostra Società un gruppo di lavorosulla promozione della salute, per far crescere tra gli igienistil’attenzione su questi temi, che sono la nostra missione, ma deiquali, poi, rischiamo di non occuparci con costanza. Devoprendere le risultanze di questa esperienza, di questo lavorobiennale, straordinario.
Ho ascoltato la tavola rotonda e le relazioni. Il primo obiettivo- mettere in rete tutte le risorse, le istituzioni - aumental’entropia, la messa a disposizione di risorse almenosensibilizzate, ci diceva la Fioretti all’inizio. Il solo pensare,progettare questa cosa, sensibilizza le istituzioni a lavorare traloro. Certamente è un risultato. Per altro ci è stato detto dairelatori che spesso queste istituzioni hanno questa missione,questa vocazione, ma non sempre la esprimono, o non sannocome coordinarla. E non è una rete obbligatoria, per cuimettiamo in rete le istituzioni, le più disparate che poi vanno aconfluire sulla promozione della salute nella scuola; parliamo,infatti, di scuola promotrice di salute. Anche il Preside Stellaci ha confermato l’entusiasmo, lui era fiero di aver fatto questaesperienza, fiero che nella sua scuola tutte queste attenzionifossero confluite. Questi, a mio avviso, sono risultati importanti,e occorre meditare se queste ricerche sono prototipi percontinuare a camminare insieme.L’esperienza da Massa Carrara, il dott. De Angeli ci diceva:lavorare allo stesso tavolo, mettere allo stesso tavolo operatorisanitari e scolastici; questo tavolo deve essere nella scuola, enella scuola diventiamo, noi, sanità, parte della scuola, ciriconoscono i ragazzi; cioè, la scuola per la sanità, vista in unmodo diverso, è un risultato, è un’esperienza che va ripetuta.
Si parla tanto di formazione, si moltiplicano corsi, ne ha parlatola relazione della Rassmussen, il Direttore Sergi; corsi diformazione per operatori sanitari e per operatori della scuola,ma io mi chiedo: ma questo tavolo, questo incontro, questocontenitore, in cui operatori diversi si confrontano e si
raccontano esperienze e si scambiano cultura e competenze,non è formazione? Ma non possiamo incentivare questo tipodi attività e attribuire a questa i crediti formativi che debbonocollezionare sia gli operatori della scuola che quelli sanitari?Perché non investire su questo, perché non motivare, perchédeve essere tutto “gratuito”, se abbiamo strumenti così potenti,in fondo, atti dovuti? Credo che questa sia la formazione vera:lo scambio di opinioni tra professionisti.Questo tavolo di lavoro, probabilmente, può lavorare sugliindicatori (risultati dell’obiettivo B), che in questa sede nonsono stati presentati. So benissimo che gli indicatori sono unprocesso, non sono un fatto obiettivo di per sé; l’indicatore vacostruito, va ragionato, sono d’accordo, però stiamo costruendoprototipi, scambiamoci qualche idea, tutti gli attori possonocontribuire.E quello che mi appassiona - uno spunto ce l’ha dato Quintiliani- è quando noi andiamo a individuare i bisogni formativi: se laformazione educativa è globale, se è centrata sullo studente,noi vediamo che i nuovi bisogni sono ben diversi da quelli cheio, medico, epidemiologo del Dipartimento di Prevenzione, miaspetto. Io mi accorgo che il bisogno nasce nel tessuto sociale,nasce dal disagio, nasce dalla dispersione scolastica, nasce intutti i settori nei quali dobbiamo saper ragionare insieme,riorientando non solo i servizi sanitari, ma tutto quel tessuto dienti che lavora sul territorio e che deve contribuire a quello chepuò essere chiamato un piano integrato di salute, che possalavorare su tutte queste risorse. Si tratta di piccole coseconcrete.Da questa ricerca ci nascono alcuni spunti, proviamo aripeterli, a creare il prototipo, per passare però dal prototipo adattività di servizio ampie e diffuse, perché il mondo della sanità,il mondo dei servizi sociali e il mondo della scuola si mettanoin rete; anche piccole cose, se il Dipartimento di Prevenzionedeve andare nella scuola, per vari e differenti motivi, lo faccia,e lo faccia in modo organico in tutte le scuole, allocando risorsein modo idoneo. Allora, da chi fa politica, da chi ha questocompito, mi aspetto risposte concrete.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200342
�����������������������
Maurizio ROSI
Assessore alla Sanità, Regione dell’Umbria
Non volevo far mancare l’apprezzamento per una ricercaimportante come questa, alla quale abbiamo creduto comeRegione e che ci sollecita a continuare sulle linee indicate. NelPSR 2003/2005 sicuramente inseriremo come puntifondamentali quelli che sono stati gli aspetti più rilevantidella ricerca: l'interazione fra le istituzioni e la promozionedella salute attraverso il lavoro scolastico.Avete detto tante cose interessanti, siete voi quelli che noidobbiamo ascoltare, perché la politica, credo, debba averesempre più il compito di saper ascoltare, soprattutto in questafase, e di servirsi del patrimonio tecnico-scientifico che lenostre comunità hanno, sia quella umbra che quella toscana.Per tale motivo non farò “l’esperto di tutto e di tutti”. Noivogliamo, però, tramite queste ricerche, tramite il patrimonioscientifico che possediamo, fare in modo di non sbagliare gliatti conseguenti, ma rendere concrete le cose che abbiamodiscusso.
Per rendere concreto quanto discusso dobbiamo pensare allerisorse. Ci troviamo in un momento politico in cui le risorse,anche quelle già acquisite, per la scuola e la sanità vengonoassottigliate sempre più: questi discorsi vengono proposti in unmomento non "propriamente ben indirizzato". Attualmentesono sconcertato da alcuni atti del Governo nazionale; avreteletto, in queste ore, anche della rottura tra Regioni e Governocentrale, tra Presidenti delle Regioni e il Ministro dell'Economiae Finanza. Qui c’è una discussione pesante: qualcuno parlavadi risorse, ma non è solo un problema di risorse. Qui c’è untentativo, ormai, non so se per negligenza o per incompetenza,o per scelta politica - non voglio parlare di politica in questosenso - di mettere in discussione fatti fondamentali, risorseacquisite, che c’erano per la scuola, per la sanità, soprattuttoin alcune regioni come la nostra o la Toscana, qui presente, cheavevano fatto uno sforzo enorme, in termini di rigore, per farquadrare i conti, di fare in modo anche, diventando impopolarispesso, di garantire un’assistenza sanitaria a tutti, estendendoanche, come è stato riferito, i LEA alla medicina sportiva, aigiovani, a quelli che non hanno compiuto ancora 18 anni.Ora le cose procedono in una certa maniera - siamo in un’aulauniversitaria - si tagliano le risorse per la ricerca, per la scuola,
����������� per la sanità, per l’innovazione, cioè per la formazione. Eguardate che questa non è una lamentela sic et simpliciter,perché, se si tagliano le risorse alla sanità, è difficile cheverranno tagliate agli ospedali, ma chi ne subirà maggiormentele conseguenze sarà la medicina del territorio, perché piùdebole, la salute mentale, la tossicodipendenza, i problemi deiragazzi, la medicina scolastica - quella che facciamo -, gli stilidi vita, le cose che vorremmo affermare per una sanitàmoderna, a cui si riferiva anche il dott. Orlandi e a cui noicerchiamo di prestare attenzione.Ora, questo cosa vuol dire? Abbandonarci alle lamentele?Non deve essere la nostra cultura. Pur con queste concretelimitazioni, ci proponiamo di agire. Come si suggeriva nellerelazioni, dobbiamo sapere invertire il clima: mettere insiemel’università, la scuola, le famiglie, e puntare su un modello chein qualche maniera porti a compimento una serie di scelte chesono state suggerite dalla ricerca.
E’ chiaro, e non mi stanco di ripeterlo, che lo stile di vita deiragazzi, l’attenzione all’adolescenza, all’età evolutiva, questaalleanza per dare un supporto alla scuola, in cui anche gli entilocali facciano la loro parte, è congeniale alle nostre politicheche mirano alla promozione della salute delle nostre popolazioni.Mi auguro che queste concretezze vengano avvertitemaggiormente anche nel nostro sistema scolastico e nel nostrosistema sanitario, in modo tale che i buoni indirizzi, le ricercheche realizziamo siano una indicazione concreta per un’azioneche renda sempre più aderente ai bisogni la scuola cheabbiamo.
Noi cercheremo di valorizzare le proposte della ricercaattraverso il nuovo Piano, che la Regione dell’Umbria sta perapprovare, ma è necessario che la scuola, i servizi sanitari, glienti locali si sensibilizzino per mettere in atto quanto proposto.Noi siamo a disposizione per fare in modo che su questa stradala nostra scuola e anche i nostri servizi sanitari possano avereun futuro molto importante e significativo, in una regione comel’Umbria, che è sempre stata disponibile, a innovazioni e adaffrontare problemi di questo tipo. Vi ringrazio.
�����������������������
43n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
����� �� � ���� ����� � � � � � ���� � � ��!����
������� ������ � ��� ����� �������� �������� ���� �� ��������������
��� ��� ���� �� ������������ ������� ����� �� ����������� �� �� �� ��� �� �
���� �
���������
���� ����� � ���� ������ ��� � ���������� ���� ��� "�� � � � ������� ��������
� ���� �� � ���� � � � �!#�������� � ��������
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200344
�����������������������
������� � ��������� � ��� �������� �� � ���� ������� � ��$%����������� � ������
� ���� ������� � �� �������� ������ � � � ���������� ������ � ��� �����
Paola Beatini, Maria Antonia Modolo
Analisi
La riflessione sullo stato attuale dellaattuazione degli interventi di educazionesanitaria, o alla salute, nella scuola, e inparticolare verso gli adolescenti, ha co-stituito il punto di partenza per impostarele ipotesi della ricerca. Le osservazionitratte dalla analisi ci hanno convintodella necessità di sperimentare una nuo-va impostazione e una nuova operativitàispirate agli elementi concettuali conte-nuti nella strategia indicata dall'OMSper una "Scuola promotrice di salute",che vorremmo interpretare nel senso diuna "scuola che produce salute".Da una parte, quindi, analisi delleesperienze realizzate nelle scuole eindividuazione di nuove esigenzeespresse dalle principali istituzioni cheoperano con la finalità di coniugare edu-cazione e salute (istituti scolastici, servi-zi socio/sanitari, enti locali) e, dall’al-tra, modelli, criteri, obiettivi propostidall’OMS nel Progetto “Scuolapromotrice di salute”. (1,2,3,11,12)
L’educazione sanitaria nellascuola media italiana
Nei primi anni ’80 il Ministero dellaPubblica Istruzione, a seguito dell’af-fermarsi di problematiche riguardanti idanni derivanti dall’abuso di alcol, ta-bacco e sostanze stupefacenti tra i gio-
vani, inizia a parlare di educazione sani-taria, e individua la scuola come ambien-te di elezione per la realizzazione diincontri, dibattiti, interventi finalizzati allaprevenzione di comportamenti dannosiper la salute. Si tratta di azioni sporadi-che, legate all’emergenza (Fumo, AIDS)di taglio nettamente sanitario. Con lalegge 162/1990 e alcune successive cir-colari (tra le quali la C.M. 15-10-1990n.270 che istituisce la figura del “docen-te referente per l’educazione alla salu-te”) il concetto di educazione alla salutesi amplia: si inaugura una nuova lineacon Progetto giovani ’93, Progetto ra-gazzi 2000 per la quale la salute non èconsiderata solo “contenuto da insegna-re, ma attività da realizzare e obiettivo daperseguire da parte di una scuola, in cuispazio, tempo, metodi e relazione sonoda considerare risorse idonee a raffor-zare le potenzialità positive dei ragazzi”(C.M. 2-8-1991 n.240). L’attivitàprogettuale condotta nelle scuole di ogniordine e grado diviene più organica,continuativa, complessa e finalizzata apromuovere stili di vita positivi.Le esperienze di educazione alla salutesi moltiplicano e si rivolgono a un targetpiù ampio e differenziato coinvolgendoinsegnanti, studenti, famiglie, la comuni-tà. In una concezione di salute e dibenessere “dilatati” si ampliano anche icontenuti degli interventi: ambiente,interculturalità, cittadinanza...
Le innumerevoli attività realizzate nelcorso di questi venti anni hanno indub-biamente favorito la diffusione di infor-mazioni e consapevolezze intorno alletematiche affrontate, creando una diffu-sa cultura della prevenzione, in principio,e di stili di vita favorevoli, poi, tra inse-gnanti, genitori e studenti.Le esperienze analizzate, tuttavia,fanno rilevare come troppo spesso lastrategia di promozione della salutenon sia stata ancora completamenteaccolta in alcuni suoi principi con-cettuali fondanti, in particolare ci si èorientati essenzialmente a inserirealcuni contenuti di un “curriculumdella salute” all’interno della pro-grammazione scolastica, ma la scuo-la non viene ancora intesa quale am-biente di lavoro promotore di salute,e scarsamente utilizzato l’approcciodi setting come suggerito dall’OMS,nel tentativo di approfondire la stra-tegia di promozione della salute. (7, 8,10)Altro elemento evidente è la sovrappo-sizione e la mancanza di progettazio-ne sistematica tra le istituzioni chepossiedono competenze e impegnanorisorse tecniche ed economiche nellascuola, da cui l’esigenza di nuove moda-lità di raccordo e sistematizzazione dellecollaborazioni.Quale percorso di un nuovo orientamen-to e di azione nella scuola ci sembrava
�����������������������
45n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
significativo, pertanto, sperimentare lapossibilità di analizzare e di collegare piùdirettamente la promozione della saluteal “cuore” del lavoro scolastico stesso,vale a dire il processo di apprendimento/insegnamento. La scuola, istituzionedeputata alla trasmissione della cultura edei saperi e, al contempo, luogo di edu-cazione del soggetto al riconoscimentodella propria identità, all’affinamento delleproprie capacità di apprendimento,all’acquisizione di autonomia e consape-volezza, è in grado, attraverso le di-scipline curriculari, e nel nome e nelsenso dell’unità del sapere e dellapersona, di costruire un lavoro sco-lastico promotore di benessere, sicu-rezza, espressione delle proprie ca-pacità, per gli studenti?L’evoluzione della progettazione e rea-lizzazione di interventi di educazione epromozione della salute nella scuola, leesigenze espresse dai soggetti interes-sati sembravano dare strada a questaipotesi, così come le indicazioni dell’Or-ganizzazione Mondiale della Sanità. (4)
Concetti di base dell’Organiz-zazione Mondiale della Sanitàper una scuola promotrice disalute
In relazione, dunque, all’esame dellostato della progettazione e realizzazionedi interventi di educazione alla salute
nella scuola, due ci sono apparsi i nodiconcettuali di base della strategia dipromozione della salute nella scuola,proposti dall’OMS, su cui fondare leprospettive della nostra ricerca:- il primo, la scuola come comunità
educante allargata a interventi e colla-borazioni intersettoriali e interistitu-zionali (partnership),
- il secondo, la scuola come ambiente divita e di lavoro favorevole alla salute distudenti, insegnanti, genitori, comunità(school as healthy workplace). (9)
Il partnerariato è obiettivo e metodo diuna scuola promotrice di salute per pre-venire duplicazioni e frammentazioni ecostruire un’ossatura per sostenere ediffondere innovazioni, modelli di buonapratica.I modelli di scuola promotrice di salutepresenti in letteratura sono numerosi edifferiscono in relazione agli specificicontesti politici e socio-culturali di riferi-mento. Assunto di base è, infatti, quellosecondo il quale non è possibile, nèauspicabile creare “il” modello di scuolapromotrice di salute. Ogni modello è ilrisultato di dialogo e consenso dai suoicostruttori e trae il suo valore in un par-ticolare contesto. La scuola promotricedi salute è più un processo di interpreta-zione contestuale che un esito del-l’implementazione di principi globali; imodelli presenti costituiscono pertantola base di un dialogo tra i decisori politicieuropei, più che una verità oggettiva ouno standard normativo. (5)Pur tuttavia in tutti i modelli europei piùsviluppati (danese, finlandese, inglese)la cooperazione interistituzionale è unelemento strutturante.I collegamenti tra le diverse istituzioniprevedono, secondo il modello eco-olistico di Parsons, un livello internazio-nale (influenze normative internazionali,collegamento con il network europeo)nazionale (politiche di salute e formazio-ne e iniziative nazionali), regionale (poli-tiche di salute e formazione e iniziativeregionali) e locali (politiche di salute eformazione e iniziative locali). (7)
Anche il modello finlandese prevede inriferimento alla coordinazione di politi-che di programmazione quattro livelli: illivello internazionale, quello nazionale, illocale e il livello scolastico. Il piano diazione di quest’ultimo è basato sulleesigenze delle singole realtà scolasticheautonome.Il processo di collegamento e coopera-zione, ai diversi livelli nella programma-zione e realizzazione di programmi eazioni di promozione della salute, richie-de un lavoro interistituzionale eintersettoriale proprio per la natura com-plessa dell’operatività della promozionedella salute. (5)Per quanto concerne il secondo punto, ilriferimento alla scuola come ambien-te di vita e di lavoro, trova la suaesplicitazione più diretta nella definizio-ne stessa dettata dall’OMS: per scuolapromotrice di salute si intende “una scuolache ha strutturato una serie di politiche,procedure, attività e strutture finalizzatea tutelare e promuovere la salute e ilbenessere degli studenti, del personalescolastico e dei membri dell’intera co-munità”. (6)Pur senza dimenticare l’importanza el’assoluta necessità di ambiente fisicosano (e i conseguenti requisiti igienici edi sicurezza), una scuola promotrice disalute si qualifica essenzialmente qualeambiente organizzativo. Essa utilizzaquindi strutture di gestione, organiz-zazione interna, stili di insegnamentoe apprendimento, modalità di stabili-re sinergie con l’ambiente sociale pergarantire ai ragazzi e all’intera co-munità scolastica migliori strumentiper avere il controllo sulle condizionidella propria salute, tutelarle e ac-crescerle. (9)Da una parte la promozione della saluteviene intesa quale strategia per accre-scere la qualità del setting scuola, dal-l’altra il processo educativo stesso tendea identificarsi con quel processo checonsente agli studenti di acquisire capa-cità fondamentali, quali autonomia econsapevolezza della scelta negli ambiti
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200346
�����������������������
della cultura, della vita, e, di conseguen-za, anche per il raggiungimento del-l’obiettivo "salute" (empowerment).Conferire maggiore indipendenza ecapacità di decisione ai ragazzi, ri-chiede una formazione che solleciti eorienti a tale obiettivo: i ragazzi do-vranno essere educati a esprimere laloro opinione, ad apprendere più at-tivamente, a scegliere e lavorare in-sieme per obiettivi comuni.Nuove libertà e maggiore consape-volezza per i ragazzi richiedono an-che nuove capacità per insegnanti,cambiamenti nei curricula e nellemetodologie, nelle politiche di inse-gnamento, nuovi sviluppi in aree qualila comunicazione, i metodi attivi diapprendimento e insegnamento, coo-perazione con genitori. (9)
Stabilire gli obiettivi
In sintesi i capisaldi e gli elementi con-cettuali di riferimento individuati per losviluppo della ricerca sono stati l’attiva-zione di partnerariato e l’attenzione allascuola come ambiente di vita e di lavoro.Questi presupposti hanno consentitol’individuazione di due obiettivi forti:- costruire un sistema di programmazio-
ne e azione interistituzionale per lapromozione della salute nella scuola e
- tutelare e accrescere il benessere del-la comunità scolastica attraverso unlavoro scolastico e un’organizzazionescolastica positivi per la promozionedella salute.
Una evidente esigenza conseguente atale quadro è stata la necessità dieleborare un sistema di verifica checonsentisse la valutazione dell’impattosul benessere dei soggetti.Questo ha imposto un terzo obiettivo perconsentire il monitoraggio delle condi-zioni di salute della popolazione scolasti-ca, una costante rilevazione dei compor-tamenti e degli stili di vita in età scolare.Ciò presupponeva, a sua volta, l'appro-fondimento e lo studio del significato disalute e di benessere attribuito dai sog-
getti (in particolare gli studenti) coinvoltinelle specifiche realtà socio-culturali,l’identificazione di aree per sviluppareindicatori di salute-benessere nei conte-sti presi in considerazione.A livello operativo si imponeva, infine,l'esigenza di individuare le strutture sani-tarie territoriali cui attribuire compiti dirilevazione dati e di intervento nella scuo-la, modalità di programmazione e dioperatività che evitassero la sovrap-posizione e garantissero continuità e co-ordinazione, collaborazioni con istituti diricerca che portino a conoscenza di tuttil’evidenza della ricerca scientifica.Sulla base di tali premesse concettualidell’Organizzazione Mondiale della Sa-nità e dall’analisi degli interventi attuatinella scuola italiana per l’educazione epromozione della salute i tre obiettividella ricerca:- Obiettivo Scuola: realizzare un mo-
dello di metodologia didattica all’inter-no del lavoro scolastico coerente coni principi della promozione della salute
- Obiettivo Istituzioni: costruire unsistema di gestione interistituzionaleper la promozione della salute: Scuola,Sistema sanitario, Enti Locali
- Obiettivo Sanità: individuare un si-stema di verifica.
Bibliografia1. Barnekow Rasmussen V. et al. The
European Network of HealthPromoting Schools. A trainingManual for teachers and othersworking with young people, - a jointWHO-EC-CE project. World Health,Marzo 1996.
2. Denman S., Moon A, Prsons C.,Stears D. The Health promotingSchools. . Policy Research andPractice. Routledge, 2002.
3. Development plan 1996-2000 for theEuropean Network of HealthPromoting Schools - a joint WHO-EC-CE project. Regional Office forEurope, the European Commissionand the Council of Europe,Copenhagen, WHO, Regional Office
for Europe, 1997.4. First Workshop on practice of
evaluation of the health promotingschool. Models, Experiences andperspectives, Berne/Thun,Switzerland, 19-22 novembre 1998.Executive Summary. WHO, RegionalOffice for Europe, 1998.
5. Jensen Bruun B., Simovska V. editedby Models of Health promotingSchools in Europe. European Networkof Health Promoting SchoolsTechnical Secretariat, WHO, RegionalOffice for Europe, 2002.
6. Rowling L. The adaptability of thehealth promoting school framework.Health Education research 1996,11,519-526.
7. Parsons C., Stears D, Thomas C. TheHealth Promoting School in Europe. AConceptualising and Evaluating theChange. Health Education Journal,1996, 55, 311-321.
8. Rivett D., Concept and Structure ofthe European Network of HealthPromoting Schools, in EuroNews,vol.5, n.0, dic.1996,3-5.
9. Stewart Burgher M., BarnekowRasmussen V., Rivett D. TheEuropean Network of HealthPromoting Schools. The alliance ofeducation and health. InternationalPlanning Committee of the EuropeanNetwork of Health Promoting Schools,1999.
10. St Leger L., Nutbean D. A model formapping linkages between health andeducation agencies to improve schoolhealth. Journal of School Health 2000,70, 45-50.
11. World Health Organisation, TheEuropean Network of HealthPromoting Schools: a Joint WHO-CE-CEC Project, Copenhagen: WHO,1993.
12. World Health Organisation, TheOverall Progress of the ENHPSProject, January-December 1994,Copenhagen: WHO Regional Officefor Europe, 1995.
�����������������������
47n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
UNITA’ OPERATIVE
Direzione Scolastica Regionaledr.ssa Carmela LO GIUDICE SERGI
prof.ssa Anna Maria DOMINICI
Ex Provveditorato agli Studi diPerugiaDott.ssa Caterina PIERNERA
Ex Provveditorato agli Studi diTerniDott.ssa Patrizia FIORETTI
Università di Perugia-ConsulenzascientificaC.S.E.S.i.Prof.ssa Maria Antonia MODOLO
Dott.ssa Paola BEATINI
Dott.ssa Benedetta FAZIO
Dott.ssa Anna Lisa FERRANTE
Facoltà di Scienze della formazioneProf.ssa Floriana FALCINELLI
Facoltà di MatematicaProf.ssa Giulianella COLETTI
Facoltà di Lettere e FilosofiaProf.ssa Antonietta ALONGE
Facoltà di Medicina e ChirurgiaProf. Rosario Francesco DONATO
Prof. Sandro ELISEI
Società Internazionale MedicinaAvanzata ed Integrate e di Scienzedella Salute (SIMAISS)Dott. Francesco BOTTACCIOLI
Istituto Magistrale Statale “A.Pieralli” di PerugiaDirigente scolastico Franco PRESILLA
���������� ��������� � �� �� �� � ����� �� � ���� ��� �� �� ������� �� ������� �� ����� ���� ���
� �� ��� �� � ����������� � �� � ������� ������������������������
Prof.ssa Antonella BIBI
Prof.ssa Maria LUCCHETTA
Prof.ssa Claudia MIGLIORATI
Prof.ssa Simonetta RICCI
Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” di PerugiaDirigente scolastico ProsperoCASTIGLIONE
Prof.ssa Maria Giovanna BALLOI
Prof.ssa Patrizia CARROZZA
Prof.ssa Marcella MARIOTTI
Prof.ssa Emanuela RONGONI
Prof.ssa FrancescaVERGINE
Istituto Professionale Statale per iservizi commerciali e turistici “ B.Pascal” di PerugiaDirigente scolastico EnricoCANESTRELLI
Prof.ssa Grazia MIGNI
Prof. Silvio RONDONI
Istituto Tecnico per le attivitàsociali “G. Bruno” di PerugiaDirigente scolastico Alberto STELLA
Prof.ssa Francesca BONACA
Prof.ssa Francesca LEONETTI
Prof.ssa Carmelina VIVIANI
Istituto Statale a indirizzoamministrativo e perprogrammatori “F. Cesi” di TerniDirigente scolastico DomenicoMARINOZZI
Prof.ssa Paola ANGELOSANTI
Prof.ssa Roberta BAMBINI
Prof.ssa Simonetta BOLLONI
Prof.ssa Elvira CALLARI
Prof.ssa Stefania Roberta CECCARELLI
Prof.ssa Silvana GATTUCCI
Prof.ssa Anna Rita MANUALI
Prof.ssa Carla MILIONI
Prof.ssa Serafina PETRONE
Prof.ssa Agata DEA PEZZI
Prof.ssa Clori TAZZA
Istituto Magistrale Statale “F.Angeloni” di TerniDirigente scolastico ErmannoSCARAMUZZA
Prof.ssa Roberta BALDONI
Prof.ssa Graziella LARDANI
Prof.ssa Paola LATINI
Prof.ssa Clara MAURELLI
Prof.ssa Franca PETROLLINI
Prof. Giovanni RONCONI
Prof.ssa Maria Cristina STEFANINI
Prof.ssa Cristina ZAGAGLIONI
Liceo Scientifico Statale “EnricoFermi” di Massa
Istituto d'Istruzione Superiore“Luigi Einaudi” di Carrara
Istituto Tecnico “Leonardo DaVicni” di Villafranca di Lunigiana(Sezione di Pontremoli)
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200348
�����������������������
������������������������������������ ��� �� �����������
��� �� ��� ����� ��� ������ �� �������Paola Beatini, Anna Lisa Ferrante, Maria Antonia Modolo
Premessa
Le linee del progetto sono state costruiteattraverso una serie di incontri daricercatori del Centro Sperimentale perl’Educazione Sanitaria (C.S.E.S.i.),funzionari dell’ex-Provveditorato agliStudi di Perugia, dirigenti e docenti discuole medie di primo e secondo gradodella provincia di Perugia, realizzatinell’ambito di una convenzione stipulatatra C.S.E.S.i e Provveditorato agli Studidi Perugia.Scopo degli incontri era quello diindividuare la possibilità di recepire erendere operative le indicazionidell’Organizzazione Mondiale dellaSanità relativamente al Progetto europeo“Scuola Promotrice di Salute”. (1,3,6,10)Punto di partenza è stata l’analisi e lavalutazione della progettazione ineducazione alla salute attuata, nel corsodegli anni, dagli insegnanti partecipanti.La rilevazione delle esperienze pregresseè stata effettuata tramite una grigliaper l’analisi curata dai ricercatori delC.S.E.S.i.L’analisi ha evidenziato un’ormaiconsolidata e corretta prassi delle attivitàdi programmazione e attuazione diinterventi di educazione alla salute nellescuole prese in considerazione. Gliinterventi sono risultati per la maggiorparte caratterizzati da obiettivi preventivie centrati sui tradizionali contenuti di
salute nei confronti degli adolescenti,quali dipendenze, sessualità, alimen-tazione, e miravano a incrementareconoscenze, promuovere la discussionee la condivisione di opinioni e atteggia-menti tesi a sostenere comportamentifavorevoli alla salute degli studenti. Leiniziative testimoniavano il prevalere diuna linea metodologica tradizionale,sostanzialmente corretta ed efficacenell’immediato (stando al gradimentodimostrato da alunni e discenti).Un’osservazione, più volte emersa acommento delle iniziative svolte, hariguardato la capacità di queste parentesieducative di mettere in luce potenzialitàindividuali degli studenti non mostratenel corso del quotidiano lavoro scolasticoe di conseguenza non supposte dagliinsegnanti.Tali pregi didattici delle attività dieducazione alla salute risiedevanoessenzialmente in una metodologiacaratterizzata da un approccio olistico(riferito all’aspetto cognitivo, emotivo econcreto dell’apprendimento), dall’ado-zione da parte dell’insegnante di unaprospettiva di facilitatore e dall’arti-colazione di metodologie diversificate:lezione frontale, brainstorming, lavoroindividuale, di gruppo, simulazioni(7,8,9,11), indicazioni metodologichepresenti anche nei documenti OMS.Da ciò l’interrogativo degli insegnanti sucome fosse possibile trasferire alle attività
curriculari i pregi didattici delle iniziativedi educazione alla salute.
La definizione del progetto
Nel corso di un seminario di confrontosui nuovi orientamenti proposti dalMinistero della Pubblica Istruzione e suiDocumenti Internazionali dell’OMS èstata avanzava l’ipotesi di un progettoper la promozione della salute cheprivilegiasse il lavoro scolastico e pertantola stessa attività didattico-curriculare.Non fosse un progetto di educazione allasalute extracurriculare, né affrontasse,all’interno di un curriculum, i contenutisettoriali dell’educazione alla salute, mafocalizzasse l’analisi e l’intervento sullapossibilità di costruire un ambiente, unlavoro scolastico e, più specificamente,percorsi disciplinari curriculari “promotoridi salute”.Proprio la I Conferenza sulle Scuolepromotrici di Salute dell’OMS tenutasi aTessalonica nel 1997 (2) includeva ilcurriculum all’interno dei 10 principi diuna Scuola promotrice di Salute, qualeoccasione per acquisire conoscenze,ovviamente, ma al contempo sviluppareconsapevolezza, responsabilità, spiritocritico, attitudini fondamentali per operarescelte nella vita e come tali elementi dibenessere; evidenziava l’importanzadello sviluppo nel soggetto dicompetenze per l’azione intendendo
�����������������������
49n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
PRINCIPI per una scuola promotrice di salute
1. democrazia: la scuola promotrice di salute si basa su principi democraticiche portino alla promozione dell’apprendimento, allo sviluppo individuale esociale e alla salute;
2. equità: per rendere ciascuno capace di sviluppare le proprie capacità senzadiscriminazioni;
3. potere e competenze per l’azione: sviluppando quelle capacità chedanno il senso del raggiungimento delle proprie aspirazioni, lavorandoinsieme, insegnanti e studenti;
4. ambiente scolastico: un contesto fisico e sociale idoneo; 5. curriculum: che offra ai giovani occasioni per acquisire conoscenze,
sviluppare acume e spirito critico, nonché le capacità per affrontare la vita; 6. formazione degli insegnanti: un investimento per la salute, oltre che per
l’educazione; 7. misura del successo: sia rispetto la scuola che la comunità; 8. collaborazione: tra Sanità e Educazione, a tutti i livelli, nazionale, regionale,
locale; 9. comunità: i genitori e la comunità svolgono un ruolo vitale;10. sostenibilità: tutti i livelli di governo debbono investire risorse nelle scuole
promotrici di salute
Prima Conferenza Rete Europea, Thessaloniki (Grecia) 1997
con tale termine quelle potenzialità ecapacità che garantiscono il senso diraggiungimento delle proprie aspirazionie le conseguenti possibilità diautorealizzazione da sviluppare proprioattraverso un lavoro cooperativodocente-discente.In una prospettiva di azione legata alcontesto, in una scuola intesa quale luogodi lavoro, quale elemento può risultarepiù significativo per promuoverebenessere se non il processo diapprendimento stesso e, in concreto, glispecifici percorsi disciplinari checaratterizzano lo svolgimento deiprogrammi scolastici nella scuola mediaitaliana?Con l’intenzione di sperimentare unpercorso didattico-disciplinare chepotesse contribuire a promuovere lasalute di studenti e docenti si è pervenutidunque alla formulazione del progetto“Scuola promotrice di Salute: può lamatematica promuovere la salute?”Si intendeva vagliare la possibilità dicostruire percorsi didattico-disciplinaricoerenti con i principi della promozionedella salute (basati sulla centralità dellostudente e cioè sulle caratteristiche bio-psico-sociali del soggetto in appren-dimento, portatore di potenzialità edesideri), percorsi in grado di produrresoddisfazione e risultati attraversol’adozione di metodologie diversificatein grado di motivare e stimolare
l’apprendimento e atte a stabilire buonerelazioni tra i soggetti.Soddisfazione e risultati, possibilità diapportare un contributo, opportunità direalizzare le proprie aspettative, buonerelazioni con i compagni e con gliinsegnanti, sono elementi correlabili albenessere del soggetto (4,5), inparticolare durante l’età evolutiva.Solo attraverso il contributo allacostruzione di un soggetto sicuro,soddisfatto e consapevole, la scuola potràessere promotrice di salute e prevenireefficacemente anche la comparsa didisagio e comportamenti a rischio.
La metodologia: la ricerca-azione
La messa in opera di una cooperazionetra ricercatori, insegnanti, studenti delprimo biennio di scuole medie superiori,dirigenti scolastici e funzionari degli ex-Provveditorati (soggetti che costituivano
l’Unità operativa dell’Obiettivo Scuoladella ricerca) è stata l’azione piùcomplessa della ricerca in termini disvolgimento, di soggetti coinvolti e dirisultati ottenuti.Il progetto era esplicitamente rivolto aconsigli di classe nella convinzione checambiamenti sostanziali e duraturi nellavita scolastica non possano prescinderedalla partecipazione e condivisionedell’intero corpo docente di una classecui è affidata la formazione dei soggetti.Realizzare il percorso attraverso lametodologia della ricerca-azione cherichiede la partecipazione e lacondivisione da parte dei soggetticoinvolti a tutte le fasi di svolgimentodell’esperienza - dalla programmazionestessa e dall’analisi dei bisogni fino allavalutazione del processo svolto - hacomportato un lavoro capillare, uncostante atteggiamento e agire riflessivoe critico, la disponibilità a rivedere,aggiornare e sviluppare il percorso in
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200350
�����������������������
ogni momento della sua attuazione, purnell’osservanza dei principi concettualidi riferimento.Complessivamente i soggetti partecipantia tutte le fasi (escludendo i contributi diesperti coinvolti nei momenti diformazione) della ricerca-azione sonostati: tre ricercatori del C.S.E.S.i., duedisciplinaristi (uno per l’area matematico-scientifica, uno per l’area linguistico-letteraria), due funzionari degli exProvveditorati agli Studi, trentatreinsegnanti, sette dirigenti scolastici.
Struttura del progetto
La struttura del progetto può esseresinteticamente distinta in tre fasi.La prima, FASE INIZIALE, è statapropedeutica alla definizione dellaProgetto esecutivo e ha visto l’identi-ficazione dei soggetti da coinvolgere, ladefinizione dei ruoli e la condivisionedelle successive fasi operative dellaricerca.
Sono seguite quindi due fasi entrambecaratterizzate:a) formazione iniziale, organizzazione e
condivisione del programmasperimentale
b) realizzazione del programmasperimentale
c) riflessione e sintesi della fasesperimentata
d) valutazionee) socializzazione dei risultati
Più dettagliatamente sono stati realizzatiper la
FASE PRIMA
a) Sei Seminari di formazione perinsegnanti “Scuola promotrice disalute”
b) costruzione e sperimentazione delModulo trasversale “Appartenenza”
c) riflessione e sintesi sul Modulotrasversale verso la costruzione dimoduli disciplinari
d) valutazione in progresse) I Seminario Regionale
Per la
FASE SECONDA
a) Corso di formazione per insegnanti“Scuola promotrice di salute: dallavoro di gruppo al gruppo di lavoro”
b) costruzione e sperimentazione diModuli disciplinari
c) riflessione e sintesi sui Modulidisciplinari e sull’esperienza dellaricerca
d) valutazionee) II Seminario Regionale
La Ricerca si è conclusa con larealizzazione di un Convegno Nazionale“Scuola promotrice di salute: ricerca-intervento per la sperimentazione di unmodello organizzativo gestionale per lapromozione della salute nella scuola”.
FASE INIZIALE
Impostazione e condivisionedel progetto
La fase iniziale del progetto ha visto losvolgersi di una serie di incontri coordinatidal Responsabile Educazione alla Salutedell’Assessorato ai Servizi Socio-Sanitaridella Regione Umbria tra tutte le UnitàOperative per l’impostazione, ladefinizione degli strumenti di direzione ela predisposizione del programmaoperativo.Sono stati identificati i componentidell’organizzazione del progetto e i teamoperativi delle specifiche unità.L’identificazione dei soggetti dacoinvolgere, in particolare degli EntiLocali e delle Aziende Sanitarie, hacomportato difficoltà legate allespecifiche competenze nei confronti dellaScuola dei diversi Assessorati comunalie provinciali (Servizi Sociali, Sanità,Cultura, Pubblica Istruzione) e dei Servizisanitari del territorio (Distretto,Dipartimenti di prevenzione, MaternoInfantile, Salute Mentale) che impegnanorisorse umane e finanziarie in programmiper e con gli Istituti Scolastici.Il Progetto è stato presentato alle
Conferenze di Servizio dei Provveditoratidelle realtà scolastiche di Perugia eTerni.La scelta delle classi si è orientata alprimo biennio delle scuole medie superioriper i seguenti criteri: a) si trattava, all’iniziodella Ricerca (progetto di riformaBerlinguer) del primo anno di un cicloper così dire già riformato, quindi ogniindicazione che fosse venuta dalla ricercaavrebbe potuto essere utilizzata anche infuturo, b) il biennio accoglie sia ragazziche intendono proseguire, sia quelli cheseguono solo il biennio per l’obbligo, c) ilprogramma della ricerca richiedeva dueanni di svolgimento.Sono state reclutate quattro classi diIstituti Superiori a Perugia, tre a Terni.Per Perugia: Istituto Magistrale AssuntaPieralli, Istituto Professionale BlaisePascal, Istituto Tecnico per le AttivitàSociali Giordano Bruno, Liceo ScientificoGalileo Galilei; per Terni: IstitutoMagistrale Francesco Angeloni, IstitutoTecnico Federico Cesi, Istituto TecnicoAllievi, e alcuni istituti di scuole Mediesuperiori di Massa Carrara.Tutti gli Istituti aderenti al progetto hannoinserito il Progetto all’interno del Pianodell’Offerta Formativa (P.O.F.) delproprio Istituto.Sono seguiti due Incontri Seminarialicon gli insegnanti dei consigli di classeaderenti al Progetto per presentare,discutere e condividere il programma
�����������������������
51n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
OBIETTIVI per una scuola promotrice di salute
1. Creare un ambiente scolastico promotore di salute di cui possano beneficiaretutti i membri di una comunità scolastica: alunni, docenti, non docenti, genitori.
2. Introdurre nuove metodologie di insegnamento capaci di stimolarel’apprendimento e di favorire buone relazioni.
3. Sostenere il concetto di coinvolgimento attivo degli alunni nei processidi apprendimento.
4. Analizzare l’organizzazione della scuola e il suo funzionamento per garantireequità, equilibrio, accordo.
5. Definire un curriculum della salute, rendendo questa una componente integrantedella carriera scolastica degli allievi.
6. Considerare la valutazione come parte integrante dei programmi di promozionedella salute, in modo da assicurare la definizione di obiettivi realistici e lamisurazione dei risultati e dei progressi conseguiti.
7. Promuovere le relazioni tra scuola e comunità.che avrebbe preso il via all’inizio dell’annoscolastico successivo, 2000-2001, nelcorso dei quali è stato consegnatomateriale bibliografico agli insegnanti daesaminare durante la pausa estiva inpreparazione dei seminari predispostiper settembre-ottobre.Gli insegnanti hanno richiesto larealizzazione di incontri con esperti checonsentissero di accrescere le propriecompetenze rispetto all’insegnamentodisciplinare centrato sullo studente.
FASE PRIMA
Riflettere sull’apprendimento
Sono stati realizzati sei Incontriseminariali di formazione con gliinsegnanti, per scambi di conoscenzesugli aspetti fisiologici, motivazionali epsicologici del processo di apprendimentofunzionali a un’azione didattica centratasul soggetto che apprende.I temi sviluppati sono stati per un primogruppo: “Struttura e funzionamento delcervello”, “La disponibilità adapprendere”, “La connessione mente-corpo-ambiente”.Per un secondo gruppo centrato sugliaspetti pedagogici-metodologici:“Paradigma educativo e paradigmaprogettuale”, “La relazione educativa”“Da una scuola del contenuto a unascuola delle competenze”.Si è trattato di un processo di interscambi
molto attivo tra gli esperti coinvolti e gliinsegnanti. L’apprezzamento dei temitrattati è stato molto alto, nellaconsapevolezza della carenza di fondodella preparazione di base offerta nelcorso del processo di formazioneprofessionale.Ci si è resi conto della complessitàconnessa a un insegnamento centratosullo studente e di come la ricerca dovràtrasferire in pratica i temi affrontati, inun lavoro comune nel quale il supportometodologico dovrà essere costante.Questa attività comune ha portato allaproposta di una Scheda metodologicaper la realizzazione di un modulotrasversale da attuare con gli studenti alprimo ingresso nella scuola.
Il modulo trasversale“Appartenenza”
Tutti gli Istituti scolastici curano per glistudenti iscritti al primo anno una formadi accoglienza, un approfondimentoulteriore di tale prassi è stata larealizzazione di momenti formativi chefacessero sentire allo studente che lascuola gli appartiene e che lui appartienealla scuola.Si è così sviluppato il modulo“Appartenenza” su tre Unità Didattiche:
1. il lavoro scolastico “Contrattorompighiaccio”,
2. l’ambiente “Scuola, il mio ambientefisico”,
3. il benessere “La mia salute”.
Obiettivo generale del modulo: sviluppareil senso di appartenenza alla scuola.
Ogni unità didattica ha definito propriobiettivi educativi e didattici, proprieprocedure metodologiche, strumen-ti e metodi valutativi.
Le tre unità hanno lavorato su:1. “tre elementi positivi e tre
negativi” dell’esperienza scolastica,per focalizzare il lavoro siasull’esperienza condivisa da tutti isoggetti che sulle attese di chi iniziaun nuovo corso scolastico,
2. “l’ambiente”, rilevazione dell’am-biente attraverso una schedapredisposta e concordata con i docentie gli operatori dei servizi sanitari;elaborato da discutere con operatorisanitari e di enti locali,
3. “la mia salute”, rilevazione dicondizioni di benessere/malessereattraverso il questionario HealthBehaviour School Aged Children(HBSC) predisposto dall’Organiz-zazione Mondiale della Sanità.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200352
�����������������������
Le tre unità didattiche hanno prodottorisultati significativi in funzione di:1. obiettivi educativi e didattici individuati2. indicazioni per il prosieguo della ricerca3. valutazione qualitativa e quantitativa.La sperimentazione del modulo, tracciaper un lavoro scolastico coerente con iprincipi della promozione della salute, èstata seguita da incontri a cadenzamensile tra ricercatori del C.S.E.S.i. einsegnanti.L’attuazione del modulo si è articolatasulla didattica centrata sui soggetti inapprendimento, partendo dalladescrizione e analisi delle loro esperienzeper consentire di realizzare nuoveesperienze.La prima unità didattica ha raccoltoinformazioni relative a esperienze positivee negative nel lavoro scolastico, cosìcome vissute e percepite dagli studenti,offrendo nelle discussioni in gruppopossibilità di produrre proposte.L’unità didattica sullo studiodell’ambiente non solo ha consentito allostudente di conoscere a fondo il proprioluogo di lavoro e le sue risorse, ma, conl’attenzione agli obiettivi didattici, hapermesso agli insegnanti di valutareanche alcune conoscenze acquisite (adesempio gli strumenti di misurazione, lacapacità di redigere un documentotecnico) che appartenevano agli obiettivididattici dell’unità.La terza unità ha consentito agli studentidi riflettere sulle loro reazioni rispettoalle relazioni con i compagni e gliinsegnanti e alla loro posizione neiconfronti del lavoro scolastico.
Verso i moduli disciplinari
Nell’arco di questa fase si sono succedutiincontri mensili degli insegnanti condocenti universitari di disciplinescientifiche e umanistiche per porre lebasi per la definizione dei futuri modulidisciplinari, trasferendo nella program-mazione scolastica i nuclei concettuali eoperativi sperimentati nel modulo“Appartenenza”. Per evitare la tendenza
a proporre per la sperimentazioneargomenti a latere delle disciplina, manon inseriti direttamente nel “programmascolastico”, si è partiti da quest’ultimo edalle programmazioni di ognuno deiConsigli di Classe. L’analisi e ladiscussione di tali programmi ha messoin evidenza le notevoli diversità diimpostazione e di formulazione fra i variistituti, fra i vari insegnamenti, comeanche all’interno di singoli consigli (inparticolare quelli non consolidati neltempo a causa della mobilità dei docenti),che non riescono a operare come verogruppo. Durante questo lavoro dicostruzione vengono individuate da partedegli insegnanti ulteriori esigenzeformative. Si progetta una serie diseminari per l’inizio del successivo annoscolastico sul tema “Dal lavoro di gruppoal gruppo di lavoro” con l’intento diapprofondire tematiche pedagogiche emetodologiche.
La valutazione della primafase
La valutazione del processo svolto nelleprima fase ha riguardato: i Seminari diformazione, il modulo “Appartenenza”,gli incontri mensili.Gli strumenti utilizzati sono stati: il Diariodi bordo (insegnanti e studenti ericercatori), le Interviste (insegnanti),una Relazione finale scritta (insegnanti),gli Incontri con le classi (studenti).
I Diari di Bordo sono uno strumentoutile per indicare la direzione in cui siorienta la ricerca- azione, individuandonel processo, rispetto a un certo momentoformativo (in questo caso l’Unità didattica“Appartenenza”), che cosa è statorealizzato (che cosa ho fatto) e cosa èstato acquisito (che cosa ho imparato), ecostituendo al contempo ancheun’occasione e una modalità diespressione di un proprio giudiziopersonale rispetto al percorso (che cosane penso).Interessanti sono le indicazioni emerse
dai Diari compilati dagli studentinell’ambito del Modulo Appartenenza.In rapporto alla metodologia di lavoro, iragazzi richiedono serietà, ordine,collaborazione, assunzione diresponsabilità, ascolto e condivisione delle“proprie idee”, aspirano a uninsegnamento che utilizzi metodologiediversificate, alternative alla lezionefrontale.In rapporto con l’ambiente fisico: i ragazziamano conoscere, nel senso più ampiodel termine, l’ambiente fisico in cui vivonoe dimostrano che è proprio dallaconoscenza che si sviluppa la “coscien-za” di una realtà e l’appartenenza adessa.In relazione al rapporto con la propriasalute: i ragazzi hanno apprezzato gli“strumenti” utilizzati (questionario OMS)per esprimere la propria opinione pervedere meglio come si è, per avere unavisione più completa della vita, purribadendo con insistenza il rispetto per lapropria privacy.
Gli insegnanti nella Relazione scrittadi fine I anno giudicano il percorsopositivo per gli studenti per l’opportunità,offerta dal Modulo “Appartenenza” diriflettere sulle loro condizioni easpettative e per la possibilità di lavorarein gruppo su “casi” concreti.Essi dichiarano che la sperimentazionedel modulo “Appartenenza” ha sviluppato
�����������������������
53n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
- Promozione attiva dell’autostima degli studenti attraverso la dimostrazione che ciascuno può dare uncontributo alla vita della scuola.
- Sviluppo di buone relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti nella vita di tutti i giorni.
- Chiarificazione per insegnanti e studenti degli scopi sociali della scuola.
- Offerta di “sfide stimolanti” per tutti i ragazzi attraverso un’ampia gamma di attività didattiche.
- Uso di ogni opportunità per migliorare l’ambiente fisico della scuola
- Sviluppo di buone relazioni tra scuola-casa-territorio.
- Continuità tra i vari gradi della scuola.
- Opportunità per gli insegnanti di costituire un modello di riferimento per la salute.
- Promozione attiva del benessere del personale della scuola.
- Ruolo complementare per il benessere dei momenti ricreativi della scuola.
- Sviluppo del potenziale educativo dei servizi sanitari deputati alla tutela della salute dei ragazzi.
in loro la consapevolezza che laformazione professionale del docentedeve essere anche psicopedagogica eche l’approccio didattico deve esseresempre più centrato sullo studente; hastimolato la loro capacità di osservazionedei comportamenti degli allievi nellediverse proposte di lavoro.In un processo di ricerca-azione il modulo“Appartenenza” costituiva un primoapproccio atto a produrre risultati rispettoal modo di porsi nel processo del lavoroscolastico futuro, e, contestualmenteintrodurre alla impostazione della secondafase di programmazione per l’attuazionedi moduli disciplinari, in modo da entrarenel cuore della realizzazione delprogramma del curriculum.La sperimentazione della tecnica dellavoro di gruppo e cooperativo haconsentito di riflettere sul ruolo delconsiglio di classe: se la collaborazionetra docenti è efficace e orientata alraggiungimento degli obiettivi educativitrasversali, essa si rivela molto utile ancheper il raggiungimento degli obiettividisciplinari.
Dalle Interviste con gli insegnantiorganizzate intorno a dieci domandeguida si ricava un condiviso giudiziopositivo sugli argomenti dei seminariiniziali, centrati sull’apprendimento e sulmodulo “Appartenenza”, giudicatosemplice, comprensibile e ben applicabile
all’interno delle attività di accoglienzache le scuole superiori effettuano per glialunni al primo anno di ingresso.Si ribadisce la assoluta necessità diaffrontare il discorso disciplinarecoinvolgendo nella maniera più allargatapossibile il consiglio di classe.Gli insegnanti denunciano insicurezzesul tipo di scuola verso la quale ci si staorientando, dichiarando apertamente leloro difficoltà nel confrontarsi enell’individuare un modello a cui riferirsi.Le stesse insicurezze sono percepite, aloro avviso, dagli stessi alunni, giudicatispesso fragili, demotivati e disinteressati.
I Seminario regionale:conclusione della prima fase
Il primo anno di lavoro si è concluso conun Seminario regionale che ha visto lapartecipazione di tutti i soggettiresponsabili dei tre obiettivi della ricerca,dai rappresentanti delle istituzioni a quellidelle aziende sanitarie, a tutti i dirigenti,docenti e studenti dei vari istituti.Si è trattato di un momento importante diverifica e di compattamento dell’interogruppo di ricerca, in particolare per ilrapporto della “unità operativa Istituzioni”che ha proposto la costruzione di un“Sistema organico di supporto al lavoroscolastico”, mentre la “unità operativaSanità” ha presentato alla discussioneun primo nucleo di indicatori da
approfondire con la scuola.Nei lavori dei gruppi che hanno seguito,nel pomeriggio, gli interventi dei soggettidella unità operative dei tre obiettivispecifici del mattino, si è discusso su duetendenze che sembra caratterizzino leinnovazioni nella scuola, che potremmodefinire “una scuola che fa matematica”la quale concentra le innovazioni sullavoro scolastico, e “una scuola che fafuochi di artificio”, metafora suggeritadagli insegnanti per indicare una scuolainvasa da progetti frammentati, daproposte esterne che sovente noninfluiscono positivamente sul lavoroscolastico. Si è confermato che vafavorita la prima tendenza la quale,tuttavia, richiede cambiamenti eapprofondimenti.Il gruppo dei ricercatori universitari haorganizzato un dossier raccogliendo tuttoil materiale prodotto in questa primafase, memoria da utilizzare per dareavvio alla seconda fase.
SECONDA FASE
Il corso di formazione
Il corso richiesto “Dal lavoro di gruppo algruppo di lavoro” si è tenuto all’iniziodella seconda fase del progetto, insettembre. Il corso, sviluppato in quattromoduli, è stato strutturato sulle esigenzeevidenziate dagli insegnanti nella prima
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200354
�����������������������
fase dell’esperienza. In riferimento altema insegnamento/apprendimento si èritenuto necessario approfondire dueelementi: uno metodologico didattico -letecniche del lavoro di gruppo-, l’altrosugli aspetti relazionali ed emozionalidell’apprendimento.
Il I Modulo ha preso avvio con lavori digruppo eterogenei, non per consigli diclasse, per analizzare e discutere imateriali del dossier realizzato al terminedella prima fase. I gruppi hannoevidenziato problemi, spunti di riflessione,linee di indirizzo per lo svolgimento dellaseconda fase, connessa in modo piùspecifico al lavoro scolastico.Si è messa in evidenza l’importanza, enel contempo la difficoltà, di fare inmodo che il consiglio di classe opericome gruppo di lavoro in funzione dellacondivisione sia del lessico che deisignificati dei percorsi disciplinari, chedella individuazione di metodologie diinsegnamento idonee e adeguate alprincipio della centralità dello studente(ricerca-azione, didattica per concetti,didattica modulare...). Si ribadiscel’importanza della organizzazionescolastica per una migliore organiz-zazione didattica.
Il II Modulo ha approfondito i suddettitemi con una introduzione di un espertosu “Didattica centrata sull’allievo peruna scuola promotrice di salute”, i duetemi centrali della ricerca.I lavori degli insegnanti hanno evidenziatola necessità di competenze per gestirevarie forme di intelligenza, personalizzarel’intervento (obiettivo ostacolato dallanumerosità delle classi), creare un climasociale positivo, revisionare i propricurricula in una prospettiva dicollegamento con il futuro lavoro, il cherichiede un collegamento stabile construtture universitarie per un confrontocostante per approcci didattico-metodogici efficaci ed appropriati.
Il III Modulo ha sviluppato più a fondo
il nucleo relazionale motivazionale delprocesso di insegnamento/apprendimento,analizzando vari aspetti delle esperienzedi docenza. Il lavoro sulle esperienze èiniziato dal compito individuale sulmandato “Descriviti come insegnante”.Dalle presentazioni sono emersisoprattutto elementi significativi per lacomprensione della situazione dimalessere vissuta anche dagli stessiinsegnanti: la necessità di rispetto delleregole (“sia per gli insegnanti che per glialunni”) e dei ruoli (“l’insegnante non èuna figura parentale, né un pari”), ildisagio psicologico dell’insegnante nel“dover ripetere contenuti spesso nonascoltati e non studiati”, il desideriodell’insegnante di nuove conoscenzedidattico-disciplinari, reso irrealizzabileda un carico burocratico eccessivo chelimita la formazione, la riaffermazionedella valenza disciplinare per non sfociarenella “tuttologia”, la stanchezza di fare il“capro espiatorio” di una societàcontraddittoria e di un sistema fortementeoscillante in riferimento ai principi dieducazione/istruzione/istituzionescolastica.
Il IV Modulo, propositivo, ha lavoratosu uno “Schema per lo sviluppo diindicatori per il monitoraggio del processodella scuola promotrice di salute”elaborato dal Centro Sperimentale perl’Educazione Sanitaria, allo scopo diproporre direttrici operative. Gliinsegnanti hanno lavorato in gruppo sulconcetto di indicatore, analizzando gliindicatori proposti e selezionandonealcuni relativi al processo diinsegnamento/apprendimento, punti diriferimento per la individuazione dei meto-di della realizzazione del programma diinsegnamento delle discipline nel corsodell’anno.
Le discipline
In questa fase della ricerca si è lavoratosu come affrontare le discipline tenendoconto di tutte le premesse. Sono
continuati gli incontri mensili traricercatori e gruppi insegnanti perapprofondimenti e per mantenere inecessari collegamenti e le verificheintermedie.Gli insegnanti hanno potuto scegliere diprogrammare per singole discipline oper gruppi disciplinari affini, o, comesarebbe stato auspicabile, per consigliodi classe.La possibilità di scegliere tra diverseopzioni era legata al differente numerodi insegnanti per classe aderenti allaricerca e all’esigenza di rispettarel’autonomia didattica di ogni insegnanteo gruppo di insegnanti e le loro abitualimetodologie di programmazione e dilavoro.
Nuclei concettuali e obiettiviformativi
Gli incontri iniziali degli insegnanti conesperti di didattica specializzata hannoportato a definire:obiettivi educativi,obiettivi didattici enuclei concettuali,per i due ampi ambiti disciplinaridell’area matematico-scientifica edell’area linguistica- letteraria.
Per l’area matematico-scientificagli obiettivi educativi:1. individuare i concetti base in
�����������������������
55n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
matematica per affrontare i problemiconoscendo gli strumenti necessari,evitando la cumulazione ed eliminandola paura,
2. acquisire, attraverso i procedimentimatematici, la capacità di accrescerela propria autostima ed evitare lostress,
3. sviluppare la capacità e l’abitudine ausare la parola (“arrivare a far sì chequello che si dice è quello che sivoleva dire”);
gli obiettivi didattici:1. sviluppare la capacità di “manipolarei numeri” per “abbandonare i numeri” earrivare all’astrazione individuando 4nuclei essenziali:
1. potenze2. equivalenze3. proporzioni4. funzioni, equazioni
Per l’area linguistico letterariagli obiettivi educativi :1. favorire la comunicazione come
strumento per- lo sviluppo della consapevolezza di sé- la conoscenza del contesto socio- ambientale- la promozione dell’affettività e della relazionalità,
2. sviluppare la capacità e l’abitudinead usare la parola (“arrivare a far sì
che quello che si dice è quello che sivoleva dire”)
gli obiettivi didattici:1. sviluppare conoscenze e competenze
riflessive, analitiche ed espressiverelativamente a 4 nuclei essenziali
1. il linguaggio2. il segno3. la differenza di codici4. l’analisi del testo
Lavoro scolastico promotoredi salute
Per garantire una migliore operativitàsono stati ripresi i nodi concettuali emetodologici di riferimento di: scuolapromotrice di salute, lavoro scolastico/processo di apprendimento-insegna-mento, centralità dello studente, metodoesperienziale per coniugare questi congli specifici percorsi disciplinari che igruppi-insegnanti stavano elaborando.Si è proposto per la definizione di “lavoroscolastico favorevole” il lavoro fondatosul processo di apprendimento/insegnamento centrato sullo studente,caratterizzato da tre elementi di base:1. motivazione verso l’apprendimento:
rendere lo studente attore dell’azionedidattica e della conoscenza,
2. creatività nell’apprendimento: favorirelo sviluppo e l’espressione di capacitàpersonali nell’ambito di ogni singoladisciplina ponendo lo studente in una
situazione di ricerca e in grado diprodurre conoscenza,
3. sicurezza dall’apprendimento:accrescere la fiducia in se stessi neiconfronti della propria capacità diapprendimento e controllare lo stressnegativo.
Per lo sviluppo del percorso si proponel’adozione del metodo esperienziale: fareriferimento al vissuto cognitivo, emotivoe concreto sul quale lo studente riflette edel quale acquisisce consapevolezza:
1. legare la motivazione
all’esperienza pregressa,
2. sviluppare la creatività
dall’esperienza agita,
3. derivare la sicurezzadall’esperienza valutata.
I percorsi disciplinari
Gli insegnanti di ogni singola scuola hannoelaborato percorsi disciplinarisperimentali che sono stati presentatisecondo la normale prassi dellaprogrammazione scolastica e in base aiprogrammi delle singole discipline.
Istituto Magistrale Assunta Pieralli,Perugia: un modulo interdisciplinare(educazione fisica, matematica echimica) “Funzione” e un modulodisciplinare (educazione musicale)
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200356
�����������������������
“Lessico specifico”.Si è cercato di individuare nel programmadi matematica un tema che potesseessere svolto a partire da un esperienzaconcreta (esperienza fisica: il battitocardiaco, esperienza cognitiva: i grafici)e coinvolgesse altre discipline.L’argomento è stato “il concetto difunzione”.Il modulo ha consentito un confronto trai colleghi, caratteristica considerata dagliinsegnanti “generalmente difficile darealizzare”. Ha stimolato nella ricerca distrategie didattiche diversificate, haconsentito di utilizzare strumenti come illavoro di gruppo e il diario di bordo, hapermesso di controllare meglio i nodiproblematici, le difficoltà e i punti debolidel percorso.
Istituto Professionale Blaise Pascal,Perugia: un modulo disciplinare (inglese).L’unico insegnante aderente al progettoha presentato e sviluppato insieme airagazzi le varie fasi del modulo.Dall’ascolto di un brano musicale “Fatherand son” titolo coincidente con ilcontenuto del modulo sono stati previstimomenti di ascolto di vari testi musicaliin lingua inglese e conversazioni di gruppoin lingua fino all’interpretazione del testo.Il modulo voleva inserirsi nel processodei rapporti tra genitori e figli, sentito ecomplesso, soprattutto nelle fasce d’etàin causa, senza invadere il vissutopersonale.
Istituto Tecnico Giordano Bruno,Perugia: tre moduli disciplinari: “Testoteatrale”(italiano), “Dalla fiaba allascrittura creativa”(inglese), “Il nuoto”(educazione fisica).La realizzazione dei moduli è stataconcretizzata dai docenti di italiano elingua straniera. Un valido supporto èstato fornito dagli insegnanti di educazionefisica e dall’insegnante di matematicache ha seguito gli studenti nellaelaborazione grafica delle diverse fasidel prodotto cartaceo. Gli insegnanticoinvolti nella attuazione dei moduli hanno
lavorato in sintonia condividendo obiettivie finalità. L’organizzazione verticale dellecattedre ha comportato un contributomarginale dei docenti impegnati nellarealizzazione di progetti che coinvol-gevano le III le IV e le V.La partecipazione collaborativa hacoinvolto gli studenti, definiti dagli stessi“insegnanti entusiasti motivati ed infineanche stanchi”; ha potenziato il senso diappartenenza e la condivisione.Il numero delle ore previste per larealizzazione dei moduli ha richiestocambiamenti, flessibiltà e impegno siaper rispondere alle aspettative deglistudenti (che hanno richiesto di realizzareun filmato su uno degli argomenti delpercorso disciplinare di lingua inglese “lafiaba) sia per rispondere a esigenze diflessibilità proprie del lavoro di ricerca.
Liceo Scientifico Galilei Galilei,Perugia: modulo interdisciplinare(italiano, latino, matematica, scienze) “Lavita extraterrestre: viaggio tra fantasia eragione”.Tutti gli insegnanti hanno iniziato i singolipercorsi curriculari trattando unargomento connesso al tema (Lucianoper latino, le coniche e le ellissi permatematica, letteratura e cinema difantascienza per italiano, l’osservazioneastronomica per scienze).La scelta dell’argomento, propriosecondo le indicazioni del progetto, èpartita dall’osservazione degli insegnantiche molti dei ragazzi erano interessati ealcuni addirittura appassionati diastronomia e letteratura di fantascienza.Da questo interesse sono stati coniugatii temi che le singole discipline eranotenute a svolgere.La metodologia ha previsto lavalorizzazione del lavoro di gruppo: perla matematica utilizzo della scopertaguidata - sperimentazione/deduzione/concettualizzazione - anche in fase dirielaborazione di quanto appreso; perl’italiano, dalla lettura e visione dei filmalla produzione originale di testi.
Istituto Magistrale FrancescoAngeloni, Terni: modulo multidisci-plinare “Società umana, ambiente,risorse” (religione, italiano, francese,geografia, matematica, biologia).La scelta dell’argomento è partita da untema attuale, la globalizzazione, sullaquale i ragazzi avevano manifestatointeresse per legare a questa argomenticurruculari, di programma.Ciascun insegnante ha esposto il propriopercorso disciplinare con gli studentienucleandone obiettivi e metodologia.La metodologia applicata è stata centratasulla motivazione degli alunni, discussionee riflessione sulla loro esperienza, e suelementi problematizzanti, individuazionedel problema e percorso di ricerca, libertàdegli alunni di proporre problemi esoluzioni, utilizzo di strumenti interattivi.
Istituto Professionale FedericoCesi, Terni: tre moduli disciplinari, perdiscipline affini uno per l’area linguistico-letteraria “La comunicazione: illinguaggio pubblicitario” (lettere, linguastraniera 1 e 2, diritto, trattamento testi,religione), due per l’area metamatico-scientifica “L’alimentazione” (scienzedella terra, scienza della natura, matema-tica, educazione fisica, religione) “Glistrumenti di pagamento” (economiaaziendale, diritto, trattamento testi).
�����������������������
57n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
La metodologia ha previsto: lasomministrazione di un questionario perreperire informazioni dagli studenti,l’elaborazione da parte degli studenti el’individuazione dei punti chiave su cuigli studenti stessi hanno lavoratoattraverso ricerca-azione individuale odi gruppo, esperienze di laboratorio,confronto tra la situazione reale del lorovissuto e le conoscenze acquisiteIl modulo “Alimentazione”, in particolare,ha trovato punti di aggancio con i temidell’apparire e dell’essere, dell’immaginedel corpo e della sua prestanza,fortemente sentiti in una età in cui ilcorpo è in fase di trasformazione
Riflessioni e sintesi
Gli studentiIl lavoro dei ricercatori e l’azione diformazione realizzata nel corso progettoera stata rivolta esclusivamente agliinsegnanti per valutare la fattibilità delpercorso in classe attraverso la normaleorganizzazione della didattica, senza lapresenza di “esperti” esterni alla classe.Per tale motivo e anche per la complessitàe i tempi lunghi del progetto, si èevidenziata una certa difficoltà da partedegli studenti ad entrare nel climasperimentale, nonostante il programmafosse proposto e, pertanto non dovesseessere, percepito come “progetto”aggiunto al quotidiano lavoro scolastico.
Sono stati effettuati, pertanto, su richiestadegli insegnanti due incontri tra iricercatori e gli studenti delle classiaderente al Progetto per una riflessionesu percorsi disciplinari sperimentali,presentati loro dagli insegnanti.Gli incontri sono stati focalizzati su dueelementi: l’esperienza di essere studentie l’esperienza attuale nel programma diricerca. Il primo è stato affrontato conun gioco “il gioco dei sacchetti” nel qualesi utilizzano ritagli di immagini perdescriversi, in questo caso nella loroesperienza di studenti. Sono emerseosservazioni comuni come il carattere“noioso e ripetitivo” del lavoro a scuola,la positività dei rapporti con i compagni,la diffusa varietà delle relazioni con idocenti. Alcuni docenti che hanno presoparte alla conclusione di questo incontrohanno riconosciuto la validità dellostrumento che, nella sua semplicità, aiutaa comprendere molti aspetti dellacomplessa realtà degli studenti.Il secondo elemento è stato affrontatocon una riflessione individuale descrittabrevemente e utilizzata in una discussionedi gruppo per produrre un giudizioconcordato sulla esperienza della ricerca.Si è, infine, convenuto di realizzare una“Narrazione” della partecipazione allaricerca, con modalità scelte dagli stessistudenti (relazione, drammatizzazione,disegno e quant’altro) da presentare alSeminario di chiusura di fine anno.
Dirigenti scolastici e insegnantiPresso la Direzione generale scolasticaregionale dell’Umbria si è tenuto unincontro cui hanno partecipato il DirettoreGenerale, i dirigenti scolastici e iresponsabili della ricerca dei dueprovveditorati e i ricercatori del CSESiper trarre le conclusioni dell’esperienzae programmare il Seminario regionalefinale.Con gli insegnanti si sono tenuti dueincontri finali per riflettere sui varimomenti del percorso modulare svoltoseguendo uno schema proposto dallaScheda di documentazione e analisidell’esperienza di ricerca Sperimen-tazione del modulo disciplinare,redatta dai ricercatori del CSESi perfavorire il lavoro di descrizione, analisi evalutazione dei risultati che sono statioggetto di presentazione al Seminarioregionale
La valutazione della secondafase
La valutazione della realizzazione deimoduli disciplinari ha riguardato ilprocesso di costruzione dei percorsididattici da parte degli insegnanti e daparte degli studenti.Gli insegnanti hanno utilizzato la“Scheda di analisi per la documen-tazione dell’esperienza di ricerca.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200358
�����������������������
Sperimentazione del modulo disci-plinare”, costruita per analizzare,descrivere, il percorso, presentare ilprodotto finale e valutare l’esperienzadella ricerca. La scheda era impostatasu un percorso preciso, ma lasciavaspazi alla autonomia degli insegnanti; sitrattava di ripercorrere le fasi dellaricerca-azione rispetto al modulorealizzato (dalle premesse concettuali di“scuola promotrice di salute” fino allavalutazione dell’esperienza)L’esperienza è stata valutata positi-vamente sia da un punto di vistapedagogico che didattico, ma faticosada inserire nello svolgimento delprogramma curriculare proprio perl’attenzione che richiede tale meto-dologia.Gli obiettivi disciplinari sono stati giudicatiraggiunti; la relazione docente-discenteimprontata a maggior rispetto ecollaborazione. Il lavoro scolasticodefinito “partecipato e creativo”.Per alcuni insegnanti l’esperienza haprodotto conoscenze in terminipedagogici (importanza di partire dallostudente e dalla sua esperienza), in terminimetodologici (utilizzo del Diario di Bordoe del Lavoro di gruppo), in terminiorganizzativi (confronto con i colleghi,programmazione dettagliata, precisascansione dei tempi e dei modi).E’ stato rilevato un atteggiamento criticoe consapevole dei ragazzi nei confrontidelle metodologie adottate.Alcune difficoltà hanno portato, tuttavia,in alcuni casi ad un rapporto docente-allievo più critico e dialettico.L’elemento positivo in relazioneall’apprendimento degli allievi è risultatoessere la scoperta da parte degliinsegnanti delle potenzialità degli stessie, di conseguenza, una valutazione piùlibera dagli stereotipi.Metodologie e strumenti didatticidiversificati hanno permesso agli studentidi acquisire conoscenze scientifiche suuno stesso argomento attraverso unapproccio multidisciplinare, motivando evivificando esperienze pregresse,
sviluppando la creatività attraversol’esperienza agita e promuovendosicurezze interiori.Sono state acquisite competenzemetodologiche spendibili in ogni disciplinae nella propria realtà quotidianaGli insegnanti hanno ritenuto stimolanteil confronto periodico continuo con altrigruppi-insegnanti. E’ stata evidenziatala necessità di modifiche “organizzativo-normative” della scuola che un tale mododi lavorare esige.Gli studenti oltre al Diario di Bordohanno utilizzato un “Questionario divalutazione dell’azione didattica pre-post” per ciascuna disciplina, costituitada dieci quesiti su Scala Lickert a cinquepunti compresi tra “moltissimo” e “nienteaffatto”. Questionario costruito suindicatori di apprendimento/insegna-mento individuati e selezionati (metodo-logie attive, motivazione, partecipazione)assieme agli insegnanti durante i Seminaridi formazione.Il Questionario, pur essendo ancora insperimentazione, ha offerto alcuneindicazioni di risultato, soprattutto rispettoall’aumento della cura di ricercare ecogliere la motivazione, di valorizzare leesperienze, di rielaborare assieme ingruppo gli apprendimenti, di coinvolgeregli studenti.Un lavoro individuale e di gruppo congli studenti, ha costituito un’occasioneper una valutazione qualitativa delpercorso complessivo.L’esperienza viene giudicata positi-vamente per la novità dell’approccio eper gli strumenti utilizzati, apprezzate lemetodologie partecipative che hannomotivato e responsabilizzato i ragazzi. Illavoro è stato al contempo definito “duro”e impegnativo.Ed è stata ovviamente avvertita ladifficoltà a raccordare la sperimentazionecon l’ordinaria attività scolastica, il cheha comportato scarsa continuità,mancanza di collegamento e quindipesantezza e accumulo di lavoro, inparticolare quando non era impegnatol’intero consiglio di classe e di conse-
guenza le diverse discipline venivanosviluppate su metodologie diverse,quando non divergenti.
Il II Seminario regionale
Il 28 maggio 2002 si è svolto a Villa Lago(Terni) il Seminario regionale conclusivodella Ricerca.Ogni unità operativa ha presentato irisultati dei lavori del proprio gruppo.Gli insegnanti hanno presentato i risultatidei moduli disciplinari sperimentati, glistudenti le diverse “Narrazioni dellaesperienza”.Le relazioni redatte e presentate dagliinsegnanti, elaborate secondo gli indirizzidel progetto OMS “Scuola promotrice disalute”, sviluppati nel corso dei due annidi ricerca possono costituire modelli dibuona pratica.Agli studenti è stato dato un ampio spazioper la presentazione delle loro“Narrazioni.”Gli studenti dell’Istituto Professionale F.Cesi così come le studentesse dell’IstitutoMagistrale A.Pieralli hanno realizzatouna presentazione Power Point dei lavoridell’intero percorso dei due anni diricerca. Gli studenti dell’IstitutoMagistrale F. Angeloni una presenta-zione in VHS; anche gli studentidell’Istituto Professionale B. Pascalhanno presentato il lavoro sul modulodisciplinare di Inglese in VHS.
�����������������������
59n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Sono state presentate due dramma-tizzazioni: “A surprise for the king”, delmodulo disciplinare di inglese dai ragazzidell’Istituto Tecnico per le Attività SocialiG. Bruno e “La vita extraterrestre:viaggio tra fantasia e ragione” risultatodel modulo interdisciplinare del LiceoScientifico Galilei.
La valutazione conclusiva
La valutazione della ricerca è calibratasugli obiettivi che questa si proponeva diraggiungere.Obiettivo finale per l’obiettivo specificoScuola era quello di esplorare la possibilitàdi intervenire sulle modalità del lavoroscolastico, in particolare sull’applicazionedi metodologie di svolgimento dei percorsicurriculari tali da rispettare la centralitàdello studente, come soggetto attivodell’apprendimento.Quali esiti di tale obiettivo si intendevanoottenere la messa a punto di:- modelli di corsi di formazione per il
personale docente per l’acquisizionedelle base concettuali
- della complessità dei parametri disalute e benessere,
- della promozione della salute e delbenessere in ambiente scolastico,
- delle caratteristiche delle diverseforme di apprendimento
allo scopo di rendere il lavoro scolasticopiù rispondente alle esigenze dello
sviluppo dell’età evolutiva e delbenessere dei docenti;
- esempi di buona pratica di percorsididattici extradisciplinari, interdisci-plinari, pluridisciplinari e disciplinaricoerenti con i principi della promozionedella salute.
I criteri per la verifica del raggiun-gimento dell’obiettivo e degli esiti ottenutisono stati:- il monitoraggio della adesione al
progetto- la verifica della qualità dei corsi di
formazione, il grado di partecipazionedei soggetti
- l’individuazione degli elementi deiprocessi di apprendimento/insegna-mento orientati al raggiungimentodell’obiettivo benessere
- la realizzazione di parti del programmascolastico attraverso moduliinterdisciplinari, pluridisciplinari edisciplinari coerenti con i principi dellapromozione della salute.
Per quanto riguarda l’obiettivo generaleè stata dimostrata la fattibilità delpercorso ipotizzato per la realizzazionedi un lavoro scolastico coerente con iprincipi della salute.
L’adesione dei dirigenti scolastici e degliinsegnanti è stata costante (eccezionfatta per una scuola).E’ da sottolineare il forte impegno e il
coinvolgimento dei partecipanti inconsiderazione del numero elevato deisoggetti: due referenti degli ex-provve-ditorati, sette dirigenti scolastici, trentatreinsegnanti, quattro ricercatori delComitato di consulenza scientifica, duedisciplinaristi, e del lungo arco di tempodi svolgimento della ricerca (due anni)che prevedeva la frequenza a incontrimensili nelle scuole, e a cadenzatrimestrale con le unità operative deglialtri due obiettivi (Istituzioni e Sanità)del progetto a due blocchi seminarialiuno di sei e l’altro di quattro moduli,oltre, ovviamente al lavoro di studio e diricerca individuale e di gruppo.
Testimonianza della possibilità disuccesso delle linee concettuali emetodologiche del progetto è l’averesvolto un effettivo percorso di ricerca-azione, avere ottenuto una partecipa-zione e frequenza alle diverse forme diincontro dagli insegnanti, in genereabituati, nei propri corsi di aggiornamento,a un’attività di formazione quasiesclusivamente recettiva e sicuramentenon sperimentale, così come l’averecondiviso con loro un’esperienza di studioorientata alla ricerca e sperimentazionedi unità didattiche trasversali, di modulidisciplinari, e di verificare congiunta-mente elementi favorenti e ostacolantila fattibilità stessa di un simile percorso.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200360
�����������������������
Il corpo docente ha espressosoddisfazione sia per entrambi i corsi diformazione strutturati, sia per gli incontrimensili.Al termine della ricerca gli stessi inse-gnanti hanno sostenuto la riproposizionedell’esperienza e, insieme alle unitàoperative degli altri obiettivi (Istituzioni eSanità), hanno condiviso la richiesta perla messa a regime del sistema di supportopsicopedagogico al lavoro scolastico,esprimendo la volontà di continuare econdividere insieme agli altri insegnantie ad esperti un costante lavoro di ricerca-azione per costruire un lavoro scolasticopromotore di benessere, soddisfazione,risultati.
Il modulo “Appartenenza”, modello perimpostare un percorso centrato sullostudente, in grado di fornire obiettivieducativi e didattici, e le successivesperimentazioni di moduli intradisciplinari,pluridisciplinari, disciplinari coerenti conprincipi della promozione della salutecostituiscono esempi di buona pratica euna traccia su cui poter procedere nellacostruzione di un possibile modello.
La diffusione la ricerca di tutti i risultatie di un confronto con una platea piùampia ha trovato il momento ha trovatoun forte momento di rilievo nel ConvegnoNazionale di cui si pubblicano gli atti perulteriore divulgazione.
Bibliografia1. Denman S., Moon A, Prsons C.,
Stears D. The Health promotingSchools. Policy Research andPractice. Routledge, 2002.
2. ENHPS Technical Secretariat. TheEuropean Network of HealthPromoting Schools. ”The HealthPromoting School – an investment ineducation, health and democracy.Conference Report. First Conferenceof the European Network of HealthPromoting Schools, Thessaloniky-Halkidiki, Grecia, 1-5 maggio 1997,Copenhagen, WHO, Regional Officefor Europe, 1998. (documento EUR/ICP/IVST 06 01 02 (A)).
3. Jensen Bruun B., Simovska V. editedby Models of Health promotingSchools in Europe. European Networkof Health Promoting SchoolsTechnical Secretariat, WHO, RegionalOffice for Europe, 2002.
4. Konu A., Alanen E., Lintonen T.,Rimpela M. Factor structure of theschool well-being model. HealthEducation Research, 2002, 17 (6), 732-742.
5. Konu A, Lintonen T., Rimpela M.Factors associated with schoolchildren’s general subjective well-being. Health Education Research,2002, 17(2), 155-165.
6. Parsons C., Stears D, Thomas C. TheHealth Promoting School in Europe. AConceptualising and Evaluating theChange. Health Education Journal,1996, 55, 311-321
7. Promoting health in second levelschools in Europe. A practical guide.Copenhagen, International PlanningCommittee of the European Networkof Health Promoting Schools, 1995.
8. Promoting Heath of young people inEurope: a training Manual for teachersand others working with youngpeople. International PlanningCommittee of the European Networkof Health Promoting Schools, 1994.
9. Resource Manual-the EuropeanNetwork of Health Promoting Schools.Copenhagen, WHO Regional Officefor Europe, 1993.
10. Stewart Burgher M. BarnekowRasmussen V., Rivett D. TheEuropean Network of HealthPromoting Schools. The alliance ofeducation and health. InternationalPlanning Committee of the EuropeanNetwork of Health Promoting Schools,1999.
11. Weare K., Gray G. Promoting mentaland emotional health in the EuropeanNetwork of Health Promoting Schools,Copenhagen, WHO Regional Officefor Europe, 1995
�����������������������
61n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
MINISTERO DELLA SANITA’REGIONE DELL’UMBRIA
Scuola promotrice di salute. Ricerca intervento per la sperimentazione di un modello organizzativo-gestionalenella scuola per la promozione della salute
OBIETTIVO SCUOLA
La tabella evidenzia le fasi di esecuzione del progetto, elencando gli interventi e gli esiti in riferimento all’obiettivo Scuola e alle Unità Operativecoinvolte (U.O)Responsabile della Ricerca: Regione dell’UmbriaU.O. = Unità Operative: ASL (Aziende USL) – E.L. (Enti Locali) - Provv. St. (Provveditorati agli Studi) – Regioni (Regioni) – Scuole (Scuole)Consulenti scientifici: C.S.E.S.i. (Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia) - Dip. Igiene(Dipartimento di Igiene dell’Università degli Studi di Perugia)
Fasi Obiettivo Scuola U.O.
FasePropedeutica
- Impostazione del progetto, predisposizione del programma operativo,individuazione del bacino scolastico.
- Pianificazione dettagliata del progetto.- Identificazione dei componenti dell’organizzazione del progetto, del team di lavoro
operativo, assegnazione dei rispettivi compiti e delle attività di consulenzascientifica
- Incontri ricercatori CSESi e funzionari Provveditorati per la condivisione delprogetto.
- Seminario di presentazione del progetto rivolto a Presidi ed Insegnanti allaConferenza di servizio delle Scuole Medie Superiori
- Individuazione delle scuole- Verifica disponibilità adesione al progetto.- Verifica della presentazione di progetti d’Istituto secondo le linee del MIUR che
prevedono l’offerta pedagogica (POF) e la formazione docenti.- Indagine conoscitiva per verificare le attività svolte in Ed. e PdS e per delineare
nuovi bisogni in funzione della progettazione del modello.- Realizzazione di due incontri seminariali con gli insegnanti delle scuole coinvolte- Consegna dei materiali informativi in preparazione della programmazione del
progetto agli insegnanti.Esiti- Progetto esecutivo riveduto e corretto- Gruppi formati- Raccolta e analisi dati indagine conoscitiva- Programma di lavoro e gruppi di lavoro formati all’interno delle scuole- Organizzazione e programmazione dei corsi di formazione in servizio per gli
insegnanti
Tutte
Fase I
- Incontri seminariali di formazione per gli insegnanti su Promozione della Salute eprocesso di apprendimento/insegnamento
- Costruzione e Sperimentazione del Modulo trasversale “Appartenenza”- Valutazione in progress- I seminario regionaleEsiti- Realizzazione di un modello di corso di formazione per il personale docente- Costruzione e realizzazione del Modulo trasversale “Appartenenza”: percorso
didattico disciplinare coerente con i principi di promozione della salute- Condivisione degli strumenti di valutazione- Seminario regionale di diffusione dei risultati del I anno di Ricerca
Provv. StudiScuoleASL
C.S.E.S.i.
Fase II
- Proseguimento dei Corsi di formazione in servizio per insegnanti “Dal Lavoro digruppo al gruppo di lavoro”.
- Definizione di un percorso formativo con gli insegnanti volto alla progettazione dipercorsi didattico-disciplinari rispondenti alle premesse concettuali
- Sperimentazione di percorsi didattico-disciplinari, interdisciplinari,pluridisciplinari coerenti con la promozione della salute
- Valutazione- II Seminario regionaleEsiti- Realizzazione di un modello di corso di formazione per il personale docente- Progettazione di percorsi didattico-disciplinari, interdisciplinari pluridisciplinari
coerenti con la promozione della salute- Esempi di buon pratica di percorsi didattico-disciplinari, interdisciplinari
pluridisciplinari coerenti con la promozione della salute- Condivisione delle modalità di applicazione dei percorsi- Condivisione degli strumenti di valutazione- Diffusione dei risultati
Provv. StudiScuoleASL
C.S.E.S.i.
Conclusione
- Convegno Nazionale “Scuola Promotrice di salute”Esiti- Messa a punto di linee guida, sintesi ed esplicazione del percorso svolto- Pubblicazione del rapporto finale- Socializzazione dei risultati
Tutte
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200362
�����������������������
���� � ������ ��� ������� �&������� ������ � ��� ����� &
Dalle schede distribuite agli insegnanti
FONDAMENTI E STORIA DELLA TEORIA DELLE DECISIONIGiulianella Coletti, Dipartimento di Matematica, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Universitàdegli Studi di PerugiaDecidere è senza dubbio il processo che più frequentemente viene attuato da un individuo e, di riscontro, ogni avvenimentoè prodotto (o quanto meno condizionato) dall’effetto delle decisioni di uno o più individui.Pertanto è immediato comprendere quanto sia importante (e interessante) lo studio delle problematiche legate al processodecisionale. E’ forse meno immediato pensare che ci possa essere una teoria matematica che si occupa di decisioni.In realtà oggi potremmo dire che ce ne sono almeno due: una che studia, anche al fine di dare una valutazione sulle possibiliscelte future, i modelli che descrivono il modo in cui la “maggior parte degli individui” (con certe caratteristiche) decidein determinate condizioni (teoria descrittiva), e un’altra che studia quale sia il criterio migliore di decisione perraggiungere il più possibile i risultati desiderati (teoria normativa).La teoria normativa, è senz’altro quella più interessante per un matematico. Essa si occupa di fatto della formulazionedi modelli per la ricerca della “decisione ottima”.Ma esiste una “decisione ottima”?Ovviamente non esiste una decisione ottima in assoluto, ma solo decisioni che sono tali da massimizzare l’obiettivo checi si è prefissi: è ovvio che l’obiettivo di un monaco tibetano non sarà lo stesso del dirigente di una banca o del presidentedi una azienda che produce materiale bellico: quindi, di fronte ad una stessa situazione di scelta fra più alternative, saràdiversa, addirittura opposta, la decisione “ottimale” per ognuno di loro.Cosa può e deve fare allora una teoria matematica? Certo non fissare gli obiettivi, né giudicare se un obiettivo è miglioredi un altro (questo spetterà ad altre discipline); può invece individuare “le regole” (assiomi) che debbono essere rispettateda ogni decisore per raggiungere il proprio fine (dichiarato), cioè le regole di coerenza (o di razionalità) che evitano sceltein contraddizione tra loro o con l’obiettivo che ci si è prefissi.La teoria descrittiva è più recente di quella normativa e potremmo dire che è nata come una “teoria contro”, nel sensoche ha preso impulso dalle critiche alla più famosa delle teorie normative, che si riteneva “non praticata” (e non praticabile)in casi critici, neanche da chi l’ha accettata e la conosce bene.Per rispetto della verità storica dobbiamo dire che per lungo tempo non si è affatto enucleata questa suddivisione, cheè essenzialmente degli ultimi cinquanta anni: i primi modelli di decisione vengono elaborati a partire da considerazioni siadescrittive che normative. C’è inoltre da dire che una consistente corrente di pensiero dei nostri giorni cerca in qualchemodo di dare risposte che coniughino le esigenze dei due punti di vista.Entrambe le teorie suddette devono fare i conti con tre (la divisione è ovviamente molto schematica) livelli di difficoltàlegati a tre diverse condizioni in cui si viene a trovare colui che deve decidere (decisore):- situazione di certezza: il decisore è in possesso di una informazione completa sul processo decisionale, cioè saesattamente quale sarà il risultato che otterrà optando per una o l’altra delle alternative disponibili;- situazione di incertezza: il risultato che otterrà il decisore non dipende solo dalla alternativa che egli sceglie, ma ancheda circostanze a lui non note. Cioè la sua informazione sul processo decisionale non è completa, vuoi perché i risultatisono legati a fatti che dovranno accadere in seguito (dopo che la decisione viene presa), vuoi perché non conosce a fondoi fatti e le circostanze che influiscono sull formulazione di uno o più risultati;- situazione di incertezza e competitività: il risultato della decisione dipende anche dalle scelte di un “competitore” chepuò (e, in genere, vuole) influire sul risultato di ogni scelta del decisore. (...)
�����������������������
63n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
LA DIDATTICA CENTRATA SULL’ALLIEVO, PER UNA SCUOLA PROMOTRICE DI SALUTEFloriana Falcinelli, Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi diPerugiaL’azione didattica è l’azione di insegnamento intenzionalmente programmata per promuovere nell’allievo il processo diapprendimento tanto che insegnamento e apprendimento sono indissolubilmente legati.L’apprendimento è quel processo che, prevalentemente in seguito all’esperienza, produce un cambiamento relativamentestabile nella capacità di operare del soggetto; esso implica una trasformazione qualitativa delle strutture mentali che incidesul comportamento e sul modo di essere.L’apprendimento si caratterizza come processo che si realizza nella continua interazione tra il soggetto e l’ambiente.Molto importante è dunque l’esperienza che può essere attiva, iconica, simbolica, diretta e mediata, personale e socio-culturale.Nella scuola l’esperienza è prevalentemente simbolico-culturale (saperi disciplinari) e decontestualizzata. Da qui lanecessità per l’insegnante di conoscere l’esperienza spontanea intuitiva che il ragazzo fa nella dimensione extra-scolastica per portarlo ad una graduale revisione dei concetti scientifici. (Vygotskji)Si ha apprendimento significativo quando si produce una modificazione, una trasformazione qualitativa delle strutturementali precedentemente costruite per dare risposte nuove e originali alle situazioni (Ausubel).L’obiettivo è dunque quello della comprensione cioè della padronanza di concetti, principi e abilità che consente diaffrontare problemi e situazioni nuove (Gardner).L’apprendimento significativo può realizzarsi per ricezione e per scoperta ma in entrambi i casi deve muoveredall’esperienza dell’alunno, creando le condizioni per la formulazione di problemi e l’attivazione di un processo personaledi ricerca e di costruzione della conoscenza.Per questo l’insegnamento deve tener conto delle diverse intelligenze e dunque della personalizzazione dell’interventoe deve superare l’approccio intellettualistico per diventare tecnica di pianificazione dell’apprendimento dell’allievo.Le condizioni generali perché ciò si realizzi sono generalmente le seguenti:* creare nella classe un clima sociale positivo, fondato sulla conferma, sull’accoglienza e valorizzazione delle diversità* organizzare l’attività didattica in modo flessibile (spazi, tempi, tipologia delle attività, tipologia dei gruppi di alunni)* attuare una reale valutazione formativa* considerare le discipline come forme epistemiche.Quest’ultimo punto merita una attenzione particolare.Di fronte alle sfide della società odierna (globalizzazione dell’economia, diffusione delle tecnologie dell’informazione edella comunicazione, diffusione dei mass-media, confronto-scontro delle diverse culture) il sistema scuola è chiamato nona consegnare saperi, abilità e capacità definitive, ma a sviluppare capacità di orientarsi e di appropriarsi degli elementinecessari per la crescita, per l’impostazione dei problemi, per la scelta dei settori ai quali dedicare un approfondimento,la capacità di coniugare il momento cognitivo teorico con il momento applicativo.Per questo obiettivo le discipline devono essere viste come sistemi di segni, di significati culturalmente e storicamentedeterminati con cui nel corso dei secoli gli uomini hanno rappresentato, elaborato e codificato la propria esperienza.Esse sono forme di conoscenza dell’uomo che si riconducono all’unità della cultura vista come produzione creativadell’uomo che si esprime nelle diverse forme simboliche (Cassirer)L’allievo deve dunque cogliere lo specifico linguaggio, il metodo di indagine, la struttura concettuale di ogni disciplina perleggere in modo culturale la globalità dell’esperienza; nello stesso tempo deve saper cogliere la fecondità delle lorodiverse intersezioni che, muovendo da problemi, rimandando ad un’idea unitaria di cultura.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200364
�����������������������
LO SVILUPPO DEL CERVELLO NELL’INFANZIA E NELL’ADOLESCENZAFrancesco Bottaccioli, Società Internazionale Medicina Avanzata ed Integrate e di Scienze della Salute (SIMAISS)
(tratta con qualche modifica da P. Pancheri, le basi biologiche della psichiatria, in Pancheri-Cassano trattato italiano di psichiatria,II edizione, Masson, Milano, 1999)Nel l° periodo critico, lo stress è centrato sui genitoriNel 2°, è centrato sull’esternoNei due periodi critici il cervello è estremamente sensibile a eventi stressanti e in particolare a traumi
Stress e apprendimento: una relazione a due facce1. Gli ormoni dello stress sono utili per la memorizzazione2. Uno stress prolungato, oppure un trauma, danneggiano i sistemi di memorizzazione e il cervello medesimo
Emozioni e apprendimento
E’ ormai chiaro che non esistono circuiti emozionali e cognitivi rigidamente separati
Amigdala
Memoria implicita, inconscia
Ippocampo\corteccia
Memoria esplicita o dichiarativa
Una serie di studi sperimentali dimostrano che l’attivazione emozionale, mediata dall’amigdala, influenza la formazionedella memoria esplicita
Età Sviluppo cervello Sviluppo emozioni Sviluppo Cognitivo0-3 AnniPeriodo critico
Aumento delle sinapsiAumento della complessitàaspecifica della rete neurale
Sviluppo sistema pulsionaleelementare e programmaattaccamento perdita (madre-bambino)
Alta densità di apprendimentoInizio concettualizzazione del linguaggioDistinzione sé/non sé
3-9 AnniFase distabilizzazione
Prima fase di stabilizzazioneSinapsi costantiRicettori costanti
Il mondo esterno visto con gliocchi degli schemi diattaccamento perdita
Apprendimento sistematico PerfezionamentolinguaggioSviluppo socialitàProgrammazione comportamento a breve termine
9-15 Anni (fino a 18)Periodo critico
Secondo periodo criticoSemplificazione rete neuraleSinapsi e ricettori in diminuzione
Stress da separazione (genitori)Stress da attaccamento(amori)
Comportamenti finalizzati complessiProgrammazione comportamento a lungo termine
>15 Anni (oltre 18)Fase distabilizzazione
Seconda fase di stabilizzazioneSinapsi e ricettori costanti
Schemi di reazione emozionalestabilizzati
Schemi cognitivi stabilizzati
�����������������������
65n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTOSCOLASTICO (spunti per una riflessione)Francesco Bottaccioli, Società Internazionale Medicina Avanzata ed Integrate e di Scienze della Salute (SIMAISS)
1. Le informazione da trasmettere devono essere altamente codificate (con un forte significato semantico)
2. Vanno trasmesse con un elevato contenuto emozionale
3. Vanno costantemente richiamate, nella loro essenzialità, in rapporto alle conoscenze acquisite e da acquisire
Tutti i sistemi, biologici e artificiali, di immagazzinamento delle informazioni hanno bisogno di:
1. Poter essere codificati (encoding)
2. Porte essere immagazzinati (storange)
3. Poter essere accessibili e racuperati (retrieval)
- Il significato semantico si riferisce al primo procedimento di acquisizione delle informazioni, alla codifica. Questorichiede al docente un livello elevato di elaborazione concettuale con una codifica adatta al contesto.
- Fa riferimento al ruolo delle emozioni nella fissazione dei ricordi. Richiede all’insegnante passione per la materiache insegna e forte motivazione del proprio ruolo sociale.
- Fa riferimento al meccanismo di “interferenza proattiva” che non solo non cancella memorie precedenti (comela interferenza retroattiva), ma che anzi le valorizza in una nuova sintesi. Ciò richiede all’insegnante una assolutapadronanza del programma, una forte pianificazione del lavoro, una notevole duttilità nell’andare avanti e indietro.
Costruire un ambiente stimolante (eustress), imparando a gestire lo stress dell’insegnamento.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200366
�����������������������
Polo unito
- L’insegnante è contemporaneamente adulto sapiente-bambino ignaro
- Non si deve perdere il contatto con la propria spontaneità nell' svolgere le lezioni
- Farsi guidare anche da ciò che più interessa
- Risvegliare una sere di sapere (solo se "il bambino-ignaro" affamato di conoscenza vive in lui)
- Si attiva nell'allievo la spinta verso "l'adulto sapiente"
L’incontro tra insegnante e allievo avviene sul filo di una “tensione interna” tra lo stato di adulto sapiente e allievo-bambino-che non sa
E’ importante che si conservi la memoria e la consapevoezza che nel rapporto con lo studente si sta trattando anchecon il proprio “studente interno”
In ogni uomo maturo esiste “un bambino-che non sa” che spinge continuamente verso cose nuove, ma il saperedell’adulto lo rende rigido e inaccessibile alle innovazioni
Si rimane emotivamente vivi se si conserva il potenziale della sperimentazione e dell’ingenua apertura del “bambino-ignaro”
Scissione del polo
- L’adulto-sapiente affronta l’allievo-bambino-ignaro come fosse un nemico
- Si lamenta che gli allievi non sanno nulla, non vogliono studiare, imparare,
- Hanno i nervi lacerati dalla mancanza di controllo degli allievi
- Gli allievi sono “altro” e si tenta di tenerli a bada con voti calcolati con matematica esattezza
- Ci si lamenta che “una volta” gli allievi studiavano più e avevano molto più “voglia”
- Il contatto con l’allievo si allontana e tende ad avvenire sempre più attraverso il potere e la disciplina
- L’insegnate tende a divenire amaro e triste, tutto ciò che è nuovo, fresco, appassionante tende a morire
- Il processo di apprendimento si blocca. L’”adulto-sapiente” non si attiva nell’allievo
MOTIVAZIONE E APPRENDIMENTOSandro Elisei, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Facoltà di Medicina e Chirugia, UniversitàdegliStudi di Perugia
Maslow: teoria dei livelli gerarchici1. bisogni fisiologici (fame, sete, sesso...)2. bisogno di sicurezza (protezioni contro i pericoli, privazioni...)3. bisogni sociali (di appartenenza, di associazione, di comunicazione)4. bisogni di autonomi di indipendenza5. bisogni di realizzazione di sé (successo, sapere, fiducia di sé, espansione personale...)
Concezione interazionista- la motivazione non ha un'origine unicamente esterna, né unicamente interna- nasce dall'incontro tra soggetto e oggetto ed entrambi hanno caratteristiche cheinteragiscono le une con le altre- valenza e forza nascono dall'incontro dell'individuo con il suo ambiente- come i bisogni fondamentali possono realizzarsi nelle strutture dell'ambiente
�����������������������
67n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
UNITA’ OPERATIVE
Regione dell’UmbriaDr. Gonario GUAITINI, DirigenteResponsabile del Servizio IV°Prevenzione e Sanità PubblicaDr.ssa Anna TOSTI, Responsabile dellaSezione Sorveglianza e ProtezioneMalattie infettive e diffusive - EducazioneSanitaria - Medicina del Lavoro
Direzione Scolastica Regionaledr.ssa Carmela LO GIUDICE SERGI,Direttoreprof.ssa Anna Maria DOMINICI, DirettoreEx Provveditorato agli Studi diPerugiaDott.ssa Caterina PIERNERA
Ex Provveditorato agli Studi di TerniDott.ssa Patrizia FIORETTI
Università di Perugia-ConsulenzascientificaC.S.E.S.i.Prof.ssa Maria Antonia Modolo,Professore ordinario di IgieneDr.ssa Paola Beatini, RicercatoreDr.ssa Anna BELTRANO, RicercatoreDr.ssa Benedetta FAZIO , RicercatoreDr.ssa Anna Lisa FERRANTE, Ricercatore
Provincia di PerugiaDr.ssa Maria Pia BRUSCOLOTTI
Assessore alla Pubblica IstruzioneDr. Ilio LIBERATI, Responsabile allaPubblica Istruzione
���������� "������������������� � �� � ������ �� ����� � � ����������� ����
��������������� �������� �� ������
Provincia di TerniDr. Giuseppe CHIANELLA, Assessore allaPubblica IstruzioneDr.ssa Tiziana DE ANGELIS, Coordinatoredel Nucleo Tecnico di AssistenzaPermanente all’Istruzione
Comune di PerugiaDr. Wladimiro BOCCALI, Assessore aiServizi SocialiDr.ssa Floretta SERRANTI, Funzionariodell’Ufficio Progetti Educativi eScolastici
Comune di TerniDr.ssa Alida NARDINI, Assessore allaPubblica Istruzione e alla CulturaDr.ssa Vincenza FARINELLI, Dirigentetecnico Diritto all’Istruzione
Azienda Usl n 2 Regione UmbriaDr. Walter ORLANDI, Direttore GeneraleServizi:Dipartimento PrevenzioneDr. Filippo Maria BAULEO, DirettoreDr.ssa Maria Donata GIAIMO, DirettoreIgiene e sanità pubblica: Dr.ssa OronzinaPENZA , OPT Rolando BOCO
Medicina del lavoroDr. Massimo GIGLI, Dr. Luigi SICILIA
Dipartimento materno infantileDr. Massimo BIANCHI
Staff qualità e promozione dellasaluteDr.ssa Daniela BARZANTI, Responsabile
Educazione SanitariaDipartimento salute mentaleDr. Franco COCCHI
DistrettoDr. Emilio DUCA, Dirigente
Azienda Usl n 4 Regione UmbriaDr. Marco Aurelio LOMBARDELLI,Direttore GeneraleServizi:Unità Operativa Risorse umaneinnovazioni organizzativeDr.ssa Marina BRINCHI, ResponsabileDipartimento PrevenzioneMedicina del lavoro, Dr.ssa LauraSARNANI
DistrettoDr. Giancarlo MARCHIONNA, Dirigente
Azienda Usl n.1 Massa CarraraServizio Unità Operativa di EducazioneSanitaria- Comunicazione InformazioneDr. Antonio DE ANGELI, Dr.ssaMaddalena FREDDI, Carlota JaneCOZZUPOLI
Per la Direzione regionale Scolasticadella ToscanaDr.ssa Tiziana RICCOBALDI, DirettriceDidattica del 1° Circolo di Carrara eComponente della Rete delle Scuole chePromuovono Salute di Massa-Carrara
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200368
�����������������������
�� ��������� � ����� �������� ����������� ����� � ������������������ ��� ���
������ ��� ������ � ������a cura di Gonario Guaitini e Anna Tosti
Uno degli obiettivi del progetto era col-legato all'esigenza di costruire un Siste-ma organico e permanente di appog-gio alla Scuola attraverso il coinvol-gimento delle istituzioni - Regione (As-sessorato ai Servizi Sanitari, Assessora-to alla Formazione), Enti Locali (Comu-ni e Province), Direzione ScolasticaRegionale (Ministero dell'Istruzione,della Università e della Ricerca), Azien-de Sanitarie (centri salute, centri salutementale, dipartimenti di prevenzione, di-partimento materno infantile, distretti)che operano e impegnano risorse - uma-ne e finanziarie - in ambito scolastico perla promozione della salute.
L’obiettivo era quello di superare unaprogettualità e un’operatività frammen-taria e discontinua e di raccordare e otti-mizzare il lavoro che tali soggetti svolgo-no con le scuole.Si intendeva facilitare la formazione diun collegamento stabile in grado di ana-lizzare e valutare le reali esigenze intermini di salute-benessere del sistemaeducativo, garantisse un quadro strate-gico e allargato per la programmazionee realizzazione delle politiche in materiadi salute della comunità scolastica, evi-tasse la sovrapposizione degli interventi.
Le unità operative individuate per ilraggiungimento di tale obiettivo (obietti-vo Istituzioni della Ricerca) - funzionarie tecnici di Regioni, Province, Comuni,(Ex) Provveditorati agli Studi, Aziende
USL insieme al Comitato di consulenzascientifica dell’Università di Perugia -hanno lavorato nel corso di incontri pro-mossi dall’Assessorato alla Sanità dellaRegione Umbria per verificare e ottene-re dapprima l’impegno istituzionale,quindi per l’individuazione di nuove mo-dalità collaborative di supporto al pro-cesso di promozione della salute in am-biente scolastico.
Un ruolo più forte voleva essere attribu-ito agli Enti Locali, nella promozionedella salute con il supporto tecnico dellecompetenze delle Aziende SanitarieLocali, sotto la guida, ovviamente delGoverno Regionale nell’indicare priori-tà, assicurare competenze tecniche disupporto e garantire un’adeguata uni-formità di applicazione sul territorio.Per gli Enti Locali è stato complessoindividuare le modalità di intercon-nessione fra le azioni di competenza deivari assessorati e, quindi, le risorse im-pegnate, a riprova della settorialità checaratterizza a volte tali ambiti di inter-vento, ricollegabile alla complessità del-la programmazione inquadrabile nel-l’area della promozione della salute checoinvolge di fatto diversi settori degliEnti Locali stessi (istruzione/cultura,sanità/servizi sociali, ovviamente, maanche trasporti, ambiente, edilizia, lavo-ro…).Anche per i funzionari e gli operatori deiservizi sanitari le difficoltà dell’adesione
al lavoro di ricerca sono ricollegabili allaindividuazione dei dipartimenti da impe-gnare, poiché non sono consolidati servi-zi dedicati alla scuola, se si escludonoquelli di educazione sanitaria o quelli diprevenzione, questi ultimi sovente limi-tatamente alla applicazione della leggesulla sicurezza.In relazione agli Enti Locali, i soggettiindividuati dalle rispettive amministra-zioni (comunali e provinciali) quali Re-sponsabili del gruppo di lavoro, confer-mando l’esigenza di una programmazio-ne di un’operatività stabile e congiunta,hanno proceduto all’esame della norma-tiva e sottolineato, in particolare, alcunidettati legislativi, quali punti di riferi-mento rilevanti per lo sviluppo di politi-che favorevoli allo sviluppo di un rappor-to organico interistituzionale permanenteche permettesse il raccordo delle speci-fiche competenze di Enti e Istituzioni(D.L. 112/98, art. 138-139 "Competen-za piena della provincia per le scuole diistruzione secondaria superiore per quan-to concerne l’edilizia scolastica dal 1settembre 2002 azioni" - D.L. 233/98"Piano di dimensionamento delle Istitu-zioni scolastiche per tutti gli ordini dellescuole" - Legge Regionale 77 sul dirittoallo studio - D.L. 285/97 - Legge 328/98).Nel corso degli incontri succedutisi conritmo regolare, coordinati dal Responsa-bile dell’Assessorato ai Servizi Socio-
�����������������������
69n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
sanitari (Servizio prevenzione e sanitàpubblica) della Regione Umbria, i Re-sponsabili delle Unità di Ricerca hannopresentato e discusso le esperienze at-tuate nei territori interessati, in termini dicooperazioni tra le Istituzioni coinvolte.Si evidenziavano tra gli elementi favo-renti un sistema interistituzionale: lanormativa vigente quale contatto realetra i vari Enti, i bisogni formativi territo-riali individuati dai Piani di Zona, la ne-cessità di integrazione delle diverse pro-fessionalità, l’avviato consolidamentodella politica di Rete nelle aree prese inconsiderazione della ricerca (Rete isti-tuzionale, Rete informale).Come elementi ostacolanti i tempi diprogettazione e di utilizzo delle risorseeconomiche (la scuola programma dasettembre, Enti e Azienda da gennaio),lamobilità del personale (della scuola inparticolare e degli Enti), l’input politicodelle Amministrazioni, la stessa autono-mia scolastica.
Il risultato: un documento perla promozione della salutenell’età evolutiva
Il risultato dei lavori di ricerca è statosintetizzato dai componenti di questaUnità operativa in un documento, pre-sentato nel corso del Seminario regio-nale conclusivo della Ricerca, di cuipresentiamo per intero il testo.
Tutti i soggetti istituzionali aderenti alla Ricerca, Province diPerugia e di Terni, Comuni di Perugia e di Terni, Azienden.2 di Perugia e USL n.4 di Terni, n. 1 di Massa Carrara,Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, hanno concordatosulla necessità di dare un nuovo impulso a tutto quanto fin quirealizzato, sulla spinta dell’appello alla Promozione della Salutenella Scuola, lanciato negli anni ottanta dall’OMS.Tutti hanno concordato che, sia nel settore sanitario che in quellosocio-educativo, formativo e culturale, si sono attivati moltissimiprogetti, i quali, tuttavia, sembrano procedere separatamente,senza la definizione di obbiettivi formativi comuni, e, soprattutto,senza una concreta integrazione. Il livello di integrazione è differen-ziato a seconda delle diverse realtà locali, ma anche laddove è piùconsolidato, esso si concretizza di più nell’operatività che non nellaimpostazione metodologica o nella condivisione istituzionale. Inol-tre a rafforzare, va evidenziato che gli assetti organizzativi egestionali dei diversi sistemi si sono modificati (D. L. 112/98, DPR275/99, DPR 347/2000, Piano Sanitario Regionale 98/2001) equindi i precedenti accordi interistituzionali quali strumenti di pro-grammazione integrata devono necessariamente essere rivisti eintegrati. Partecipando e accettando il Piano della Ricerca, hannoconcordato di individuare un sistema che, in base alle aperturelegislative di decentramento, consenta:a) di realizzare un servizio organico e coordinato di appoggio alla
comunità scolastica (insegnanti, studenti, famiglie) allo scopo dioffrire un osservatorio dei fattori favorenti o ostacolanti lafunzione promotrice di salute del sistema scolastico e dellepolitiche territoriali;
b) di offrire supporti per appoggiare un processo organico dievoluzione nei contenuti, metodi e strutture della scuola, in modo
������ ���������� �� ��������������� �������� �
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200370
�����������������������
da favorire salute e benessere;c) di definire obbiettivi di riferimento anche per i progetti offerti in
vario modo alla scuola, nel superamento della frammentarietà eoccasionalità dei progetti stessi, in modo da consentire unavalutazione del contributo da essi dato al processo educativo,costruendo un processo nel quale anche i singoli progetti attivatipossano trovare la giusta collocazione programmatica,metodologica e di risorse.
Quanto previsto dal Piano di Ricerca per la sperimentazione nellaScuola e quanto previsto per la definizione dei contributi tecnici daparte degli operatori delle Aziende USL e degli Enti Locali, hainiziato un percorso che può consentire di dare continuità a taleprogetto.Durante questa prima fase di sperimentazione del Progetto, comeEnti Locali e Soggetti Istituzionali che comunque destinano risorsealla Scuola, abbiamo lavorato nell’intento di costruire un sistemadi supporto gestito in comune che possa costituire un punto diriferimento certo per raggiungere gli obbiettivi previsti in rapportoalla strategia Scuola promotrice di salute, a favore dell’ampia fasciadi cittadini dell’età evolutiva che la frequentano, delle famiglie edegli insegnanti.L’attività di ricerca si è avviata su un percorso di confronto e diconoscenza delle iniziative e delle modalità di realizzazione dellestesse rispetto alla Promozione della Salute. Da tale confronto èemerso che le tre realtà territoriali, pur diversificandosinell’operatività messa in campo fino ad ora, condividono la neces-sità e l’opportunità di contestualizzare un sistema che sia funzionalealla:- condivisione di un metodo- realizzazione di un progetto con garanzia di continuità.
Documento/propostaprodotto da responsabili dell'Obiettivo "Istituzioni"
Il Gruppo dei Rappresentati delle Istituzioni coinvolte ha inoltreredatto un documento che conteneva alcuni elementi a supportodella redazione del Piano Sanitario Regionale 2003/2005.Innanzitutto è stato sottolineato il ruolo della famiglia e della scuolaquali reti di sostegno delle attività di promozione della salute per l'etàevolutiva; quindi, definiti i problemi e gli obiettivi dis alute daraggiungere, vengono affrontati i possibili assetti organizzativi e lefunzioni che Scuola, Aziende Sanitarie, Province e Comuni dovreb-bero svolgere in rete fra loro.
A) CORNICE
1. La base conoscitiva che si riferisce al presente progetto èimpostata su basi innovative rispetto all’attenzione prestata alproblema nei Piani precedenti ed è centrata sulla strategiaPromozione della Salute. La prima riflessione, importante,anche se ovvia, riguarda il fatto che la salute di una popolazionesi imposta lungo il corso dell’età evolutiva, dal concepimento
�����������������������
71n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
all’infanzia, all’adolescenza, fino all’età di diciotto anni, ed è inquesto lungo periodo che si strutturano anche gli stili di vita rilevanti.
2. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, indicando ai paesi lastrategia Promozione della Salute, ha richiamato l’attenzione sulprincipio che problemi di popolazione vanno affrontati con interven-ti allargati e promozionali, oltre che preventivi e curativi, soprattuttolungo l’arco della formazione dell’individuo.
3. Le grandi e veloci trasformazioni sociali, della comunicazione, dellaeconomia, dei costumi, occorse negli ultimi decenni, hanno resodifficile per la comunità e le sue reti affrontare compiutamente iproblemi sanitari e sociali dei giovani e soprattutto degli adolescenti.
4. Contemporaneamente, i servizi sanitari e sociali destinati a questafascia di popolazione, non hanno subito la stessa evoluzione. Ingenerale sono stati orientati verso interventi emendativi a posteriori,mentre la prospettiva promozionale richiede programmazione,sistematicità, integrazione, continuità, capillarità, individuazione diobbiettivi positivi di salute e indicatori di impatto sulla salute degliinterventi, monitoraggio e valutazione dell’esperienza.
5. Al contempo la famiglia e la scuola, le due reti sociali piùimportanti per l’età evolutiva, soffrono di questa situazione. Si trattadi due reti che costruiscono dalla base la comunità e nelle quali lastrategia Promozione della Salute si colloca per i suoi obbiettiviprimari.
6. La famiglia è la prima rete. La famiglia attuale unicellulare,costituita in genere da due genitori e uno o due figli, e, a volte, ancheda un solo genitore, non usufruisce più, soprattutto nelle zoneurbane, del sostegno, della guida, dell’esperienza della famigliaallargata. Le basi della salute e degli stili di vita si costruisconoproprio nella famiglia e nei primi anni: le abitudini alimentari el’attività fisica, l’abitudine al fumo e quella del ricorso ai farmaci peralleviare l’ansia o l’insonnia. Per non parlare della salute mentalee dello sviluppo dell’apprendimento. La famiglia ha diritto ad unaguida da parte del sistema dei servizi, i quali oggi possono attingerea una straordinaria mole di conoscenze, che per la famiglia restanoconoscenze non usabili e non usate. Tali diritti sono sanciti a livellodella normativa nazionale vigente (legge 285/97 e legge 833/2000del nuovo Piano Sociale) che richiama ad una progettualità integra-ta che vede il SISTEMA FAMIGLIA come centrale e confermal’obiettivo della promozione della salute.
7. L’altra rete che coinvolge tutti i soggetti in età evolutiva, per anni,per molti giorni all’anno e molte ore, è la scuola, la quale puòvantare un bagaglio di conoscenze in più e di esperienza collettiva,ma che, comunque, deve oggi affrontare problemi di non piccolaentità. Si evidenzia anche per questa la necessità di un supportoorganico, strutturato, programmato, non lasciato alla improvvisazionedell’offerta del mercato, o alla attività operativa per l’emergenza,con le numerose campagne che le vengono proposte. La Scuola èin primo luogo un ambiente di lavoro, il lavoro scolastico che puòessere promotore di salute, ma anche fonte di malessere edesclusione. E’ necessario innanzitutto occuparsi di questo aspetto,come è chiaramente indicato nelle raccomandazioni dell’O.M.S.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200372
�����������������������
rispetto alla “Scuola promotrice di salute”.8. Le due reti richiedono una attenzione più puntuale da parte dei
servizi sanitari e sociali, per cui è necessario attivare in modo piùorganico un sistema di servizi a rete, utilizzando meglio quelliesistenti, con le risorse economiche e di personale già operanti, eattivandone o riattivandone altri.
B) PROBLEMI DI SALUTE
1. Conoscenze epidemiologiche. E’ necessario sviluppare: la baseconoscitiva relativa alla salute dei soggetti in generale e dei soggettiin riferimento al lavoro scolastico: la salute dei bambini e dei ragazzi,la salute degli insegnanti. Per programmare azioni di promozionedella salute è necessario avere dati su indicatori di salute concretie in tempo reale.
2. Conoscenze rispetto al lavoro scolastico. E’ necessario sviluppare:indicatori positivi di salute, ma anche indicatori di rischio rispetto allaemarginazione ed esclusione, alla fatica e ad altri parametri legatialla vita dentro e fuori la scuola (pendolarità, lavoro, ecc.).
3. E’ necessario sviluppare sistemi di supporto, anche informativo-educativi, alle famiglie e alla scuola.
C) OBBIETTIVI DI SALUTE
1. Aumentare l’attenzione allo stile di vita generale dei ragazzi, anchecon la collaborazione delle famiglie e della comunità, con partico-lare enfasi per gli adolescenti.
2. Favorire la conoscenza di sé e delle proprie capacità e aiutare asvilupparle per evitare il rischio della mancanza di autostima,sovente alla radice di problemi di devianza di vario genere.
3. Aumentare i livelli di soddisfazione tra gli allievi/studenti e i docenti,secondo le raccomandazioni dell’O.M.S., includendo anche lefamiglie.
4. Ridurre le condizioni di abbandono scolastico e delle situazioni chelo favoriscono, tra le quali è da includere anche la fatica e lo stressnegativo e le condizioni negative legate all’apprendimento.
5. Inserire le azioni settoriali di educazione alla salute nel quadro piùgenerale dello sviluppo della promozione della salute nel lavoroscolastico.
6. Favorire la formazione in servizio degli insegnanti relativamentealla conoscenza dei problemi di salute del lavoro scolastico, allaconoscenza dei discenti e alle modalità di sviluppo della scuolacome ambiente favorevole.
D) ASSETTI ORGANIZZATIVI
1. La rete delle scuole e delle famiglie richiede un sistema di servizianch’essi in rete. Riorientare i servizi nello spirito della strategiadella Promozione della Salute O.M.S., che non si limitino alla azioneverso i rischi, ma si amplino nel contribuire alla implementazione dicondizioni favorevoli, che in questa fascia di età costituiscono la viapiù efficace anche per prevenire gli stessi rischi.
2. Strutturazione di un settore dell’osservatorio epidemiologico sullasalute dell’età evolutiva, con particolare attenzione al lavoro scola-stico. Indagini campionarie su aspetti particolari. Individuazione di
�����������������������
73n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
eventi sentinella.3. Per la realizzazione degli obiettivi
sopra esposti si sollecita l’istituzionedi una Conferenza Regionale di Ser-vizio che veda integrati i Sistemi del-l’istruzione, del sociale e del sanitarioattraverso la quale si individuano:- linee di indirizzo per la progettazionedi iniziative di promozione alla saluterealizzate;- supporti organizzativi anche attra-verso risorse economiche che per-mettano la concreta attuazione delprogetto.
Il lavoro della Conferenza di Serviziodovrà essere supportato da un gruppo dilavoro tecnico che predisponga tutti gliatti e le proposte che verranno discussida questo organismo.
E) FUNZIONI
La rete dei servizi è assicurata da una
struttura che deriva dall’insieme dellefunzioni attualmente già espletate per lescuole da parte dei Comuni, delle Azien-de Sanitarie Locali, delle dirigenze sco-lastiche. Si rende necessario, anche at-traverso Piani Sanitari di Zona, riorga-nizzare in modo organico le risorse giàistituzionalmente impegnate da provincee comuni, aziende sanitarie, autorità sco-lastiche, disegnando un sistema conobbiettivi formulati con un approccioolistico, che serva a rispondere alle esi-genze di sostegno tecnico-scientifico-sociale dei docenti.1. Le aziende sanitarie inseriscono nel
sistema le funzioni di un certo numerodi servizi, epidemiologia, materno-in-fantile, educazione alla salute, am-biente di vita e di lavoro, assistentisanitarie (da ristrutturare), rete deipediatri di base e dei medici di medi-cina generale.
2. La scuola inserisce nel sistema lafunzione di supporto e consulenzapermanente pedagogica con gliobbiettivi legati al lavoro scolastico,attraverso istituti già esistenti o attra-verso collegamenti con l’università(già esistenti in alcuni casi vedi Scuolaspecializzazione della facoltà di Scien-ze della Formazione, o IRRAE).
3. Le province e i comuni inseriscono lefunzioni espletate rispetto all’edilizia,alle strutture per l’attività fisica, aisupporti per ampliare l’offertaformativa della scuola.
IL Piano Sanitario Regionaledell'Umbria 2003-2005:un piano integrato per unascuola produttrice di salute
La Regione Umbria ha rivolto grandeattenzione nella stesura del Piano Sani-
FattoriCondizioni
ContestiResponsabilità
Metodologia Strumenti Calendario attivitàtriennale
Ambiente Comuni,Province,Regione (SSR,ARPA,Uff. urbanistici, etc.)
Patto per unambiente sanoPatto per “Cittàsane in Umbria ”
Piano Integrato perambiente e città sane
I - stipula patto- approvazione Piano- attiv. OsservatorioII - monitoraggio esupportoIII - valutazione
Età evolutiva Scuola, Comune,
Associazioni (es. famiglie)
Patto per la salutenella scuola
Piano Integrato per una scuolaproduttrice di salute
(come sopra)
Lavoro-disoccupazione
Regione,SindacatiConfederali Ass.Imprenditori
Patto per la salutenei luoghi di lavoro
Piano integrato per la salutenelle attività produttive
(come sopra)
Anziani Regione,Comuni,Sindacati Confederalipensionati ed altri
Patto per la salutedegli anziani
Piano integrato per lasalute degli anziani
(come sopra)
Integrazionesociale
Regione,comuni,province Scuola,associazionismo
Patto perl ’integrazionesociale
Piano integrato per la Salutementale e le dipendenze (es.)
(come sopra)
Alimentazione
Sicurezzastradale
Regione,associazioniimprenditori,Associazioniconsumatori
Regione, SSR,Province, Comuni.Prefettura, ISTAT,Forze dell’Ordine,Scuola, ANAS, INAIL,Autoscuole, As. Vittimedella strada, IstitutiAssicurativi
Patto per unaalimentazione sana
Patto per lasicurezza stradale
Piano integrato per la salutealimentare
Piano integrato per la sicurezzastradale e per la salute degliutenti delle strade
(come sopra)
(come sopra)
��������� ��� �� ��� �������� ��� ��������� �� ����������� ������ ������� ���� ��� ����������� ������ ������
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200374
�����������������������
tario Regionale 2003-2005 "Un patto perla salute, innovazione e la sostenibilità"(approvato con Deliberazione del Con-siglio Regionale dell’Umbria del 23 lu-glio 2003) alla strategia "promozionedella salute" dell’O.M.S.Le indicazioni dell’Organizzazione sonoassunte dal Piano - capitolo 5 “Patti epiani integrati per il governo della salu-te”- come sintesi delle evidenze scienti-fiche disponibili sulle politiche che pro-ducono salute e base di partenza persviluppare politiche di promozione dellasalute sostenibili.Anche l’esigenza di adottare politicheintegrate è accolta dal PSR, che “sicolloca inoltre nella prospettiva dellaconcertazione, in materia di program-mazione partecipata, assumendo le indi-cazioni di politica sanitaria dell’OMS inmateria di promozione della salute e
inserendo in tale ambito strategico diattività le indicazioni provenienti dallaletteratura internazionale in materia dicapitale sociale”.Un forte impegno viene ribadito nei con-fronti dell’Età evolutiva (paragrafo 5.1)individuata quale condizione e fattore dipriorità per l'azione in quanto fase dellavita "in cui si accumulano/dissipanopotenzialità per un positivo sviluppo dellavita".La Scuola (in una nota del PSR è espli-citamente citata, la Ricerca finanziatadal Ministero della salute, RegioneUmbria con la consulenza scientifica delCSESi) viene considerata luogo di ele-zione di intervento attraverso politicheconcertative, anche sulla base dellamaturità del contesto applicativo.A corollario di ciò il Piano SanitarioRegionale inserisce l'Età evolutiva tra i
contesti socialmente definiti rilevanticui possono corrispondere titolarità ri-spetto ai fattori e alla condizioni indivi-duate la Regione (Giunta e/o assessora-ti), le province ed i comuni e le rispet-tive strutture amministrative e/o opera-tive e la Scuola, intesa come Direzioneregionale e singole autorità scolastiche.Propone anche in tale contesto lasperimentazione di una metodologia dilavoro centrata sulla concertazione diPatti per la salute promossi dalla Giuntaregionale (paragrafo 5.3) che preveda-no: obiettivi definiti; responsabilità pre-cise assegnate a ciascun contraente;risorse da impegnare valorizzando an-che il capitale sociale e le risorse giàattivate negli interventi posti in essere(vedi tabella).
�����������������������
75n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
UNITA’ OPERATIVE
Azienda Usl n 2 Regione UmbriaDr. Walter Orlandi, Direttore GeneraleServizi:Dipartimento PrevenzioneDr. Filippo Maria BAULEO
Dr.ssa Maria Donata GIAIMO
Igiene e sanità pubblicaDr.ssa Oronzina PENZA
OTP Rolando BOCO
Medicina del lavoroDr. Massimo GIGLI, Dr. Luigi SICILIA
Dipartimento materno infantileDr. Massimo BIANCHI
Staff qualità e promozione dellasaluteDr.ssa Daniela BARZANTI
Dipartimento salute mentaleDr. Franco COCCHI
DistrettoDr. Emilio Duca
Azienda Usl n 4 Regione UmbriaDr. Marco Aurelio LOMBARDELLI,Direttore GeneraleServizi:Unità Operativa Risorse umaneinnovazioni organizzativeDr.ssa Marina BRINCHI
Dipartimento PrevenzioneDr.ssa Laura SARNANI
DistrettoDr. Giancarlo MARCHIONNA
���������� �������� � ���� � ��� ��� � ������!� ��� �� �������� � � ��!���� �� � ����� ��
�� ��������� �� �� �� ����� �� ����� � �� ����� ��� ������
Azienda Usl n.1 Regione ToscanaMassa e CarraraServizio Unità Operativa di EducazioneSanitaria- Comunicazione InformazioneDr. Antonio DE ANGELI
Dr.ssa Maddalena FREDDI
Dott.ssa Carlota Jane COZZUPOLI
Università di Perugia - ConsulenzascientificaDipartimento Igiene e sanitàPubblicaDr. Anna Beltrano, Dottore di ricercaProf. Paola Rivosecchi, ProfessoreAssociato di IgieneDr. Rino Vitali, Coordinatore r.s.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200376
�����������������������
GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
- Individuare indicatori e strumentiper il monitoraggio delle condizionidelle strutture e dell’organizzazionescolastica e di salute del gruppotarget.- Individuare nuove strategieoperative per i servizi sanitaribasate su una visione olistica disalute che possano essere disupporto alla Scuola
La ricerca
Il concetto olistico di salute, le indicazionidella carta di Ottawa, le basi concettualidella scuola promotrice di salute e lacentralità dello studente che apprende,sono stati i riferimenti teorici sui quali èstato costruito il progetto di ricerca.Per poter identificare in modo correttogli obiettivi da raggiungere e per poterdelineare l’intera azione da mettere incampo è stato necessario, nelle fasiiniziali della ricerca, definire quali fosserole “componenti essenziali” che delineanouna scuola capace di promuovere saluteper i propri allievi.Questo primo momento di studio haportato alla definizione delle macroareeche sono state utilizzate successivamentecome schema di riferimento sia per losviluppo dell’intera azione: l’ambientefisico, l’ambiente relazionale, l’organiz-
zazione della scuola, i programmi e lemetodologie di insegnamento, i rapportitra la comunità scolastica e l’ambienteesterno (territorio, comunità, famiglia).L’individuazione dei punti di forza e didebolezza nelle attuali organizzazioni siadella Istituzione Scuola che delle altreIstituzioni coinvolte, ha permesso, tral’altro, di definire il cosa, il come e ilquanto fosse in essere in favore delgruppo target.L’esplorazione approfondita dellemacroaree ha permesso di definire unprimo set di indicatori, a cui è statonecessario far precedere la definizionedel profilo di salute dei giovani in etàscolare, centrando lo studio princi-palmente sul lavoro scolastico.Strumento idoneo a questo scopo è statoritenuto dal gruppo di ricerca, unquestionario messo a punto dall’Or-ganizzazione Mondiale della Sanità(OMS), di semplice esecuzione e giàvalidato in più paesi, in grado di rilevarei determinanti della salute degliadolescenti.La verifica delle condizioni delle strutturescolastiche è stata effettuata con unascheda di rilevazione messa a punto adhoc dal gruppo di ricerca.All’inizio dell’anno scolastico 2000/2001,nel I modulo didattico, appositamentestrutturato (illustrato in altra parte) dedi-cato all’accoglienza e denominato nellaricerca “Appartenenza”, sono stati som-
ministrati agli allievi delle classi coinvolte:- una scheda per la rilevazione dei fattori
positivi e negativi della pregressaesperienza scolastica
- una scheda per la rilevazione dei datiambientali (strutture scolastiche)
- il questionario OMS per la raccolta deidati per la definizione del profilo disalute
I dati raccolti sono stati elaborati e irisultati hanno offerto indicazioniindispensabili per definire gli effettivibisogni di questa popolazione.L’analisi della letteratura italiana e inter-nazionale, con particolare riferimento aesperienze di attività di promozione dellasalute nella scuola già effettuate in altriPaesi, nonché lo studio dei dati raccolticon gli strumenti prima descritti, hapermesso di individuare una prima listadi indicatori per una scuola promotrice disalute.Questo primo set di indicatori dopo alcu-ni incontri di discussione con gli operatoridei Servizi sanitari e dopo opportunacondivisione con i docenti dei consigli diclasse coinvolti, è stato ridotto numerica-mente e rivisto in alcuni punti.La lista degli indicatori, elaborata secondola procedura sopra descritta, è stata sot-toposta a una prima applicazione sulcampo con il duplice obiettivo di veri-ficarne da una parte l’applicabilità edall’altra per avere una prima immaginedella situazione attuale.
� ���� ������ � ��� ������ ��� ������� ������� ��������� ��� ��������
a cura di Anna Beltrano
�����������������������
77n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Macroarea “Curriculuminsegnamento apprendimento”I gruppo di indicatori
La formazione degli insegnantiIl significato e le basi concettualiLa conoscenza da parte dei docenti dellecaratteristiche psico-fisiche dell’etàadolescenziale permette di organizzarela propria metodologia di insegnamentofavorendo lo spostamento dell’obiettivodidattico dalla disciplina all’allievo. In talsenso la conoscenza dei diversi modi diapprendere, di alcuni meccanismi dellarelazione mente-corpo-sistemi endocrini,favorisce la lettura di alcuni compor-tamenti e atteggiamenti degli allievi neiconfronti della scuola e permette la messain opera di fattori in grado di influenzarepositivamente le relazioni e il profittoscolastico.Modalità di rilevazioneI primi due indicatori sono stati rilevatiattraverso intervista ai dirigenti scolasti-ci. L’organo interno all’istituto che ha incarico la formazione degli insegnanti è ilcollegio dei docenti, formato da un rap-presentante per ogni disciplina. All’ini-zio dell’anno scolastico quest’organoraccoglie le richieste dei docenti sugliargomenti da trattare, le esamina e sullabase del numero delle richieste di parte-cipazione e della disponibilità economicadell’istituto, fa richiesta di attivazione delcorso alla dirigenza. La formazione è
effettuata da Enti privati o pubblici inrelazione all’offerta che proviene daagenzie di formazione, non esistono spe-cifici accordi con il SSN per questoaspetto. In relazione a quanto evidenziatonel corso dello studio la formazione degliinsegnanti dovrebbe essere effettuataoltre che sulla base di nuovi bisognirilevati dal corpo docente, su indicazioniprovenienti dalla rilevazione del profilodi salute della comunità scolastica.Metodo didatticoIl significato e le basi concettualiNumerosi studi sono stati condotti percapire come l’efficacia dell’insegnamen-to possa influenzare il benessere pre-sente e futuro dei ragazzi.Concettualmente il benessere (globale)degli studenti all’interno della scuolaappare connesso alla qualità dell’inse-gnamento. Gli studenti che sono soddi-sfatti della loro scuola sono generalmen-te più motivati a seguire le regole scola-stiche e quindi a dare il meglio nel loroimpegno scolastico. Pertanto la promo-zione della soddisfazione degli allievipotrebbe essere un duplice veicolo peruna buona performance scolastica e perla salute. I molti studi sull’efficacia dellascuola hanno dimostrato che l’apprendi-mento migliora moltissimo quando glistudenti hanno una visione positiva dellascuola e del loro ruolo all’interno di essa.La diversità degli allievi, nelle reazionipersonali di adattamento alle situazioninuove e negli stili di apprendimento (ledifferenze individuali che intervengononei processi di apprendimento), con leloro conseguenze sul rendimento scola-stico, sono spesso oggetto di inter-pretazioni differenti da parte dei docentie degli psicologi. L’allievo che presentaun evidente disagio emotivo o reazionicomportamentali non conformi alla co-siddetta normalità sono interpretati dagliinsegnanti come conseguenza di unascarsa motivazione, scarso impegno,cattiva volontà, scarse basi culturali do-vute alla scuola dell’obbligo. Gli psicolo-gi dal canto loro ritengono queste mani-festazioni esempi di un mancato
adeguamento delle metodologie didatti-che alle esigenze della personalità adole-scenziale, ovvero una sorta d’incompa-tibilità tra stile d’insegnamento e stiled’apprendimento.Modalità di rilevazioneGli indicatori sono stati individuati, con-divisi e selezionati dai ricercatori insie-me agli insegnanti nel Corso di for-mazione “Scuola promotrice di salute.Dal lavoro di gruppo al gruppo di lavoro”e nei successivi incontri. Per la valuta-zione dell’azione didattica è stata co-struita una scheda con 10 quesiti misura-ti con una scala Likert a 5 punti compresitra moltissimo e niente affatto.La scelta dei quesiti era finalizzata arilevare alcuni elementi del processo diinsegnamento centrato sullo studenteche apprende e in particolare, si inten-devano individuare indicatori relativi ametodologie di insegnamento/ap-prendimento attive, motivazione, par-tecipazione dello studente e valuta-zione dell’azione formativa.Uno strumento ulteriore di valutazioneanche se settoriale è stato il “diario dibordo” elaborato da allievi ed insegnanticome momento di riflessione personale.In generale è stato evidenziato un impe-gno da parte dei docenti nell’utilizzaremetodologie didattiche più orientate allapartecipazione attiva dell’allievo, anchese i risultati migliori sono stati ottenutinelle scuole professionali piuttosto chenei licei che risentono di un’impostazionepiù ”tradizionale” (scarsa abitudine allavoro di gruppo - durata delle spiegazio-ni superiore ai 20/30 minuti).
Macroarea ambiente socialeII gruppo indicatori
Autostima e appartenenzaIl significato e le basi concettualiL’esperienza scolastica degli studenti inun periodo cruciale per la loro vita, in-fluenza lo sviluppo della loro autostima epiù in generale i comportamenti di salu-te. La scuola, pertanto, può essere allostesso tempo fattore di rischio e risorsa
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200378
�����������������������
La lista di indicatori
Componente della scuolapromotrice di salute
Area d'interesse perlo sviluppo
dell'indicatore
Variabile diriferimento
Indicatore
Formazione degliinsegnanti
(primadell’ingresso nella
scuola)
L'insegnante ha frequentato corsispecifici sui seguenti aspetti : -
aspetti psicofisici dell'etàadolescenziale - i diversi modi di
apprendereGli insegnanti hannoun adeguato supportoper il loro sviluppo
professionaleFormazione degli
insegnanti(aggiornamento in
servizio)
La formazione in servizioprevede la trattazione degliaspetti relativi al primoindicatore se non trattati in altreoccasioni.
La lezione è basata su metodologieinterattive
La lezione frontale non eccede i 20min
Gli allievi in gruppo organizzano inmappe concettuali quanto appreso ecostruiscono la documentazione del
lavoro svolto
All’inizio dell’anno è definito il pianodi lavoro per ogni disciplina ed èportato a conoscenza degli allievi
Curriculum,insegnamento,apprendimento Il curriculum è
supportato dametodologie
d'insegnamentocentrate sullo
studente che sono ingrado di sviluppare la
capacità critica edecisionaledell'allievo
Metodo didattico
Gli obiettivi da raggiungere in ognidisciplina sono stati condivisi con gli
allievi all’inizio dell’annoLo studente è incoraggiato ad
esprimere la propria opinione inclasse(domanda 37 del questionario
OMS)Autostima
Buone relazioni scolastiche (domanda38 del questionario OMS)
Partecipazione alla definizione delleregole della scuola (domanda 36 del
questionario OMS)
Ambiente socialeLa scuola promuovel'autostima e il senso
di appartenenza
Senso diappartenenza
Individuazione e socializzazione daparte della scuola, di modalità per
esprimere soddisfazione e proporremodifiche
Strutturazione del programmascolastico in relazione ai ritmifisiologici dell'apprendimento
Previsione di una congrua pausadurante la mattina per attenuare la
fatica
Sono stati individuatigli aspetti relativi allavoro scolastico chefavoriscono la salutee il benessere degli
allievi
Igiene del lavoroscolastico
Individuazione di un luogo idoneo perla ricreazione
Organizzazionescolastica
Offerta del serviziomensa in presenza diattività pomeridiane
Nutrizione Presenza di mensa scolastica
segue
�����������������������
79n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Componente della scuolapromotrice di salute
Area d'interesse perlo sviluppo
dell'indicatore
Variabile diriferimento
Indicatore
Buone condizioni igienico sanitariedelle strutture scolastiche
Ambiente fisico
Sono state pianificateattività ed interventiper il miglioramento
igienicoorganizzativo e dellasicurezza degli edifici
scolastici
Sicurezza esalubrità degli
edificiPresenza piano di autocontrollo nella
mensa
Offerta servizi perla salute, indaginiepidemiologichemirate al lavoro
scolastico(autostima,stress……)
Presenza di specifici accordi tra scuolae SSN e individuazione di modalità diinformazione per gli allievi e famiglie
Formazione esupporto al
personale docente
Presenza di specifici accordi traIstituzioni per la formazione del
personale scolastico
Cooperazioni
Sono stati definitiprotocolli di
cooperazione tra leIstituzioni
Risorse Messa in comune di risorse (umane emateriali) specificamente destinate allascuola, attraverso la stesura di accordi
tra gli enti
per la salute degli studenti. Alcuni studihanno messo in evidenza ad esempiocome gli studenti che non amano lascuola tendono più precocemente a fu-mare e bere rispetto agli altri compagni,oltre che ad avere una qualità di vita piùbassa e più problemi di salute. Crescen-te attenzione è stata data infine all’im-patto che il clima scolastico all’interno
della classe e la qualità della relazionecon gli insegnanti hanno sul profitto sco-lastico. La scuola, che si configura comela sfida cognitiva e motivazionale piùimpegnativa per i giovani durante la fasedi crescita, è anche un luogo dove si creauna competizione interpersonale, chepuò condizionare, in relazione alle pro-prie possibilità di successo, anche l’im-
magine di sé e l’autostima. Questi stessifattori d’altro canto, sono influenzatianche dalle relazioni interpersonali, dalsenso di competenza e controllo sul-l’ambiente (capacità di risolvere proble-mi e raggiungere obiettivi), dall’emotività(consapevolezza e la capacità di con-trollo delle proprie emozioni), dal suc-cesso scolastico, dalla vita familiare (re-
* Domande n. 36 – 37 –38 del questionario O.M.S.
36 Leggi attentamente queste affermazioni sulla tua scuola. Per ognuna di esse scegli una sola opzione(molto in accordo; d’accordo; né in accordo/né in disaccordo; in disaccordo; fortemente in disaccordo)1. nella nostra scuola gli studenti partecipano nella definizione delle regole2. gli studenti in questa scuola sono trattati severamente3. le regole in questa scuola sono eque4. la nostra scuola è un bel posto5. sento di appartenere a questa scuola37 Rispondi ad ognuna di queste affermazioni sui tuoi insegnanti(molto in accordo; d’accordo; né in accordo/né in disaccordo; in disaccordo; fortemente in disaccordo)1. sono incoraggiato ad esprimere la mia opinione nella mia classe2. i nostri insegnanti ci trattano equamente3. quando ho bisogno di un aiuto extra posso chiederlo4. i miei insegnanti si interessano a me come persona38 Rispondi ad ognuna delle seguenti affermazioni sui tuoi compagni di scuola(sempre; spesso; a volte; raramente; mai)1. gli studenti della mia classe stanno bene insieme2. molti degli studenti sono gentili e collaborativi3. gli studenti mi accettano così come sono
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200380
�����������������������
lazioni e giudizio di sé in ambito familia-re), dal vissuto corporeo (giudizio sulproprio aspetto).Modalità di rilevazionePer la rilevazione dell’autostima , essen-do un aspetto sottoposto all’influenza dipiù variabili, il gruppo di ricerca ha sele-zionato tra le domande del questionarioquelle in cui sono esplorati gli aspettirelazionali che possono condizionare lapercezione del sé, tra essi in particolarela relazione insegnante/allievo ( possibi-lità di potersi esprimere liberamente,percezione di equità nei trattamenti, so-stegno nel bisogno…) e la relazione tracompagni di scuola. La rilevazione diquesti aspetti può in ogni caso essereeffettuata con strumenti già predispostiin altri contesti e disponibili per unarilevazione più approfondita.La partecipazione attiva degli studenti èstata rilavato tra l’altro con un’intervistaal dirigente scolastico. Dai colloqui èemerso che la partecipazione è garantitain due modi ovvero:- l’assemblea di classe mensile, durantela quale sono discussi e verbalizzati ar-gomenti ritenuti importanti dagli allievi, ildocumento è poi consegnato alla dire-zione che lo utilizzerà per valutare even-tuali proposte;- la rappresentanza degli studenti all’in-terno del consiglio d’Istituto e nei consi-gli di classe (quest’ultimo è composto datutti i docenti della classe, due rappre-
sentanti dei genitori, due degli studenti);la funzione del consiglio è quella di for-mulare proposte al collegio dei docenti inordine all’azione didattica, oltre che ave-re funzione di agevolare ed estendere irapporti tra genitori, insegnanti e allievi;- in un caso è stata utilizzata anche unacassetta per la raccolta di suggerimenti,lamentele, osservazioni, rivolte al corpodocente e al dirigente.
Macroarea organizzazionescolasticaIII Gruppo di indicatori
Orario scolasticoIl significato e le basi concettualiDall’analisi delle schede di rilevazionedegli aspetti positivi e negativi dell’espe-rienza scolastica, fatta dagli allievi dellescuole coinvolte nella ricerca, emergonoalcuni fattori che mettono in luce lanecessità di rivedere l’organizzazionedel lavoro scolastico come punto di par-tenza per una corretta prevenzione epromozione della salute dei ragazzi.E’ stato da più parti messo in evidenzacome alcune variabili legate all’organiz-zazione del lavoro scolastico possonoinfluenzare in modo positivo o negativo ilrendimento e la salute degli allievi, deter-minando fenomeni di disagio fino all’ab-bandono della scuola stessa.Molti psicologi hanno ritenuto come piùdirettamente responsabili del disagio
dell’alunno, alcuni fattori inerenti l’orga-nizzazione scolastica, tra essi orari eprogrammi scolastici, metodi educativi evalutativi, dimensione autoritaria nel rap-porto insegnante allievo, carenze nelrapporto scuola/famiglia.La scuola è comunque da considerarsiun qualunque luogo di lavoro e comeogni altro lavoro produce fatica, ilsurmenage o malmenage scolastico. Essaorigina dal normale orario scolastico , dalcarico di lavoro prodotto, dal grado dicomplessità della disciplina trattata e dalmodo in cui le singole discipline sonodistribuite durante la giornata.I principali segni e sintomi della faticascolastica sono la diminuzione dell’at-tenzione, la mancanza d’interesse, l’in-capacità a concentrarsi, l’indebolimentodella memoria, la sonnolenza, fino asegni più importanti come il rilassamentodel tono muscolare, l’insonnia, l’anemia,il dimagrimento.La fatica scolastica che possiamo defi-nire fisiologica, che si manifesta soprat-tutto con la disattenzione e si esauriscedi norma con il normale riposo, ed èprevenuta da una corretta organiz-zazione del lavoro scolastico, che deveessere impostato sulla base dei ritmifisiologici dell’allievo, tenendo in consi-derazione il ritmo della normale attivitàmentale durante la giornata, e la motiva-zione ad apprendere che dipende tral’altro anche dal tipo di metodologia
�����������������������
81n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
didattica utilizzataModalità di rilevazioneGli indicatori sono stati rilevati con duediverse modalità:1. attraverso la somministrazione agli
allievi di una scheda in cui dovevanoessere individuati i fattori scolasticiritenuti positivi o negativi (di seguitosi riportano le indicazioni complessi-ve della rilevazione effettuata nelcorso della ricerca)
2. mediante intervista al dirigente sco-lastico
Aspetti positiviBuone relazioni con i compagniBuone relazioni con gli insegnantiSentirsi considerato come personaRegole giusteIl lavoro in gruppo che dà la possibilitàdi confrontarsi con gli altri e capire chele paure sono comuniL’integrazione nel gruppo classeDisponibilità e competenza dei profes-soriPoter dire cosa ci fa stare male
Aspetti negativiOrario delle lezioni troppo lungoMaterie pesanti nelle ultime oreIntervallo di ricreazione troppo cortoStato di manutenzione della scuola scar-soTroppe ore con lo stesso insegnanteTroppi compitiNon sentirsi preso in considerazionedai compagni e dai professoriScarsa igiene dei bagni
L’obiettivo del gruppo di ricerca eraquello di capire se l’orario scolasticofosse strutturato in modo da favorire iritmi fisiologici degli allievi, con partico-lare attenzione alla quantità di ore con lostesso insegnante, al peso di ogni disci-plina rispetto al grado di impegno menta-le che richiede, alla distribuzione dellediscipline nell’arco della giornata e nellasettimana (es. matematica ultima ora…).Dai colloqui è emerso che un insegnanteindividuato nel corpo docente predispo-ne l’orario sulla base dei criteri stabilitidal consiglio dei docenti, alcuni di questicriteri sono: il “peso” di ogni disciplina, il
giorno libero dei docenti, la disponibilitàdei laboratori, la presenza a tempo pienodi un docente in un istituto o a comunecon più istituti.Al momento dell’elaborazione dell’ora-rio non sono consultati gli studenti, i qualiperò potranno discuterne nelle assem-blee di classe.Il verbale di riunione con le relativeosservazioni è inviato al dirigente scola-stico che si farà carico delle richieste, eapporterà nei limiti dei vincoli sopra dettile modifiche richieste.Pausa per la ricreazioneSignificato e basi concettuali (vedisopra)Modalità di rilevazioneL’indicatore è stato rilevato medianteintervista con il dirigente scolastico conl’obiettivo di individuare se il tempo adisposizione per la pausa è sufficienteper diminuire la sensazione di fatica, sela stessa è collocata nell’arco della mat-tinata quando normalmente avviene ilcalo fisiologico dell’attenzione.Altro aspetto importante da evidenziarese l’autonomia scolastica può favorireuna certa flessibilità per modellare que-sta pausa sulle esigenze degli studenti, ese in ogni caso esistono vincoli cheprovengono dal territorio che possonocondizionarne sia la durata che la collo-cazione temporale (orari autobus, nu-mero di pendolari….).In una sola scuola non è stato evidenziatoil problema relativo alla pausa perché, peraccordi interni tra la dirigenza scolasticae gli allievi dell’Istituto, è stata inserita unadoppia pausa nell’arco della giornata (allafine della seconda e quarta ora).Dai colloqui è emerso che nella maggiorparte dei casi la pausa è collocata tra le11,00 e le 11,30, il tempo a disposizioneè di circa 10 minuti.Questa pausa è condizionata da varifattori tra i quali gli orari degli autobusche a loro volta condizionano gli orarid’ingresso e d’uscita e quindi la possibi-lità di rispettare la puntualità alle lezioni.Altro fattore importante, per quanto so-pra, il numero di pendolari presenti
Secondo alcuni dirigenti l’Autonomiascolastica è comunque uno strumentoefficace per programmare l’intera atti-vità didattica, così come per l’organizza-zione anche in considerazione dei ritmifisiologici degli allievi.Luogo per la ricreazioneSignificatoLa presenza di un luogo dedicato alriposo è un indicatore di qualità dell’or-ganizzazione scolastica che permette dievidenziare se c’è un orientamento ver-so le necessità degli allievi.Modalità di rilevazioneL’indicatore è stato rilevato medianteintervista con il dirigente scolastico, edopo sopralluogo effettuato dai tecnicidel Servizio di Igiene Pubblica dellaAzienda Sanitaria.La maggior parte delle scuole hanno unbar interno a servizio dei ragazzi, glispazi a disposizione non risultano attrez-zati, gli allievi consumano la merendaprevalentemente in classe o nei corridoi,in alcuni casi nel cortile interno.Presenza di mensa scolasticaSignificatoSpesso le scuole offrono attività pome-ridiane sia curriculari che extra cur-riculari, la presenza di una mensa scola-stica è come il precedente un fattore diqualità dell’organizzazione scolastica chemette in evidenza come la scuola favo-risce il benessere degli allievi garanten-do agli stessi uno spazio per riposarsi eper alimentarsi in modo corretto.Modalità di rilevazioneIntervista al dirigente scolastico.Nessun Istituto offre un servizio mensa,anche in presenza di attività curricolaried extracurricolari, in un solo caso inpassato c’è stato un tentativo di offertache è stato rifiutato dalle famiglie e dagliallievi per più ragioni , tra cui la richiestadi contributo economico alle famiglie, laqualità del cibo scarsa, l’impossibilitàper i ragazzi di uscire dall’istituto nel-l’orario della pausa pranzo, un impegnoeconomico da parte della scuola pergarantire la presenza dei collaboratoriscolastici.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200382
�����������������������
Macroarea ambiente fisicoIV gruppo di indicatori
Buone condizioni igienico sanitariedegli edifici scolasticiPresenza di piano di autocontrolloLa modalità di rilevazioneLe condizioni igienico sanitarie degliedifici scolastici sono un elemento es-senziale per garantire la sensazione dibenessere. Molto spesso lo stato di ma-nutenzione è scarso, gli edifici sono statiriconvertiti nella funzione di scuola, nellamaggior parte dei casi non rispettanoneppure i requisiti minimi igienico sanita-ri (microclima, luminosità, dimensioni...).Le questioni legate alla sicurezza di cuial Dlgs 626/94 compresi gli aspetti legatialle emergenze (terremoti, incendio…)non sono stati rilevati anche in conside-razione delle proroghe accordate per gliadeguamenti.Modalità di rilevazioneLa rilevazione è stata effettuata tramitescheda predisposta ad hoc dal Serviziodi Igiene Pubblica del Dipartimento diprevenzione sulla base delle indicazionicontenute nelle leggi sull’edilizia scola-stica. L’indicatore relativo alla presenzadel piano di autocontrollo può essereutilizzato solo nel caso di presenza dimensa scolastica, come fattore di quali-tà del servizio oltre che un obbligo dilegge. Alcuni Istituti presentano caren-ze di tipo strutturale dovute in parte alla
manutenzione ordinaria e straordinaria,ed in parte legate alla precedente desti-nazione d’uso degli edifici stessi. Quasitutti hanno messo in opera sistemi disicurezza per le emergenze (incendio,terremoti...). Gli obblighi relativi alDlgs.626/94 non sono stati rilevati.
Macroarea cooperazioniV gruppo di indicatori
Presenza di specifici accordi tra scuo-la e SSN per offerta di servizi eindividuazione di modalità di infor-mazione per gli allievi e famiglie.Presenza di specifici accordi tra Isti-tuzioni per la formazione del perso-nale scolastico.Messa in comune di risorse (umane emateriali) specificamente destinatealla scuola, attraverso la stesura diaccordi tra gli entiSignificatoL’indicatore ha come obiettivo quello dirilevare eventuali accordi a livello terri-toriale tra gli enti che interagiscono infavore della scuola e nello specificoquello di evidenziare eventuali cambia-menti nell’offerta di servizi in relazione anuovi bisogni individuati. La stesura diaccordi specifici garantisce la nonoccasionalità delle azioni e la loro tradu-zione nei documenti di programmazionedelle Istituzioni, a livello locale, sono unimportante indicatore per la compren-
sione degli indirizzi politici in favore delgruppo target oltre che uno strumentooperativo che impedisce la sovrapposi-zione di azioni e uno spreco di risorse.Modalità di rilevazioneAnalisi dei documenti di programmazio-ne delle istituzioni (PAL, Piani di zona…).Il piano attuativo locale è la traduzione inazioni organizzative delle indicazioni po-litico-programmatiche fornite dalla nor-mativa Nazionale e Regionale in materiasanitaria. Queste indicazioni di tipo “stra-tegico” dell’azienda sono prioritaria-mente approvate dalla Conferenza deiSindaci e successivamente applicatedall’Azienda Sanitaria. In esso sonocontenute l’organizzazione funzionale deimacro-livelli cosi come i modelli orga-nizzativi aziendali per alcune problema-tiche relative alla salute contenute nelPSR.L’analisi dei piani attuativi locali è stataeffettuata allo scopo di individuare glispazi di intervento su cui poter (ri) orien-tare i servizi sanitari nella direzione deibisogni dell’adolescenza. La valutazio-ne è stata effettuata al tempo 0 dellaricerca, non è stato possibile inserire levariazioni che saranno eventualmenteapportate nel documento di program-mazione successivo.
�����������������������
83n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
������ ��� ������ � ���������������� � ����� �������
DOCENTI E STUDENTI:Liceo Scientifico G. Galilei, Istituto Magistrale A. Pieralli, Istituto Tecnico G. Bruno, Istituto Profes-
sionale B. Pascal (PERUGIA); Istituto Magistrale F. Angeloni,Istituto Tecnico F. Allievi, Istituto Professionale F. Cesi (TERNI)
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” (MASSA),Istituto d'Istruzione Superiore “L. Einaudi” (CARRARA)
Istituto Tecnico “L. Da Vinci” di Villafranca di Lunigiana (Sezione di PONTREMOLI)
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200384
�����������������������
������ "#������ � ��$
I unità didatticaRompighiaccio
ITIS F. Allievidal DIARIO DI BORDO DELL’INSEGNANTEI ragazzi non sanno lavorare in gruppo. Si chiede moltoall’insegnante, ma si è poco disposti a dare.
dai DIARI DI BORDO DEI RAGAZZIS. ora scambiata per ricreazione, il lavoro di gruppo è unmomento per chiacchierareB. ma perché il mondo è così difficile? Resterà un enigma,io intanto faccio i compiti!V. il lavoro di gruppo toglie molto tempo e pazienzaperché devono essere ascoltati tutti. Ma questo vuol direlavorare beneL. osservazioni interessanti… sono pochi 20 minuti perlavorare in gruppo… né positiva, né negativa, l’unicapositiva parlare di ciò che ci fa stare male a scuola…G. ho imparato a organizzarmi in modo autonomo e aconvivere nel gruppo senza l’aiuto dell’insegnanteP. l’esperienza per me è un po' negativaC. è positiva la collaborazione di più persone, a volteanche ordinata
Istituto Magistrale F. Angelonidai DIARI DI BORDO DEI RAGAZZIP. ogni gruppo ha espresso la sua creatività nel foglioL. prima non lo capivo (il lavoro di gruppo), poi ho capitoche ogni tanto dobbiamo esprimerci anche noi studentiA. ci siamo conosciuti meglio (siamo uniti), la lezionepresentata in maniera diversa invoglia a studiareT. con la classe non mi trovo bene, sto cercando dicambiare classeA. ho la certezza che le cose che abbiamo dette verrannoprese in considerazioneB. ci ha fatto lavorare con i pensieri dei nostri compagnidi classe, facendo capire che ognuno la pensa a modo suoG. sinceramente da questa esperienza non ho appresomolto. Forse solo a migliorare i rapporti con i compagniO. il nostro preside così poteva capire le cose che ci“fastidiano”
ITAS F. Cesidai DIARI DI BORDO DEI RAGAZZIT. vedere le opinioni non solo mie, ma anche dei mieicompagniR. il lavoro serve ai prof per evitare gli aspetti negativiA. le difficoltà possono essere risolte parlandone insiemeC. queste esperienze ci aiutano a capire come si vive ecome si sta con gli altriA. ho capito che non sono l’unica ad avere paura di nonsentirmi integrataN. ho capito che ognuno di noi ha idee e opinioni diversesu queste coseB. ho capito che ognuno deve cercare di migliorare il suorapporto con i compagniB. ho capito che bisogna giudicare le persone non dafuori, ma dal carattere e da ciò che pensano
II unità didatticaIl mio ambiente fisico
Liceo Scientifico G. Galileidal DIARIO DI BORDO DELL’INSEGNANTEIl lavoro dei ragazzi è stato eseguito con impegno e serietà
dai DIARI DI BORDO DEI RAGAZZI SULLARILEVAZIONEP. insieme con il gruppo abbiamo proposto di cambiare ibanchi nelle classi e l’ubicazione dei radiatori…G. … questo studio è stato utile per conoscere lo spazioe le infrastrutture della classe, ma io credo che star beneci voglia ben altro che uno spostamento di banchi. Illavoro tra alunno e insegnante deve essere innanzituttoun rapporto di lavoro, ma non deve tralasciare un’intesa,un’armonia che creano nello studente un motivo in piùper migliorarsi. Infatti si sa che lo studio non è sempre ungran piacere, ma lo può diventare quando colui che stadietro la cattedra si appassiona a ciò che fa appassionandoanche coloro che lo ascoltano. E per far ciò è anchenecessario un rapporto di stima reciproca Anche il lavoroscolastico deve essere ben organizzato: una spiegazioneseguita da un’interrogazione, per evitare ore tropponoiose. Questo è per me il vero star bene a scuolaS. cosa ci sta a fare un infermeria se non c’è il personale?I. i banchi sono a tal punto rotti che non si può fare ildisegno geometrico. Speriamo di risolvere al più prestoquesti problemi
�������� � !���"
�����������������������
85n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
M. i lavandini per i portatori di handicap sono presentiin tutti i bagni, ma molti non possono essere usati perchédi fronte alla porta del bagno ci sono i gradini. I laboratorisono belli e grandi
dai DIARI DI BORDO DEI RAGAZZI SULLADISCUSSIONEG. Di primo acchitto, non mi sembrava avesse grandeutilità, invece mi sono accorto che è stata utilissimaperché è necessario conoscere i disagi e i problemiscolastici per una soluzione giusta.B. E' servita come stimolo per gli argomenti da trattare inassemblea.S. Abbiamo capito che l’igiene dipende anche da noi.T. I banchi sono bassi e molto rovinati e tendono astrappare abiti e peli.G. La parte più interessante e animata è stata quella in cuidovevamo proporre cambiamenti e dare suggerimenti
Istituto Magistrale A. Pierallidal DIARIO DI BORDO DELL’INSEGNANTEMi ha colpito l’incapacità di ascolto reciproco e latendenza a voler imporre come valore assoluto leconclusioni a cui ogni singolo gruppo era giunto. Poiabbiamo dato loro alcune indicazioni e le ragazze lehanno seguite. Ogni dato della scheda veniva commentatonegativamente (in particolare da alcune allieve) poi inseguito a chiarimenti e discussioni i giudizi siridimensionavano (impressione di preconcetti più che dauna attenta analisi della realtà circostante)Le ragazze hanno deciso di “rallegrare “ l’ambiente cheora sembra rispondere alle loro esigenze. E’ la loro aula.La più polemica è stata la più attiva nel ripulire e rivestirele pareti dell’aula. Personalmente mi spiace che nonabbiano colto la “personalità” dell’Istituto che gli derivaproprio dalla sua storia. Non è anonimo. Ho insegnato inedifici moderni e razionali, ma anonimi, tutti dipinti di unbel grigio asettico. Splendidi esemplari di architetturaanonima e alienante anche se profondamente isonomica!
dai DIARI DI BORDO DEI RAGAZZIS. Non mi è piaciuto andare in giro per la scuola. Con tuttequelle scale!F. Ho conosciuto meglio la mia scuolaM. È stata una mattinata bellissima nella quale ho imparatomolte cose, a stare insieme con persone con le quali non
avevo molto dialogo, mi sono sentita a mio agio anche contutti i professoriL. Ho imparato a disegnare e a misurare adeguatamenteuno spazioF. Lavoro interessante e coinvolgente… è stata unamattinata splendida, mi sono sentita a mio agio anche coni professori: eravamo un unico gruppo. Volevamo starbene a scuola e ci siamo riusciti!T. Mi ha insegnato a lavorare in gruppo con alcunecompagneL. E’ stato un insegnamento, ma anche un divertimento
III unità didatticaLa mia salute
Liceo Scientifico G. Galileidalla RELAZIONE PER GRUPPI1. Il questionario ci è sembrato in alcune cose inopportuno,come la domanda sul reddito familiare, troppo riservata.2. Esperienza utile, ma noiosa, si risponde soloparzialmente perché le opzioni da scegliere non sonomolte, come iniziativa non è male perché ci propone diindagare sulle abitudini di vita di noi ragazzi. E’ emersoche non hanno abitudini diametralmente opposte, lerisposte si differenziavano solo per alcuni dettaglimarginali3. …per quanto riguarda l’ultima domanda ci siamorifiutato di rispondere perché indiscreta (reddito familiare)4. Molte domande non pertinenti, non necessarie epersonali: reddito familiare, fumo alcol e salina. Chi haun problema è già in difficoltà a dirlo a se stesso (figurarsiscriverlo su un questionario!). Non è stato dato spazio acose interessanti come il rapporto con gli insegnanti o coni genitori.
dalle RELAZIONI DOPO LA DISCUSSIONE INPLENARIACi siamo conosciuti meglio e abbiamo potuto esprimere lenostre idee
dai DIARI DI BORDO DEI RAGAZZI SULLACOMPILAZIONEG. alcune domande non erano inerenti al tema principale,alcune personali. Il lavoro si è svolto e si è svolto anchebene.F. mi sono piaciute le domande sul tempo libero, perché
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200386
�����������������������
lo studio non è tutto…B. sono utili ai ricercatori per capire come si comportanoin media i ragazzi della mia etàS. troppo invasivo e neanche anonimo in quanto cichiedeva la data di nascita…ma i questionari ci aiutanoa capire meglio la nostra società, aspetti positivi e negatividi noi giovaniL. il questionario -logico e ben strutturato- non èintelligente e quindi inutile perché chi ha veramenteproblemi non li dirà mai… alcuni lo avranno preso comeuno sfogo, perché non hanno nessuno con cui parlare..qualcuno come una cosa stupida perché ti fa dire agli altricose che non li riguardano e che vorresti tenere per te,alcuni si saranno divertiti a sparare cacchiate… maallora io mi chiedo saranno le vere situazioni sociali efamiliari quelle?G. mi ha fatto riflettere sulle mie abitudini alimentari, sulmio tempo libero e sul mio stato di salute che è legatoanche alla mia opinione su me stessaP. crea una pausa nelle lezioni pesanti…compilandoquesto questionario mi sono sentito un adolescenteconsiderato come un bevitore e un fumatore anche se nonlo sono; a me non piace l’idea di essere analizzato dapsicologi e persone del ramo: è come se debbano emettereun giudizio sulla tua persona…T. mi è molto piaciuta questa esperienza, non sosinceramente se possa servire “la mia opinione” mapenso che se serve per “qualcosa” è giusto che lo facciaM. domande fatte da una persona invadente che non si fagli affari suoi…utile per capire il tuo stato di salute fisicae moraleB. domande che mettono in difficoltà, perché fattipersonali… ad esempio lo stato economico della famiglianon dovrebbe riguardare altre persone al di fuori deimembri della famiglia stessa, alcune domande andrebberoriviste, altre omesse per far rispondere lo studente con piùsincerità e sicurezzaG. ho letto che il questionario è stato svolto in altri 28paesi del mondo e che i risultati emersi possono essereutili per migliorare la scuola.P. le domande si riferivano al nostro stato d’animoL. le domande sono servite a conoscermi meglioM. non ho avuto nessuna difficoltà e mi è anche piaciutoF. sono stata sincera anche se le domande erano personali,ad esempio come sono i rapporti con la mia famiglia
Istituto Magistrale A. Pierallidal DIARIO DI BORDO DELL’INSEGNANTEHo avuto l’impressione che i ragazzi subiscano questenostre proposte in quanto ai loro occhi sembrano astrattee lontane dalla loro quotidianità
dai DIARIO DI BORDO DEI RAGAZZIL. è stato un lavoro interessante, mi ha fatto rendereconto che nella vita è tutto importante e anche i mieigenitori sono fondamentali, ho capito che devo affrontarela scuola con tranquillità… mi è servito a sfogarmiB. ho imparato parole e concetti che non conoscevo e hopotuto esprimere il mio parereC. molto personale, anche troppo, magari ha situazionifamiliari che lo fanno star male; i questionari servono apoco, perché puoi dire quello che pensi, ma le coserimangono le stesse…era una tortura, un interrogatorioP. è un lavoro utile che aiuta molto noi alunni, perchéspesso amici o genitori si limitano a chiedere: Stai bene?e io mi ritrovo sempre a dire: Sì, perché è difficilerispondere no…… comunque è inutile piangere su noistessi , bisogna pensare a quelle cose belle che ci aiutanoad andare avanti nella vitaS. è positivo perché non capita mai di farsi domande diquesto genere, ho cercato di essere sincera, anche sealcune domande erano personaliB. riesco meglio a vedere come sono veramente e anchele persone che mi stanno intornoL. sono riuscita a fare un quadro di me stessa un po’ piùdefinito. Fare lavori che servono a capire il nostrobenessere è interessanteT. è stato significativo perché mi ha fatto capire quantosono importanti i miei genitori e quanto voglia loro bene.ho imparato che questa vita anche se a volte mi sembracontro di me, mi piace moltoC. non so però quanto i nostri professori prendano attodelle nostre considerazioni
ITAS G. Brunodai DIARIO DI BORDO DEI RAGAZZIA. mi ha fatto porre delle domande che non mi sarei maiposta, come quella se mi sento sola e io non sapevo cosarispondere perché non mi ero mai posta quella domanda…ci aiuta a capire più cose su noi stessi… importante chesiano anonimiC. ho riflettuto e quindi il questionario mi è servito molto…
�����������������������
87n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
mi ha chiesto se parlavo mai con la mia famiglia e io nonmi confido mai con loro e sicuramente sbaglio ad averequesto comportamento… anche il mio rendimentoscolastico non è buono, ma non perché non ho voglia, peruna serie di problemi anche familiari… la domanda se misento sola… mi accorgo che vicino a me non c’è nessunoche mi possa ascoltareN. mi ha fatto riflettere, soprattutto le domande sulla miafamiglia… mi trovo molto bene, mi sento protetto con tuttequeste persone…non mi sento mai sola… mi fanno pauragli insegnanti severi, sarò una bambina, ma per me ècosì…forse passeràD. gli argomenti trattati sono quelli che interessano igiovaniL. ma perché non si fanno gli affari loro?P. le domande di questo genere non ti vengono postemolto spesso, anzi quasi maiM. mi ha fatto capire di cosa è fatta la saluteA. almeno è stata una giornata diversa dalle altre, io nonamo tanto parlare di me e della mia famiglia, ma se questiquestionari servono per migliorare la vita degli scolarifuturi li faccio volentieri…anzi questo gruppo di fogliettimi è servito per comprendere meglio i miei rapporti con glialtri e me stessoG. mi alzo alle sei meno venti… e questo è importante perla mia salute
ITIS F. Allievidai DIARI DI BORDO DEI RAGAZZIA. l’esperienza non mi è piaciuta, perché?…ci vorrebberotroppe pagine per dirlo…mi ha fatto arrabbiare perdomande molto irritantiC. dovrebbe essere più approfondito, poi una spiegazioneper ogni domanda…ci ha aiutato ad essere sinceriF. è un’esperienza buona perché aiuta a scoprire dentrodi noiL. mi piace mettere le crocette nelle cose in cui miidentificoM. ci ha permesso di autovalutarci… ora aspettiamo irisultatiP. molti mettevano le crocette a caso, bisogna educare lagente spiegando a cosa servono e cosa ci guadagniamoA. io ho risposto con molta sincerità poiché il test eraanonimo e non valeva la pena di non affermare la verità
Istituto Magistrale F. Angelonidal DIARIO DI BORDO DELL’INSEGNANTEI ragazzi hanno appreso l’importanza di conoscere esoprattutto assumere comportamenti utili a preveniredanni alla propria salute, in particolare hanno saputoanalizzare le problematiche psico-affettive legate allaloro età - rapporto con i genitori e compagni -sufficientemente acquisite gli obiettivi didattici riguardantela metodologia del lavoro di gruppo, più difficoltà nellarielaborazione statistica. Importanti momenti diautoverifica personale, di confronto collettiva permaturare una consapevolezza di sé più profonda e sicura.
dal DIARIO DI BORDO DELLA CLASSECi stupisce che molte persone abbiano mentito perché tuttivorrebbero essere delle persone modello che in realtànon sono. Perciò i risultati non sono veri. …riguardo alrapporto con i professori alcuni si dimostrano partecipidella classe e del singolo individuo aiutando a migliorareil loro rapporto con lo studio, se gli insegnanti adottasseroquesto metodo, gli studenti acquisirebbero maggior fiducianelle loro capacità (anche se ci sono persone a cui noninteressa lo studio).
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200388
�����������������������
����#���������� ������� ����� �������$������
Istituto d’Istruzione Superiore L. Einaudidalla RELAZIONE DELL’INSEGNANTEIl primo momento è stato quello d’individuare, coll’appoggiodei vari Consigli di Classe, tra le classi dell’Istituto quale o qualifossero più idonee per partecipare a questa esperienza. Dopoun attento vaglio della situazione che si è portato per circa unmese, si è identificata come oggetto/soggetto la Ia A. In taleclasse, infatti, è stata riscontrata la presenza di ben noveelementi su ventuno che si mostravano non scolarizzati esoprattutto non motivati sufficientemente a proseguire glistudi. Di essi infatti già due abbandonavano la frequenza intempi assai brevi. Si è quindi costituito un gruppo di lavoroformato dalla scrivente, insegnante d’Italiano e Storia, dalprofessor Paolo Ferrari, docente d’Economia Aziendale edalla professoressa Enrica Santucci, insegnante di Scienzedella Terra che si sono riuniti più volte per discutere sull’argo-mento e organizzare iniziative e interventi. E’ stato particolar-mente gradito l’appoggio dell’ASL che, nella persona delladott.ssa. Maddalena Freddi, è intervenuta per conoscere icomponenti della Ia A ed è stata larga di consigli.Il procedimento è avvenuto in più tappe. Tenendo semprepresente la centralità dello studente e dello strumento delprocesso d’apprendimento, nella prima riunione del gruppo dilavoro citato sono stati evidenziati i punti significativi di questoprocesso - atti a favorire tale centralità - a quanto emerso neimomenti formativi.Individuati tali punti, si sono poi confrontati con altri elementiderivanti dalle conoscenze previe e dalle esperienze degliinsegnanti del gruppo. Sono stati quindi evidenziati gli elementi dei metodi didatticitrasversali alle discipline insegnate da utilizzarsi a tal fine daparte degli stessi e dei colleghi del Consiglio di Classe.Occorreva innanzitutto conoscere bene gli appartenenti allaclasse.Consci delle difficoltà dovute all’eterogeneità di esperienzepersonali, familiari e curriculari dei vari appartenenti alla Ia. A,si è proceduto, con l’aiuto della referente della ASL a focaliz-
zare per scritto, con qualsiasi mezzo anche grafico, e oralmen-tea) chi sono iob) per quali motivazioni ho scelto questa scuolac) quali sono state le situazioni positive e quelle negative delle
recenti esperienze scolasticheE’ stata fatta un’indagine di come gli appartenenti alla classevedevano la struttura scolastica (lati positivi e lati negativi) ei rapporti sociali tra alunni e insegnanti e tra alunni e loro stessi.In tal modo si sono analizzati i fattori favorenti e ostacolanti lasalute relativi all’ambiente fisico (la scuola) e relazionale aiprogrammi e metodologie d’insegnamento/apprendimento.Il contributo atteso dall’esperienza in atto è appunto quello dimigliorare le capacità degli alunni di comprendere se stessi edanche quella degli insegnanti di comprendere gli alunni, ondeacquisire le capacità di intervento per ridurre ed eliminare ildisagio in atto e abituare all’autoresponsabilità. Lo scopo è cheil lavoro scolastico sia di per se stesso promotore di salute:“prendere decisioni” influisce sulla salute!A questo scopo si è attivata una relazione famiglia scuola conla convocazione, per problemi inerenti all’andamento didatticodisciplinare, si tutti i rappresentanti delle famiglie stesse.Riteniamo infatti che sia necessario avvicinare le famiglie nelloro complesso, anche al di là della malattia e del malessere perconoscerle, appoggiarle e aiutarle nella crescita dell’adole-scente.I risultati ottenuti dalla stragrande maggioranza della classesono soddisfacenti.
Rosa Maria Pellegrini
�����������������������
89n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
dai DIARIO DI BORDO DEI RAGAZZIG. L’altro giorno ero tristissimo, era il giorno prima delcompito di latino, che sarebbe la materia che non mi riesceproprio, ed oltre ad essere triste ero anche un po' nervosoquindi sono riuscito a litigare con la mia ragazza 2 voltein 2 giorni, l’ho trattata malissimo; e per fortuna che leimi capisce perché se era un’altra mi aveva già lasciato.Dopo il compito di latino avendolo fatto bene il nervosismoe la tristezza se ne sono andati e andandosene mi hannofatto ritrovare il sereno con la mia ragazza e il resto dellepersone. Con questo volevo solo dire quanto una giornatascolastica può pesare sul comportamento di una personasolo a pensarci alcuni giorni prima e quanto sia bellosuperarla con una ragazza al mio fianco, che ti vogliatanto bene.L. Ieri è stata una giornata sotto certi aspetti davverofantastica. E difficile riuscire a dire tutto quello che hoprovato e pensato, però so che spiegarmi un po’ potràfarmi davvero bene.B. Vengo a scuola volentieri anche se per alcuni dei mieicompagni non riesco ad avere un’opinione precisa perchémolte volte sono ambigui.La Calace spiega troppo e di conseguenza sono sempre astudiare la sua materia.L’orario è troppo pesante, i compiti e le interrogazionisono spesso concentrati o il lunedi o il sabato: la nostraconcentrazione in questi giorni è quasi nulla.M.“una giornata da sparo”La 1°ora: storia: la prof. faceva addormentare!! Ha finitodi interrogare minacciandoci di stare attenti perché poine interrogava altri.2°ora chimica: ci ha dato il compito. Ho preso -7 e il prof.ci rideva sopra mentre mentre io ho pianto.3/4 ora italiano: ha spiegato e non l’ho ascoltata per unsecondo perché pensavo a chimica: poi la prof. ci ha datoil risultato del compito. Ho fatto 5 errori mi ha dato 6 e hadetto che chi andava a protestare abbassava il voto!!!
5°ora inglese: l’ora più divertente!6°ora recupero di chimica: ha interrogato quelli cheavevano preso 10 al compito.P. Ieri è stato un gran giorno perché nessuno mi hainterrogato. Ho preso 8+ a chimica e 71/2 e non ho fattoniente il pomeriggio, ho giocato alla play station. VIVA!
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200390
�����������������������
������ ��' ��� ��� �������� � � ��� ���� ������� � � ��$ �� � ���%������ ����� � �� � ��
������ �� �������
Elementi facilitanti:- Partire da un’esperienza concreta ha sicuramente attivato la curiosità e quindi la motivazione. Sviluppare un argomento in modo
continuativo e sequenziale. La serenità con cui si è lavorato, dal momento che le alunne non si sentivano pressate dallavalutazione di ogni loro attività.
- L’aver potuto usufruire dei concetti appresi e “digeriti” in precedenza nella matematica ha permesso di rendere la lezione piùfluida e contemporaneamente di non far ritenere alle alunne le materie distinte.
- Clima della scuola, abitudine consolidata a lavorare per obiettivi e per progetti.
Elementi ostacolanti- Le assenze delle alunne e quindi la difficoltà a riprendere il discorso. Una certa superficialità da parte delle alunne ad adempiere
i compiti loro assegnati a casa tipo la ricerca di materiale o la compilazione dei diari di bordo. Infatti la mancanza di valutazioniin itinere ha comportato che il loro impegno si esaurisse nel lavoro in classe.Purtroppo sempre più spesso ci rendiamo contoche l’interesse dei ragazzi nasce da motivi utilitaristici contingenti (il voto, l’interrogazione...) senza una reale motivazione allostudio ed è molto difficile modificare certi atteggiamenti.
- Purtroppo nel progettare questo modulo l’insegnante di chimica non ha tenuto conto (come primo anno in questo istituto) che,con un’ora soltanto alla settimana di chimica, non avrebbe ottenuto i prerequisiti se non nell’ultima parte del secondoquadrimestre e addirittura che avrebbe dovuto anticipare una parte del programma per questo.
- La novità della formula (modulo pluri-interdisciplinare), forse non sempre condivisa dagli insegnanti e recepita in modoaltrettanto contradditorio dagli studenti.
- La non omogeneità dei tempi di svolgimento del modulo.- La mancata esplicitazione o consapevolezza delle modalità di valutazione.
Reazioni dei soggettiInsegnanti- Il modulo ha consentito un confronto con i colleghi che è generalmente difficile da realizzare. Personalmente mi ha stimolatonella ricerca di qualche possibile strategia alternativa alla mia usuale didattica, mi ha consentito di utilizzare strumenti come illavoro di gruppo e il diario di bordo, mi ha permesso di controllare meglio i nodi problematici, le difficoltà e i punti deboli delpercorso.- L’aver aderito al progetto ha favorito la rapida integrazione dell’insegnante di Chimica nel consiglio di classe anche nel tentativodi svolgere un modulo interdisciplinare. Si ritiene che per un buon andamento della classe sia importantissimo il rapporto umanotra i componenti del consiglio e questo progetto ha dato il suo contributo positivo.- I docenti coinvolti hanno dedicato alla preparazione ed allo svolgimento dei moduli segmenti temporali non coincidenti e nonomogenei.Il Progetto è stato condiviso solo parzialmente dal consiglio di classe e, solo nella sua parte finale, condiviso appienodalla classe. Altrettanto parziale è stata la collaborazione tra insegnanti, sebbene rappresenti un inizio assai significativo.- Disponibilità iniziale da parte dei docenti del consiglio di classe. Graduale riduzione del numero delle discipline coinvolte dovutoa fattori oggettivi. L’organizzazione verticale delle cattedre ha visto i docenti più disponibili a collaborare impegnati nellarealizzazione di progetti che coinvolgono le III le IV e le V classi e pertanto il contributo è stato marginale. La realizzazione deimoduli è stata concretizzata e condivisa dai docenti di italiano e lingua straniera. Un valido supporto è stato fornito agli insegnantidi ed .fisica e dall’insegnante di matematica che ha seguito gli studenti nella elaborazione grafica delle diverse fasi del prodottocartaceo.- Sono stata incitata ad andare avanti nello svolgimento del modulo, stupefatta e soddisfatta.
�����������������������
91n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Studenti- Le studentesse hanno ritenuto il modulo “dispersivo” perché troppo dilatato nel tempo, ma divertente perché ha permesso lorodi svolger argomenti anche difficili in modo più leggero.- In generale gli alunni hanno verificato le proprie capacità di gestire le situazioni autonomamente e utilizzare al meglio le abilitàpregresse,anche in riferimento alle fasi precedenti del progetto (lavori di gruppo, diari di bordo ecc.); hanno mostrato perplessitànel riconoscersi nell’attività del modulo,quasi che non avessero interiorizzato il coinvolgimento nella ricerca. Inoltre è affioratoil problema della mancanza di motivazione e interesse nei confronti dell’azione didattica,come se il modulo mancasse di unapropria specificità rispetto alla lezione curricolare di routine.- Pienamente coinvolti, motivati, entusiasti ed infine anche stanchi.- Scettici inizialmente ma coinvolti, attivi e propositivi sempre.
Riflessioni generali sulle conoscenze prodotte dall’esperienza (pedagogiche, didattiche, organizzative, ecc.)- L’esperienza ha prodotto conoscenze
- in termini pedagogici: l’importanza di partire dall’esperienza dello studente, di renderlo protagonista, di svilupparne lasicurezza per accrescere la motivazione che è elemento centrale dell’apprendimento;
- in termini didattici: l’utilizzo di strumenti poco usuali come il lavoro di gruppo e il diario di bordo;- in termini organizzativi: la necessità di un confronto con i colleghi, la predisposizione di una programmazione per unità
didattiche abbastanza dettagliata e con una precisa scansione dei tempi e dei modi.- Da questa esperienza è sicuramente nata una maggior attenzione nei confronti degli alunni, quando dobbiamo introdurreargomenti complessi, che se abbinati al loro vissuto, risultano più facili da comprendere; inoltre ha portato un altro importanterisultato, di stimolare nel consiglio di classe un’armonia di gruppo che comporta una migliore attività dei docenti. L’esperienzadel progetto “Scuola promotrice di salute” è apparsa certamente positiva per aver discusso con esperti dell’educazione e inparticolare per aver tentato i lavori di gruppo, verso i quali si aveva un certo senso di contrarietà a causa dell’inevitabile difficoltàdi ottenere, in quelle circostanze, un silenzio in classe. Si è applicato spesso con successo questo tipo di lavoro ottenendo risultatiinaspettati. L’insegnante di chimica pur non avendo partecipato alla prima parte del progetto (2000/2001) ha notato come unquaderno dove chiunque (alunni ed insegnanti) scrivesse in modo anonimo le sue sensazioni fosse molto utile a creare un climapositivo.- Dal punto di vista del processo di apprendimento degli allievi, più che di un arricchimento di contenuti specifici nelle variediscipline, si potrebbe parlare di una più chiara valutazione, da parte di noi insegnanti, delle potenzialità degli alunni e di unavalutazione più libera da stereotipi, almeno per alcune materie.Metodologie e strumenti didattici diversificati hanno permesso agli studenti di acquisire conoscenze scientifiche relative ad unastessa tematica attraverso l’apporto di discipline differenti come, la matematica, la fisica e le scienze naturali (sistema solare,moti dei pianeti, studio dell’ellissi, legge gravitazionale), motivando e vivificando esperienze pregresse, sviluppando la creativitàattraverso l’esperienza agita e promuovendo sicurezze interiori con il rimuovere lo stress negativo.Gli studenti, infine, hanno potuto valutare, in modo più consapevole e critico, se non quanto appreso, perlomeno il tipo diesperienza effettuata e la qualità della formazione ricevuta,nel confronto con le diverse metodologie e i diversi punti di vistaforniti. Ma è soprattutto nel grado di trasferibilità di quanto appreso, nella capacità di cogliere di ogni disciplina il linguaggiospecifico, il metodo di indagine e la struttura concettuale, che risiede la acquisizione fondamentale del progetto. Esso ha propostoun approccio al lavoro scolastico di tipo alternativo, fornendo uno strumento convincente anche ai fautori del metodo tradizionaleche, tuttavia, non potrà continuare a consistere in una consegna fine a se stessa, di saperi definitivi.- Sul piano pedagogico l’esperienza è stata più che positiva per il coinvolgimento, la partecipazione costruttiva, degli studentie il clima collaborativo.- Sul piano didattico ha rallentato gli apprendimenti disciplinari curriculari.- Sul piano organizzativo ha richiesto flessibilità, cambiamenti ed impegno notevoli ai docenti coinvolti soprattutto nella fase di
realizzazione dei due prodotti: dossier cartaceo e filmato in lingua inglese.- Esperienza molto positiva ed entusiasmante sia da un punto di vista pedagogico che didattico ma difficile da inserire, serealizzata in modo così approfondito, nello svolgimento del programma curricolare (soprattutto l’elaborazione del prodotto finaleda parte degli studenti).
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200392
�����������������������
������ ��' ��� ��� �������� � � ��� ���� ������� � � ��$ �� � ���%������ ����� � �� � ��
������ �� ��� �
Elementi facilitanti- Disponibilità oraria dei docenti coinvolti- Massimo coinvolgimento degli alunni in questa attività non propriamente curriculare- Clima collaborativo docenti-studenti- Competenze e organizzazione dei tempi e dei modi attuati dal gruppo di ricerca- Interesse per l’argomento. Prerequisiti facenti parte della programmazione disciplinare.- Possibilità di accesso alla Biblioteca multimediale e agli altri laboratori- Interesse per l’argomento da loro scelto.- Prerequisiti (L1) già presenti nella programmazione dell’anno precedente. Possibilità di lavorare con mezzi multimediali.- Vivere la biblioteca come laboratorio.- Il metodo induttivo nella presentazione dei contenuti disciplinari e la realizzazione/somministrazione del questionario-intervista
ad opera degli studenti, che si sono visti riconoscere un ruolo di protagonisti, hanno contribuito a sviluppare interesse emotivazione nell’apprendimento dei contenuti disciplinari stessi, alla maggior parte della classe.
Elementi ostacolanti- Non completa partecipazione del C.d.C. sia a causa della discontinuità didattica che dell’interesse del docente.- Scarsa organizzazione ed autonomia di alcuni gruppi.- Scarsa importanza attribuita alle discipline scientifiche nell’ambito del curriculum scolastico. Difficoltà intrinseca delle
discipline scientifiche.- Incapacità degli alunni di organizzarsi in modo autonomo.- Resistenza di alcuni alunni ad impegnarsi in uno studio attivo e costante.- Difficoltà di conciliare il progetto con i vari impegni curriculari.- Lo svolgimento del modulo in esame ha avuto come principale elemento ostacolante la scarsa partecipazione di un gruppo di
studenti della classe che, pur se esiguo, ha rallentato e impedito in alcune fasi, il regolare proseguimento del lavoro programmato(Ripetute posticipazioni dei termini di consegna dei dati raccolti attraverso le interviste da parte di alcuni studenti della classe).
Reazione dei soggettiInsegnanti- Estremamente motivati ed interessati dall’idea che seminari proposti nel progetto, introducano un nuovo modo di lavorare incui le esperienze personali della didattica quotidiana e le conoscenze teoriche della psicologia della età evolutiva trovanocollocazione e fondamento scientifico.Molto stimolanti e proficui sono stati i gruppi di lavoro fra gli insegnanti delle diverse scuolecoinvolte, sia per il fecondo “scambio di informazioni professionali”, che per sperimentare il “gruppo” nel consiglio di classe.- L’aspetto che è apparso in parte disatteso è quello che riguarda le “necessarie modifiche normative per rendere operativoquanto emerso e proposto dal progetto e che mal si cala nei tempi, nella struttura e nelle risorse economiche a disposizione.Gliinsegnanti auspicano che questi seminari diventino una realtà di aggiornamento e formazione professionale con tempi e risorsededicati, non sovrapposti al normale carico di lavoro, ed uscire così da quell’aspetto di “volontariato” che ha sinoracontraddistinto l’attuazione di tutti i progetti innovativi di evoluzione scolastica.
Studenti:- La maggior parte di questi ragazzi dichiara che la partecipazione a questo progetto biennale ha facilitato l’integrazione nelcontesto classe consentendo loro di superare disagi relazionali.- I ragazzi concordano che si sono costruiti nel tempo rapporti positivi con la maggior parte dei docenti sia a livello interpersonalesia nell’ambito del dialogo didattico. Tutti dicono di aver trovato interessanti e motivanti le tematiche affrontate, soprattutto perle modalità di lavoro che li hanno coinvolti nell’utilizzo dei linguaggi non verbali. Tutti gli studenti sono consapevoli di aver
�����������������������
93n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
conseguito dei risultati soprattutto in funzione delle metodologie acquisite che hanno permesso loro di consolidare ulteriormenteun metodo studio personale ed organizzato.
Riflessioni generali sulle conoscenze prodotte dall’esperienza (pedagogiche, didattiche, organizzative, ecc.)
L’esperienza del modulo ha abituato gli studenti alla discussione, all’assunzione di responsabilità anche in senso negativo Alcunidocenti hanno rilevato che gli studenti preferiscono essere fruitori di un sapere passivo trasmesso, in modo nozionistico daldocente. Autoapprendere o apprendere per scoperta, anche se guidati dall’ insegnante facilitatore è più faticoso soprattutto pèrle discipline scientifiche. Il lavoro di gruppo, a volte dispersivo da un punto di vista didattico, è però molto positivo da un puntodi vista pedagogico, perché più coinvolgente.
Sviluppi e proposte
L’esperienza è sicuramente riproponibile e trasferibile perché la didattica modulare è coinvolgente ed attivante le capacità dicritica, di correlazione dei vari saperi e dei vari saperi con il bagaglio di conoscenze pregresse degli studenti. Noi tutti, insegnantied alunni, siamo stati protagonisti di una ricerca che, soprattutto nella progettazione del modulo disciplinare non è stata facile,perché nessuno di noi aveva un habitus mentale per questa impostazione metodologica. Certamente abbiamo avuto un supportopedagogico didattico ed organizzativo dal C.S.E.S. Abbiamo appreso che partire dalle conoscenze pregresse, dal vissuto deglistudenti, dalle loro esigenze e dall’attualità, rende il lavoro più motivante per docenti e studenti, in quanto scoperta e ricerca-azione vera e propria.Auspichiamo però in un futuro proseguimento dell’esperienza che:1. Venga proposto agli insegnanti del consiglio di classe un input didattico-disciplinare più concreto e calato nella realtà dello
studente di un biennio dell’attuale Scuola Media superiore.2. Ci venga fornito materiale riguardante moduli disciplinare da sperimentare nel curriculum dello stesso biennio, in modo che
i docenti possano attuare tali moduli nelle classi e valutarne i risultati.3. Il consiglio di classe sia formato da docenti che aderiscono volontariamente al progetto senza subirlo e che si prosegua sempre
con gli stessi insegnanti in modo da assicurare una continuità pedagogica, didattica e organizzativa al progetto.
Gli insegnanti coinvolti nel progetto esprimono apprezzamento per l’iniziativa e valutano positivamente il progetto anche se illavoro poteva essere svolto con più attenzione se ci fosse stato l’interesse ed una maggiore motivazione da parte dell’interaclasse e non di una sola parte di essa.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200394
�����������������������
�� � �� ��������� � ��� ������������ �����% �� ��� ������"
Istituto Tecnico G. Bruno, Perugia
Istituto Professionale B. Pascal, Perugia
un aggettivo una motivazioneaffascinante Mi è piaciuto il modo in cui le ragazze “fanno questo lavoro”
utile Si imparano cose nuove; aiuta a capire cose relative al rapporto con i genitoriinteressante Costringe a riflettere sui discorsi, è una nuova esperienza, mi sono piaciute le attività
svolte, i nuovi argomenti trattatipiacevole Non è stressante, né pesante
inutile Non lascia nessun chiarimentoripetitivo Nelle lezioni si fanno più o meno le stesse cose
insignificante Non lascia nessun insegnamentocoinvolgente Partecipazione nella rilevazione dell’ambiente scolastico, mi inserisco subito nei
discorsi (le ricercatrici sono state capaci a coinvolgermi)particolare È una cosa strana che non si fa sempre e non in tutte le scuole
un aggettivo una motivazione
utileIl progetto fa conoscere la situazione vissuta dagli studenti e alcuni aspetti deicompagni; aiuta a capire meglio se stessi e i propri progetti; ci fa capire cose sullascuola e riflettere sulle relazioni
creativa Il progetto consente di usare la fantasia anche per migliorare il rapporto con la scuolaimbarazzante Ci si espone alla classe, alcune domande del questionario dell’O.M.S. sono invadenti
interessanteEsperienza nuova e diversa dalle altre che attira l’attenzione, ci si integra nel lavoro;dal questionario ho capito che altri vivono l’esperienza scolastica come me; ci hafornito motivi di dibattito e nuovi spunti di riflessione; dal questionario ho capitocome sono e in che ambiente vivo; si analizzano aspetti ignorati; è importante starebene a scuola, cioè trovarsi bene con le cose fatte
simpatica Sono piaciuti i lavori di gruppodivertente Ci si scarica dopo le lezioni, ha coinvolto insegnanti e studenti insieme, si lavora di
più insieme facendo cose diverse dal solito; il gioco dei sacchetti fa scoprire ciò cheognuno pensa della scuola e dei rapporti al suo interno, si esprimono le proprie ideesenza problemi
orientativa Dopo si hanno le idee più chiareallegra Ci si diverte
coinvolgente Il metodo proposto rende partecipi al progetto tutti insegnanti e studenti; fa capire leidee dei compagni sulla scuola, ci riguarda da vicino
pratico Perché il lavoro è organizzato in modo pratico e ordinatostimolante Nel teatro ho sconfitto la timidezza
impegnativo Ha occupato molte ore di lezioneappassionante Per il lavoro di teatro fattoentusiasmante Argomenti particolari rendono più bello venire a scuola
�����������������������
95n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Liceo Scentifico G. Galilei, Perugia
un aggettivo una motivazionepenalizzante Le cose da fare hanno portato via tempo dalle lezioni
piacevole I lavori di gruppo sono stati divertenti e interessanti per gli argomenti trattaticonfusionario Non è stato ben programmatointeressante Si è fatto lezione in modo diverso, esperienza diversa dal solito, abbiamo appreso
cose nuove, abbiamo approfondito dei rami della fisica della matematica e dellascienza
divertente Ha coinvolto professori e alunni contemporaneamente e perché abbiamo lavorato ingruppo
impegnativo Studiare argomenti al di fuori del programma, anticipare programmi dei prossimianni
rilassante Ha spezzato la routine scolasticainutile Non capisco dove porti un lavoro del genere e non l’ho preso sul serio, non abbiamo
imparato niente di nuovoirrilevante Non mi ha acculturato più di tantodiscontinua Difficoltà ad unire il lavoro scolastico con le attività e mancanza di temponon creativa Il metodo usato è troppo simile al lavoro scolastico; per certe cose il progetto si è
rilevato più noioso del modo stesso di studiare lasciando dei punti vuoti chepotevano essere occupati da attività più creative
confusionario Non c’era un orario programmato e a volte non si capiva lo scopo del lavorocoinvolgente Ci siamo sentiti un gruppo unito
noioso Per come era affrontato da alcuni professori, le lezioni non ci hanno interessatosuperficiale Nel secondo anno mi sono impegnato di meno; tutti l’hanno preso come un gioco;
alcuni argomenti trattati non sono stati approfonditi adeguatamentepesante Perché sono state svolte verifiche e lezioni per ogni disciplina
sporadica Pochi incontri per far entrare l’alunno nell’ottica del progettoingiusta Abbiamo fatto test e compiti che sono stati valutati come gli altri compiti di routine
innovativo Un modo nuovo per trascorrere le lezionidispersivo Gli argomenti non si univano con il programma e le lezioni venivano intervallate e
non c’era continuitàsemplice nei contenuti
rilassante Ha spezzato la settimana scolastica
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200396
�����������������������
Istituto Magistrale A. Pieralli, Perugia
un aggettivo una motivazioneinteressante Abbiamo imparato cose correlate a più materie; diario di bordo, nuovo modo di
studiare, si lavora sia individualmente che in gruppodivertente Abbiamo imparato in modo leggero e abbiamo lavorato in gruppo; il gioco dei
sacchetti è un modo per confrontarci; in tutti i lavori partecipavonoioso Diario di bordo
dispersivo Non si è capito bene il significato; non si è concluso nientepiacevole Trascorrere momenti diversi
poco frequente Incontri troppo distantiutile Materie sono più interessanti di quel che sembra
creativopoco comprensibile Nel I° anno non si capiva di che si trattava
costruttiva Abbiamo imparato cose nuove anche sulla nostra scuolacuriosaillogica I lavori del primo anno non si collegavano
�����������������������
97n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
Istituto Magistrale F. Angeloni, Terni
un aggettivo una motivazioneutile Ha offerto nuove conoscenze soprattutto sulla vita dei vari paesi del mondo, ci ha
permesso di migliorare l’ambiente; per il modulo “Appartenenza” è importante saperecome funziona la scuola oggi
impegnativo Ha richiesto molte ore e un ritmo di studio maggiorecoinvolgente Ha migliorato i rapporti tra i compagni e tra questi e i professori, ci ha permesso di
socializzare e di agire in prima persona; gli argomenti trattati hanno stimolato la vogliadi apprendere; ci siamo impegnati dando il massimo di noi stessi
interessante Ho capito meglio alcune cose, abbiamo ampliato le nostre conoscenze; bello elaborare idati e lavorare in gruppo; abbiamo trattato argomenti che ci “toccano” e ci riguardano;gli argomenti attuali sono interessanti; con i questionari ci siamo conosciuti di più
piacevole Esperienza positiva e non noiosadivertente Si è instaurato un buon rapporto tra i compagni, è stato un momento di gioco e al tempo
stesso abbiamo imparato, ci siamo conosciuti meglio; essendo multidisciplinare è statobello lavorare tutti insieme per uno scopo comune
stimolante Ci ha spinto a trovare delle possibili giustificazionisignificativa Ho riflettuto meglio su alcuni aspetti
educativo Abbiamo allargato le nostre conoscenze; dà istruzione riguardo la societàlenta Avrei preferito concludere prima
appagante All’inizio mi sono fatta delle risposte e sono riuscita a darmi delle risposteintelligente Ho capito molte cose ed era ben strutturato
collaborativaimportante Si ricavano molte informazioni
allegro Si è svolto come un giocoistruttivo Ci siamo resi conto del mondo che ci circondanoioso Si potevano fare attività diverse sempre nell’ambito della salute
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 200398
�����������������������
Istituto Tecnico F. Cesi, Terni
un aggettivo una motivazioneinteressante Ci siamo conosciuti meglio e confrontati; gli argomenti non erano solo sui libri ma ci
circondano realmente; abbiamo capito che la scuola può mettere noi primadell’insegnante; ha coinvolto alunni e insegnanti; modo diverso di svolgere ilprogramma; partecipazione attiva; il metodo di studio e di apprendimento è statodiverso
entusiasmante Mi sono divertito; l’alunno è al centro dell’attenzionepositivo Ho imparatoistruttivo Abbiamo approfondito le nostre conoscenze, imparato cose nuovepiacevole Lavoro rilassante divertente ed istruttivo; abbiamo avuto modo di esprimercidivertente Il dialogo ci ha motivati e ci siamo confrontati in un clima sereno; ci siamo
impegnati facendo anche lavori più piacevoli (disegni, ricerche…) su un argomentoserio: questo ci ha fatto sentire parte integrante della scuola
stancante Spesso l’organizzazione di gruppo non era ottimaleproducente Ho conosciuto meglio i compagni al di fuori della scuolastimolante Ci siamo sentiti protagonisti perciò abbiamo dato il nostro meglio; da soli possiamo
raggiungere un nostro obiettivo; ci ha aiutati a credere in noi stessi; si è dato spazioalle nostre idee
duro Abbiamo lavorato più del solitoimpegnativo Richiede approfondimentosconvolgente Cambia il modo di studiarealternativo Si esce dal solito insegnamento
difficile Si lavora di più; metodo ancora incapace di prevalere su un metodo di studio ormaitroppo radicato
utile Abbiamo imparato a lavorare in grupporesponsabilizzante Responsabilizza l’alunno spronandolo a crearsi un percorso di lavoro
innovativo La lezione frontale si è trasformata in lezione individuale, svolta dall’alunno, ocollettiva, svolta dal gruppo
�����������������������
99n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
"�������� ��� ������� � &(���� � ������&�� �������
��� ������ ������� ��� �� ��� � ����
FATHER AND SON
It’s not time to make a change, just relax take it easy you’re still young, that’s your fault, there’s so much you have to know.Find a girl, settle down, if you want you can marry, look at me, I am old but l’m happy.I was once like you are now and I know that is not easy to be calm when you found something going on, but take your time,think a lot, think of everything you’ve got when you will still be here tomorrow but your dreams may not.How can I try to explain when I do he turns away it’s always been the same, same old story; from the moment I could talkI was ordered to listen, now there’s a way and I know that I have to go away, I know I have to go.It’s not time to make a change just sit down, take it slowly, you’re sti11 young, that’s your fault, there’s so much you have togo throughFind a girls, settle down, if you want you marry, look at me, I am old but I’m happy.Al the times that I’ve cried keeping all the things, I knew inside, it’s hard but it’s harder to ignore it. If they were right I’d agreebut it’s them that know not me now, there’s a way and I know that I have to go away; I know I have to go.
What makes good parents?
1) Trust you judgement and allow you to make your own choices.
2) Are reasonably strict because they want to protect you.
3) Have reasonable expectations about your school performance.
4) Don’t embarrass you in front of your friends.
5) Respect your privacy.
6) Understand the fact that you may be in a bad mood and want to be alone.
7) Don’t constantly criticize the way you look.
8) Don’t fight in front of you but if they have a problem, they share it with you.
9) Help you to make decisions without imposing their opinions.
10) Care about you, know what you need and take time to listen to you.
11) Reward you and make you feel good about yourself.
12) Are always there for you even if they’re very busy.
We think that “good parents”
1) Respect your silence.
2) Are alwayse sincere and spontaneous.
3) Don’t always stress every mistake you make.
4) Don’t make comparison between you and other young people.
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003100
�����������������������
"�������� ������� � &)��� ���� � *�� ����&������
��� ������ ������������ ���
LE CAUSE DEL SOTTOSVILUPPOIl progetto “scuola promotrice di salute” da noi effettuato è stato svolto in due fasi. Laprima, quella dello scorso anno, ci ha visti impegnati nella compilazione di questionaririguardanti la scuola che abbiamo scelto e il nostro rapporto con essa. Tutto ciò haavuto come obiettivo principale quello di cerare un ambiente scolastico per noi piùaccogliente e sereno in cui noi studenti fossimo consapevoli del nostro processo diapprendimento. La seconda parte, invece, si è sviluppata intorno ad un modulodidattico multidisciplinare su una problematica da noi scelta: quella del sottosviluppo inalcuni paesi del mondo, con l’obiettivo di applicare il metodo di studio da noi appresonel corso del biennio attraverso lavori di gruppo spesso da noi autogestiti. A tale fine abbiamo raccolto attraverso internet e altrefonti di ricerca dati riguardanti i problemi da noi ritenuti di maggio rilievo quali i tassi di analfabetizzazione, gli indici di mortalità,il Pil, ecce, nei paesi da noi scelti come campione della nostra indagine. Abbiamo quindi creato grafici al computer per megliomostrare i risultati ottenuti. Abbiamo infine relazionato il tutto in un testo argomentativo, inserendovi anche le nostre opinioniformatesi grazie all’analisi delle cause dei problemi affrontati: abbiamo scoperto che spesso fenomeni ancora attuali diarretratezza affondano le loro radici nelle storie travagliate di questi paesi.Proficuo si è rivelato inoltre l’incontro con una suora missionaria che vive in Thailandia e una ragazza della nostra scuola cheè stata un mese in Uruguay: entrambe ci hanno raccontato le loro esperienze di vita in quei paesi. Particolarmente interessantisono state anche le lezioni del nostro futuro professore di filosofia, il quale ci ha illustrato le origini del fenomeno del razzismonella nostra cultura e, soprattutto, le gravi implicazioni ideologiche. Con la professoressa di francese abbiamo parlato delleminoranze sociali in Francia, mentre con l’insegnante di inglese delle minoranze etniche in America. Come prodotto finale cisiamo poi cimentati nella realizzazione di un filmino che raccontasse, anche in modo simpatico, la nostra esperienza e le variefasi del nostro lavoro.SOME IMPORTANT FACTS ABOUT THE LATIN-AMERICAN SITUATION IN THE USAPopulationThe grafic about percentuage of total popultion in the USA shows that by the 2005, 71% of people in the US will be white,13% will be hispanic, 12% will be afican-american, 4 will be asian.The ghrafic about the pecentuage of total people shows that in 2050, 53% of people in the USA will be white, 25% will behispanic, 14% will be african-american and 8% will be asian.Youth groupMedian age by race for the blacs incresaed by the end of 1999 and it was of 38 years old, for the white people it was of 30years old and of 25 years old for the hispanic people in the USA.Born in te United StatesPercentiage , by ethnicity and race, of all US residents who were born in this country was of 61,6% for mexicans, 57, 9% puertoricons, 27% for cubans, 30,9% for the central and south americans, 95,7% for whites and 94,4% for african-americans.Home and education The grafics about households by members in 1997 show as that the 26% of hispanic families were composed by two membres,the 24% by three, the 24% by five, the 7% by six and the 5% by seven or more.Instead in the non hispanic families the 43% was composed by two members, the 23% by three, the 21% by four membres,the 9% by five, the 3% by six and 1% by seven or more.About the education of 25-to-34-years-old in 1997, the 67% of hispanics didn’t attend any college, the 16% attented somecolleges and only the 9% got the Bachelor, the 6% Associate’s and only the 2% had an advanced degree.Instead the 40% of non-hispanics didn’t attenda any college, the 23% attented some colleges, the 21% got the Bachelor, the9% attented the Associate’s and only 7% had an advanced degree.
�����������������������
101n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
+�� �� ��� �������� &,���� �� ,��� ��&�� �������
��� ������ ������������ ���
LA VITA EXTRATERRESTRE TRA FANTASIA E RAGIONE
PROLOGOUn cordiale saluto a tutto. Io sono il prologo di questo spettacolo e ho il compito di informarvi su ciò che accadrà tra poco sulpalcoscenico.I ragazzi che vedete recitare davanti ai vostri occhi sono gli alunni della II H del liceo scientifico Galileo Galilei di Perugia, essihanno lavorato a un modulo pluridisciplinare dal titolo “La vita extraterrestre viaggio tra fantasia e ragione” perché , sapete,pare che tra di loro ci siano dei provetti astronomi. Essi si sono messi a studiare i moti dei pianeti e le ellissi, la legge di gravitazioneuniversale, ma non basta. Come degli astronauti hanno compiuto un viaggio nell’universo della fantascienza letteraria ecinematografica, in compagnia di letterati come Brown, Bradbury, Wells, risalendo fino alle radici del genere fantascientifico,indagando il concetto di alieno come diverso, scandagliando la profondità dell’io con E. Allan Poe e F. Kafka, giungendo allaconclusione che… be’, questo non ve lo dico, lo capirete da soli.
SCENA INIZIALE- BUIO- musica (10 secondi)- VOCE FUORI CAMPO
1. Siamo soli nell’universo? Cosa succederebbe se arrivasse un alieno sul nostro pianeta? Come vedrebbe in nostro mondo?Riusciremmo a comunicare con lui?
2. C’è nessuno?3. MONOLOGO ALIENO. Mh……..! che facce toste hanno questi terrestri! Ci trasferiamo
da un paineta all’altro per non farci vedere da loro, sono così curiosi che siamo costretti acambiare continuamente casa per avere un po’ di privacy e con quello che costano oggi gliappartamenti! Marte è il più caro. Bè lì c’è un’atmosfera, ha l’asse inclinato e quindi ci sonole stagioni e poi le calotte polari. Scusate se è poco…. Ma ora torniamo ai terrestri. Dallemie parti sono soprannominati “guardoni”, stanno lontano da noi milioni di anni luce e tuttavianon siamo più liberi di avere i nostri piccoli segreti perché questi con i loro occhi allungabilia forma di tubo non fanno altro che guardarci. E poi sono anche sciocchi, vogliono guardarele stelle illuminandole e non capiscono che più illuminano il cielo e meno vedono i suoi segreti.E guarda come hanno ridotto il povero loro pianeta: l’effetto serra, il buco nell’ozono, loscioglimento dei ghiacciai……
II, III, IV SCENA(…)
FINALE- …tutto ciò che esiste è un frammento del grande enigma. Anche voi lo siete: noi siamol’enigma che nessuno risolve.- Allora non ce la puoi dare una risposta?- Una risposta è il tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle. Solo una domanda puòpuntare oltre.
CANZONE FINALE
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003102
�����������������������
"�������� � ������ &,������� (���&�� �������
��� ������ � ���������� ��� &���� ������ � ������!�&
TESTI CREATIVI
Daniela era una ballerina eccezionale, ma ho detto bene, era, perché nessuno ha mai avuto il piacere di vederla ballare.“Paura del palcoscenico” così è che lei lo definiva, ma non credevo fosse possibile rinunciare ai propri sogni, alla propriavita. Eppure lei voleva farlo, ma si sa, i sogni non si possono uccidere. Io avevo avuto la fortuna di assistere a qualche sualezione perché lei non aveva paura della gente che le stava di fronte; lei riteneva che era il palcoscenico, salire lì sopra,guardare tutti dall’alto e … e poi scappare per paura di non farcela.Daniela ballava proprio bene… era di una trasparenza mai vista prima, come fosse fatta di vetro, le si leggevano addossole emozioni, quelle che non tutti riescono a provare ballando o comunque non riescono a far vedere agli altri.Aveva un talento naturale, era davvero grande.Ma non poteva rimanere nel guscio, e così arrivò per lei il momento di salire sul palco e far vedere a tutti ciò di cui eracapace.E fu quello il giorno che rimarrà impresso nella sua vita per sempre.Daniela si fece coraggio e salì sul palco; si aprì il sipario. Rimase in silenzio e soprattutto immobile con lo sguardo fisso nelvuoto. Il pubblico rimase a sua volta paralizzato, incerto su ciò che pensare. Allora lei corse via sciogliendo i suoi lunghicapelli che per l’occasione aveva raccolto.La stessa cosa successe per altre poche volte, perché inizialmente Daniela non si voleva dare per vinta, pensava che cel’avrebbe fatta, che si trattava solo di timidezza.Ma si sbagliava, purtroppo non riusciva ad esprimersi sul palco, di fronte ad un grande pubblico, ci riusciva solo mentreprovava, mentre imparava cose nuove, mentre si allenava, insomma quando sentiva di meno la pressione intorno a lei,credo.Mi ricordo che pianse tanto in quei giorni anche se davanti a me, che ero la sua più grande amica, cercava di non farsivedere, addirittura si sforzava di accennarmi un sorriso.Parlammo tanto di questa sua paura, senza riuscire a sciogliere il problema.Daniela rinunciò a quello per cui aveva lavorato tutta la vita, lasciò la città senza dire niente a nessuno e io non ebbi più suenotizie.Il mio pensiero andava spesso a lei.Avrei voluto aiutarla ma era impossibile.Non sapevo più nulla di lei, addirittura pensavo che avesse potuto fare una sciocchezza, non sapevo nulla della sua nuovavita… fino che un giorno il telefono ha squillato.Ho risposto tranquillamente non pensando a chi potesse essere.All’inizio ci fu il silenzio e proprio quando stavo per riattaccare, Daniela mi ha parlato.E’ stato un tuffo al cuore, ma io ho riconosciuto subito che era lei.E’ stato bellissimo, un’emozione mai provata.Da quel giorno ci sentiamo sempre e ogni tanto ci vediamo, quando possibile, visto che non abita più in Italia.Adesso ha una bambina e un marito stupendi, è sempre felice, ma la sua trasparenza è rimasta tale, come alcuni anni fa,quando ballava; ed è per questo che nel fondo dei suoi occhi vedo un grigiore di tristezza che forse nessuno riuscirà amandare via.Un’ultima cosa, all’inizio affermavo che i sogni non si possono uccidere… mi sbagliavo.
�����������������������
103n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003
"�������� � ������ �� ���� � &) � ���� � ��&�� �����
��� ������ ������� ���
ItalianoI° Teoria della comunicazione-le funzioni linguisticheI° Teoria della comunicazione-le funzioni linguisticheI° Teoria della comunicazione-le funzioni linguisticheI° Teoria della comunicazione-le funzioni linguistiche Il testo pubblicitario, il linguaggio pubblicitario, le figure Il testo pubblicitario, il linguaggio pubblicitario, le figure Il testo pubblicitario, il linguaggio pubblicitario, le figure Il testo pubblicitario, il linguaggio pubblicitario, le figure
retoriche.retoriche.retoriche.retoriche.II° Analisi della pubblicità progresso.II° Analisi della pubblicità progresso.II° Analisi della pubblicità progresso.II° Analisi della pubblicità progresso.III° Dibattito e scelta del temaIII° Dibattito e scelta del temaIII° Dibattito e scelta del temaIII° Dibattito e scelta del temaIV° Giovani e alcool: studio delle cause e degli effettiIV° Giovani e alcool: studio delle cause e degli effettiIV° Giovani e alcool: studio delle cause e degli effettiIV° Giovani e alcool: studio delle cause e degli effetti
dell’alcool sull’organismo.dell’alcool sull’organismo.dell’alcool sull’organismo.dell’alcool sull’organismo.V° Esercizi di BRAIN STORMING V° Esercizi di BRAIN STORMING V° Esercizi di BRAIN STORMING V° Esercizi di BRAIN STORMING ““““Il Rione dell’Alcool”.Il Rione dell’Alcool”.Il Rione dell’Alcool”.Il Rione dell’Alcool”.VI° Analisi di pubblicità rivolte ai giovani ;VI° Analisi di pubblicità rivolte ai giovani ;VI° Analisi di pubblicità rivolte ai giovani ;VI° Analisi di pubblicità rivolte ai giovani ;VII° Verifica sommativa delle conoscenze con la produzioneVII° Verifica sommativa delle conoscenze con la produzioneVII° Verifica sommativa delle conoscenze con la produzioneVII° Verifica sommativa delle conoscenze con la produzione
di un saggio breve.di un saggio breve.di un saggio breve.di un saggio breve.VIII° Divisione in gruppi ed elaborazione di manifestiVIII° Divisione in gruppi ed elaborazione di manifestiVIII° Divisione in gruppi ed elaborazione di manifestiVIII° Divisione in gruppi ed elaborazione di manifesti
pubblicitari contro l’abuso di alcool da parte dei giovanipubblicitari contro l’abuso di alcool da parte dei giovanipubblicitari contro l’abuso di alcool da parte dei giovanipubblicitari contro l’abuso di alcool da parte dei giovani
Lunghi dibattiti in classe, hanno caratterizzato la prima parte dellLunghi dibattiti in classe, hanno caratterizzato la prima parte dellLunghi dibattiti in classe, hanno caratterizzato la prima parte dellLunghi dibattiti in classe, hanno caratterizzato la prima parte dell’attivitattivitattivitattivitàààà e e e ele opinioni sono state talvolta contrastanti: alcuni ragazzi hanno espressole opinioni sono state talvolta contrastanti: alcuni ragazzi hanno espressole opinioni sono state talvolta contrastanti: alcuni ragazzi hanno espressole opinioni sono state talvolta contrastanti: alcuni ragazzi hanno espressoil loro dissenso soprattutto perchil loro dissenso soprattutto perchil loro dissenso soprattutto perchil loro dissenso soprattutto perchéééé non avevano ben capito quali fossero i non avevano ben capito quali fossero i non avevano ben capito quali fossero i non avevano ben capito quali fossero icompiti e gli obiettivi che si dovevano raggiungere; altri hanno detto dicompiti e gli obiettivi che si dovevano raggiungere; altri hanno detto dicompiti e gli obiettivi che si dovevano raggiungere; altri hanno detto dicompiti e gli obiettivi che si dovevano raggiungere; altri hanno detto diaver imparato molte cose interessanti e di essersi invece sentiti parteaver imparato molte cose interessanti e di essersi invece sentiti parteaver imparato molte cose interessanti e di essersi invece sentiti parteaver imparato molte cose interessanti e di essersi invece sentiti parteintegrante del progetto.integrante del progetto.integrante del progetto.integrante del progetto.
Anche per quanto riguarda la metodologia per lavori di gruppo si sonoAnche per quanto riguarda la metodologia per lavori di gruppo si sonoAnche per quanto riguarda la metodologia per lavori di gruppo si sonoAnche per quanto riguarda la metodologia per lavori di gruppo si sonoevidenziate difficoltevidenziate difficoltevidenziate difficoltevidenziate difficoltàààà in quanto i gruppi non sempre sono stati omogenei e in quanto i gruppi non sempre sono stati omogenei e in quanto i gruppi non sempre sono stati omogenei e in quanto i gruppi non sempre sono stati omogenei enon tutti i componenti hanno partecipato attivamente.non tutti i componenti hanno partecipato attivamente.non tutti i componenti hanno partecipato attivamente.non tutti i componenti hanno partecipato attivamente.
Dobbiamo dire perDobbiamo dire perDobbiamo dire perDobbiamo dire peròòòò, che nella rielaborazione del materiale e nella produzione, che nella rielaborazione del materiale e nella produzione, che nella rielaborazione del materiale e nella produzione, che nella rielaborazione del materiale e nella produzionedel cd che presentiamo, la classe ha trovato motivazione pidel cd che presentiamo, la classe ha trovato motivazione pidel cd che presentiamo, la classe ha trovato motivazione pidel cd che presentiamo, la classe ha trovato motivazione piùùùù ampia ampia ampia ampiapotendo esprimere la propria creativitpotendo esprimere la propria creativitpotendo esprimere la propria creativitpotendo esprimere la propria creativitàààà nell nell nell nell’applicazione delle proprieapplicazione delle proprieapplicazione delle proprieapplicazione delle propriecompetenze multimediali.competenze multimediali.competenze multimediali.competenze multimediali.
Al termine di questo progetto possiamo affermare di aver imparato molte coseAl termine di questo progetto possiamo affermare di aver imparato molte coseAl termine di questo progetto possiamo affermare di aver imparato molte coseAl termine di questo progetto possiamo affermare di aver imparato molte cosenuove;nuove;nuove;nuove;
di aver approfondito argomenti, che altrimenti non avremmo trattato nelladi aver approfondito argomenti, che altrimenti non avremmo trattato nelladi aver approfondito argomenti, che altrimenti non avremmo trattato nelladi aver approfondito argomenti, che altrimenti non avremmo trattato nellaconsueta programmazione scolastica e soprattutto ci sentiamo di poterconsueta programmazione scolastica e soprattutto ci sentiamo di poterconsueta programmazione scolastica e soprattutto ci sentiamo di poterconsueta programmazione scolastica e soprattutto ci sentiamo di poterdire di aver raggiunto ldire di aver raggiunto ldire di aver raggiunto ldire di aver raggiunto l’obiettivo piobiettivo piobiettivo piobiettivo piùùùù importante: importante: importante: importante: èèèè migliorata l migliorata l migliorata l migliorata l’unitunitunitunitààààdella classe, abbiamo imparato a collaborare ed anche a conoscerci megliodella classe, abbiamo imparato a collaborare ed anche a conoscerci megliodella classe, abbiamo imparato a collaborare ed anche a conoscerci megliodella classe, abbiamo imparato a collaborare ed anche a conoscerci megliosia negli aspetti negativi sia in quelli positivi.sia negli aspetti negativi sia in quelli positivi.sia negli aspetti negativi sia in quelli positivi.sia negli aspetti negativi sia in quelli positivi.
Riflessioni alla fine dei due anniRiflessioni alla fine dei due anniRiflessioni alla fine dei due anniRiflessioni alla fine dei due anniRiflessioni alla fine dei due anniRiflessioni alla fine dei due anniRiflessioni alla fine dei due anniRiflessioni alla fine dei due anni
Da due anni la nostra classe Da due anni la nostra classe Da due anni la nostra classe Da due anni la nostra classe èèèè coinvolta nel progetto coinvolta nel progetto coinvolta nel progetto coinvolta nel progetto “ Scuola Scuola Scuola ScuolaPromotrice di SalutePromotrice di SalutePromotrice di SalutePromotrice di Salute”. Quest. Quest. Quest. Quest’attivitattivitattivitattivitàààà ci ha fatto maturare sia come ci ha fatto maturare sia come ci ha fatto maturare sia come ci ha fatto maturare sia comegruppo classe, sia come individui.gruppo classe, sia come individui.gruppo classe, sia come individui.gruppo classe, sia come individui.
Inizialmente, eravamo un poInizialmente, eravamo un poInizialmente, eravamo un poInizialmente, eravamo un po’ titubanti ed il nostro atteggiamento non titubanti ed il nostro atteggiamento non titubanti ed il nostro atteggiamento non titubanti ed il nostro atteggiamento nonèèèè sempre stato positivo, ma con il passare del tempo ci siamo sentiti sempre stato positivo, ma con il passare del tempo ci siamo sentiti sempre stato positivo, ma con il passare del tempo ci siamo sentiti sempre stato positivo, ma con il passare del tempo ci siamo sentitimaggiormente motivati e responsabili per la riuscita del lavoro, ed ilmaggiormente motivati e responsabili per la riuscita del lavoro, ed ilmaggiormente motivati e responsabili per la riuscita del lavoro, ed ilmaggiormente motivati e responsabili per la riuscita del lavoro, ed ilnostro impegno nostro impegno nostro impegno nostro impegno èèèè cos cos cos cosìììì aumentato. aumentato. aumentato. aumentato.
Durante il primo anno non ci sentivamo molto coinvolti perchDurante il primo anno non ci sentivamo molto coinvolti perchDurante il primo anno non ci sentivamo molto coinvolti perchDurante il primo anno non ci sentivamo molto coinvolti perchéééédovevamo soltanto analizzare la struttura del nostro istituto, eddovevamo soltanto analizzare la struttura del nostro istituto, eddovevamo soltanto analizzare la struttura del nostro istituto, eddovevamo soltanto analizzare la struttura del nostro istituto, edesprimere opinioni su un ambiente con il quale eravamo venuti daesprimere opinioni su un ambiente con il quale eravamo venuti daesprimere opinioni su un ambiente con il quale eravamo venuti daesprimere opinioni su un ambiente con il quale eravamo venuti dapoco a contatto e che ancora sentivamo estraneo.poco a contatto e che ancora sentivamo estraneo.poco a contatto e che ancora sentivamo estraneo.poco a contatto e che ancora sentivamo estraneo.
QuestQuestQuestQuest’ anno invece, siamo stati i veri e propri anno invece, siamo stati i veri e propri anno invece, siamo stati i veri e propri anno invece, siamo stati i veri e propri “ protagonisti protagonisti protagonisti protagonisti “ del del del delprogetto, sebbene non sempre a nostro agio in tale ruolo.progetto, sebbene non sempre a nostro agio in tale ruolo.progetto, sebbene non sempre a nostro agio in tale ruolo.progetto, sebbene non sempre a nostro agio in tale ruolo.
Area scientificaArea scientifica
Scienze della Natura, Scienze della MateriaMatematica, Educazione Fisica
n° 183 - 184 - 185 - 186 Maggio - Dicembre 2003104
�����������������������
"�������� ������� � ������ � &*������� �� ����&�� �������
��� ������ � ���������� ��� &'� ��� �&
L'insegnante ha precedentamente chiesto agli studentidi raccogliere grafici da quotidiani, riviste, libriscolastici, ecc... .
Obiettivi educativi- acquisire la capacità di ricerca su un compito assegnanto- acquisire la capapcità di analizzare- acquisire la capacità di lavorare in gruppo
Obiettivi didattici- capire l'importanza di alcuni elementi per una corretta
lettura di un grafico- saper individuare da un grafico le grandezze in gioco e
alcune semplici relazioni
Metodo- l'insegnante distribuisce i grafici raccolti e chiarisce quali
informazioni ricercare sui grafici- ciscuna alunna analizza grafici a propria disposizione
attraverso una scheda di rilevazione- lavoro di gruppo per il confronto e la discussione sulle
osservazioni individuali- ogni gruppo illustra gli esiti della discussione attraverso un
"relatore"- l'insegnante opera una sintesi
Valutazione"Diario di bordo"
L'insegnante formalizza il concetto di funzione
Obiettivi educativi- sviluppare le capacità di ascolto- sviluppare la capacità di formalizzare concetti già
introdotti- sviluppare la capacità di lavorare in gruppo- comprendere l'importanza dei propri contributi
Obiettivi didattici- comprendere il concetto di funzione- conoscere e saper ripetere correttamente la definizione di
funzione- conoscere e comprendere i concetti di dominio, codominio
e grafico di una funzione
Metodo- lezione frontale dell'insegnante- la classe è divisa in gruppi- compito del gruppo attraverso un "relatore"- discussione
Valutazione"Diari di bordo"