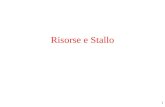P R MM SS...massimizzare i risultati impiegando al meglio date risorse. In esse si consumano risorse...
Transcript of P R MM SS...massimizzare i risultati impiegando al meglio date risorse. In esse si consumano risorse...

““IILL CCOONNCCEETTTTOO DDII AAZZIIEENNDDAA EE
LLEE SSUUEE PPRRIINNCCIIPPAALLII
CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE””
PPRROOFF.. MMAARRCCOO SSOORRRREENNTTIINNOO

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
2 di 22
Indice
1 ATTIVITÀ ECONOMICHE, UNITÀ ECONOMICHE E AZIENDE----------------------------------------------- 3
2 CARATTERI DISTINTIVI E MISSIONE DELL'AZIENDA -------------------------------------------------------- 6
3 CLASSI DI AZIENDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
3 di 22
1 Attività economiche, unità economiche e aziende1
Nella sua esistenza, l'uomo manifesta di continuo bisogni o desideri di varia natura, per
soddisfare i quali si attiva nella ricerca di beni e servizi, ossia risorse e mezzi, atti ad appagarli.
Alcuni di tali bisogni sono essenziali o indifferibili, poiché connaturati alla stessa sopravvivenza;
altri, invece, si definiscono voluttuari o differibili; questi ultimi possono facilmente mutare nel
tempo o subire condizionamenti esterni, e occupano pertanto posizioni variabili nella scala dei
valori dei singoli individui o di un'intera società umana, presso cui si collocano di conseguenza in
un ordine gerarchico, soggetto a modificazioni. Appartengono alla prima categoria bisogni quali il
nutrimento, il riposo, e così via. Rientrano nella seconda i bisogni del divertimento, della cultura, e
così via.
Dunque, nel momento in cui percepisce la carenza di certe condizioni, ossia avverte un bisogno o
desiderio, l'uomo si adopera per soddisfarlo, cioè agisce, pone in essere una data attività che gli
consenta di ottenere i beni o risorse indispensabili allo scopo. Notava giustamente Amodeo2 che
«bisogno, in significato economico, non vi è ove non vi sia carenza dei mezzi che potrebbero
soddisfarlo; e non vi è nemmeno quando quei mezzi siano assolutamente inesistenti. Il bisogno
presuppone il mezzo di soddisfazione e ne postula la carenza presso il soggetto che il bisogno
avverte».
Ora, com'è noto, i beni o risorse sono distinguibili in due classi: non economici ed economici. I
primi sono quei beni disponibili in natura in quantità illimitata, liberamente e agevolmente
acquisibili, e possono pertanto soddisfare senza limitazioni i bisogni di chiunque li ricerchi.
I beni economici sono invece scarsi rispetto alle esigenze degli individui, i quali non possono
facilmente acquisirli e sono pertanto indotti di continuo a compiere scelte e a ingegnarsi e
adoperarsi per riuscire ad appagare i bisogni avvertiti.
L'attività umana è dunque diretta alla soddisfazione di bisogni o desideri, attraverso la ricerca di
beni o risorse di ogni tipo. Essa viene definita attività economica, allorché diventa indispensabile
l'uso di beni, risorse ovvero mezzi che sono scarsi. L'attività umana è sempre fatta di scelte; quando
1 La presente dispensa è tratta da: L. Potito, Azienda ed economia aziendale, in AAVV, “Economia Aziendale”,
Giappichelli Editore, 2012, pp. 1-19. 2 D. Amodeo, Ragioneria generale, p. 4.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
4 di 22
è di natura economica, nel senso che deve confrontarsi con il limite della scarsità dei mezzi
disponibili, le scelte sono scelte economiche. Queste tendono costantemente verso l'obiettivo di
cogliere il miglior rapporto possibile tra mezzi (scarsi) e bisogni da soddisfare (secondo un dato
ordine gerarchico).
Prima di proseguire, si rendono a questo punto opportune due puntualizzazioni:
a. come si è visto, al termine beni si sono talvolta accostati altri termini quali risorse e mezzi.
Ciò per rendere palese che quando si parla di beni, in particolare di quelli economici, non si
fa riferimento soltanto a qualcosa provvisto di materialità, quale può essere un'auto o una
scatola di biscotti. Ma vi si comprendono, in primo luogo, tutti i servizi possibili (da quelli
commerciali, a quelli professionali e artigianali di ogni specie, da quelli sanitari a quelli
connessi alla formazione e all'istruzione, e così via); e, poi, i beni immateriali o, più in
generale, ogni tipo di risorsa intangibile: si pensi alle conoscenze, alle informazioni, ma
anche alle rappresentazioni artistiche, alle manifestazioni di carattere religioso, agli eventi
musicali e culturali, e così via. Insomma a tutto ciò che può appagare sul piano fisico,
psichico e spirituale l'uomo moderno. Anzi, i bisogni del giorno d'oggi spingono verso
l'espansione, come si vedrà più avanti, della produzione di risorse immateriali e intangibili.
b. è stato chiarito che le scelte economiche sono scelte umane, ma particolari. Ne discende che
esse, in quanto tali (umane), sempre e necessariamente, risentono dell'influenza di
molteplici fattori extraeconomici, di natura culturale, etica, religiosa, sociale, ideologica,
nonché legati all'esperienza, alle preferenze individuali o alle convinzioni politiche. Non si
tratta dunque, se non raramente, di scelte in cui il calcolo economico gioca un ruolo esclu-
sivo. Spesso non sono neanche del tutto razionali, come pure, astrattamente, qualcuno
potrebbe essere indotto a ritenere.
Nel sistema economico odierno svolgono attività economica diversi soggetti: singoli individui,
gruppi di persone, entità diversamente organizzate e complesse. Essi sono tutti unità economiche,
dalle più semplici a quelle di più vaste dimensioni e di più varia composizione. In tutte ritroviamo
comportamenti tesi a minimizzare l'uso delle risorse in vista del raggiungimento di dati risultati, o a
massimizzare i risultati impiegando al meglio date risorse. In esse si consumano risorse (intendendo
per tali, come s'è detto, beni materiali, servizi, intangibili), o si producono risorse, o, ancora, si
trasferiscono risorse ad altre unità, essendo forti e frequenti le relazioni e i legami tra loro
intercorrenti. Consumi, produzioni e trasferimenti sono, appunto, momenti tipici dell'attività
economica.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
5 di 22
Se si vuole individuare l'azienda, oggetto centrale dell'Economia Aziendale, bisogna riferirsi, tra
quelle prima indicate, alle unità economiche costituite da entità organizzate e complesse. Queste,
mentre consentono di soddisfare i bisogni di coloro che a vario titolo ne fanno parte o che
comunque contribuiscono allo svolgimento della loro attività, hanno come obiettivo fondamentale
quello di apprestare beni economici da cedere ad altri soggetti, così che questi possano a loro volta
soddisfare propri bisogni.
Ciò che ora sinteticamente si è detto, meglio sarà chiarito e sviluppato più avanti. Ma intanto è
opportuno subito precisare che non è azienda ogni unità economica di questo tipo. E azienda l'unità
economica provvista di determinati caratteri, mancando i quali l'unità economica resta una non
azienda.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
6 di 22
2 Caratteri distintivi e missione dell'azienda
Secondo quanto prevalentemente oggi si ritiene, un'unità economica può considerarsi un'azienda, se
possiede i seguenti caratteri:
a. coordinazione sistemica;
b. economicità;
c. autonomia.
A prima vista, sapere che una realtà osservata sia un'azienda o una semplice unità economica
potrebbe sembrare irrilevante; non lo è invece per l'aziendalista. Difatti, occorre essere coscienti del
fatto che soltanto alle aziende è possibile applicare i principi, le regole e gli strumenti elaborati dal-
le discipline aziendali. L'adozione dei concetti e dei modelli dell'organizzazione e della gestione
delle attività, l'implementazione dei sistemi di controllo e, in genere, dei sistemi informativi, sono
soltanto alcuni esempi di principi e strumenti che sono preclusi alle non aziende.
Dalle argomentazioni appena sviluppate consegue la possibilità di configurare un continuum tra le
unità economiche più complesse e articolate: tra i due estremi - aziende e non aziende - trovano
collocazione tutte le attività economiche, da quelle provviste di tutti i requisiti prima indicati fino a
quelle prive di qualcuno di essi o di tutti.
Infine, in merito ai suddetti caratteri si osserva che la dottrina più avveduta li considera elementi di
un nucleo centrale, composto per l'appunto dalla coordinazione sistemica, dall'economicità e
dall'autonomia, tra loro strettamente collegate, che consentono all'azienda non solo di essere tale,
ma anche di conservare la condizione d'esistenza fondamentale ed essenziale, che è la durabilità,
ovvero la continuità del suo funzionamento in prospettiva nel tempo. Intorno a tale nucleo, possono
individuarsi altre caratteristiche e condizioni identificative, alcune, a ben vedere, implicite nel
concetto stesso di attività economica3.
3 Secondo Vigano, un'attività economica configura un'azienda se, unitamente alla coordinazione
sistemica:
«attua processi economici di acquisizione, di produzione, di scambio e di erogazione, misurabili o
meno monetariamente;
c'è gestione per operazioni e funzioni;
è composta di beni e persone. Si forma un patrimonio;
c'è coordinazione spazio-temporale (sistema);

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
7 di 22
Ora si approfondisce meglio il significato attribuibile agli indicati caratteri.
a) Coordinazione sistemica
L'azienda è composta da un insieme di elementi interagenti e interdipendenti, vale a dire legati tra
loro da relazioni e rapporti di dipendenza reciproca. In tal senso essa costituisce un sistema.
I due elementi fondamentali che compongono la struttura di un'azienda sono il lavoro e il
patrimonio. Il primo s'identifica con il personale che vi opera, mentre il secondo con i beni
necessari allo svolgimento delle attività. Può trattarsi di beni materiali, particolarmente presenti in
aziende in cui si attuano produzioni tecniche, ma anche, e sempre più spesso, di risorse immateriali,
talvolta meglio definibili intangibili. Ci si riferisce a: modelli, formule, know how, software, diritti,
ma anche a conoscenze e competenze specifiche, a risorse legate all'informazione, alle relazioni
sviluppate, a prassi e culture costruite nel tempo.
Posto preliminarmente ciò, si osserva che, nel momento in cui nasce un'azienda, la qualità e la
quantità delle risorse, monetarie o d'altra natura, apportate sono il frutto di complesse decisioni,
volte a individuare la combinazione più conveniente in rapporto all'ambiente e ai risultati che
s'intende ottenere. Tale condizione deve conservarsi per tutta la vita dell'azienda, giacché la scelta
di ogni elemento o fattore che entra a far parte di un'azienda deve basarsi su valutazioni che
tengono conto della compatibilità di ciascuno con tutti gli altri che partecipano alla combinazione
produttiva, così che, in modo coordinato, essi assicurino la formazione di un insieme armonico, in
grado di generare valore e utilità.
si pone finalità mutevoli;
con la sua attività soddisfa automaticamente bisogni umani di natura economica;
è autonoma e duratura;
tende all'efficienza del suo funzionamento; si pone obiettivi che tende a conseguire;
vi è un'innata componente di rischio:
esterna (mercato, ambiente);
interna;
vi è un soggetto economico, specifico e consapevole, in grado di incidere sul funzionamento e sulle
finalità dell'azienda senza peraltro sovvertirne la forza di esistenza autonoma;
vi è un governance:.
diretto;
in rapporto con la proprietà;
c’è una regolamentazione giuridica esplicita per il suo vestito;
rispetta regole di condotta (etica)».
E. Viganò , Il concetto generale, pp. 635-636.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
8 di 22
Tutto questo determina che gli elementi della struttura aziendale e, ancora prima, le decisioni dalle
quali promanano tali elementi, si trovino in stretta correlazione tra loro. L'azienda, in tal modo,
assume l'immagine di una coordinazione sistemica che è, a ben vedere, una conseguenza della co-
mune finalità verso cui tendono tutti gli elementi della combinazione, cioè della finalizzazione del
sistema, che meglio sarà chiarita in seguito.
In effetti, la visione sistemica è prima di tutto un atteggiamento mentale di tutti quelli che a vario
titolo e livello partecipano alla vita dell'azienda. Atteggiamento che si forma lentamente, attraverso
la formazione, la cultura e l'esperienza; ecco perché un'azienda, di qualsiasi tipo essa sia, risulta mal
condotta se mancano le necessarie competenze.
Le decisioni e gli elementi strutturali del sistema aziendale consentono di attuare operazioni e
processi, che vanno creati naturalmente in maniera non casuale ma tenendo conto dei legami che
sussistono con operazioni e processi già in precedenza avviati e con quelli che si ha in animo di
intraprendere in futuro. Anche in tal caso i legami che sussistono tra le operazioni aziendali
derivano dal comune orientamento che le pervade.
Infine, l'azienda è un sistema di tipo aperto. È inserita come ogni sistema in un ambiente, col quale
costantemente interagisce: nel senso che dall'ambiente esterno provengono i suoi input, e a esso
vanno i suoi output. Poiché l'ambiente è in continuo movimento, l'azienda è tenuta a essere molto
dinamica e flessibile, adattando con frequenza e rapidità le proprie combinazioni produttive alle
mutazioni delle condizioni esterne.
Mai come in questi ultimi anni, all'azienda è chiesto altresì di porre le esigenze dei soggetti cui il
suo output è destinato, e dell'ambiente in generale, al centro della sua attenzione e dei suoi
comportamenti.
b) Economicità
È un carattere non semplice, e quindi non definibile facilmente, se non a rischio di darne un'idea
approssimativa. Esso poi assume connotati differenti secondo il tipo di azienda, la natura della sua
attività, il contesto in cui agisce. Comunque, come s'è detto, l'azienda è un sistema finalizzato. Ogni
decisione, ogni comportamento deve trovare ispirazione in un orientamento generale di fondo che
conduce verso un obiettivo generale, declinato volta per volta in obiettivi più immediati, per giunta
da rettificare di continuo.
L'obiettivo di fondo perseguito dalle aziende di ogni specie è di operare in una stabile condizione di
equilibrio.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
9 di 22
E per questa ragione che il requisito dell'economicità risulta garantito, in primo luogo, quando si
pone l'azienda in grado di funzionare nella condizione di equilibrio, economico finanziario e
monetario4. L'esistenza di tale condizione, però, non è valutabile se non con riferimento a un
orizzonte temporale piuttosto lungo, poiché non avrebbe alcun senso che essa sia soltanto
provvisoriamente raggiunta o comunque mantenuta per un limitato periodo. Si aggiunga che tale
condizione, una volta acquisita, tende per sua natura a non conservarsi costante nel tempo, a causa
del dinamismo sia dell'ambiente, sia dello stesso sistema aziendale. Essa è perciò destinata a essere
continuamente compromessa da ostacoli, interferenze, fattori ed eventi contrari, di origine sia
esterna, sia interna.
Per la sua conservazione, pertanto, si richiedono scelte e comportamenti fondati su una convinta e
persistente tensione verso l'equilibrio e che con tempestività siano in grado di ripristinarlo
rapidamente ogni volta che si mostri intaccato. In definitiva, una condotta, da parte dei responsabili
del governo aziendale, che voglia essere avveduta, richiede consapevolezza dell'incertezza, capacità
di percepire per tempo i rischi sapendoli poi fronteggiare, competenza nell'individuare carenze e
disfunzioni, volontà di assumere con rapidità e flessibilità decisioni conseguenti e appropriate.
Il principio di economicità comporta, poi, che l'azienda sappia attrarre le risorse che meglio siano
compatibili con le proprie esigenze, assicurandoseli al massimo livello di convenienza economica;
il che si ottiene se essa è in grado di stabilire con i fornitori delle risorse (beni e servizi) relazioni
che vengono ritenute soddisfacenti, nel senso che chi fornisce tali risorse si riconosca
adeguatamente remunerato. In questo modo l'azienda riesce a ricevere apporti di mezzi produttivi
coerenti con i propri modi di operare, e provvisti di elevata convenienza, in quanto a regolarità,
qualità, tempi e condizioni.
4 I temi dell'equilibrio economico e di quello finanziario saranno approfonditi in seguito. A questo
punto è sufficiente dire che la gestione aziendale può riguardarsi sotto due principali aspetti:
economico e finanziario. Nel primo, essa risulta osservata con riguardo all’effetto che le sue
operazioni determinano sulla complessiva ricchezza aziendale, nel secondo con riguardo agli effetti
che si hanno sull'andamento delle risorse finanziarie disponibili. Ciò premesso, l'equilibrio
economico è assicurato se la gestione produce effetti positivi sulla complessiva ricchezza aziendale;
l'equilibrio finanziario si ha quando la naturale alternanza tra acquisizioni e impieghi di risorse
finanziarie è tale da consentire all'azienda di essere sempre capace di fronteggiare i suoi impegni
di pagamento. Se, nell'ambito delle risorse finanziarie, si osservano solo gli andamenti delle risorse
liquide (liquidità immediate o pressoché tali) si evidenzia l'aspetto monetario della gestione, di cui
può parimenti apprezzarsi l'equilibrio.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
10 di 22
Economicità significa altresì che l'azienda sappia utilizzare nel modo più conveniente possibile i
mezzi produttivi di cui si procura la disponibilità, riuscendo a ottenere, con il loro impiego, il
massimo risultato possibile (efficienza operativa).
Significa ancora che i processi produttivi aziendali, per il modo con cui sono selezionati, impostati
e attuati, siano in grado di pervenire a risultati, ovvero output, che soddisfino al meglio, cioè al
massimo livello possibile, le attese dei soggetti cui sono destinati (efficacia strategica). Sicché dai
destinatari essa si metta in condizione di ricevere il massimo consenso5.
In merito a quest'ultimo punto, tuttavia, c'è da osservare che la configurazione dei processi
produttivi aziendali non è soltanto una conseguenza dei mutamenti intervenuti nell'ambiente e, in
particolare, nelle esigenze dei soggetti destinatari degli output aziendali. Una simile accezione di
efficacia strategica sottintende, a ben vedere, un rapporto dell'azienda con l'ambiente esterno
soltanto di tipo «reattivo», giacché considera i mutamenti in esso avvenuti alla stregua di impulsi
che, captati e poi selezionati alla luce delle risorse interne possedute, i responsabili aziendali
recepiscono nella propria condotta, adeguando a essi i processi produttivi, nonché gli assetti
strutturali dell'intera azienda. Negli ultimi anni invece sono sempre più frequenti i casi di aziende
che riescono a indirizzare l'ambiente verso i cambiamenti che sono loro più congeniali in relazione
alle competenze e alle conoscenze da esse possedute, così che si possano creare vantaggi rispetto ai
concorrenti che ne siano invece sprovvisti. In tali casi, le aziende da reattive diventano proattive o
anticipative e le condotte intraprese non sono più condizionate esclusivamente dall'ambiente.
In definitiva, da quanto sin qui, seppure brevemente, detto, si ritiene che sia emerso con chiarezza
quanto sia complesso il concetto di economicità. Nel quale perciò sono da considerare rientranti:
condizione di equilibrio (non provvisorio) considerato in tutti i suoi aspetti, adeguata remunerazio-
ne dei fattori produttivi acquisiti, efficacia strategica in relazione agli obiettivi di risultato da
raggiungere, efficienza operativa nell'uso delle risorse. Ciò implica che complessa è anche la
valutazione che se ne riesce a dare; in effetti, questa è fattibile solo se si utilizza un insieme
5 I concetti di efficienza e di efficacia saranno chiariti più dettagliatamente in seguito. Intanto,
sinteticamente si ricorda che, per efficacia, s'intende la capacità di raggiungere gli obiettivi e, per
efficienza, la capacità di minimizzare l'impiego di risorse nel raggiungimento degli obiettivi. Se,
dunque, per strategia s'intende la definizione degli obiettivi e degli indirizzi fondamentali
dell'azienda, nonché le scelte e le politiche, atte a conseguirli, assunte dai massimi vertici aziendali,
risulterà chiaro il significato di efficacia strategica, quale capacità di elaborare scelte strategiche
idonee: cioè di saper fissare e centrare gli obiettivi aziendali.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
11 di 22
articolato e differenziato di strumenti rilevatori, di natura, sia quantitativa, sia anche qualitativa,
come sarà successivamente meglio esposto. Sin da ora, però, deve essere chiaro che la presenza di
un'adeguata economicità nella gestione aziendale non può essere valutata limitandosi all'analisi dei
risultati di bilancio o comunque dei soli dati economico-finanziari. Un risultato positivo, o una serie
di risultati positivi, conseguiti a un certo momento o anche per un breve periodo di tempo, non
garantiscono l'esistenza di economicità. E ciò sia perché tali risultati assumono un significato solo
parziale in relazione ai contenuti dell'economicità, sia perché sono indicatori il cui orizzonte
temporale di riferimento si esaurisce nel breve termine.
c) Autonomia
L'autonomia rappresenta lo stato dell'azienda che agisce in vista del conseguimento dei suoi
obiettivi, in cui comportamenti e decisioni sono assunti in piena indipendenza e tenendo di mira
l'esclusiva convenienza dell'azienda stessa, senza essere in alcun modo assoggettati agli interessi o
alle influenze dei soggetti che la governano, o che a vario titolo vi operano.
Naturalmente i comportamenti e le decisioni aziendali sono sempre il frutto di volontà personali; di
qui l'esigenza, specialmente avvertita nelle aziende di certe dimensioni, di istituire, all'interno,
meccanismi e procedure che, limitando azioni arbitrarie, impediscano di assumere condotte
devianti.
Negli ultimi anni si sta insistendo in modo particolare sull'uomo quale vero motore dell'azienda; su
come l'azienda ne possa rappresentare uno strumento per il raggiungimento di propri fini; su come
gli obiettivi assunti dall'azienda debbano essere preliminarmente condivisi dai soggetti che vi
operano e poi trovare diffusione a ogni livello organizzativo. In tal modo, si garantisce quel
processo di allineamento tra le finalità dell'azienda e quelle dei soggetti che vi partecipano e si
creano i presupposti per assicurarne la continuità nel tempo.
Quello dell'autonomia è un requisito che un'attività economica riesce a garantirsi con molta
difficoltà: l'autonomia presuppone innanzitutto l'indipendenza economica, cioè occorre evitare che
la possibilità di continuare ad attuare i processi produttivi sia sistematicamente subordinata al
ricevimento di risorse che vengono fornite da terze economie.
È l'azienda che, con il suo operare, deve mostrarsi in grado di riavviare, via via che giungono a
compimento, i suoi processi produttivi, grazie al riaflusso delle risorse in precedenza impiegate. Gli
interventi di sostegno da parte di altre economie possono anche ammettersi, anzi sono spesso indi-

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
12 di 22
spensabili, purché abbiano natura temporanea e non forniscano sistematici aggiustamenti a gestioni
generatrici di perdite, cioè distruttrici di ricchezza.
Dalle considerazioni testé presentate emerge come l'autonomia costituisca un carattere intimamente
legato a quello dell'economicità. Un'azienda è autonoma quando riesce a operare in condizioni di
economicità, e quando, conservando la capacità di decidere in maniera indipendente, può attuare
ogni azione che favorisca, in ogni tempo, il mantenimento di tali condizioni.
Un'ultima annotazione concerne la relatività del concetto di autonomia.
Come da più parti si osserva, nell'attuale fase dello sviluppo economico la separazione tra le
aziende non può essere proposta in modo netto e rigoroso. In effetti, il successo di un'azienda, mai
come in questa epoca, si mostra spesso dipendente dalle relazioni che essa è in grado di istituire con
altre aziende, e dalle quali inevitabilmente provengono poi condizionamenti. Si pensi alle
molteplici forme d'intese e di alleanze fra aziende, grazie alle quali si riesce a scambiare risorse,
know how, capacità e conoscenze. Da esse possono sicuramente derivare, insieme a molti vantaggi,
anche vincoli più o meno stringenti nell'espletamento di alcune delle tipiche funzioni aziendali,
come, per esempio, gli acquisti o la distribuzione dei prodotti. Ciò accade pure allorché l'azienda
decide di aderire a reti. Queste, specialmente attive in certi settori, costituiscono di frequente, per le
aziende, un'opportunità per superare le debolezze legate alla piccola dimensione e per creare valore,
interagendo con altre aziende6. Si tratta, infatti, di collaborazioni organizzate - in forme le più
diverse - fra una pluralità di aziende (in particolare di quelle che producono beni e servizi), e che
oggi peraltro possono trarre vantaggio, e stimolo, dalla prodigiosa diffusione delle tecnologie
informatiche. La caratteristica delle reti è l'interdipendenza che si crea fra le aziende partecipanti.
Esse, facendo massa critica, riescono a competere con successo, anche sui mercati internazionali,
pervenendo a prodotti che richiedono conoscenze differenziate e complesse, alla cui realizzazione
ciascuna azienda contribuisce con le proprie specifiche competenze. Ma la collaborazione e la
condivisione di esperienze agisce anche da stimolo per accrescere le conoscenze e le competenze
già possedute da ciascuna partecipante, cioè per innescare processi di ulteriore apprendimento.
Infine, l'autonomia aziendale assume connotati molto sfornati quando l'azienda fa parte di un
gruppo. Questo, com'è noto, si caratterizza per l'esistenza di una pluralità (variamente estesa) di
aziende, le quali, sebbene indipendenti dal punto di vista giuridico, in realtà sono fra loro collegate
dal fatto di essere tutte direttamente o indirettamente controllate da un unico soggetto: la

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
13 di 22
capogruppo (o holding). In altri termini, i soggetti giuridici delle singole aziende sono distinti, ma il
soggetto economico è comune. Ora è chiaro che l'attività di indirizzo e di coordinamento di ogni
azienda appartenente al gruppo è accentrata presso la capogruppo, dove è collocato il soggetto
economico. Ne consegue che l'autonomia decisionale della singola azienda risulta limitata in misura
più o meno ampia, a seconda del modello organizzativo e della politica di governo che la capo-
gruppo adotta nei vari casi.
È stato giustamente affermato che «l'azienda - quali che siano le finalità che la orientano, le
attività svolte e le condizioni di contesto - deve intendersi sempre e comunque come un "fatto di
produzione"»7.
La funzione di produzione - di beni e di servizi, ovvero, più in generale, di utilità e di valore - è ciò
che accomuna ogni tipo di azienda, qualunque sia la sua attività: dalla fabbrica di occhiali alla
banca, dal supermercato al museo, dall'agenzia di pubblicità all'Azienda Sanitaria Locale.
Indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalle caratteristiche del mercato in cui opera, dal
modello di governo adottato, ogni azienda si trova a fronteggiare analoghi problemi strategici,
operativi, organizzativi, relativi al personale, e così via; e in modo simile si confronta con
l'ambiente esterno, con le altre aziende, con i tanti altri soggetti esterni con cui entra in contatto, con
l'incertezza e con i rischi.
La funzione di produzione può definirsi la sua missione. L'azienda è uno strumento per soddisfare
bisogni umani, in quanto produce output utili a tale scopo. Ma nel contempo soddisfa i bisogni di
chi ne è titolare, di chi vi lavora, di chi a essa apporta risorse e fattori produttivi.
I bisogni pertanto determinano e condizionano la funzione di produzione delle aziende, ne
influenzano modalità attuative e configurazioni. Ma può anche accadere, in determinate condizioni,
che vi siano aziende che riescono a suscitare nuovi bisogni o a modificare quelli esistenti.
La funzione produttiva prevede tre momenti tipici, idealmente distinguibili:
l'acquisizione all'esterno di ogni risorsa (finanziaria, umana, materiale, intangibile) necessaria a
impostare e intraprendere l'attività produttiva;
il consumo delle risorse acquisite per eseguire e portare a termine i processi produttivi. Il
consumo avviene attraverso il più conveniente utilizzo coordinato di tali risorse, attuando
6 Peraltro, anche medie e grandi aziende spesso organizzano le proprie relazioni interaziendali
secondo forme e logiche reticolari.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
14 di 22
appunto le cosiddette combinazioni produttive, secondo le modalità più idonee in relazione
all'output cui l'azienda è finalizzata;
la destinazione all'esterno di quanto ottenuto. Il che può avvenire mediante scambio o
erogazione:
- lo scambio sottintende la presenza di mercati in cui i partecipanti danno luogo a libere
negoziazioni. Lo scambio, naturalmente, presuppone un corrispettivo, generalmente
monetario;
- l'erogazione è una cessione degli output in assenza di negoziazione, e potrebbe anche
consistere, in certe aziende, in atti di pura liberalità.
7 Soc ietà I tal iana dei Docenti d i Ragioner ia e d i Economia Aziendale ( SIDREA), Manifesto dei
soci promotori, in “Appunti per un dibattito sulla cultura aziendale”, p. 5. Documento pubblicato sul sito
www.sidrea.it.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
15 di 22
3 Classi di aziende
Preliminarmente alla classificazione delle aziende, giova definire i concetti di soggetto
economico e soggetto giuridico.
Con l'espressione soggetto economico s'identifica la massima autorità di governo dell'azienda, chi
ne determina gli indirizzi di fondo e ne ritrae i conseguenti benefici. In una piccola azienda,
appartenente a un unico proprietario (ditta individuale), è generalmente egli stesso il soggetto
economico. Se l'azienda appartiene a più soci, questi possono tutti comporre il soggetto economico
(specialmente nelle piccole società a carattere personale), oppure questa figura può restringersi a
chi o a coloro che hanno la maggioranza del capitale, oppure a chi - per la riconosciuta competenza
o per il possesso di una spiccata personalità - si riconosce di fatto il massimo potere. In molte altre
realtà, soprattutto di maggiori dimensioni, non è raro che il soggetto economico, cioè la funzione di
guida e di governo, si trovi distribuito tra più persone, alcune delle quali possono anche essere
estranee alla proprietà dell'azienda: manager di particolare prestigio, consulenti autorevoli, ma
talvolta anche grossi creditori (in particolare, banche) che nelle aziende fortemente indebitate
acquisiscono, proprio per tale ragione, la facoltà di apportare contributi decisionali al massimo
livello. Non c'é dunque, nelle realtà compiesse, un preciso criterio che aiuti a identificare e
circoscrivere il soggetto economico. Nelle singole realtà è la situazione specifica che in concreto
esiste, o che si crea, a determinare la configurazione del soggetto economico.
Il soggetto giuridico, invece, è chi assume i diritti che si acquisiscono e gli obblighi che si
contraggono nei confronti dei terzi in dipendenza dell'attività aziendale (acquisti, vendite, altri
contratti e rapporti e così via). Nelle piccole realtà, appartenenti a una persona fisica (le ditte
individuali), è l'unico titolare a essere il soggetto giuridico, rilevandosi in tal caso una coincidenza
con il soggetto economico. Nelle aziende di maggiori dimensioni è l'ente che costituisce la veste
giuridica dell'azienda a essere il soggetto giuridico (società di capitali, fondazioni, associazioni,
ente pubblico).
Se è vero che le aziende hanno tutte una medesima missione e affrontano quotidianamente
problematiche generali assai simili, è altrettanto incontrovertibile che le modalità attuative della
funzione produttiva possono essere differenti, come di diverso tipo possono essere gli output
generati. Ciò implica che a questo punto l'esposizione, per svilupparsi in modo proficuo, debba
tener conto di tali specificità, passando quindi a distinguere differenti classi di aziende.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
16 di 22
Un criterio utile e convincente per tracciare una siffatta classificazione, già adottato da altro
autorevole autore8, è quello secondo il quale le aziende vengono distinte in base alla modalità con
la quale si rapportano al mercato e in considerazione della conseguente via di misurazione del
valore creato attraverso la propria attività produttiva. Al riguardo, si ritiene utile separare, da tutte
le altre, quelle aziende (dette, come si vedrà, imprese) in cui è possibile apprezzare la creazione di
valore utilizzando, da un lato, i valori di scambio che si determinano al momento dell'acquisizione
delle risorse produttive e, dall'altro, i valori di scambio che si formano all'atto della cessione dei
prodotti ottenuti. Ciò naturalmente accade quando gli scambi, attraverso cui si è avuto l'ingresso
degli input e la cessione degli output, sono avvenuti sul mercato, nel quale hanno ricevuto ima
oggettiva misurazione di valore. Nelle altre aziende, invece, l'apprezzamento della creazione di
valore è ben più difficile, poiché, in assenza totale o parziale di scambi di mercato, occorre fare
riferimento ad altri parametri valutativi di natura quantitativa e/o qualitativa, rinunciando a un
indicatore sintetico qual è il prezzo di mercato.
In sintesi, le aziende possono così essere distinte:
Imprese;
Cooperative;
Associazioni e fondazioni (dette talvolta, in senso ampio, organizzazioni non profit);
Amministrazioni pubbliche.
Si definiscono imprese quelle aziende che acquisiscono con liberi scambi di mercato (alle
condizioni per loro più convenienti possibile) le risorse produttive necessarie e cedono al mercato,
sempre con liberi scambi e alle migliori condizioni possibili, il risultato delle loro produzioni. Le
imprese operano in competizione sui mercati. In sostanza vivono di mercati e di concorrenza e ne
affrontano i rischi. Ricercano altresì, attraverso l'attività, il profitto, cosicché possa determinarsi
un'adeguata remunerazione per coloro che ne hanno la proprietà.
Talora, si afferma che il fine delle imprese è la massimizzazione del profitto; tale affermazione va
correttamente interpretata al fine di non cagionare fraintendimenti. Per utilizzare le parole di un
autorevole studioso, l'obiettivo dell'impresa deve essere quello di «dominare in certi ambiti concor-
renziali grazie ad un vantaggio competitivo difendibile, scaturente da competenze distintive
soggette a un continuo rinnovarsi», svolgendo un ruolo «fondato non già su posizioni di privilegio o
di rendita di varia natura, ma su una superiore capacità di soddisfare il cliente, che si costruisce
8 E. Cavalieri, Economia Aziendale, p. 126.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
17 di 22
avanzando su di un sentiero di apprendimento imprenditoriale fecondo»9. Con ciò si vuol dire che
l'impresa non può e non deve (pena la sua stessa sopravvivenza) ricercare a ogni costo la
massimizzazione del profitto, magari penalizzando fornitori, dipendenti, e quanti altri forniscono il
loro contributo all'attività da essa svolta; anzi, gli apporti di tutti questi soggetti devono essere
remunerati in equa misura. Né l'impresa, per quanto riguarda le cessioni, può approfittare di
eventuali condizioni di forza per imporre ai clienti prezzi superiori al valore del prodotto offerto.
Insomma, deve condividersi una visione più «sociale» e «plurifinalistica» rispetto alla semplice
massimizzazione del profitto, affermando che una condotta eticamente e socialmente responsabile
non solo può portare nel lungo periodo alla migliore redditività possibile, ma addirittura è
condizione della stessa sopravvivenza dell'azienda come sistema sociale duraturo.
All'interno della categoria delle imprese si possono, poi, individuare svariate tipologie.
Per esempio, secondo l'attività produttiva svolta si può distinguere tra: imprese manifatturiere (che
trasformano con la propria attività materie prime in prodotto finito); commerciali (all'ingrosso o al
dettaglio), che rendono disponibili in tempi e luoghi diversi un determinato bene senza lo
svolgimento di una trasformazione tecnica; di servizi (trasporti, credito, assicurazione,
informazione, pubblicità, e così via).
Da un altro punto di vista, può distinguersi tra l'impresa padronale e l'impresa ad azionariato diffuso
(public company).
L'impresa padronale, o a proprietà concentrata (modello assai diffuso nel nostro paese), si
caratterizza per l'appartenere a un numero ristretto di persone, spesso legate da rapporti familiari, se
non addirittura a una sola persona, nei casi di unità di piccole dimensioni. In questo caso, i
proprietari esercitano essi stessi il supremo potere di guida e di governo e assumono di frequente
anche le decisioni operative. Cioè, essi sono il soggetto economico e insieme svolgono funzioni
dirigenziali. Le imprese vicine a tale modello presentano indubbiamente il pregio della flessibilità e
della rapidità decisionale, tuttavia la loro sorte è strettamente legata al possesso di adeguata visione
strategica e di capacità innovativa da parte dei proprietari. Si deve anche notare che le possibilità di
crescita restano spesso limitate da due fattori:
1. la dimensione del patrimonio personale degli stessi proprietari (quando questi non
intendono condividere con terzi la proprietà dell'impresa);
9 V. Coda , L'orientamento strategico, p. 201.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
18 di 22
2. il possesso di idonee competenze e capacità atte a gestire lo sviluppo, soprattutto se
questo si orienta verso settori di attività o mercati mai prima praticati10
.
Come momento critico nella vita di tali imprese, per questo ultimo medesimo motivo, si presenta
spesso anche il passaggio generazionale.
All'estremo opposto si colloca la public company, caratterizzata da una proprietà frazionata e
diffusa tra una moltitudine di soci, che conduce a creare una netta separazione tra chi detiene il
capitale dell'impresa e chi ne ha il governo. Al management è delegato tutto il potere di guida, ed
esso peraltro deve dimostrare di saper contemperare i molteplici e variegati interessi che un'impresa
di questo tipo ha intorno a sé. Tale modello si è sviluppato nei paesi anglosassoni, specialmente
negli Stati Uniti, perché lì ha trovato favorevoli condizioni culturali e di ambiente sociale. In tali
paesi, difatti, è diffusamente radicata una grande fiducia nell'efficienza e nel ruolo stesso del
mercato. Si è fortemente convinti che il sistema concorrenziale ivi presente stimoli l'efficacia di
governo delle aziende e che, il medesimo mercato, sia in grado di misurare con immediatezza i
risultati aziendali (fornendone quindi anche il controllo). Tante che le remunerazioni dei manager
sono generalmente correlate alla performance da esse ottenuta. Un mercato aperto ed esteso, come
quello di cui si dice, inoltre, facilita fortemente la possibilità di disinvestire o reinvestire in quote di
capitale delle imprese, e ciò facilita ancor più la diffusione della proprietà. Si nota, infine, che le
descritte condizioni hanno d'altra parte consentito la formazione di una classe di manager con
elevato spessore professionale e favorito un notevole sviluppo degli studi e delle tecniche
manageriali. Tra questi due opposti ed estremi modelli, nella realtà si ritrova l'ampia varietà di
concrete tipologie d'impresa, che tendono più verso l'uno o più verso l'altro modello, e che si
differenziano: per il grado di concentrazione e di stabilità, della proprietà, per come quest'ultima è
composta, per le configurazioni assunte dagli organi e dai meccanismi di governo e di controllo. Un
esempio di tipologia intermedia è offerto dalla Germania, paese nel quale sono presenti imprese
nelle quali, pur in presenza di una elevata diffusione della proprietà, tuttavia coesiste una forte e
stabile fascia di soci, composta da famiglie di imprenditori, banche (in percentuali spesso elevate),
rappresentanti dei dipendenti. La stabilità di tale fascia di soci assicura un sostegno sicuro e
10
È chiaro che, mentre alla carenza di competenze è facile ovviare accettando l'ingresso nella
«cabina di regia» di manager esterni di comprovate capacità ed esperienza (così come di fatto
avviene nelle compagini familiari più lungimiranti), alla carenza di sufficienti mezzi finanziari è
difficile porre rimedio, se non s'intende in alcun modo diluire le proprie quote di partecipazione al
capitale. L'eventuale indebitamento, cui si potrebbe far ricorso, ha difatti limiti ben precisi, oltre i
quali si compromette l'equilibrio aziendale (come molti esempi concreti dimostrano).

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
19 di 22
durevole all'impresa. La maggioranza dei soci non nomina direttamente i dirigenti, ma designa i
membri del consiglio di sorveglianza, che a sua volta sceglie gli amministratori (consiglio di
gestione). Il comitato di sorveglianza assume così il compito di controllare la gestione aziendale
nell'interesse dei soci e di tutti gli altri soggetti esterni portatori d'interessi nell'impresa. In questo
modo si dà luogo al sistema di corporate governance11
cosiddetto dualistico, che è stato previsto
anche dalle norme del nostro codice civile, sebbene abbia trovato in concreto limitata applicazione.
Le cooperative sono aziende che si contraddistinguono per operare, dal lato della domanda o
dell'offerta (secondo il tipo), su mercati particolari e limitati, caratterizzati dal fatto che i fornitori di
alcuni importanti fattori della produzione o i clienti destinatari dei prodotti ottenuti coincidono con
gli stessi proprietari. I soci della cooperativa, difatti, mentre sono titolari di una quota del capitale,
assumono, al contempo, la veste di:
- conferenti fattori specifici della produzione (materie e prestazioni di lavoro), nelle cooperative
cosiddette di trasformazione e in quelle di lavoro;
- destinatari dei beni o servizi prodotti, nelle cooperative cosiddette di consumo.
S'intuisce quindi che nelle cooperative (che sono, come si è visto, di tre tipi) l'interesse alla
remunerazione delle quote di capitale di proprietà apportato dai soci è del tutto secondario rispetto
al bisogno economico che con l'appartenenza alla cooperativa i soci intendono soddisfare. Il quale
consiste nella maggiore remunerazione che i soci conferenti realizzano nel cedere beni e prestare
servizi alla propria cooperativa, e nel risparmio di spesa che i destinatari dei prodotti o servizi
ottengono nell'acquistare dalla propria cooperativa. Nelle cooperative, quindi, gli acquisti o le
vendite (secondo il tipo) avvengono attraverso uno scambio mutualistico, a differenza delle imprese
che, come si è detto, attuano scambi nel libero mercato.
Naturalmente, quanto detto vale con riferimento alle cooperative propriamente intese, la cui attività
è orientata, almeno in prevalenza, alla mutualità. Non vale viceversa per tutte quelle aziende che,
pur denominate formalmente cooperative, sono nei fatti imprese vere e proprie (vedi, per esempio,
molte imprese cooperative della grande distribuzione, o molte banche di credito popolare) che
11
Con l'espressione corporate governance - che ha ricevuto negli anni recenti una rapida diffusione,
e che anzi è spesso usata in modo improprio - si fa riferimento all'insieme di regole, organi e
meccanismi, con cui sì governa e sì controlla un'impresa. L'attenzione alla corporate governance si
è accresciuta nel tempo, perché nasce dall'esigenza (oggi assai avvertita) che un'impresa, soprattutto
di certe dimensioni, eserciti la sua attività nel modo più efficace possibile, con un adeguato

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
20 di 22
operano sul mercato in piena competizione dal lato della domanda e dell'offerta, riservando ai soci
cooperatori poche marginali facilitazioni, oltre che, naturalmente, la remunerazione del capitale
conferito a titolo di proprietà. In queste prevale il fine di lucro, non certamente quello mutualistico.
Il fatto che nelle cooperative propriamente intese, come si è precisato, il valore degli input
acquistati o dell'output ceduto non si forma attraverso un libero scambio di mercato, andrebbe
tenuto presente nel determinare la loro capacità di creare valore. In ogni caso, il mantenimento in
vita della cooperativa si giustifica finché la sua attività apporti ai soci cooperatori benefìci
economici (ai quali si è accennato) superiori a quelli altrimenti ottenibili.
Le associazioni e le fondazioni12
, invece, acquisiscono gratuitamente la disponibilità di alcuni
fattori della produzione e/o cedono gratuitamente beni e servizi a talune categorie di utilizzatori. In
generale, in questa categoria si possono comprendere tutte quelle aziende, spesso dette
organizzazioni non profit (ONP) o del «terzo settore»13
, che pur però producendo beni e servizi di
rilevanza pubblica (quali la gestione di un museo pubblico, di un impianto sportivo o l'assistenza ai
disabili di una certa comunità territoriale) non appartengono alla pubblica amministrazione. Esse
sono unità economiche private che beneficiano del volontariato, di apporti gratuiti (e comunque non
derivanti da scambi di mercato) dei fattori della produzione, oppure dell'esistenza di un patrimonio
gratuitamente conferito, e non cedono la produzione (beni, servizi, liberalità) a condizioni di
mercato, proprio in quanto la loro azione è fondata sull'altruismo, sulla solidarietà, sulla produzione
di socialità. Il fatto che tali aziende non possono distribuire gli eventuali utili ai conferenti il
patrimonio sociale ha spinto a definirle, come si è detto, non profit; si è giustamente notato peraltro
inserimento nel sistema economico, sociale e politico-istituzionale circostante e nel rispetto degli
interessi di tutti i soggetti esterni e interni coinvolti o comunque interessati alla sua attività. 12
Le associazioni sono costituite da gruppi di persone che si riuniscono per soddisfare bisogni
condivisi di natura culturale, scientifica, religiosa, politica, sportiva o per la migliore difesa
d'interessi e diritti comuni, ma senza scopo di lucro. I costi per il loro funzionamento sono ripartiti
tra gli associati. Le fondazioni si costituiscono per gestire un patrimonio lasciato da persone dette
appunto «fondatori», che intendono con tale scelta permettere il perseguimento di un determinato
obiettivo, che non sia il lucro. Può trattarsi dell'avanzamento della ricerca scientifica, della
conservazione di beni artistici e d'interesse storico, di scopi sanitari e di utilità sociale, della
promozione dello sviluppo economico, e così via. I costi per la loro attività sono sostenuti con i
frutti del patrimonio conferito. 13
Per Terzo settore si intende quell'insieme di organismi (di natura privata) che si collocano tra lo
Stato (e altre istituzioni pubbliche) e il Mercato, quali fonti di beni e servizi a destinazione pubblica
o collettiva e che non operano a scopo di lucro. Nel suo ambito si trovano organismi dalle forme
più diverse. Le persone che ne fanno parte o che vi collaborano, con spirito puramente altruistico,

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
21 di 22
che tale denominazione non deve indurre a ritenere che la gestione di queste organizzazioni non
debba essere improntata a criteri di efficacia, efficienza e, più in generale, di economicità14
.
Altrimenti non sarebbero più aziende.
Sebbene la frequente mancanza di scambi monetari renda problematica la determinazione del
valore degli input consumati e degli output ceduti, resta fermo che la sopravvivenza anche di tali
aziende è legata al fatto che il valore (l'utilità) dell'output ceduto (erogato e non scambiato, in
questo caso) sia maggiore del valore degli input consumati (il cui approvvigionamento non si è
concluso parimenti a condizioni di mercato). Le fondazioni e le associazioni potranno sopravvivere
nella misura in cui riescono a soddisfare i bisogni istituzionali cui sono preposte; occorre acquisire
la consapevolezza che la possibilità di tali aziende di accedere alle risorse (finanziarie e non) è
largamente condizionata dal livello di efficienza dei processi produttivi attuati e dal grado di
efficacia dell'azione esplicata per il raggiungimento delle finalità istitutive. Anch'esse, insomma,
devono saper creare utilità, valore.
Infine, si ricordano le aziende facenti parte dell’amministrazione pubblica in generale. In tale
ambito si comprendono unità economiche che cedono gratuitamente o a prezzi «politici» e quindi
per nulla remuneratoli i propri servizi alla collettività organizzata su un territorio. Può trattarsi di
aziende appartenenti ad amministrazioni pubbliche centrali (per es., Ministeri, Agenzia delle
Entrate, ANAS), ad amministrazioni territoriali (per es., Regioni, Province, Comuni, Università,
Organismi sanitari), a enti di previdenza e assistenza (per es., INPS, INAIL). Lo Stato e le sue
articolazioni territoriali sono tenuti a contemperare obiettivi di natura economica con altri di
carattere politico e sociale della propria comunità di riferimento. Anche le pubbliche
amministrazioni, che spesso operano in condizioni di monopolio naturale, non trovano nei valori di
scambio la misura della loro economicità; la valutazione della qualità della loro performance deve
essere pertanto ricercata ricorrendo ad altri indicatori (a esempio, di misurazione della sod-
disfazione degli utenti dei servizi), certamente assai meno semplici da rilevare dei prezzi che si
formano su mercati competitivi15
.
tendono a individuare bisogni che non vengono soddisfatti (o, almeno, non adeguatamente
soddisfatti) né dall'azione pubblica, né dal mercato. Di qui la denominazione. 14
E. Cavalieri, Economia Aziendale, p. 17. 15
Sul punto, R. Mussari, Amministrazioni pubbliche, cap. 3.

Università Telematica Pegaso Il concetto di azienda e le sue principali caratteristiche
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
22 di 22
Bibliografia
D. Amodeo, Ragioneria generale delle imprese, Giannini, 1990.
E. Cavalieri (a cura di), Economia Aziendale, Giappichelli Editore, 2010.
V. Coda, L'orientamento strategico dell’impresa, Utet, 1988.
R. Mussari, Economia delle Amministrazioni pubbliche, McGraw Hill, 2011.
L. Potito, Azienda ed economia aziendale, in AAVV, “Economia Aziendale”, Giappichelli
Editore, 2012.
Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), Manifesto
dei soci promotori, in “Appunti per un dibattito sulla cultura aziendale”. Documento
scaricabile dal sito: www.sidrea.it.
E. Viganò, Il concetto generale d’azienda, in AAVV, “Azienda. Primi contributi per un
rinnovato concetto generale”, Cedam, 2000.