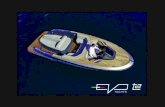LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL CURRICOLO … ssis.pdf · Questi ultimi si caratterizzano...
Transcript of LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL CURRICOLO … ssis.pdf · Questi ultimi si caratterizzano...

1
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL CURRICOLO PSP
(PER SOGLIE DI PADRONANZA)
Maria Renata Zanchin Dimensioni del profilo formativo, soglie di padronanza e valutazione
Maria Grazia Tollot
Indicatori e descrittori dei processi di apprendimenti
Eufemia Giambelluca Dall’analisi cognitiva di una prova alla comunicazione del profilo
emergente

2
Indice Presentazione Dimensioni dell’apprendimento Perché parliamo di soglie di padronanza
Gli indicatori Partecipazione e impegno Socialità e collaborazione Applicazione Transfer Ricostruzione –generalizzazione
Il paradosso di Galileo Commento all’analisi della prova La definizione del profilo e la sua comunicazione

3
Presentazione Questa lavoro ha lo scopo di condividere i risultati della ricerca in atto nel Laboratorio PSP, relativa alla valutazione, all’interno del binomio Profilo formativo integrato atteso e Profili individuali emergenti. Sentiamo infatti l’esigenza di un sistema coerente, basato su una valutazione dei processi di apprendimento e di insegnamento e non solo dei loro prodotti e sulla trasparenza dell’atto valutativo, che diventa così anche atto orientativo per il progetto di vita dell’allievo. Lo scopo della nostra ricerca è stato ed è quello di costruire e verificare un modello di tale sistema valutativo processuale e orientativo, offrendo alcuni esempi e soprattutto proponendo strumenti di guida alla valutazione. Questi ultimi si caratterizzano per un paradigma teorico di riferimento e sono al tempo stesso assolutamente flessibili e contestualizzabili. Inoltre rappresentano, anche sul piano grafico, un’ alternativa alle strutture di pensiero e alle rappresentazioni lineari, non adatte a esprimere la visione sistemica che caratterizza la valutazione degli apprendimenti nel curricolo “per soglie di padronanza”.

4
Dimensioni del profilo formativo, soglie di padronanza e valutazione a c. di Maria Renata Zanchin “…. da quando ti ho preso in prima, sei proprio cresciuto! Non solo di altezza, ma soprattutto come persona. Ti ringrazio per il contributo di riflessione che hai dato alla classe, per la tua profonda sensibilità, per lo stupore e l’incanto con cui guardi e accogli ogni contenuto ed esperienza. Ti auguro di trascorrere una bella estate, un po’ anche di studiare!” (come introduzione a questo messaggio di saluto alla fine dell’anno, l’insegnante cita un passo di Antoine de Saint Exupéry, Il Piccolo Principe “ “Addio” disse la volpe “ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi… E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante… Gli uomini hanno dimenticato questa verità; ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa…”) Insieme a questo messaggio, prima delle vacanze, l’allievo in questione ricevette un “debito”. Correttezza metodologica vuole, nel presentare un “caso”, soprattutto quando lo si fa solo come spunto introduttivo, che non si traggano nè si sollecitino affrettate conclusioni (come quelle che verrebbero indotte se mi soffermassi ora a riferire che il ragazzo, di un classe terza superiore, ebbe qualche difficoltà a coniugare l’immagine di sé che gli veniva restituita attraverso il saluto con quella che gli veniva trasmessa dal “debito”). Lo scopo di questo citazione è soltanto quello di scoprire e osservare alcune categorie che l’insegnante utilizza per “pensare” il suo allievo. L’unica conclusione che forse è possibile trarre, per ora, si riassume nell’idea di quanto sia difficile essere insegnante e di quanto lo sia essere studente. Niente si può dare per scontato…. Il docente che scrive queste parole sembra considerare con attenzione la dimensione sociale-relazionale e affettiva (“contributo di riflessione.. profonda sensibilità… stupore e incanto nei confronti di ogni contenuto ed esperienza”), ma la “performance” di questo allievo, almeno per come viene riconosciuta dall’insegnante stesso, non fa pensare che tale dimensione si sia integrata, arricchendola, con quella cognitiva cui vengono tradizionalmente attribuiti gli esiti dell’apprendimento. Nonostante gli atteggiamenti positivi espressi “come persona” e descritti nel messaggio, non è riuscito a produrre risultati sufficienti sul piano cognitivo o l’insegnante non è riuscito a leggerli come tali. E’ rimasto “insufficiente. Fatto sta che le due dimensioni sembrano restare separate, o nell’allievo, o nell’ immagine che il docente ha di lui, o in entrambi.

5
Con una dissolvenza sui due protagonisti del caso, lasciamo emergere ora gli argomenti di cui essi sono diventati spunto, accennando a una traccia di questa breve relazione: • Padronanza dei saperi • dimensioni dell’apprendere e dimensioni del • profilo formativo integrato • soglie di padronanza e compito esperto • un modello valutativo “non lineare” per un curricolo “non lineare” Coniughiamo subito i primi tre in un’affermazione sintetica, che poi svilupperemo: un curricolo per padronanze si fonda su - e postula al tempo stesso - più dimensioni dell’apprendere e di conseguenza il concetto di profilo formativo, che prefigura un punto di partenza e un punto d’arrivo articolato su più piani (non soltanto sulla questione: “quanto l’allievo sa all’inizio - quanto sa alla fine”) e strumenti di osservazione e verifica tarati su più dimensioni, appunto. Fatta questa premessa, sviluppiamola, facendone scaturire le implicazioni anche a livello valutativo.

6
Dimensioni dell’apprendimento per la padronanza e dimensioni del profilo formativo integrato dell’allievo: un percorso non lineare tra pianificazione e valutazione Nella quotidianità dell’esperienza scolastica, in base alla loro concezione di apprendimento, sapere e insegnamento i docenti, sia a livello individuale che collegiale, selezionano come base del curricolo e rendono oggetto della loro azione di insegnamento uno o più aspetti - dimensioni che considerano rilevanti nell’esperienza di apprendere. Ciò può accadere intenzionalmente e consapevolmente, ma il più delle volte si verifica in modo inconsapevole e traspare soltanto da una lettura quasi “indiziaria” come quella che abbiamo timidamente accennato poco fa rispetto al messaggio di fine anno. Nel curricolo per contenuti e nozioni, per esempio, la dimensione dominante è quella cognitiva. Con una semplificazione grafica e forse con un eccesso di semplificazione sul piano dei significati, potremmo rappresentare la situazione come nella figura 1
figura 1 Continuando a semplificare, in modo utile a chiarire i termini della questione, anche se riduttivo nei confronti della realtà, in un curricolo che privilegi le relazioni e le situazioni di apprendimento, la dimensione predominante è quella relazionale - affettivo – motivazionale, figura 2

7
figura 2 (mantenendo ovviamente una quota di campo alla dimensione cognitiva, in quanto non c’è docente né gruppo di docenti che non intenda promuovere l’acquisizione di nozioni nei suoi allievi).

8
Una distribuzione delle dimensioni come quella appena presentata potrebbe essere abbastanza realisticamente riferibile ad una scuola dell’infanzia. E quella rappresentata nella figura 3, dove il peso della dimensione cognitiva aumenta, a quale tipologia e/o ordine di scuola potrebbe appartenere, con buona approssimazione?
figura 3

9
Nel Curricolo PSP (per soglie di padronanza) vengono prese in considerazioni, intenzionalmente, consapevolmente e collegialmente, più dimensioni dell’apprendere, che, allo stato attuale del percorso, possiamo più o meno schematizzare come nella figura 4, dando rilievo, accanto a quella cognitiva, alla dimensione metacognitiva (“Nessun apprendimento può essere dichiarato tale se esso non è capace di rappresentarsi contenuti, metodi e contesti di uso” Margiotta, 1991, p. 94) e a quella motivazionale - affettivo - relazionale (occorre “consentire all’allievo di avere desiderio di apprendere, perché in ciò che fa apprezza itinerari e materiali utili a proseguire l’opera in cui è particolarmente assorbito: la costruzione dell’identità del sé” Margiotta, 1997, p. 45).
Figura 4 A loro volta esse vengono “scandagliate” negli ulteriori e compositi aspetti che le caratterizzano, come nella seconda relazione vedremo meglio. E non potrebbe non essere così, visto che la “padronanza”, perno del nostro curricolo, si spiega e si promuove allargando lo sguardo, come il raggio di un faro sensibile a attento, ad una molteplicità e complessità di aspetti, processi e atteggiamenti, tra loro implicantisi. E allora vediamo , o meglio rivediamo, questo concetto dal quale non possiamo prescindere. Padronanza è “sapere esperto”, in quanto capace di manifestarsi in contesti determinati e vari, con ridefinizione progressiva delle procedure d’uso e delle regole di

10
generalizzazione, in un processo ricorsivo di trasformazione della conoscenza. Si caratterizza per una dimensione di consapevolezza dei processi messi in gioco, ma anche e soprattutto delle mete che quell’apprendimento consentirà di raggiungere e del significato che esso può assumere per la propria crescita personale, in situazione scolastica e di vita (“a che cosa mi servirà?”). Richiede il coinvolgimento affettivo e motivazionale del soggetto rispetto agli scopi per i quali apprende, al contributo che può offrire al sapere che elabora, alle soddisfazioni e ai vantaggi che ne può trarre, agli scambi che potrà sviluppare con gli altri grazie ad esso, figura 5.
Figura 5 E’ per questo che nel nostro curricolo le padronanze vengono sempre formulate con un “per” che completa finalizzandola ad uno scopo che non è solo scolastico, ma è anche di vita, la capacità indicata dal verbo iniziale all’infinito, per esempio :

11
ARGOMENTARE PER COMPROVARE LE PROPRIE AFFERMAZIONI
E PER NON “PARLARE A VANVERA” / PER COMPROVARE IL GRADO DI VALIDITA’ DI UNA DETERMINATA TESI CON DATI, GARANZIE E RICUSAZIONI
OPERARE SECONDO UN PIANO PER IMPARARE A RAGIONARE E A GUIDARE IL PROPRIO COMPORTAMENTO
INDAGARE LA REALTA’ PER DESCRIVERLA E INTERPRETARLA RAGIONANDO PER SISTEMI E MODELLI
INDAGARE E INTERPRETARE IL PASSATO ANCHE PER CAPIRE IL PRESENTE PROGETTARE IL FUTURO
LEGGERE SECONDO UN PIANO PER RISPONDERE A SCOPI DIVERSI DI LETTURA
Figura 6 La considerazione della molteplicità di dimensioni coinvolte nei processi di apprendimento per la padronanza (indispensabili per sviluppare i sistemi nei quali essa si articola) rende necessario e induce a ricorrere ad un concetto come quello di “profilo”, figura 6, che quasi

12
automaticamente nella nostra mente e anche nel senso comune, dalla forma singolare che caratterizza il “profilo formativo atteso” si volge al plurale: “profili”, figura 7, ad indicare subito la pluralità di esiti possibili nella varia combinazione e composizione delle dimensioni e degli aspetti.
Figura 7 Poichè non ci interessa capire solo e tanto “quanto” un allievo sa o sa fare, ma anche e soprattutto “come”, sia rispetto a modalità di tipo cognitivo e metacognitivo che affettivo e relazionale ( e questo “come” ci coinvolge anche per migliorare il “quanto”) ci sono indispensabili un concetto come quello di profilo e strumenti efficaci per pensarlo, rappresentarlo, descriverlo. Gli allievi che corrispondono ai due profili rappresentati sul video (e che trovate nelle pagine di G. Giambelluca) hanno un punteggio simile: 63/100 l’uno, 64/100 l’altro. Ma grazie a questa rappresentazione del loro profilo individuale emergente la nostra attenzione si orienta sui modi diversi con i quali lo conseguono, sui processi e sugli atteggiamenti propri di ciascuno : non ci fermiamo al livello, che è quello della sufficienza in questo caso, ma vediamo oltre, in trasparenza e, ciò che è più importante, aiutiamo l’allievo a farlo, perchè prenda consapevolezza dei suoi personali modi di apprendere, diventi esperto nell’analisi e nel controllo degli stessi ed elabori strumenti più

13
raffinati per migliorare il suo apprendimento e incrementare il suo punteggio. Gli assi su cui si sono disegnati i contorni del profilo individuale emergente dell’allievo A e dell’allievo B corrispondono alla varie tipologie di processi e di atteggiamenti che consideriamo rilevanti nel curricolo PSP : i processi di apprendimento (come applicazione, transfer, ricostruzione, generalizzazione…) che si intendono sollecitare nelle fasi di lavoro didattico del compito esperto e i processi e gli atteggiamenti relazionali – affettivo - motivazionali (come quelli inerenti la socialità, la collaborazione, la partecipazione e l’ impegno), che sono sottesi a tutte le fasi del compito. Di tali processi e atteggiamenti parlerà tra poco la nostra collega Maria Grazia Tollot. Essi rappresentano nel nostro curricolo dei veri e propri “catalizzatori” dell’azione di pianificazione dell’insegnamento e insieme dell’azione di valutazione dell’apprendimento, oltre che dell’insegnamento stesso. Con estrema coerenza, seppure non con rigidità, devono informare specularmente l’una e l’altra. In questo senso il docente non può valutare un determinato processo nei propri allievi se non è certo di aver progettato un ambiente di apprendimento ad esso coerente e di aver offerto le sollecitazioni didattiche per promuoverlo, in armonia con le indicazioni del Collegio dei docenti. Proprio a questo scopo è finalizzata la strutturazione del compito di apprendimento per fasi di lavoro tipica del Curricolo PSP, ma la fase di lavoro non è una garanzia in sé e per sé: è necessario esercitare un controllo continuo e soprattutto cooperativo per valutare, per esempio, se le esercitazioni proposte nella fase di transfer siano realmente corrispondenti a tale processo e che, nel caso in cui si debbano segnalare delle difficoltà da parte dell’allievo, esse non siano imputabili a una debolezza dell’ azione didattica. Gli indicatori (siano essi sovradisciplinari o disciplinari) che vengono selezionati, devono essere anche e in primo luogo indicatori per la progettazione dell’azione didattica e per l’autovalutazione dell’Insegnante e dell’Istituto, all’interno di un “progetto capace di sorvegliarsi”, nel quale la valutazione è un’azione “preventiva”, in quanto fornisce una “anticipazione delle regole d’azione da seguire” (Lucia Valle, Corso di specializzazione SOS, Lezioni di psicopedagogia del curricolo). Tutto questo non disconosce un altro principio fondamentale cui ci riferiamo nel Curricolo PSP: il docente esperto prende in considerazione anche tutto ciò che non ha previsto nella programmazione e che emerge dai suoi allievi (atteggiamenti, saperi, processi…), ma quello che ha programmato va coerentemente attuato e valutato. Poter rappresentare le varie tipologie di processi e di atteggiamenti con quello che chiamiamo il “grafo a stella”1, del quale abbiamo appena avuto una rapida presentazione, ci consente: 1 L’idea del grafo a stella o a diamante è nata da una metafora suggerita da Fiorino Tessaro in un intervento al Laboratorio PSP, da noi scandagliata e analizzata nelle sue molteplici

14
- di disporre di una specie di “radar”, figura 8, con il quale esplorare circolarmente e chissà, raffinando lo strumento, anche in profondità davvero pluridimensionale rispetto a quanto siamo in grado di fare ora, la varietà di processi e atteggiamenti che sono in gioco nella padronanza, cioè le sue componenti, per un’indagine e una valutazione anche qualitativa, non solo e tanto quantitativa
Figura 8 - di disporre di uno strumento “non lineare” per un curricolo “non lineare”: se un allievo ha sviluppato un certo processo, per es. di applicazione, ad un livello che viene valutato non soddisfacente, ciò non necessariamente pregiudica le sue possibilità di sviluppare buoni livelli di transfer (questi due processi non sono disposti in ordine tassonomico nel curricolo PSP, ma sono correlati alla maturazione degli stili di apprendimento personalizzati da parte dell’allievo e quindi a geometria variabile). La rappresentazione con il “grafo a stella” ci consente di descrivere sia il “vuoto” corrispondente all’uno che il “pieno” corrispondente all’altro e di ricavarne un punteggio che non penalizzi l’allievo. E’ proprio questo strumento a ventaglio, a stella, che ci consente di uscire dall’impasse dell’associare a ogni processo un livello, possibilità anche alla luce di quanto venivamo elaborando e ha prodotto questa rappresentazione grazie all’ abilità di Eufemia Giambelluca

15
in forma lineare (e di superare così il “se sa applicare…più che sufficiente, se sa trasferire … rendimento buono…” o analoghe formulazioni). Perché parliamo di soglie di padronanza E’ legittima una domanda relativa alla padronanza… anzi, sicuramente un’obiezione è già pronta: è troppo ambizioso pensare che l’apprendimento scolastico promuova padronanze nei termini prima descritti… Ma proviamo a fare queste ipotesi: a scuola si promuovono soprattutto competenze. Alla padronanza si tende, mettendo gli allievi nella condizione di esercitare alcuni dei processi e degli atteggiamenti che ne sono tipici (motivazione alla strutturazione del sapere, alla chiarificazione, alla cooperazione, attribuzione interna dei propri successi e insuccessi scolastici, riflessione e controllo metacognitivo arricchito dell’ apprezzamento dei proprio progressi, disponibilità a confrontarsi con gli altri, autonomia e disponibilità a dare il proprio contributo personale, coerenza metodologica, flessibilità, processi di generalizzazione e di fertilizzazione del sapere, pensiero immaginativo, coerenza metodologica e insieme flessibilità ….), affinchè li acquisiscano per la vita, senza pretendere di raggiungerla necessariamente a scuola e di raggiungerla su tutti i fronti. E’ possibile però maturarne, anche ad età molto giovane, alcuni tratti peculiari, in settori che siano particolarmente congeniali al singolo soggetto. E’ per questo che il curricolo, “per padronanze”, si progetta (da parte dei docenti) e si percorre (da parte degli allievi) “per soglie” . E non a caso questo concetto dà il nome al nostro modello. Da un lato, la soglia di padronanza fa riferimento ad una dimensione diacronica, proiettata in una prospettiva a lungo termine e che richiede continuità d’intenti. In questo senso le soglie si configurano come tappe intermedie e progressive del percorso, “tappe di crescita previste per l’allievo in termini di consapevolezza concettuale e processuale” (Rigo, in Margiotta ,1997, p.150).. Dall’altro essa allude alla varietà degli accessi, dei percorsi e delle uscite anche rispetto al medesimo dominio del sapere, garantendo la personalizzazione degli apprendimenti e configurandosi in questo senso come snodo alternativo e/o complementare ad altri, in coerenza con la metafora del curricolo come foresta (corrispondente al concetto di curricolo come piano di processi di apprendimento), dove molteplici sono i percorsi e comunque una via d’uscita c’è, per tutti. In ogni caso la soglia “definisce i modi possibili di padronanza di conoscenze ed esperienze”, alludendo sempre, in forma più o meno esplicita, alle tre dimensioni citate all’inizio e a processi e atteggiamenti che le caratterizzano. Si può immaginare come uno spazio psicologico,

16
dell’allievo, non appiattito sulla pura conoscenza, ma rilevato, come un plastico, su più esperienze che si connettono a conoscenza: cognizione, metacognizione, motivazione, relazione. Essa necessita, per realizzarsi, di un ambiente educativo finalizzato, ovvero “sottende un percorso disegnato che accerta per quali vie l’ allievo svilupperà relazioni sempre più significative e personalizzerà l’apprendimento” (Rigo, in Margiotta, p. 150). Questo spazio e questo percorso sono garantiti dal “compito esperto” strutturato per fasi corrispondenti ai processi di pensiero e agli atteggiamenti che si intende promuovere negli allievi, del quale la soglia esprime, sintetizzandolo, il senso e il tracciato. Vorrei riassumere con poche parole il senso e il clima del percorso per fasi così come lo concepiamo: non potremmo chiedere agli allievi “inventa una regola con quello che hai fatto” (è uno slògan, è vero, in tal senso forse “eccessivo”, ma esprime con realismo il clima ideativo - immaginativo della fase di generalizzazione) se non li accogliessimo con un “Cosa sai?”, sollecitandoli ad assumere, fin dalle prime fasi ( quella informativa, che si radica nell’esplorazione dei saperi naturali degli allievi), un ruolo attivo nei confronti del sapere. Lo “spirito critico” di cui tanto si parla non si improvvisa “alla fine”, ma se ne coltivano fin dall’inizio e lungo tutto il percorso gli atteggiamenti, incoraggiando la motivazione all’elaborazione condivisa del sapere. Consideriamo ora come, coerentemente, viene costruita una soglia di padronanza. Essa in genere esplicita e descrive (Rigo, in Margiotta, 1997, pp. 151): • l’ ORDINATORE CONCETTUALE DEL COMPITO ESPERTO desunto dal modello esperto che i docenti hanno selezionato per affrontare un determinato nodo concettuale • LA REGOLA ovvero la “chiave di lettura”, fortemente intrisa del metodo proprio del modello esperto e formulata in termini di strategia , di piano d’azione cognitiva e metacognitiva. Essa, insieme all’ “ordinatore”, aiuta a capire verso quale sistema di padronanza si orienta prevalentemente il compito • LA META (VERSO DOVE?) che rappresenta il senso di quell’esperienza di apprendimento, sollecitando la dimensione affettiva-motivazionale e/o socio –relazionale (conoscere questo è utile a me perchè….; serve nella società di oggi perché……) Non sempre l’ultimo aspetto è rappresentato in modo esplicito nelle soglie da noi fino a oggi formulate, perché a volte vi è il rischio che il discorso diventi troppo lungo e ripetitivo tra una soglia a un’altra all’interno dello stesso modulo, ma chi le formula sa comunque che quello del coinvolgimento rispetto alla meta è elemento imprescindibile

17
nel vissuto del Compito Esperto, affinchè la soglia che ad esso corrisponde possa dirsi raggiunta. Offriamo ora alcuni esempi di soglie per concretizzare quanto sino ad ora esposto, con riferimento alla padronanza Argomentare per comprovare le proprie affermazioni e per non “ parlare a vanvera”/ per comprovare il grado di validita’ di una determinata tesi con dati, garanzie e ricusazioni e al modello esperto sull’argomentazione di Stephen Toulmin (1975), all’ interno di un Modulo Integrato che coinvolga più discipline (per es: italiano, storia, chimica….): Sono consapevole che 1) quando sostengo una tesi devo offrire dati (fatti, informazioni…) (ordinatore concettuale) 2) che diano solide basi a quanto affermato, in risposta a obiezioni di persone scettiche, che vanno attentamente ascoltate. Le diverse tesi e gli elementi che le sostengono dipendono anche dal punto di vista di chi argomenta (regola) 3) saper argomentare è utile per difendere le proprie posizioni ed essere un cittadino partecipe e responsabile, per ottenere degli scopi anche concreti, in varie situazioni di vita, oltre che per formare le proprie capacità logiche (verso dove?) Una soglia “successiva”, a livello di maggiore complessità (del tipo “diacronico e progressivo”) nasce sostituendo l’ordinatore concettuale “dati” con “garanzie” e “fondamenti”, sempre tratti dalla mappa concettuale del modello esperto di Toulmin: Viene inoltre modificata anche la parte relativa al “verso dove”, dando rilievo sul piano motivazionale alla capacità di sostenere fino in fondo le proprie idee e alla soddisfazione connessa a tale atteggiamento anche quando non si abbia il successo desiderato:
Sono consapevole che 1) se necessario e quanto più il mio interlocutore sia esigente, occorre
offrire garanzie, ovvero proposizioni generali 2) che diano forza alla tesi e giustifichino la correlazione tra essa e i dati e
occorre approfondire e giustificare tali garanzie nei loro fondamenti (leggi, statistiche, studi…)
3) sostenere fino in fondo le mie idee può essere faticoso, ma dà soddisfazione alla mente e al cuore, non solo quando riesco ad ottenere i risultati voluti…. mi accorgo infatti che arricchisco e modifico la mia tesi e le mie idee nel confronto con gli altri

18
Rispetto alla varietà degli accessi e degli snodi del percorso curricolare, all’interno di un modulo integrato sull’argomentazione, sarà possibile considerare come parzialmente alternativa alla precedente una soglia di padronanza che concretizzi l’argomentazione in un campo disciplinare più consono di un altro al soggetto, per esempio, in quello scientifico : Sono consapevole che 1) che posso interpretare, verificare, confutare una situazione problematica nell’ambito delle scienze sperimentali 2) utilizzando il metodo e i passi del ragionamento argomentativo secondo un modello di riferimento (Toulmin) 3) che questo modello mi è utile per esporre in modo chiaro e convincente i risultati di un esperimento e per sostenere i ragionamenti miranti a fondare la struttura del reale La soglia di padronanza accenna agli aspetti fondamentali e lascia impliciti, ma già affioranti, elementi che si definiscono meglio nell’ ambiente di apprendimento del compito esperto, come quello fondamentale della personalizzazione con la quale ciascun allievo interpreterà la regola. Passo il filo ancora sottile del mio discorso alle colleghe, perchè ne rinforzino la trama conducendoci all’interno del modello valutativo che abbiamo pensato come coerente con la concezione sistemico-relazionale-costruttivista dell’insegnamento e dell’apprendimento propria del curricolo PSP. Prima però vorrei fare un’ ipotesi a proposito del nostro caso iniziale… c’è un indizio che non mi sembra trascurabile: “non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi“ … certo, l’insegnante non dimentica, anzi, dà rilievo alla dimensione affettiva. Ma, forse, la colloca su un piedistallo che la rende irraggiungibile … e rende altrettanto impensabile la sua integrazione con la dimensione “della mente”. Noi, scusandoci con Antoine De Saint-Exupéry e con il suo meraviglioso protagonista, pensiamo che la dimensione relazionale - affettivo - motivazionale sia strettamente connessa a quella cognitiva e metacognitiva e che, anzi, il processo di formazione e quello di apprendimento siano un’avventura di integrazione continua, ciclica e ricorrente tra le tre dimensioni . Anche, seppure non solo, in questo senso parliamo di “curricolo integrato”. Il modello valutativo che ora le mie colleghe introdurranno più dettagliatamente intende offrire al docente gli strumenti per osservare e monitorare anche tale processo di integrazione delle dimensioni, per un sapere più significativo per ciascun allievo. Vi sono delle buone premesse? Le ricerche non sono mai lavori conclusi e i membri del Laboratorio PSP si stanno impegnando in tal

19
senso…. Siamo qui anche per discuterne insieme e arricchirci del vostro contributo.

20
Indicatori e descrittori del processo di apprendimento a c. di Maria Grazia Tollot La valutazione deve essere rigorosamente coerente al modello di curricolo adottato e alla peculiare concezione dell’apprendimento che lo anima . Nel curricolo PSP si concepisce l’apprendimento come un processo complesso che nasce dalla dinamica di un insieme di processi cognitivi-metacognitivi, affettivi e relazionali attivi e costruttivi nell’ elaborazione e rielaborazione della mappa cognitiva (semantica) personale2. La dimensione affettiva delle competenze e delle padronanze è, in qualche modo, indistinguibile dalla componente cognitiva-metacognitiva: nel processo di apprendimento tutta la persona è coinvolta , “a partire dal suo patrimonio di abilità e conoscenze, ma anche di valori, di giudizi personali, di modi di porsi di fronte alla realtà stessa, di spinte a fare, a comunicare, a conoscere” (Rigo in U. Margotta). L’apprendimento e’ sollecitato dall’interazione cognitiva , dalla negoziazione e condivisione di significati nell’ambito di un gruppo/contesto sociale: la relazione con gli altri, compagni e insegnanti, offre occasioni di scambio, di arricchimento, di verifica. Il curricolo PSP impernia i percorsi formativi su proposte didattiche progettate in modo da favorire un corretto esercizio dei processi generali sottesi all’apprendimento, fa dialogare memorie di lavoro, memorie semantiche, riorganizzazioni, abilità di transfer, pensiero procedurale, pensiero logico, pensiero immaginativo in fasi denominate perciò saperi naturali, mapping, applicazione, transfer, ricostruzione, generalizzazione. Nella fase saperi naturali prevede l’esplorazione e l’attivazione delle mappe individuali per arrivare alla la consapevolezza di ciò che si sa e si sa fare nel contesto, a dare significato a quelli nuovi, nel mapping l’insegnamento si propone di far ristrutturare al soggetto la mappa cognitiva personale apportando nuovi saperi. L’ applicazione di competenze e conoscenze apprese fornisce l’occasione di sviluppare
2 La mappa cognitiva non si identifica con la mappa concettuale più o meno strutturata delle conoscenze che il soggetto ha stabilmente acquisito (sapere “che cosa”); essa si caratterizza piuttosto come una rete di significati in cui si integrano contestualmente le conoscenze (sapere “che cosa”);le procedure per il loro apprendimento (sapere “come” e la corrispondente possibilità di estensione/trasferibilità nei comportamenti di vita sociale o professionale (sapere “verso dove “) da Margiotta Riforma del curricolo e formazione dei talenti, Armando Editore , pag.241

21
queste competenze e conoscenze, di dare loro un’impronta personale, di rivedere, rielaborare, modificare le rappresentazioni che animano le nostre strutture cognitive con nuovi schemi, di costruire una rappresentazione nuova personale e personalizzata di concetti, relazioni, confronti, di strutturare nuovi sistemi di conoscenza. La capacità di trasferire apprendimenti ( conoscenze e competenze) è essenziale nei processi educativi. Usare ciò che si è appreso in situazioni e contesti nuovi e diversi vuol dire trasferire modelli e regole per organizzare dati, per risolvere problemi, per formulare deduzioni, nuove ipotesi. Porta a riconoscere l’efficacia, ma anche i limiti di regole e modelli appresi. L’apprendimento esige la ricostruzione; ogni conoscenza è una ricostruzione, ricostruzione sotto forma di una rappresentazione mentale delle idee che sono state offerte dall’insegnante o dai compagni. Esplorare, analizzare, riflettere su quanto si è fatto, sulle proprie modalità del conoscere o del costruire conoscenza, sui dilemmi che si sono attraversati, descrivere il cammino percorso, porta al riconoscimento di conoscenze, alla ristrutturazione coerente del quadro e a riconoscere i contenuti di pensiero e i modi con cui si esprime. Più elementi, sia in termini di numero di passi del lavoro di ricostruzione, sia in termini di ampiezza, che di vastità e molteplicità delle comparazioni, connessioni e dei parallelismi fra componenti salienti del percorso verranno a trovarsi contemporaneamente presenti in questa fase, più alta sarà la competenza acquisita, più articolato sarà il ragionamento, più sviluppata la capacità di risolvere problemi. La riflessione su quanto si è fatto, l’astrazione portano alla generalizzazione, al riconoscere che il modello appreso, lo schema non è circoscritto all’ambito originario ma applicabile in ambiti differenti, può essere utilizzato in situazioni molto diverse da quella nota. Per favorire la ristrutturazione attiva della mappa personale degli studenti il curricolo PSP propone strategie di didattica attiva che sostengono la disponibilità al compito, stimolano il coinvolgimento, offrono spazio di espressione a diversi modi di apprendere, sollecitano forme di cooperazione fra gli studenti. I processi cognitivi non si attivano mai in un “vuoto” ma si esercitano e si sviluppano nel contesto di una cultura e dei suoi particolari ambiti . E la cultura in cui accade di esercitare le menti diventa determinante per generare la loro struttura e organizzazione. Gli ambiti culturali, che costituiscono il contesto capace di stimolare i processi, di attivarli, generano l’acquisizione di conoscenze, competenze, atteggiamenti che danno forma alle personalità e nello stesso tempo orientano i soggetti nel mondo in cui vivono.

22
I vari processi di apprendimento vengono simultaneamente attivati tutte le volte che un soggetto si trova impegnato nell’esecuzione di un compito complesso o nella soluzione di un problema difficile sono aspetti inseparabili di un’unica attività mentale. Ma la valutazione esige analisi e l’analisi esige la separazione. I processi sono del tutto privati, vissuti in prima persona, si realizzano come parte del processo personale che chiamiamo mente, sono anche molto difficili da seguire, ma sono, anche, processi comuni a tutti noi e li conosciamo a causa innanzitutto della nostra autoanalisi e, poi, della nostra naturale propensione ad osservarli negli altri. Ad un osservatore interessato offrono molti segni della loro esistenza: li possiamo cogliere attraverso l’osservazione di comportamenti ,di come uno studente ascolta,interviene, interagisce con i compagni, di cosa gli interessa o può essergli ostico o dedurre dalle prove a cui sottoponiamo i soggetti preparate in modo da implicare, di volta in volta l’uso prevalente di processi di memoria, o di applicazione di regole, oppure di trasferimento, o generalizzazione. La predisposizione di importanti dispositivi quali prove pensate e costruite come contesti che indagano, ma nello stesso tempo rafforzano, processi di apprendimento porta ad una valutazione complessa , che verte sul soggetto intero ed è attenta alle acquisizione possedute nel loro insieme. I processi dell’apprendimento li possiamo analizzare in maniera appropriata, li possiamo far diventare oggetto di osservazioni rigorose, di uno studio che li indaghi separatamente e li valuti. Per osservarli e rilevarli sistematicamente è necessaria l’individuazione di diverse caratteristiche “indicative” di atteggiamenti e processi. Fra le innumerevoli “caratteristiche” che compongono aspetti motivazionali, processi cognitivi e metacognitivi abbiamo individuato e scelto quelle che abbiamo considerato maggiormente più significative , più “indicative” di atteggiamenti e processi e le abbiamo utilizzate come indicatori3 per la valutazione. La scelta non risulta facile poiché si tratta di effettuare una analisi di tipo complesso, comprendente un gran numero di variabili e di relazioni fra variabili, ma è comunque opportuna se si vuole procedere in modo sistematico. Gli indicatori scelti si riferiscono a caratteristiche di processi o atteggiamenti suscettibili sia di descrizione che di misura, in grado di esprimere differenze sia sul piano qualitativo che quantitativo, sia sulle modalità che sui livelli sono mirate a cogliere anche il “come”, oltre che il “quanto”. Per ciascuno di essi sono stati individuati descrittori
2 indicatore = elemento, fattore rappresentativo di un sistema complesso; può essere qualitativo o quantitativo

23
adeguati che rappresentano cinque livelli di comportamento, competenze e padronanze acquisite. Molteplicità di stili , propensioni intellettive, varietà di motivazioni che contraddistinguono l’irriducibile differenza di ciascun soggetto rispetto agli altri richiedono l’individuazione di altri strumenti e indicatori per descrivere e valorizzare tali differenze nella descrizione di un profilo. Una volta individuati gli elementi di analisi non si deve correre il rischio di ritenerli prescrittivi: ambiti culturali diversi, compiti particolari, comportamenti inusuali possono richiedere, per essere descritti in modo adeguato, altri elementi, o non tutti. Gli indicatori scelti, come tutti quelli presentati in questo lavoro, hanno senso all’interno di un ambiente di apprendimento progettato per promuovere gli atteggiamenti e i processi cui essi e i relativi descrittori alludono e per orientarne l’esercizio negli allievi. Utilizzando nelle situazioni di apprendimento questi elementi indicatori e dei conseguenti descrittori4 per una accurata osservazione saremo in grado sia di vedere il movimento di crescita del profilo degli allievi rispetto ai processi di apprendimento, sia ad indicare le reali competenze da essi maturate di interpretare e descrivere in modo fortemente analitico come hanno lavorato le menti nell’acquisire padronanze, sia di costruire un resoconto e, ancor meglio, un racconto il più esauriente possibile dei processi di apprendimento.
4 descrittore = illustra le proprietà o le caratteristiche dell’indicatore

24
Gli indicatori Coerentemente alle riflessioni fatte abbiamo costruito uno schema per l’accertamento e la verifica organizzato intorno alle tre grandi dimensioni della personalità, la motivazionale-affettivo-relazionale che presenta caratteristiche rilevabili negli atteggiamenti tipici della partecipazione e impegno, socialità e collaborazione, la cognitiva e la metacognitiva con caratteristiche che si manifestano, in primo luogo, nelle prove che costruiamo appositamente per mettere in luce dei processi di applicazione, transfer, ricostruzione –generalizzazione. La figura 9 presenta gli indicatori scelti per il curricolo P.S.P..
Figura 9

25
Partecipazione e impegno Se l’insegnamento si propone di far ricostruire al soggetto mappe cognitive (semantiche), nella formazione di mappe cognitive categorizzazione e memoria non sono sufficienti; la costruzione delle mappe dipende dall’atteggiamento complessivo dell’allievo nei confronti dell’apprendere e in primo luogo, la partecipazione dei processi dell’attenzione collegati alla partecipazione dei processi di emozione, al piacere intellettuale. Gli indicatori livello di attenzione e grado di pertinenza degli interventi sono direttamente riferibili alla motivazione e all’interesse. Gli aspetti motivazionali sono determinanti nel promuovere o inibire un processi di apprendimento significativo: è più facile che venga fissato nella memoria ciò che ha connotazione emotiva , mentre eventi emotivamente neutri si perdono. Il livello di attenzione riguarda il coinvolgimento dello studente nel vivo dell’azione formativa, la sua disponibilità ad apprendere, il grado di partecipazione, la sua concentrazione E’ risaputo che l’attenzione cosciente ha una parte fondamentale nell’apprendimento e che la motivazione è elemento critico per orientare l’attenzione nella direzione corretta; l’interesse fornisce una base per dare o negare attenzione ad un dato oggetto. Senza motivazione non c’è mapping produttivo, orientato al transfer, non c’è una adeguata elaborazione delle cose appena apprese e forse nemmeno apprendimento. La pertinenza degli interventi rivela la capacità di ristrutturare le proprie mappe cognitive, di integrare le conoscenze, di chiarire il proprio pensiero, di capire il nuovo. Testimonia che non solo si ha interesse all’argomento, ma soprattutto che ci si orienta, almeno a maglie larghe, nella tematica in questione, si controllano i nodi della mappa. Porre e porsi domande pertinenti di chiarimento, di approfondimento, di esemplificazione, rivela motivazione alla riorganizzazione, spinta a sistematizzare, ricercando coerenza, dimostrando che si sta seguendo uno schema logico, che si cerca di inquadrare le informazioni, che si esplorano le relazioni e nei collegamenti tra le nuove informazioni e le precedenti. Socialità e collaborazione L’interazione e la collaborazione tra studenti permette il superamento dell’egocentrismo cognitivo e affettivo; evita, da una parte, il rischio di una qualsiasi chiusura e rigida schematizzazione, dall’altra rinsalda il senso di appartenenza ad un gruppo. Quando gli individui interagiscono attivamente e consapevolmente per costruire categorie concettuali, ragionare, risolvere problemi condividono le proprie conoscenze con altri, le potenziano e le approfondiscono. La costruzione delle mappe cognitive diventa più organizzata , ricca e

26
critica. E l’apertura all’accettazione delle idee diverse dei compagni, l’interesse dimostrato a queste aumenta la profondità di legami interpersonali. L’indicatore interazione cognitiva è indicativo di una capacità di socializzare i saperi. La motivazione cognitiva spinge all’esplicitazione dei propri saperi e ragionamenti, all’accoglimento dei contributi altrui; porta all’integrazione delle conoscenze proprie con quelle espresse dai compagni, produce conflitto cognitivo, genera la necessità di maggiore approfondimento. E’ molto importante nell’apprendimento significativo: un allievo che ha l’opportunità di interagire con gli altri compagni che hanno acquisito gradi diversi di conoscenza e competenza può rendersi conto di quanto sa e di come può procedere, di cosa deve rivedere in relazione al compito, impara che le proprie idee e le proprie competenze sono solo acquisizioni personali in una vasta gamma di possibilità e che i contributi degli altri elementi del gruppo favoriscono una migliore esecuzione del compito stesso. L’atteggiamento nella socializzazione dei saperi è indicativa di un’apertura alla relazione, al rapporto collaborativo, di disponibilità e fiducia ad esprimere i propri saperi basate in primo luogo sull’autostima, di generosità nell’offrire le proprie rielaborazioni e di considerazione e rispetto per le idee altrui. La disponibilità al confronto fra punti di vista diversi, a mettere in discussione una parte o un aspetto delle proprie conoscenze, a modificare punti di vista nasce, da una parte, dal senso di adeguatezza del soggetto, dal suo livello di autostima, dalla consapevolezza dei propri saperi e competenze, dall’attribuzione di valore a queste, dall’altra , dal desiderio di stabilire rapporti positivi con gli altri, di cooperare, di formare reti di sostegno, di raggiungere un’armonia interpersonale. Chi ha sicurezza in sé e da importanza ad una relazione fra pari si appella alla ragione, cerca di persuadere , di dare consigli, di ascoltare e rispettare le idee espresse, di tener conto dei saperi e delle emozioni degli altri, di condividere informazioni, di far proprie le alternative, di accettare critiche. Una bassa stima di sé stessi, un senso del limite troppo accentuato, impedisce un coinvolgimento nella relazione con gli altri, genera chiusura e ostilità verso l’esperienza scolastica. Applicazione L’applicazione consiste nell’abilità di usare in modo appropriato il modello proposto; applicare il modello proposto, valutare il risultato riguardano i processi di assimilazione e ritenzione. Vari fattori influenzano la qualità dell’elaborazione/rielaborazione delle proprie mappe cognitive nell’applicazione, quali la disponibilità e la capacità di

27
seguire le procedure e le istruzioni di lavoro offerte, l’organizzazione e la consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze, la personalizzazione su cui si basa la percezione dell’autonomia . Questi fattori contraddistinguono atteggiamenti, modi di porsi di fronte ai compiti. Gli indicatori uso corretto delle consegne e organizzazione di contenuti e metodi riguardano la personale ricerca di elaborazione/rielaborazione delle informazioni, a partire, per la prima, dall’informazione dell’insegnante, per la seconda, dalla qualità della propria personale mappa cognitiva. Prestare particolare attenzione alle istruzioni di lavoro e alle dimostrazioni dell’insegnante vuol dire ritenerle importanti , utili per affrontare il compito. Svolgere il compito con aderenza alle consegne indica che si è interessati ad eseguirlo correttamente, a provare a contestualizzarne il significato, la pertinenza, la rilevanza di quanto viene proposto; indica, inoltre, un impegno ad elaborare le informazioni offerte in modo che entrino a far parte della propria mappa cognitiva. Un’organizzazione,poi, adeguata di quanto appreso è la condizione necessaria perché sia disponibile e applicabile a nuovi compiti. Applicare ciò che si è appreso comporta il riconoscimento della struttura della propria mappatura, della sua organizzazione; riguarda, il grado di connessione fra le idee. Riconoscere la situazione che si genera di fronte a un compito, analizzarla è un processo cognitivo non banale: è far venire alla mente un insieme di immagini, di metodi e tecniche che permettono di affrontare un ragionamento o la soluzione di un problema. Quanto più la una mappatura del pensiero, cioè la costruzione ed elaborazione personale e personalizzata di concetti, relazioni, confronti e sviluppi è organizzata, tanto più si può agire correttamente e in breve tempo. L’autonomia viene garantita dalla acquisizione e personalizzazione di conoscenze e competenze; si sviluppa dall’esperienza della competenza. L’autonomia non è mai un’esperienza emozionalmente neutra: il senso dell’autonomia è fonte profonda di piacere. E’ particolarmente utile poichè procura una certa sicurezza per quanto riguarda la riuscita, rende in grado di prevedere risultati dai modelli elaborati , di gestire imprevisti e fare piani. E’ incrementata dalla percezione della propria competenza, della capacità di agire efficacemente, del controllo che si crede di esercitare sullo svolgimento del compito e sulle conseguenze di un’attività di apprendimento Chi ritiene di aver poco controllo non riesce a prendere decisioni e ad esaminare con serenità i problemi.

28
Transfer Problemi da affrontare e da risolvere, compiti da eseguire richiedono la capacità di mettere in rilievo somiglianze e differenze tra situazioni note e non note, di cogliere la struttura , i tratti costitutivi; trovano la loro radice nella capacità di riconoscere modelli, di richiamare conoscenze e competenze organizzate e applicarle, di riconoscere le eccezioni alle regole. Sono necessari sia momenti intuitivi che momenti di analisi per percepire la somiglianza fra le cose, di vedere le differenze, ma anche connettere “pezzi” di sapere, di ristrutturare mappe per comprendere, a partire da sistemi di riferimento, situazioni problematiche nuove. Gli indicatori capacità di fare analogia, capacità falsificazione, si riferiscono alla capacità di mettere in rilievo somiglianze e differenze tra situazioni note e non note, di cogliere la struttura , i tratti costitutivi, i confini. Il pensiero analogico è estremamente importante per risolvere problemi o eseguire compiti: di fronte ad una situazione nuova è normale chiedersi se il problema o il compito da affrontare assomigli in qualche modo ad uno che si è già affrontato e se c’è qualcosa che si conosce che possa aiutare. L’intuizione è preliminare: il processo di trasferimento è associato, in primo tempo alla percezione di importanti similarità tra alcuni elementi di situazioni precedenti ben analizzate e quelli della situazione in esame. Riconosciuta la similarità si possono cercare relazioni fra entità implicate, trasferire su di essa piani di azione o procedure rivelatesi utili nel contesto originario. La possibilità di proiettare le competenze e le conoscenze già elaborate a una classe di situazioni porta ad una verifica della efficacia del modello o della regola nell’affrontare e risolvere attività diverse. La capacità di falsificazione e’ stimolata dalla presentazione congiunta di esempi e controesempi e si presenta in situazioni in cui la regola o lo schema interpretativo non funziona ed quindi in contraddizione con l’esperienza del personale rapporto con un mondo fisico reale o un campo culturale reale, quando cioè non regga ad un controllo empirico. Questa non corrispondenza stimola l’allievo a capire cosa c’è di diverso tra le situazioni in cui la regola non funziona e le altre diverse nelle quali va bene. Falsificare, ritrovare eccezioni alle regole porta a scoprire che una regola non è prescrittiva di come deve funzionare il reale, non vale in ogni contesto, che i modelli sono delle costruzioni che si rapportano a un gran numero di casi, ma non a tutti. Il richiamo delle somiglianze e lo sviluppo del ragionamento analogico, la ricerca di discriminazioni e falsificazioni rendono più agevoli nuove rielaborazioni mentali e rinsaldano le competenze, stimolano la ristrutturazione di sistemi di conoscenza.

29
La capacità di riconoscere l’esigenza di ristrutturazione, si riferisce alla capacità di aprirsi a nuove rappresentazioni; richiede duttilità intellettuale. Modelli e regole coprono una classe di casi più o meno larga, ma non le coprono tutti. Nella soluzione dei problemi o nell’esecuzione di compiti, il rappresentarsi il problema o il compito, può mettere a nudo nuove questioni, può portare a percepire e riconoscere i limiti di applicabilità della regola o modello a trovarli in qualche modo “mancanti” degli elementi necessari a affrontare il compito. Porta dunque a percepire l’esigenza di ristrutturazione di modelli e regole, di acquisire nuovi attrezzi più adatti a risolvere o eseguire i compiti. Solo uno studente preparato, con mentalità aperta, nel caso in cui modello o regola non soddisfino le richieste, non riescano in alcun modo ad avvicinarsi ai dati, si dimostrino resistenti a trattare il tipo di situazione proposta, saprà riconoscerne i limiti di applicabilità, cercherà nuove informazioni, si mostrerà disponibile ad accettare nuove ipotesi, a cambiare la regola, a rivedere il modello precedentemente organizzato. Pur non disconoscendo il valore della regola o del modello proposti, è consapevole che quanto viene proposto non riassume tutto ciò che si conosce, che esistono altri modelli, altre regole da applicare più adeguati alla situazione. I meno abili si ostineranno a cercare la soluzione solo in un certo ambito, tenteranno di lavorare secondo le linee del modello presentato pensando che la mancata soluzione derivi dalla loro incapacità, si ostineranno in procedimenti ciechi, casuali, insensati. Ricostruzione –generalizzazione La ricostruzione e generalizzazione richiedono un’ impresa riflessiva e dipendono conseguente dall’analisi, rielaborazione, ma anche dalla valutazione del significato. La riflessione implica un rivedere l’esperienza affrontata, assumere la posizione di osservatore critico nei confronti del proprio lavoro, del proprio particolare modo di procedere, per rendere esplicita la maniera di rappresentarlo. Comporta un motivare perché si ritengono valide certe procedure seguite, riconoscere la validità alle regole acquisite. La ricostruzione e reinterpretazione innalzano il livello di consapevolezza degli apprendimenti, l’identificazione consapevole e controllata di schemi rappresentazionali e il confronto con altri, fornisce un maggiore controllo sugli stessi e la capacità di rivederli, un sentirsi padroni e responsabili della qualità dei propri prodotti. Innalza anche il livello di coscienza delle proprie risorse interne, delle proprie emozioni, tensioni, tenacia, curiosità. La coerenza è tesa ad organizzare gli apprendimenti in unità “organicamente” strutturate e interconnesse dopo aver ricostruire in

30
modo sequenziale e logico la successione di passi fatti. Richiede anche riconoscimento e problematizzazione di incoerenze. Giustificare la coerenza di quanto fatto e elaborato vuol dire pensare criticamente, prevedere i risultati. La Profondità di analisi richiede un investimento di tipo logico-operativo La riorganizzazione delle conoscenze comporta nello stesso tempo separazione, differenziazione, selezione, esclusione, confronto. La Consapevolezza riflessiva fa assumere il senso e il significato dell’esperienza di apprendimento fatta ,dei prodotti e dei processi di conoscenza , soddisfazione di capire l’utilità della regola , disponibilità a schiudersi ad altre ipotesi e a altri percorsi è un raccontare a se stessi ciò che è avvenuto , la capacità di giustificare quanto si è appreso. L’Originalità permette di manifestare flessibilità mentale.Consiste nel reinterpretare in modo nuovo l’informazione resasi disponibile con l’apprendimento. L’originalità richiama l’intuizione, l’invenzione, ma anche il trasferimento di abilità. Non implica processi di pensiero straordinari , ma deriva dalla capacità di creare connessioni non usuali fra elementi, aprendo la strada alla creatività e al pensiero divergente Deriva da varie combinazioni di modelli assimilati, dalla capacità di raggiungere le profondità delle proprie riserve di conoscenza, di collegare quantità di informazioni in modi nuovi e di fare supposizioni su come funzioneranno. Di fronte ad un compito si valutano più variabili, si considerano più alternative, si ricordano più punti di vista e si vedono più modi di procedere, si tende a pensare in rete di fattori collegati, non in percorsi rettilinei, si combinano i materiali immessi nei modi più stupefacenti. Richiede duttilità, flessibilità di rappresentazione e controllo, non è certo improvvisazione. Con una competenza scarsa, di ridotte dimensioni non ci può essere originalità. E’ evidente che gli indicatori da noi proposti per accertare il processo di apprendimento hanno carattere sovradisciplinare, dal momento che si riferiscono a processi di apprendimento attivati in ogni ambito culturale. Sebbene siano interdisciplinari vanno contestualizzati. La capacità propositiva di un collegio che individua e condivide alcune dimensioni fondamentali dell’apprendere , che ne definisce i processi peculiari e addita indicatori trasversali ad essi pertinenti richiede un’altrettanta decisa flessibilità da parte dei suoi diversi gruppi di lavoro (dipartimenti, team del modulo integrato….) e dei docenti che consenta loro di contestualizzare gli indicatori a seconda del modulo, del compito,dell’esercitazione.

31
Dall’analisi cognitiva di una prova alla comunicazione del profilo emergente a c. di Gioacchina Giambelluca La progettazione prima e la valutazione dopo nel curricolo PSP, figura10, si caratterizza per il suo peculiare aspetto processuale; poiché evidenziare i processi d’apprendimento, come è stato già detto non è semplice, occorrono strumenti adeguati, costruiti ad hoc. Non basta avere individuato nel dettaglio competenze specifiche e indicatori caratteristici particolari di un determinato processo di apprendimento, occorre prevedere, costruire prove capaci di attivare quei processi mentre la competenza viene praticata, e ancora gli indicatori relativi al particolare processo, in relazione alla specifica competenza, devono essere declinati e descritti per quel particolare contesto, e nei diversi livelli.
Figura 10 Allora per la costruzione di una prova di verifica che abbia queste caratteristiche quali sono le domande che devono guidare? Partendo non dall’inizio, cioè dalle ragioni del modulo (questioni già risolte in precedenza), ma dallo specifico, ci si chiede quale competenza si vuol far esperire, quale processo di apprendimento lo studente deve

32
mettere in atto per quella competenza e dunque, attraverso quali indicatori si può mettere in luce, quale situazione o prova permette di fare ciò e ancora quali descrittori esprimono il livello di competenza individuale. Man mano che viene fatta questa analisi si delinea non solo il tipo di prova, ma diventa abbastanza conseguente costruire i descrittori cioè indicatori contestualizzati, descrittori di competenza alla luce di rivelatori particolari (gli indicatori dei processi di apprendimento attivati in quel contesto). Per raccogliere questi elementi risulta utile l’uso di tabelle come quella di figura 11 dove saranno contenute tutte le informazioni relative al Modulo di riferimento (la padronanza), al Compito Esperto (la soglia di padronanza), alla competenza specifica della fase del C.E., ai processi di apprendimento privilegiati, agli item della prova, agli indicatori e descrittori. Poiché i criteri di costruzione di una prova sono uguali a quelli usati per l'analisi e il controllo della stessa, si porta ad esempio l’analisi cognitiva di una prova di fisica, costruita sul paradosso di Galileo.
Figura 11

33
Esempio di analisi cognitiva di una prova: Il paradosso di Galileo Problema Al museo di Storia della Scienza di Firenze si trova uno strumento, fatto costruire da Galileo (in figura 12 è rappresentata una sua riproduzione) allo scopo di mettere in evidenza un’apparente contraddizione, infatti viene chiamato: il paradosso di Galileo, o paradosso meccanico. Come interpretare il fatto che un corpo posto sopra un piano inclinato possa salire piuttosto che scendere? Esiste una spiegazione che sia in accordo con le leggi della meccanica? Istituto Parini di Milano 1858 Figura 12 A. prima ancora di analizzare il problema nel modo di seguito indicato, cerca di dare qualche interpretazione del paradosso, che pur essendo intuitiva, e non analiticamente giustificativa, possa essere accettabile ( cioè in accordo con la teoria) B. analizza la situazione cercando di rispondere man mano alle domande proposte e/o ad altre che ti possono venire in mente e procedi secondo i passi suggeriti da a) ad e) modifica anche la situazione; osserva e registra i cambiamenti, se se ne verificano. a) descrivi con il maggior numero di particolari possibile le caratteristiche del sistema osservato. b) annota ciò che determina una variazione di comportamento del sistema, e ciò che invece lo lascia invariato

34
c) focalizza l’attenzione su ciò che determina un cambiamento e confronta tali elementi con gli elementi del modello teorico, considerando le caratteristiche della forza agente d) schematizza allora il sistema, e metti in evidenza il “vero” centro di focalizzazione del problema e) I risultati di questa operazione, ti permettono di interpretare e giustificare il fenomeno all’interno della teoria ? in che modo? [ puoi raccogliere i dati in una tabella come quella di seguito suggerita] Guida alla osservazione: 1. Com’ è il piano su cui scende il corpo? è presente attrito? quale forma ha? di quale materiale è fatto? se non fosse inclinato il corpo resterebbe fermo? Se non fosse a V sarebbe la stessa cosa? Divaricando o chiudendo la V succede sempre la stessa cosa? 2. Quale oggetto scende? come è fatto? di quale forma? di quale materiale? E se fosse un cilindro o di altra forma? 3. Quale forza agisce sul corpo? dove è applicata? cosa rappresenta il baricentro? quale posizione ha il baricentro per i vari corpi? come deve essere la posizione del baricentro rispetto al suolo perché cada? 4. Quando vale la 2° legge della dinamica? per quali corpi? devono avere una particolare forma? se c’è attrito vale ancora la legge? 5. Quali sono gli elementi costitutivi essenziali del modello relativo ad un corpo che cade? (N.B. la guida può essere più o meno ricca di suggerimenti, in relazione alla classe cui si rivolge) A B

35
c)………………………………………………………………………………………………………
d)……………………………………………………………………………………………………… e)………………………………………………………………………………………………………
Fattori caratteristici del sistema
Fattori che non influenzano o che non sempre influenzano i risultati
Fattori che influenzano sempre i risultati
Piano a)…. b) … b)
Oggetto a)….. b) …
b)
forza a)….. b) b)
Modello teorico di un corpo che cade
a)… b) b)

36
Commento all’analisi della prova. La prova proposta può risultare più o meno difficile a seconda dei suggerimenti che si danno per l’elaborazione; in ogni caso si tratta di una prova relativa alla fase finale di apprendimento: la competenza che si vuole testare “schematizzare il sistema reale e individuare i caratteri essenziali per darne spiegazione e giustificazione alla luce del secondo principio della dinamica” richiede prevalentemente una capacità di analisi in grado non solo di evidenziare e selezionare gli elementi significativi del sistema preso in esame, ma nello stesso tempo di valutare l’importanza e il ruolo che essi giocano nella interpretazione del fenomeno, alla luce del modello teorico studiato, che rivela così la sua ampia validità persino in situazioni in cui l’apparenza sembra metterla in discussione. Per questo motivo tra gli indicatori selezionati per il curricolo PSP, relativamente ai processi di ricostruzione e generalizzazione, in questo caso si è scelto come più “indicativo”: profondità di analisi. Con la domanda A della prova però si è dato spazio anche ad eventuali risposte intuitive, ritenendo così di valorizzare schemi di ragionamento inusuali; e quindi questo ha richiesto l’aggiunta di un altro indicatore: l’originalità. Questi indicatori non sono sicuramente gli unici capaci di mettere in evidenza la competenza sopra citata; si tratta di una scelta, di volta in volta guidata da ciò che in quel momento e in quella situazione si vuol fare emergere. Figura 13
Figura 13

37
In questa analisi risulta evidente l’importanza assunta dalla scelta della prova, dalla sua struttura, dalla scelta degli indicatori e dal modo in cui tutte queste componenti si intrecciano. Per mettere in luce i vari livelli di competenza raggiunti dai vari studenti, ciascun indicatore sarà contestualizzato mediante descrittori, come risulta dall’esempio riportato nella figura 13: dalla descrizione generale e decontestualizzata degli indicatori si passa qui ad una formulazione specifica, relativa al contesto, cioè al contenuto disciplinare specifico. Lo stesso indicatore nel momento della contestualizzazione potrà essere descritto in modo diverso anche in relazione alla stessa competenza se praticata in diversi C.E., relativi a contenuti disciplinari specifici e/o a maggior ragione in relazione a diverse competenze. Ciascun indicatore avrà il peso che noi abbiamo assegnato tenendo conto di diversi fattori, relativi sia al contesto scolastico sia al contesto di apprendimento.

38
La definizione del profilo e la sua comunicazione Qualunque scelta si sia operata, alla fine di un modulo, che prevede in ogni fase del processo di apprendimento prove specifiche, si avranno una serie di dati (punteggi) relativi ai livelli, ai quali corrispondono però precise descrizioni di competenze alla luce di particolari indicatori che evidenziano peculiari processi di apprendimento e atteggiamenti (diversamente rilevati) che uno studente manifesta nei diversi compiti. Allora i dati ( fatti di punteggi, ma anche di descrizioni) raccolti in tabelle andranno a delineare il profilo che perciò potrà essere espresso o con parole o con una rappresentazione grafica quale quella proposta nella figura 14.
Figura 14 Sia le rappresentazioni che le descrizioni portano ad evidenziare modi preferenziali di apprendimento, attraverso i diversi atteggiamenti nell’esperienza proposta, la diversa organizzazione delle competenze e capacità di trasferire in vari contesti e situazioni, modelli e regole, attraverso il grado di consapevolezza della propria mappa cognitiva costruita e/o ricostruita, la capacità di analizzare, rivedere criticamente e giustificare i passi fatti e infine attraverso il prefigurarsi contesti diversi di applicazione dei saperi acquisiti. La scelta di rappresentare graficamente un profilo emergente nasce dall’esigenza di una comunicazione immediata tra le componenti interessati e coinvolti nel

39
processo di valutazione: studenti, docenti e genitori. Come si può osservare nella figura 4, punteggi uguali corrispondenti però a due profili diversi, mettono in luce in modo più immediato le caratteristiche che li differenziano, infatti rispetto al grafo non è solo importante l’estensione dell’area che esprime il profilo, ma anche in quale dimensione si estende. Ciò permette di rendere evidente quello che il curricolo PSP si propone: la promozione e valorizzazione dei talenti individuali.

40
Bibliografia I riferimenti di base della ricerca sulla valutazione sono costituiti da: - E.Giambelluca, M.G.Tollot, Materiali elaborati per il Seminario presso
il Liceo Scientifico Morin di Mestre, ottobre 1999 - Margiotta U. (a c. di) (1997), Riforma del curricolo e formazione dei
talenti, Armando (in particolare il capitolo di Tessaro F., Valutare per formare… con i
Modelli di Lavoro) - Tessaro F. (1997), La valutazione dei processi formativi, Armando - E.Giambelluca, M.G. Tollot, M.R.Zanchin, Materiali elaborati per il
Corso di perfezionamento sulla modularità didattica – Modulo 4, A.A./A.S. 2000-2001 e 2001-
2002 - IRRSAE Lombardia (1999), Dalla valutazione ai curricola, F. Angeli - GUASTI L. (1999), Valutazione e innovazione, De Agostini - GUASTI L.(2000), Valutazione degli apprendimenti e didattica. Tre
modelli a confronto, Franco Angeli - VARISCO B.M. (2000), Metodi e pratiche della valutazione.
Tradizione attualità e nuove prospettive, Guerini Studio - BECCEGATO L.S., VARISCO B.(2000), Docimologia. Per una cultura
della valutazione, Guerini Studio - IPRASE Trentino (2000), Valutazione degli apprendimenti didattici. Tre modelli a confronto, Franco Angeli - ALLULLI G, (2000), Le misure della qualità, SEAM - BERTOLINI P. (1999), La valutazione possibile, La Nuova Italia - DOMENICI (1993), Manuale della valutazione scolastica, Laterza - DOMENICI G. (1998), Manuale dell’orientamento e della didattica modulare , Laterza - VERTECCHI B. (1993), Decisione didattica e valutazione, La Nuova Italia - VERTECCHI B., LA TORRE M., NARDI E.(1994), Valutazione analogica e istruzione individualizzata, La Nuova Italia - VERTECCHI B. (1999), L’archivio docimologico per l’autovalutazione delle scuole, Franco Angeli - OECD-OCDE (1994), Valutare l’insegnamento. Per una scuola che conti, Armando - SERIO N. (a c. di) (1999), Oltre la valutazione. Idee e ipotesi a confronto, Armando Le opere citate nel contributo Dimensioni del profilo formativo, soglie di padronanza e valutazione sono:
MARGIOTTA U. (1997), Riforma del curricolo e formazione dei talenti. Linee metodologiche ed operative, Roma, Armando, 1997

41
MARGIOTTA U. (1991), Modi e modelli di valutazione dell’apprendimento scolastico, in AA.VV., Continuità del curricolo per l’obiettivo formazione/apprendimento. Identità del docente tra insegnamento e nuove figure professionali, Torino, ANIAT TOULMIN S. (1975), Gli usi dell’argomentare, Rosenberg e Sellier, Torino