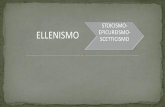La Clinica Termalelaclinicatermale.it/wp-content/uploads/2014/01/Clin-Termale-fasc_3... ·...
Transcript of La Clinica Termalelaclinicatermale.it/wp-content/uploads/2014/01/Clin-Termale-fasc_3... ·...

61
71
79
95
101
111
117
127
135
• Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismo M. CONTI, F. RUSSO
• Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bromialgica A. CARPENTIERI, S.M. COFONE
• La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartuale
C. TAGLIERI, G. LEVRA
• Valutazione di alcuni effetti di un’acqua cloruro sodica solfata sulla motilità ciliare di mucosa faringo-esofagea di rana: contributo sperimentale
G. GERARDI, F. CRISTIANO, C. VOLPE, E. LAMPA
• Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termale G. GERARDI, E. LAMPA, S. ANDREOZZI, A. CALVANESE, M. ROMANO
• Ambiente e organismo umano G. F. STRANI, G. LEVRA, S. LEVRA
• La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed Orl P. LUCCHI, M.E. BAIARDI, F. BORTOLOTTI, P. BARBIERI
• Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemia G. R. MARINI, G. CALOSSO, G. LEVRA
• Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termale G. R. MARINI, A. PUCCIO
DIRETTORE: E. LAMPA DIRETTORE RESPONSABILE: C. VOLPE
Comitato di Redazione: Consiglio Direttivo AMIITTF
E. LampaP. RichelmiGC. LevraGC. PantaleoniM. GalloE. GribaldoA. CarpentieriA. MassironeM. Costantino
La Clinica TermaleVolume 60, N. 3 - 4
SOMMARIO
Luglio - Dicembre 2013
M. VattiF. GiannoneV. Pansecco PistarinoR. GazziniP. BarbieriL. AmetranoC. VolpeG. TittaG. Gaetano
G. R. MariniM. A. VassalloM. RomanoG. D’AmelioS. AndreozziG. SerritellaF. RussoR. ConigliaroB. Miccoli
G. Casucci G. Cervadoro M. Di Capua A. Fraioli M. FusettiA. Sarno

�Therapeutic options for breast cancer treatment in patients previously irradiated for Hodgkin’s disease

61
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
Clin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
Rehabilitation and integrated therapies: experiences and perspectives
in hydrotherapy
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismo
M. Conti1, F. Russo2
1Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, Specialista in Idrologia Medica e Direttore Sanitario Terme di Ca-strocaro; 2Specialista in ORL, Specialista in Idrologia Medica, Docente in Medicina Termale Università di Pisa, Presidente Associazione Italiana di Tecnica Idrotermale.
Relazione presentata al 43° Congresso Nazionale A.I.T.I.,
Fiuggi 25 – 26 ottobre 2013
RIASSUNTO – La produzione di lavori scientifi ci secondo i criteri della Evidence Based Medicine e la diffusione della cultura termale devono essere alla base del progetto di un nuovo termalismo che utilizzi al meglio la risorsa termale secondo i principi di effi cacia, appropriatezza ed economicità.
La Riabilitazione termale integra terapie termali e crenochinesiterapia sia su patologie post-traumatiche e post-chirurgiche sia su malattie reumatiche. Trattamenti combinati farmacologico-riabilitativi eseguiti in ambito termale sono in grado di migliorare gli indici di malattia e la percezione del paziente della propria qualità di vita.
Sfruttando i co-fattori favorevoli di un ambiente piacevole, non ospedaliero, sanitariamente garantito e psicologicamente motivante, le Terme possono sviluppare parallelamente programmi riabilitativi perso-nalizzati e programmi collettivi di riattivazione psico-fi sica o di mantenimento.
ABSTRACT – The production of scientifi c papers according to the criteria of Evidence Based Medicine and the dissemination of a “thermal” culture must be the basis of a new “thermal” design, in accordance with the principles of effectiveness, appropriateness and effi cacy.
Rehabilitation therapy integrates “thermal” means and crenokinesitherapy both in post-traumatic and post-surgical disorders and in rheumatic diseases. Combined pharmacological and rehabilitative treatments performed at “thermal” environment are able to improve the indices of diease and the patient’s perception of their quality of life.
Exploiting some co-factors such as a pleasant, non-hospital, medically guaranteed and psychologically favourable environment, the spa could develop both case-by-case rehabilitation programs or groups therapy aimed to psycho-physical reactivation or maintenance.
PAROLE CHIAVE – Riabilitazione, terapia termale, crenochinesiterapia, osteoartrite, spondilite anchilosanteKEY WORDS – Rehabilitation, thermal therapy, crenokinesitherapy, osteoarthritis, ankylosing spondylitis

62
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
Introduzione
Con lo sviluppo del settore benessere, negli ultimi anni si è notevolmente incrementata an-che la popolarità delle Terme con un crescente affl usso di utenti tutto sommato rinnovati sia per tipologia che per classi di età. Ma rispetto alla gran parte della società reale del nostro paese il rapporto di fi ducia nei confronti delle cure termali appare logoro e incerto, come sospeso fra le continue minacce di misure restrittive sulla spesa sanitaria e lo scetticismo di una classe medica che con preoccupante sistematicità sembra ignorare quale sia il ruolo che la Medicina termale ricopre e potrebbe ricoprire nell’ambito del SSN. Le cause di que-sta condizione di stallo in cui pare ritrovarsi il termalismo sono da ricercare in vari ambiti che vanno da quello culturale della classe medica italiana e internazionale a quello universitario e della ricerca scientifi ca, dal disomogeneo rispetto della normativa vigente sul territorio nazionale, a pecche gestionali da parte delle strutture termali (13, 14).
Quello che è certo è che oggi, alla Medicina termale, è richiesto in modo inderogabile di produrre documentazione scientifi ca in grado di validare l’effi cacia delle terapie termali (Evidence Based Medicine) e al tempo stesso di proporre il progetto di un nuovo termalismo in continuità con il grande bagaglio culturale che secoli di esperienza scientifi ca idrologica ci hanno lasciato.
Ripercorrendo molto sinteticamente le tappe dell’evoluzione della normativa che regola l’erogazione delle prestazioni termali in Italia, è possibile ricavare alcuni punti fer-mi che sembrano indicare come rispondere all’esigenza del termalismo di recuperare la propria credibilità sul piano terapeutico e di
riallacciare uno stretto e costruttivo rapporto con la popolazione. Partendo dal Regio Decre-to del 28/09/1919 e dal Decreto Ministeriale del 20/01/1927, passando per la Legge n. 323 24/10/2000, si arriva all’ “Accordo naziona-le per l’erogazione delle cure termali 2008 – 2009” ai sensi dell’Art. 4 Comma 4 della Legge 323/2000, sottoscritto il 29 luglio 2009 fra Regioni, Province Autonome e Federterme, che ha ricevuto l’espressione di intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.
Tale Accordo ribadisce che le cure termali rientrano nei cosiddetti L.E.A. (Livelli Essen-ziali di Assistenza) ed ipotizza nuovi scenari quali l’estensione agli assistiti del S.S.N. dei cicli di riabilitazione termale riservati agli assistiti dell’INAIL e l’attivazione di percorsi mirati e linee-guida inerenti cicli di cura com-binati e la promozione di corretti stili di vita.
Individuati i mezzi più idonei alla diffusione della cultura termale sia verso il mondo medico sia verso la popolazione, l’obiettivo primario è quindi quello di utilizzare al meglio la ri-sorsa termale secondo i principi di effi cacia, appropriatezza ed economicità su cui poggia l’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali de-fi nite nel 2004.
Attualità e prospettive
Fin dalle sue origini, il termalismo ha rap-presentato un prezioso strumento di tutela della salute delle persone attraverso la prevenzione e la diffusione di una cultura di benessere a favore di tutta la popolazione ed è in questa prospettiva che le Terme devono continuare ad occuparsi della prevenzione cura e riabilitazio-ne delle malattie più comuni e prevalenti che

63
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
incidono maggiormente sulla qualità della vita delle persone e pesano sui costi sociali.
Prendendo ad esempio le malattie reumati-che, assai diffuse e inequivocabilmente incluse fra le patologie che possono trovare benefi cio dalle cure termali, risulta evidente come da de-cenni ci dobbiamo confrontare con una realtà che conta anche oggi oltre 5 milioni di mala-ti, di cui più dell’80% affetti da osteoartrosi e reumatismi extra-articolari, che incidono pesantemente sui costi dell’assistenza socio-sanitaria e rappresentano una seria minaccia per l’economia complessiva del Paese: in totale la spesa per le malattie reumatiche croniche in Italia supera i 4 miliardi di Euro l’anno, di cui quasi la metà – 1 miliardo 739 milioni – sono rappresentati dalla perdita di produttività per circa 287mila lavoratori malati.
Dai centri reumatologici universitari, ospe-dalieri e territoriali nonché dalle associazioni che si occupano con passione e competenza dei problemi di questi malati vengono registrate ancora forti diffi coltà ad infl uire concretamente sulla corretta terapia delle malattie reumatiche e sul comportamento dei malati, i quali spesso hanno diffi coltà a trovare punti di riferimento suffi cientemente diffusi sul territorio a cui rivolgersi e da cui essere informati e guidati. Ciò comporta anche che nella popolazione rimangono diffusi pregiudizi e luoghi comuni nei confronti delle malattie reumatiche quali: “sono malattie del vecchio”, “dipendono dal clima (umidità – caldo/freddo)”, “sono malat-tie croniche per le quali non vi è nulla da fare”, “i farmaci sono sempre e comunque dannosi”. Sulle cure termali, poi, il disorientamento e la scarsa informazione sono tali che non è raro ascoltare da parte di sanitari o semplici citta-dini commenti quali: “le cure termali se non fanno bene non fanno neanche male”.
La persistenza di un fenomeno così vasto e radicato che compromette la salute di tanti cittadini porta quasi a far sospettare che quan-to è stato fatto in tanti anni di impegno per il trattamento delle malattie reumatiche sia stato insuffi ciente al punto che, soprattutto per le forme su base degenerativa, viene da domandarsi se esiste di fatto qualche terapia effi cace in grado di contrastarne l’evoluzione in modo tangibile.
Nel caso dell’osteoartrosi, esistono numero-si strumenti terapeutici al servizio del medico fra cui la terapia termale che rappresenta un presidio fondamentale nel contrastare l’evolu-zione cronico-degenerativa di questa patologia. Ma per attuare veri e propri percorsi di pre-venzione e miglioramento della qualità di vita dei pazienti reumatici, occorre che la terapia termale come tutti i presidi disponibili venga correttamente applicata e integrata rispettando una “Integrazione sequenziale e sinergica” che tenga conto di diversi parametri (Fig. 1).
In questo come in altri ambiti della inte-grazione della terapia termale nei percorsi di trattamento di patologie croniche, occorre affrontare concretamente il tema della cultura termale che appare spesso carente nella clas-se medica (4). Medici specialisti e medici di medicina generale da decenni hanno abban-donato lo studio della Medicina termale già a livello universitario, ma non si possono negare anche responsabilità delle Aziende termali (14), le quali si sarebbero dovute occupare con maggiore serietà, continuità e coerenza di diffondere il più possibile la conoscenza degli scopi principali del termalismo e comunicare al potenziale utente i reali benefi ci delle proprie acque e delle proprie terapie termali.
Alcune Aziende Termali, fra cui le Terme di Castrocaro, hanno cercato di dare un im-

64
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
pulso positivo a questa situazione realizzando una serie di iniziative di studio e di aggiorna-mento trasversali, mirate a creare momenti di formazione a favore di medici, fi sioterapisti e infermieri professionali su temi inerenti le cure e la riabilitazione termale. Negli ultimi anni, in collaborazione con Istituti Universitari e coinvolgendo gli organi responsabili della formazione del personale dell’Azienda Sanita-ria Locale territoriale, le Terme di Castrocaro hanno organizzato Corsi di aggiornamento annuali che hanno abbracciato temi diversi, ma sempre connessi con prevenzione, cura e riabilitazione termale:– Il mezzo termale come elemento riabilita-
tivo– Spondilite anchilosante: ruolo della riabili-
tazione termale– La sindrome fi bromialgica – Percorsi ter-
mali di terapia integrata– I disturbi dell’equilibrio nell’anziano: nuovi
percorsi di recupero in ambito termale– Attività Fisica Adattata (AFA): un’oppor-
tunità di miglioramento della salute
La partecipazione ai Corsi è andata in crescendo e l’argomento termale si è sempre dimostrato di alto interesse in quanto introdotto quale elemento trasversale e complementare in ambiti in cui l’aspetto fi sioterapico e crenochi-nesiterapico sono determinanti.
In Italia, già molti stabilimenti termali si sono orientati a sviluppare il settore della Ria-bilitazione termale, integrando terapie termali, fi sioterapia e crenochinesiterapia, che sfruttano in particolare le azioni specifi che e aspecifi che delle acque minerali sia su patologie post-trau-matiche e post-chirurgiche sia su malattie reu-matiche e respiratorie croniche. Dopo la crisi del sistema termale dei primi anni ’90, lo sviluppo del settore riabilitativo (Fig. 2) è andato sempre più progredendo, quasi parallelamente a quello del settore benessere, in risposta anche all’esi-genza delle varie aziende termali di trovare una propria ricollocazione specialistica nell’intento di incontrare la domanda di salute intesa come miglioramento della qualità di vita espressa dalla popolazione che in quegli anni si era allontanata in massa dalle cure termali tradizionali.
Fig. 1. Approccio terapeutico-termale all’osteoartrosi

65
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
Esperienze in riabilitazione termale
Fra gli studi effettuati su alcune malattie reumatiche che dimostrano come trattamenti combinati farmacologico-riabilitativi eseguiti in ambito termale, non solo sono in grado di migliorare gli indici di malattia, ma forniscono al paziente un valore aggiunto nella percezione di incremento della propria qualità di vita, vi è quello condotto presso le Terme di Castrocaro in collaborazione con l’U.O. di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara che ha riguardato pazienti affetti da spondilite anchilosante (3,6,7). Oltre alla di-sponibilità di un razionale terapeutico sull’uti-
lizzo dei farmaci Anti-TNFα per contrastare la rigidità articolare di questi pazienti (15), le premesse che hanno portato ad intraprendere questo tipo di studio sugli spondilitici sono state le seguenti:– Evidenze in letteratura che riportavano
risultati positivi di programmi settimanali di riabilitazione termale
– Esigenza da parte degli Specialisti Reuma-tologi di disporre di un punto di riferimento riabilitativo, in grado anche di supportare un progetto di studio
– Possibilità del Centro di Riabilitazione Termale di offrire un’equipe riabilitativa qualifi cata per la presa in carico del paziente con spondiloartrite
Fig. 2. Sviluppo del settore riabilitativo all’interno degli stabilimenti termali

66
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
– Disponibilità di ambienti attrezzati e piscina riabilitativa con acqua termale
– Contesto ambientale piacevole adatto anche a soggiorni settimanali.I pazienti hanno effettuato un ciclo intensivo
di “terapia integrata farmacologica-riabilitativa della spondilite anchilosante” della durata di 6 giorni. Gli obiettivi erano di valutare quale parametro primario il miglioramento del BA-SFI (indici di malattia) e come parametro se-condario la percezione del livello della propria qualità di vita per mezzo di un questionario EQ 5DVAS. I risultati ottenuti a tre mesi dalla conclusione del trattamento sono stati positivi per entrambe i parametri e lo studio è stato pubblicato su rivista internazionale impattata (3). Le conclusioni del lavoro hanno eviden-ziato come: cicli intensivi di riabilitazione termale sono sempre indicati nella SA, con ripercussioni positive sulla “qualità della vita”; tali cicli riabilitativi saranno tanto più effi caci quanto più precocemente attuati; la terapia far-macologica rimane comunque indispensabile; principale obiettivo futuro sarà quello di una “early diagnosis” (diagnosi precoce, prima che si instauri rigidità).
È importante sottolineare che la meto-dologia di presa in carico del paziente e lo schema di trattamento fi sioterapico-termale appositamente studiata per questi pazienti, ha potuto avvalersi della “Fisioterapia Integrata Globale”, un insieme di attività fi sioterapico-riabilitative che possono trovare la loro realiz-zazione concreta solo in ambito termale.
La Fisioterapia Integrata Globale, necessita della disponibilità di un equipe riabilitativa completa composta da medici specialisti, fi sioterapisti, massofi sioterapisti, psicologi e operatori termali in grado di prendere in carico il paziente e, secondo un programma
standardizzato nelle metodologie ma perso-nalizzato nell’applicazione delle tecniche di cura, sottoporlo ad un trattamento quotidiano con: tecniche di fi siochinesiterapia a secco, tecniche fi sioterapiche strumentali comple-mentari e tecniche di crenochinesiterapia. In particolare, la crenochinesiterapia in acqua ad alta mineralizzazione, rappresenta una delle applicazioni fi siochinesiterapiche integrate più effi caci, proprio perché le azioni speci-fi che farmacologiche dell’acqua termale si associano al movimento corporeo fi nalizzato all’esercizio terapeutico ed alle azioni aspeci-fi che che vengono amplifi cate dalla forte den-sità dell’acqua stessa (pressione idrostatica, galleggiamento, effetto idrodinamico, calore specifi co)(6,7,12).
A seguito della positiva esperienza ma-turata sui pazienti spondilitici e disponendo di una struttura predisposta ad attuare la Fi-sioterapia Integrata Globale, è stato possibile creare un programma riabilitativo termale di terapia integrata della spondilite anchilosante che prevede anche l’utilizzo della ricetta del Servizio Sanitario Nazionale per un ciclo di bagni termali, accedendo a pagamento alle terapie fisiche complementari previste dal pacchetto. Ciò oltre ad orientare correttamente l’accesso ad una terapia termale già disponi-bile con l’attuale normativa nazionale, offre all’utente il vantaggio di dover sostenere solo in parte il costo della rieducazione motoria in acqua e di avere diritto all’assistenza medica specialistica.
Il pacchetto di “Terapia integrata della spondilite anchilosante” si compone di:– Visita specialistica fi siatrica– Visita specialistica reumatologica– N. 6 sedute di idrokinesiterapia personaliz-
zata

67
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
– N. 6 sedute di esercizi di potenziamento muscolare personalizzato in palestra
– N. 6 sedute individuali di rieducazione funzionale e/o ginnastica respiratoria
– Nozioni sui principi di economia articolare e terapia occupazionale.
– Abbinabile a ricetta SSN per “Ciclo di bagni per spondilite anchilosante”.Spinti dalla positiva accoglienza di questi
pacchetti sia da parte dei pazienti sia da parte degli specialisti reumatologi, si è inteso svi-luppare il medesimo approccio anche per altre patologie contenute nel D.M. del 15/12/94, ribadite nell’Accordo per l’erogazione delle cure termali 2008-2009 e a suo tempo incluse fra le patologie “riconducibili” nelle tabelle allegate alla circolare n. 4 del 15 giugno 1998 dell’Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna. Fra queste, la nostra attenzione è caduta su: artrite reumatoi-de in fase di quiescenza e reumatismi extraarti-colari (fi brositi e fi bromiositi nosologicamente riconducibili alla fi bromialgia).
È stato, quindi, avviato uno studio sulla “Terapia integrata della fi bromialgia” secondo un programma riabilitativo, costruito in colla-borazione i Reumatologi dell’U.O. dell’Uni-versità di Ferrara che si articola secondo un programma di 2 sedute alla settimana per 6 settimane che comprende:– Visita specialistica fi siatrica– Visita specialistica reumatologica– N. 12 sedute di idrokinesiterapia persona-
lizzata– N. 12 seduta individuale di rieducazione
funzionale– N. 12 terapie fi siche (magnetoterapia, la-
serterapia, elettroanalgesia, ultrasuoni)– N. 12 bagni in piscina termale.
I risultati raccolti nei primi due anni di stu-
dio sono confortanti ma, vista la complessità e la varietà di forme e di quadri clinici della fi bromialgia lo studio si sta prolungando per ulteriori approfondimenti e verifi che. Al con-tempo si stanno sviluppando protocolli per la Terapia integrata dell’osteoartrosi.
L’ambiente termale nella riabilitazione dell’anziano
In Regione Emilia Romagna è stato calcola-to che vi sono circa 2.176.000 persone affette da almeno una malattia cronica grave e che tale popolazione aumenta fortemente la propria in-cidenza rispetto alle persone sane a partire dal 65° anno di età. Sapendo che la durata media della vita si sta progressivamente allungando, una tale situazione è certamente allarmante se non vengono messi in atto provvedimenti atti a favorire il mantenimento dell’autosuffi cienza e dell’autonomia personale di questi cittadini, a fronte della certezza di un aumento della do-manda di assistenza e cure sempre più precoce rispetto al fi ne vita.
L’ambiente termale dimostra di possedere competenze adatte ad accogliere il paziente anziano (Fig. 3), affetto spesso da più di una patologia cronica, e dimostra di poter affron-tare patologie complesse sia post-acute che croniche, progressivamente inabilitanti, con un approccio polispecialistico e globale nei confronti della persona, offrendo risposte concrete a esigenze di prevenzione, utilizzan-do mezzi termali specifi catamente indicati nella cura delle patologie croniche e di solito ben tollerati. Tali mezzi, inoltre, consentono di attuare terapie combinate su vari organi e apparati sfruttando in associazione le tecniche fi sioterapiche e attuando programmi riabilitati-vi personalizzati e integrati anche nei confronti

68
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
di patologie quali: vasculopatie periferiche, patologie respiratorie e disturbi dell’equilibrio sempre più frequenti in una popolazione in progressivo invecchiamento (11).
In questo senso, in collaborazione con i docenti della Scuola di Audiologia dell’Uni-versità di Ferrara, alle Terme di Castrocaro è stato avviato un programma chiamato ”Miglio-ra il tuo cammino: cammina sicuro” dedicato alla prevenzione delle cadute e dei disturbi dell’equilibrio nell’anziano. Il metodo T.A.V. (Training di Adattamento Vestibolare), dopo un’accurata valutazione dei sistemi dell’equili-brio e della loro integrazione a livello cerebrale attraverso una visita otoneurologica e un test stabilometrico, utilizza una serie di esercizi svolti singolarmente o in piccoli gruppi, pre-
valentemente in piscina termale e in palestra sotto la guida di un trainer. Lo schema di lavoro viene impostato sulla causa del disturbo, sui sintomi lamentati e individualizzato a seconda delle necessità di ogni singolo paziente (16).
Più in generale, il paziente anziano posto al centro dell’attenzione come persona e non solo come paziente (Fig. 3), si sente protetto e rassicurato anche dai co-fattori favorevoli tipici delle terme. In un ambiente piacevole, non ospedaliero, sanitariamente garantito e psicologicamente motivante, oltre ai classici cicli di prevenzione e cura, le Terme possono sviluppare parallelamente programmi riabi-litativi personalizzati e programmi di attività motoria con coinvolgimento collettivo. Il tutto indirizzato sia alla popolazione residente del
Fig. 3. Competenze dell’ambiente termale nella riabilitazione dell’anziano

69
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
territorio sia a coloro che trascorrono il classico periodo di cura presso il centro termale.
PROGRAMMI PERSONALIZZATI– Preventivo termale della/e patologia/e in
atto con prevenzione di aggravamenti e invalidità secondaria
– Curativo e riabilitativo integrato dell’appa-rato interessato anche in fase post-acuta
PROGRAMMI COLLETTIVI– Riattivazione psico-fisica o di mante-
nimento con coinvolgimento in attività partecipative di gruppo che stimolano interessi diversi dal solito ambiente con-dizionanteÈ noto che la vita sedentaria favorisce la
scarsa effi cienza fi sica e pone l’anziano a mag-giore rischio di contrarre patologie croniche, mentre l’attività motoria costante e controllata rivela sempre più vantaggi per la salute durante tutto l’arco della vita, per cui integrare cicli di cura termale con programmi che propongono attività motoria e diffondono la cultura di un costante e corretto movimento, sembra un accostamento quasi scontato.
Un lavoro condotto presso le Terme di Castrocaro in collaborazione con l’Università di Pisa (2) al fi ne di portare un contributo che avvicini i trattamenti crenoterapici e farma-cologici, con risultati migliori se associati tra loro con idonea sequenza, ha studiato lo stress termale, indotto dal fango delle Terme di Castrocaro, per valutare come questo agisca sull’organismo. In particolare si è posta l’atten-zione sulle proteine da shock termico (HSPs), le quali aumentano nelle cellule sottoposte a stress di varia natura (termico, osmotico, chi-mico etc.), assumendo il compito di potenziare le difese cellulari. In soggetti gonartrosici sot-
toposti a crenoterapia (fangobalneoterapia) si è dimostrato per la prima volta che un trattamen-to termale con applicazioni di calore determina un signifi cativo e progressivo aumento proprio dell’HSP70 plasmatica. Tale aumento, inoltre, permane a lungo ed è correlabile ai risultati terapeutici e ai benefi ci funzionali dovuti al trattamento termale.
Altri lavori (5,9) hanno dimostrato che, rispetto alla produzione di HSPs, gli effetti di un ciclo di fangoterapia sul paziente ar-trosico corrispondono a quanto avviene con l’esercizio e l’attività fi sica intensa e costante. Appare quindi evidente che l’associazione fra fangobalneoterapia e attività motoria potrebbe diventare un binomio costante e stabilizzato nell’ambito delle già vaste opportunità preven-tive e riabilitative offerte dalle Terme.
Ciò a tutto benefi cio del benessere di una popolazione che sembra succube di modelli estremi e spesso frustranti che esasperano il pur importante aspetto estetico della persona, esaltando rimedi sbrigativi e costosi, ma troppo spesso trascurano le basi del buon vivere ba-sato sulla responsabilità di una manutenzione quotidiana del proprio corpo a tutela del bene salute.
Bibliografi a
1. SIMON L, BLOTMAN F. Exercise therapy and hydrotherapy in the treatment of rheuma-tic diseases. Clinics in Rheumatic Diseases, 1981: 7:337–47
2. BELLOMETTI S, CECCHETTIN M, GAL-ZIGNA L. Mud pack therapy in osteoarthro-sis. Changes in serum levels of chondrocyte markers. Clinica Chimica Acta, 1997; 268:101–6

70
Riabilitazione motoria e terapie integrate: esperienze e prospettive nel termalismoClin. Term. 60 (3-4):61-70, 2013
3. SPOORENBERG A, VAN DER HEIJDE D, DE KLERK E, et al. A comparative stu-dy of the usefulness of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index and the Dou-gados Functional Index in the assessment of ankylosing spondylitis. J Rheumatol, 1999; 26:961–5
4. VERHAGEN AP, DE VET HC, DE BIE RA. Balneotherapy for rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Cochrane Database of Syste-matic Reviews, Cd000518, 2000
5. WALSH RC, KOUKOULASI I, GARNHAM A, et al. Exercise increases serum HSP72 in humans. Cell Stress Chaperones, 2001; 6 (4):386-93
6. VAN TUBERGEN A, LANDEWE R, VAN DER LINDEN S. Spondylarthropathies: op-tions for combination therapy. Springer Semin Immunopathol, 2001; 23:147–63
7. VAN TUBERGEN A, LANDEWE R, VAN DER HEIJDE D, et al. Combined spa–exercise therapy is effective in patients with ankylosing spondylitis: a randomized controlled trial. Arthritis Rheum (Arthritis Care Res), 2001; 45:430–8
8. BANFI G, DOLCI A, VERNA R, et al. Exercise rises serum heat-shock protein 70 (HSP70) levels. Clin Chem Lab Med, 2004; 42(12):1445-6
9. RONCA G, AGOSTINI G, RUSSO F, et al. Variazione plasmatica delle HSPs70 in pa-zienti gonartrosici sottoposti a terapia termale con applicazione di fanghi caldi delle Terme di
Castrocaro (FC). Clin Term, 2005; 52 Suppl 1 (1-2):33-45
10. COLINA M, CONTI M, GARAVINI R, et al. - Combination treatment with etanercept and an intensive spa rehabilitation program in active ankylosing spondylitis. Int J Immu-nopathol Pharmaco, 2009; 22:1125–9
11. MARIGLIANO V, DI LOLLO GC, MARI-GLIANO B, et al. L’anziano alle terme. Clin Term, 2009; 56 (3-4):131-40
12. BLASCHE G, LEIBETSEDER V, MARKTL W.Association of Spa Therapy with Impro-vement of Psychological Symptoms of Oc-cupational Burnout: A Pilot Study. Forsch Komplementmed, 2010; 17:132–6
13. CRUDELI A. Ricerca scientifi ca, formazione, qualità e innovazione per un nuovo ruolo delle terme sul territorio al servizio del cittadino. Clin Term, 2011; (1-2):27-31
14. FIORAVANTI A, CECCARELLI L. La crisi della Medicina Termale in Italia e il ruolo della ricerca scientifi ca per il rilancio del termalismo. Clin Term, 2011; 58 (1-2):33-7
15. CIPRIAN L, LO NIGRO A, RIZZO M, et al. The effects of combined spa therapy and rehabilitation on patients with ankylosing spondylitis being treated with TNF inhibi-tors. Rheumatology International, 2013; 33(1):241-5
16. BALCI BD, AKDAL G, YAKA E, et al. Vestibular rehabilitation in acute central ve-stibulopaty: A randomized controlled trial. J Vestib Res, 2013; 1,23(4):259-67

71
Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bro-mialgicaClin. Term. 60 (3-4):71-78, 2013
Clin. Term. 60 (3-4):71-78, 2013
Effectiveness of spa therapy in fi bromyalgia syndrome
Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bromialgica
A. Carpentieri1, S.M. Cofone2
1 Direttore Sanitario delle Terme di Rapolla; 2 Master II livello in Idrologia medica e Medicina termale, AMIITTF Sezione Basilicata
Introduzione
La fibromialgia (FM) è una sindrome comune che colpisce soprattutto il sesso fem-minile in età adulta (dalla seconda alla quinta decade,con picchi tra i 25-35 e 45-55 anni). È caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico cronico diffuso a cui possono associarsi altre manifestazioni cliniche quali:
- Rigidità localizzata soprattutto al dorso e a livello lombare presente soprattutto al risveglio.
RIASSUNTO – La fi bromialgia è un problema di salute comune che causa dolori diffusi e sensi-bilità al tatto e pressione. Molto spesso le persone con questa malattia cronica sono affaticati e hanno disturbi del sonno per cui ricorrono a trattamenti integrati, in particolare alla crenoterapia, rivolti essenzialmente a ridurre il dolore e tutti gli altri sintomi che la patologia comporta.
ABSTRACT – Fibromyalgia is a common health problem that causes widespread pain and tender-ness (sensitive to touch).Most often, people with this chronic (long-term) illness are fatigued (very tired) and have sleep problems so that make use of integrated treatments, particularly in the crenotherapy, aimed primarily to reduce pain and other symptoms that the disease entails.
PAROLE CHIAVE – balneoterapia, fi bromialgia, dolore cronico diffuso, acque termaliKEY WORDS – balneotherapy, fi bromyalgia, chronic widespread pain, thermal water, spa
- Astenia: circa il 90% dei pazienti affetti da sindrome fi bromialgica riferisce astenia moderata o severa, ridotta resistenza alla fatica o una specie di stanchezza che ricorda quella normalmente riferita in corso di infl uenza o in mancanza di sonno.
- Disturbi cognitivi con difficoltà di concentrazione “testa confusa”, perdita di memoria a breve termine (1) (in inglese tali manifestazioni sono defi nite “fi bro-fog”, cioè annebbiamento FM).

72
Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bro-mialgicaClin. Term. 60 (3-4):71-78, 2013
Disturbi del sonno: si tratta di frequenti risvegli notturni. È ritenuta specifi ca della FM la cosiddetta anomalia alfa-delta: non ap-pena viene raggiunto il sonno profondo (onde delta all’EEG) si verifi ca un ritorno brusco al sonno superfi ciale (caratterizzato da onde alfa all’EEG); per cui i muscoli non si rilassano e non recuperano la stanchezza accumulata durante il giorno, infatti si parla di sonno non ristoratore (2).
Alterazioni del tono dell’umore: molti pa-zienti riferiscono manifestazioni ansiose e/o depressive anche se la FM non è una malattia psicosomatica e sono riconducibili a un effetto piuttosto che una causa della malattia.
Sintomi a carico degli arti inferiori: sotto forma di crampi o movimenti incontrollati delle gambe che si manifestano soprattutto di notte (“Restless leg Syndrome” o “Sindrome delle gambe senza riposo”).
TachicardiaLa FM può verifi carsi sia come un disturbo
primario in cui è la patologia stessa a causare diversi sintomi, o come disturbo secondario quando essa è associata ad altri stati patolo-gici quali: la sclerosi sistemica, la tiroidite autoimmunitaria, la sindrome di Syogren che ne rendono la diagnosi assai complessa.
Il dolore è il sintomo predominante della fi bromialgia. Generalmente si manifesta in tutto il corpo, sebbene possa iniziare in una sede localizzata, come il rachide cervicale e le spalle, e successivamente diffondere in altre sedi col passar del tempo. Il dolore fi -bromialgico viene descritto in una varietà di modi comprendenti la sensazione di bruciore, rigidità, contrattura, tensione. È stato proposto che la FM faccia parte di un continuum più ampio di disordini somatici, ipersensibilità sensoriali multiple e ridotta soglia del dolore
tra cui la sindrome da affaticamento cronico, la sindrome dell’intestino irritabile, la disme-norrea o la cefalea muscolo-tensiva ed altri che, presi insieme, rientrano tra le “sindromi da sensibilizzazione centrale” a causa delle anomalie nella processazione centrale del dolore che le accomunano (3).
Eziopatogenesi
La FM è una patologia dall’eziologia al momento ancora ignota. I fattori genetici pos-sono predisporre gli individui alla FM ed anzi la presenza di soggetti malati in famiglia deve costituire un campanello d’allarme in quanto potrebbe esserci una eventuale predisposizio-ne genetica. I fattori ambientali, in tal caso, verrebbero a sommarsi ad una condizione già determinata dal punto di vista genetico cau-sando i vari sintomi della patologia (5). Altri fattori coinvolti sono risultati essere l’ormone della crescita (GH), i cui livelli plasmatici basali appaiono ridotti. Considerando inoltre che la maggior parte dei pazienti depressi e fi bromialgici sono donne, sono stati effet-tuati studi di valutazione dei livelli basali di estrogeni dai quali è emerso nei pazienti con FM essi risultano ridotti rispetto ai controlli a differenza dei livelli di ormone follicolo sti-molante (FSH) i quali sono invece più elevati. Anche uno squilibrio delle citochine pro ed antinfi ammatorie è stato riportato come possi-bile causa dell’induzione e del mantenimento del dolore; una metanalisi condotta nel 2011 da Uçeyler et al. ha messo in evidenza elevati livelli dell’antagonista del recettore per l’inter-leuchina 1 (IL-1), dell’interleuchina 6 (IL-6) e dell’interleuchina 8 (IL-8); questa ipotesi, basata sul presupposto che tali mediatori, il cui

73
Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bro-mialgicaClin. Term. 60 (3-4):71-78, 2013
rilascio è causato dalla Sostanza P, sembrereb-bero avere un ruolo importante nel generare i sintomi della FM, dal momento che l’IL-8 promuove il dolore per via simpatica mentre l’IL-6 è associata a ipersensibilità al dolore, fatica e depressione. È dimostrato, infatti, che la condizione di depressione maggiore, ad esempio, sia accompagnata dall’attivazione della risposta infi ammatoria con un conseguen-te rilascio delle citochine pro-infi ammatorie sopra citate; e dunque, i pazienti fi bromialgici sono trattati con antidepressivi che hanno pro-prio l’obiettivo di sopprimere la produzione di IL-8 e IL-6 in quanto promotori dell’infi am-mazione e favorire così il rilascio di citochine anti-infi ammatorie come l’IL-106. Oltre ad elevati livelli di IL-8, nei soggetti malati sono stati riscontrati anche alti valori di TNF-α che sembrerebbe essere un altro fattore molto im-portante nel processo infi ammatorio alla base della FM (7). È stato riscontrato anche una riduzione di dopamina (necessaria al controllo inibitorio discendente a livello ippocampale) la quale potrebbe contribuire all’amplifi cazione del dolore, all’ipervigilanza ed ai disturbi del sonno (8). Secondo un’ipotesi largamente ri-conosciuta, infatti, le cause scatenanti la FM sembrerebbero affondare le proprie radici nel sistema nervoso centrale e periferico. La sen-sibilizzazione periferica che si riscontra nella patologia può verifi carsi in conseguenza di alterazioni della connettività sinaptica negli assoni contenuti nei gangli della radice dor-sale (generando un aumento della percezione dolorosa) o in seguito a scariche ectopiche; la sensibilizzazione centrale, invece, può esse-re causata da un danno a carico dei neuroni GABA-inibitori determinando anche in que-sto caso un potenziamento della trasmissione nocicettiva (10). Inoltre nella FM sono state
dimostrate e più volte confermate alterazioni di numerosi neurotrasmettitori, a riprova dell’ori-gine centrale della patologia; ad esempio, la ridotta concentrazione di serotonina e/o ridu-zione del reuptake e minori livelli di triptofano nel plasma e nel liquido cerebrospinale (CSF) rispetto ai controlli, inoltre una riduzione dei livelli di acido 5-idrossi-indolacetico (5-HIAA). Oltre a questi un incremento della concentrazione di sostanza P nel plasma e nel CSF (coinvolta nella modulazione del dolore) e una riduzione delle endorfi ne plasmatiche. Alcuni autori hanno utilizzato la spettroscopia protonica con risonanza magnetica (1H-MRS) che permette di valutare la concentrazione di specifi ci metaboliti nel sistema nervoso centrale, al fi ne di ricercare delle alterazioni dei livelli di neurotrasmettitori in individui con FM. Questa permette di individuare il maggiore neurotrasmettitore eccitatorio ed inibitorio, rispettivamente glutammato (Glu) ed acido gamma amino-butirrico (GABA). È emerso che il Glu può essere presente a con-centrazioni più elevate nei pazienti con FM e questo squilibrio è presente in diverse regioni cerebrali coinvolte nel controllo delle infor-mazioni dolorose (11). Per quanto riguarda le manifestazioni muscolari della malattia (rigidi-tà, dolore diffuso), queste derivano verosimil-mente da una regolazione delle vie simpatiche midollari, secondaria alle alterazioni centrali, che controllano la vascolarizzazione e la con-trazione muscolare. Tali meccanismi vengono poi potenziati e mantenuti da numerosi eventi collaterali (variazioni climatiche, alterazioni ormonali). Per quanto concerne la possibilità di un ruolo del sistema nervoso nella patologia, è necessario comunque chiarire che i dati e i risultati ottenuti sono tuttora discordanti, anche se tale ipotesi resta ancora del tutto valida; non

74
Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bro-mialgicaClin. Term. 60 (3-4):71-78, 2013
a caso infatti, i farmaci che hanno dimostrato maggiore effi cacia nella cura della malattia sono quelli che agiscono a livello del sistema nervoso centrale.
Diagnosi
A tutt’oggi la FM risulta essere una sindro-me tra le più controverse in ambito reumato-logico e algologico per l’assenza di lesioni anatomo-patologiche, di anomalie bioumorali, di segni di fl ogosi e di alterazioni evidenziabili con le più classiche metodiche strumentali (12). Ancora oggi per la diagnosi e la classi-fi cazione della FM sono considerati validi i criteri adottati dall’America College of Reu-mathology (ACR) nel 1990 che comprendono: presenza di dolore cronico diffuso da più di tre mesi; bilateralità del dolore; dolore presente sopra e sotto la linea-vita; alterata soglia del dolore in almeno 11 dei 18 tender points (siti anatomici specifi ci analizzati applicando una pressione di 4 kg) (13).
Occorre sottolineare inoltre l'importanza della diagnosi differenziale con patologie come la polimialgia reumatica o l'ipotiroidismo. Per cui è necessario sottoporre il paziente a esami ematici di primo livello comprendenti VES-PCR-FR-QSP-emocromo-CPK-TSH-FT3-FT4-fi brinogeno-urine-transaminasi.
Terapia
La terapia medica utilizza antidolorifi ci per breve periodo e fra essi i FANS hanno scarso successo escluso l’ibuprofene per pochi giorni. I cortisonici non vengono presi in considera-zione. Molto importanti sono gli adiuvanti Pre-gabalin e gli antidepressivi triciclici in prima battuta (Amitriptilina) o SNRI (Duloxetina e Milnacipram non ancora in commercio) men-tre gli SSRI non vengono preferiti per il loro meccanismo d’azione.
Sempre per breve periodo sono effi caci la Cyclobenzaprina e la Tizanidina.
Occipite Bilaterale, all’inserzione del muscolo sotto-occipitaleCervicale Bilaterale, superfi cie anteriore dei legamenti intertrasversari C5-C7Trapezio Bilaterale, al punto mediano del margine superiore del trapezioSovraspinato Bilaterale, all’origine del muscolo sovraspinato, al di sopra della spina
scapolare, in prossimità del margine mediale della scapolaSeconda costa Bilaterale, alla seconda sincondrosi costo-condrale, appena a lato delle
giunzioni sulla superfi cie superiore delle costeEpicondilo laterale Bilaterale, punto situato a 2 cm al di sotto dell’epicondilo lateraleGluteo Bilaterale, punto situato sul quadrante supero-esterno della natica, nella
plica anteriore del grande gluteoGrande trocantere Bilaterale, posteriormente alla prominenza trocantericaGinocchio Bilaterale, in corrispondenza del cuscinetto adiposo mediale del ginoc-
chio, in sede prossimale rispetto alla linea articolare

75
Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bro-mialgicaClin. Term. 60 (3-4):71-78, 2013
Tra gli oppioidi possono essere presi in considerazione, nel caso di dolore resistente, il Tramadolo oppure gli Oppiacei in genere e un particolare riguardo per il Nabilone, un cannabinoide sintetico.
Tenendo in considerazione che molto spes-so la terapia farmacologica nella FM non ha gli effetti sperati, a causa della cronicità della malattia e degli effetti collaterali dei farmaci impiegati, inevitabilmente i soggetti malati spesso ricorrono a trattamenti di natura non-farmacologica. Le attuali strategie terapeutiche sono rivolte essenzialmente a ridurre il dolore e tutti gli altri sintomi che la patologia com-
porta (disturbi del sonno,ansia,depressione ecc.). Negli ultimi anni è stato approfondito lo studio inerente le tecniche non convenzionali come possibile sollievo per tutti quei pazienti che a causa di sintomi debilitanti hanno visto la loro quotidianità fortemente condizionata. Per quel che concerne la cura della FM il panorama terapeutico comprende: esercizi fi sici mirati (è dimostrato che un allenamento aerobico migliori la condizione psicofi sica); massaggi terapeutici (oltre alle manipolazioni vertebrali sono state sottoposte a studio tecni-che di stretching passivo e di manipolazione dei tessuti molli) terapie fi siche; agopuntura,
Occorre sottolineare inoltre l'importanza della diagnosi differenziale con patologie come la polimialgia reumatica o l'ipotiroidismo. Per cui è necessario sottoporre il paziente a esami ematici di primo livello comprendenti VES-PCR-FR-QSP-emocromo-CPK-TSH-FT3-FT4-fi brinogeno-urine-transaminasi.

76
Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bro-mialgicaClin. Term. 60 (3-4):71-78, 2013
manipolazione osteopatica (chiropratica). Quest’ultima potrà sicuramente dare benefi ci con la sua tecnica manipolativa liberatoria alle articolazioni vertebrali e alle giunture periferiche, ripristina la funzionalità dello scheletro e quindi libera il fl usso nervoso nei tessuti e ristabilisce l’equilibrio neuromu-scolare e circolatorio. Sono indicate anche l’ultrasuono pulsato (atermico) ai tendini e la magnetoterapia a campo stabile con le sue proprietà antinfi ammatorie alle articolazioni (Massaggi con bio-magneto Eco 3 da 6000 Gauss sui punti (tender points) classici x15 min.x3 volte al giorno. Anche lo yoga; le di-scipline Bio- naturali acquatiche quali: Woga (applicazioni delle Asana dello yoga in acqua) e Ai Chi (seguenza simile al Tai Chi, l’antica arte marziale cinese,ma adatta ad essere prati-cata in acqua calda); Watsu (leggeri stiramenti, dondolii e momenti di quiete che sciolgono le tensioni articolari e riducono lo stress). Utilizzata anche la fi toterapia. Nelle opzioni terapeutiche non farmacologiche è compresa anche la terapia cognitivo-comportamentale (aiuta a riconoscere ciò che fa peggiorare i sintomi e impostare i limiti).
Terapia termale
Tra i vari presidi terapeutici utili nella Sindrome Fibromialgica, un posto particolare spetta alla terapia termale, precisamente alla fango-balneoterapia. Anche se gli studi clinico-sperimentali in quest’ambito sono scarsi, dalla valutazione dei dati a disposizione, si evince che la crenoterapia può essere considerata un valido ausilio per i pazienti fi bromialgici. L’applicazione del fango termale maturo è un metodo di trattamento delle malattie reumat-
iche in fase non acuta molto diffuso e ricono-sciuto per la sua effi cacia nella risoluzione della sintomatologia dolorosa e della functio laesa. Può essere prescritta più appropriata-mente distrettualmente. La balneoterapia con-siste nell’immersione del corpo in una vasca individuale o in una piscina contenente acqua termale. Giusto completamento prevede la reazione in camerino e il massaggio manuale di 20 minuti. È sicuramente indispensabile il controllo del medico termalista con la prescriz-ione, in base alla nostra osservazione, di sedute bi-settimanali a digiuno, per sei settimane.
Le acque ed i fanghi termali esercitano le loro azioni curative attraverso una serie di meccanismi combinati di tipo meccanico, fi sico e chimico. Gli stimoli meccanici agis-cono favorevolmente sul tono muscolare, sulla mobilità articolare e sulla sintomatologia dolorosa. L’alta temperatura del fango e delle acque termo-minerali ben si presta ad inter-rompere il circolo vizioso dolore-contrattura muscolare-dolore, tipico di questa patologia. Essa induce una rapida iperemia di superfi cie con iniziale decongestione profonda, seguita da un’iperemia attiva dei tessuti profondi tra cui quelli periarticolari (capsule, legamenti). Le conseguenze più importanti dell’iperemia e dell’aumento della velocità del circolo sono rappresentate dall’allontanamento dei media-tori fl ogistici e dalla riduzione dell’ipertono muscolare e dell’imbibizione dei tessuti pe-riarticolari. L’applicazione del fango terapeu-tico maturo induce un rapido ed immediato incremento della beta endorfi na plasmatica, i cui valori tornano ai livelli iniziali entro il periodo della cosiddetta reazione termale. L’aumento della beta-endorfi na è responsa-bile dell’effetto anlgesico e miorilassante che rende meglio tollerabile l’applicazione del

77
Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bro-mialgicaClin. Term. 60 (3-4):71-78, 2013
fango termale ed assume una particolare im-portanza nei pazienti in cui il sintomo dolore ha una rilevanza primaria. Studi recenti hanno inoltre evidenziato in pazienti affetti da FM sottoposti a fangoterapia una riduzione dei livelli circolanti, dell’interleukina-1 (IL-1) e del Tumor Necrosis Factor alfa (TNF-α) e dei suoi recettori solubili. La balneo-fangoterapia sembrerebbe avere un effetto positivo anche su fattori pro-infi ammatori particolarmente coinvolti nella genesi del dolore, riducendone ancora una volta i livelli serici, parliamo a tal proposito di prostaglandine PGE2 e leucotrieni LTB4 (18). In letteratura risultano dei lavori controllati in pazienti fi bromialgici trattati con balneoterapia solfata nel Mar Morto. Gli autori di questi contributi riferiscono un migliora-mento nel breve e nel termine (follow-up a tre mesi) dei principali sintomi (dolore, astenia, rigidità, ansia, cefalea, disturbi del sonno, sen-sazione di gonfi ore) e degli indici di qualità di vita nel gruppo di pazienti sottoposti a bagni termali rispetto ad un gruppo di controllo che soggiornava nella stessa stazione termale senza tuttavia essere sottoposta ad alcun trattamento crenoterapico. In seguito Evcik e coll. Hanno valutato gli effetti della balneoterapia in pazi-enti con FM nel corso di un trial clinico ran-domizzato e controllato. Anche in questo caso gli Autori hanno rilevato un miglioramento dei sintomi collegati alla FM sia a breve termine che in tempi più lunghi (follow-up a sei mesi) dei pazienti con FM rispetto al gruppo di con-trollo. Il contributo più recente sull’argomento è stato fornito da T.R. Zijlstra e coll. che hanno testato l’effetto di una combinazione di talassoterapia, esercizi fi sici ed educazione del paziente su un gruppo di fi bromialgici in un trial clinico randomizzato e controllato. In molte stazioni termali è possibile utilizzare
idromassaggi, mobilizzazione attiva e passiva in acqua, etc.; in tal caso oltre alle comuni vasche possono essere utilizzate vasche spe-ciali (es.: vasche “a farfalla” o “a trifoglio”) o piscine termali appositamente attrezzate che consentono di associare le metodiche chines-iterapiche al bagno in acqua termo-minerale. Queste strutture vengono utilizzate soprattutto per la riabilitazione motoria con l’ausilio di personale tecnico specializzato. Le piscine termali adibite alla riabilitazione sono dotate di attrezzature che facilitano l’immersione del paziente disabile in acqua e sono provviste di sussidi per la sicurezza nell’esecuzione degli esercizi. Sul fondo delle piscine possono essere istallati percorsi (gradini, discese e salite, etc.) per la riabilitazione motoria, propriocettiva e vascolare.
Studi osservazionali di ricerca hanno mostrato che le acque bicarbonato solfato al-caline, in provincia di Potenza, applicate per bagni con idromassaggio o meglio gorgoglia-mento (ciclo di dodici sedute) sono in grado di ridurre signifi cativamente la sintomatologia dolorosa e migliorare la escursione articolare dei segmenti interessati dai tender points (19).
Nell’ambito dei meccanismi d’azione della fango-balnoterapia devono essere considerati anche elementi di natura diversa, quali le condizioni climatiche e ambientali particolari delle stazioni termali, il maggior tempo dedi-cato al riposo durante in soggiorno termale e l’allontanamento dagli stress quotidiani (20).
Bibliografi a
1. (Marangell et al., 2011) (Mease et al., 2010) (Theadom et al., 2008)

78
Effi cacia delle terapie termali nella sindrome fi bro-mialgicaClin. Term. 60 (3-4):71-78, 2013
2. (Bigatti SM et al. Arthritis Rheum 59 2008: 961-967)
3. (McQuay et al.,2011) (Smith et al.,2011)4. (McBeth et al.,2012) (Haviland et al.,2010)
(Bradley et al.,2008)5. (Arnold et al.,2004)6. (Ortega et al.,2009) (Van West et al.,2001)7. (Bazzichi et al,.2007) (Wang et al.,2008)8. (Shipley et al.,2010)9. (Maletic et al.,2009)
10. (Maletic et al.,2009)11. (Harris et al.,2010)12. (Sarzi-Puttini et al.,2010)
13. (Arnold et al.,2010) (Skrabek et al.,2008)14. (Abele et al,2008)( Perrot S et al. Rheumato-
logy (Oxford) 47 (8) 2008: 1117-1123)15. (Mease et al.,2010) (Bradley et al.,2010)
(Sommer C et al. Schmerz 22 (3) 2008: 313-323)
16. (Kroenke et al.,2009)17. (Donmez A et al. SPA therapy in fi bromyalgia:
a randomised controlled clinic study. Rheuma-tol Int 2005 Jun 17)
18. (Ardiç et al.,2007)19. (Carpentieri A., 2011)20. (Fioravanti et al., 2007)

79
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
Clin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
The cardiac rehabilitation in spa environment in patients with
ischemic heart disease post-infarct
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartuale
C. Taglieri1, G. Levra1
1AMIITTF Sezione Piemonte Valle d’Aosta e Liguria
RIASSUNTO – Premessa. È noto che il trattamento dell’infarto miocardico successivo al supera-mento della fase acuta comprende, accanto a una adeguata terapia medica, anche una serie di interventi di tipo non farmacologico. L’intervento riabilitativo si è dimostrato utile nel prevenire le complicanze e la mortalità nel soggetto post-infartuato, nonchè nel migliorare la successiva qualità della vita del paziente. Il training fi sico è il cardine del programma riabilitativo.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 10 pazienti (6 maschi e 4 femmine) (età 68,6 ± 6,3 anni) consecutivi provenienti dalla U.O.N.A. di Riabilitazione Cardiologica di Fossano affetti da cardiopatia ischemica nota, con depressione della EFVS di grado moderato-severo all’ecocardiogramma (EFVS< 45%), in assenza di controindicazioni generali al ciclo riabilitativo. In tutti i pazienti veniva eseguito al momento della dimissione il six-minute walking test (SMWT) come indice valutativo della capacita’ funzionale e la determinazione dei valori plasmatici di BPN come indice di valutazione obiettivo del compenso emodinamico. I pazienti venivano quindi avviati ad un ciclo di riabilitazione cardiologica della durata di due settimane consistenti in una seduta di terapia fi sica in piscina al mattino e una seduta di terapia fi sica in palestra da svolgersi presso un centro termale. Al termine del ciclo riabilitativo svolto in ambiente termale veniva ripetuta la determinazione del BNP ed il six-minute walking test.
Sono state calcolate come medie e deviazioni standard le variabili continue. I confronti tra i dati basali e quelli dopo trattamento con il test t di Student per i dati appaiati. Un valore di p<0.05% è stato considerato statisticamente signifi cativo.
Risultati. Tutti i pazienti hanno portato a termine il periodo di training previsto. Nessun paziente ha presentato complicanze signifi cative sul piano emodinamico o aritmico. Nella nostra popolazione il Six minute walking test basale variava tra i 255 ed i 420 metri (media 341,30 ± 57,21 m). Al termine del ciclo riabilitativo la media risultava di 391,70 ± 62,17 m (p=0.075). Seppur non si raggiungeva la signi-fi cativita’ statistica si evidenziava in tutti i pazienti il miglioramento del dato basale. Nella popolazione considerata i valori plasmatici basali di BNP oscillavano tra 72 e 214 pg/ml (media 133,60 ± 51,47 pg/ml). Al termine del periodo considerato la media risultava di 123,80 ± 39,30 pg/ml (p=0,64 n.s.).
Conclusioni. Alla fi ne dello studio abbiamo verifi cato un miglioramento non signifi cativo sia del SMWT e di BNP, legati probabilmente all’esiguità del campione. Ovviamente riteniamo tali risultati

80
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
come un’indicazione solamente preliminare e necessitante di ulteriori verifi che sperimentali. Appare comunque estremamente importante il ruolo che l’ambiente termale nel suo insieme potrebbe svolgere nell’aiutare il soggetto con cardiopatia ischemica a mantenere e a verifi care periodicamente l’adesione al progetto di prevenzione secondaria.
ABSTRACT – Background. The treatment of myocardial infarction after overcoming the acute phase includes, in addition to proper medical care, a number of non-pharmacological interventions. The rehabilitative and ‘proven useful in preventing complications and mortality in post-infarcted subject, as well as to improve the subsequent quality of life of the patient.
The physical training is central to of the rehabilitation program.Methods. We enrolled 10 patients (6 males and 4 females) (età 68.6 ± 6.3 years) from consecutive
U.O.N.A. Cardiac Rehabilitation Fossano with known ischemic heart disease, with depression of mod-erate-to- severe EFVS echocardiography (EFVS < 45%), in the absence of contraindications to general rehabilitation cycle. In all the patients was performed at the time of discharge the six- minute walking test (SMWT) as an index of the capacity assessment ‘ functional and determination of plasma levels of BPN as an index of objective assessment of hemodynamic compensation. The patients were then sent to a cycle of cardiac rehabilitation in the last two weeks, consisting of a session of physical therapy in the pool in the morning and a therapy session in the gym to be performed at a spa. At the end of the rehabilitation carried out in a thermal cycle was repeated determination of BNP and the six- minute walking test. Were calculated as averages and standard deviations of continuous variables. Compari-sons between baseline data and those after treatment with the Student t test for paired data. A p value of <0.05% and ‘was considered statistically signifi cant.
Results. All patients have completed the training period expected. No patient presented with sig-nifi cant complications on hemodynamic or arrhythmic. In our population the Six minute walking test baseline ranged between 255 and 420 meters (average 341.30 ± 57.21 m). At the end of the rehabilitation cycle resulted in average 391.70 ± 62.17 m (p = 0.075). Albeit not reached the signifi cance ‘statistic was evident in all patients the improvement of the given baseline. In the population considered the baseline plasma BNP values ranged between 72 and 214 pg / ml (mean 133.60 ± 51.47 pg / ml). At the end of the period considered, the average appeared to 123.80 ± 39.30 pg / ml (p = 0.64 ns).
Conclusion. At the end of the study we found a non-signifi cant improvement of both the SMWT and BNP, probably related to the smallness of the sample. Obviously, we consider these results as an indica-tion only preliminary and in need of further experimental verifi cation. It appears, however, extremely important to the role that the thermal environment as a whole could play in helping the patient with isch-emic heart disease to maintain and periodically verify our membership in the secondary prevention.
Parole Chiave – Riabilitazione cardiologica, ambiente termale, cardiopatia ischemicaKey words – Cardiologic rehabilitation, Spa environment, ischemic heart disease
Premessa
È noto che il trattamento dell’infarto mio-cardico successivo al superamento della fase acuta comprende, accanto a una adeguata
terapia medica, anche una serie di interventi di tipo non farmacologico.
Tali misure devono essere instaurate il più precocemente possibile con l’obiettivo di educare il paziente verso una corretta infor-

81
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
mazione sanitaria, un adeguato controllo della propria labilità emotiva e, di conseguenza, una effi cace prevenzione delle complicanze.
L’intervento riabilitativo basato sull’indi-viduazione dei fattori correlati con le attuali condizioni del soggetto, sul rischio di deterio-ramento della qualità di vita, su una adeguata informazione del paziente, sull’impostazione di un programma di riabilitazione fi sica in-dividualizzato e sull’avvio delle regole di prevenzione secondaria, si è dimostrato utile nel prevenire le complicanze e la mortalità nel soggetto post-infartuato, nonchè nel migliorare la successiva qualità della vita del paziente.
Pertanto, in quest’ottica, possiamo intro-durre il concetto di riabilitazione cardiologica omnicomprensiva ed integrata.
Riabilitazione cardiologica
Negli ultimi anni il concetto di riabili-tazione cardiologica si è via via modifi cato principalmente per il verifi carsi di:a) Tendenza alla riduzione della mortalità per
eventi coronarici acuti con una sostanziale crescita della vita media. Questo ha deter-minato un aumento della prevalenza dei pazienti affetti da cardiopatia ischemica cronica con nuovi bisogni assistenziali.
b) Decorso prolungato delle malattie cardio-vascolari con fasi d’instabilità.
Ciò ha richiesto la necessità di ricercare e prevenire i fattori responsabili della progressione della malattia in oggetto e di identifi care i pazienti a rischio elevato su cui concentrare le risorse.
c) Maggior possibilità d’interventi terapeutici in malattie cardiache croniche inevitabil-mente progressive ad elevata prevalenza
come lo scompenso cardiaco. Pertanto la defi nizione di Riabilitazione
Cardiologica attualmente va’ intesa come: “Somma d’interventi richiesti per garantire
le migliori condizioni fi siche, psicologiche e sociali in modo che i pazienti con cardiopatia cronica o post-acuta possano, con i propri mezzi, conservare o riprendere il proprio posto nella società”.
Vengono così evidenziati sia il soggetto della riabilitazione (il paziente con cardiopatia cronica o a lungo termine) sia gli obiettivi e i benefi ci degli interventi (Tab. 1)
In conclusione possiamo affermare che la riabilitazione cardiologica è anche un “valore aggiunto in prevenzione secondaria” in quanto può offrire un intervento unitario e omnicom-prensivo, non solo parcellare, indispensabile per il passaggio del paziente dalla fase acuta della malattia al graduale reinserimento nella società.
Essa infatti fornisce un’assistenza globa-le ed una vera continuità assistenziale nella valutazione clinico-strumentale, nell’ottimiz-zazione della terapia medica e nel ricondizio-namento fi sico del soggetto.
Inoltre può favorire un più facile contatto con il cardiologo curante per la valutazione dei sintomi, per consigli e suggerimenti, per la correzione dei fattori di rischio, per la ras-sicurazione in previsione del reinserimento socio - ambientale - lavorativo.
Tabella 1. Obiettivi e benefi ci della Riabilitazione Cardiologica
- raggiungere o conservare uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale. - bloccare la progressione della malattia identifi cando e
modifi cando i fattori di rischio- promuovere il processo di recupero- counseling della gestione della malattia- favorire il reinserimento familiare e lavorativo- ottimizzare il trattamento delle frequenti comorbilità

82
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
Cardiopatia ischemica post-infartuale e disfunzione ventricolare sinistra
La disfunzione ventricolare sinistra e’ il più importante predittore singolo di mortalità dopo l’infarto miocardico (1). La disfunzione ventricolare sinistra nel soggetto post-infar-tuato è caratterizzata sia da una disfunzione sistolica isolata che da una disfunzione sisto-diastolica.
La disfunzione diastolica del ventricolo sinistro porta ad un aumento delle pressioni venose polmonari con congestione polmonare, mentre la disfunzione sistolica è principal-mente responsabile della diminuzione della gittata sistolica e della frazione di eiezione. Oltre alla dimensione dell’area infartuale altri importanti predittori dello sviluppo di sintomi di insuffi cienza ventricolare sinistra sono l’età avanzata ed il diabete mellito. La mortalità aumenta proporzionalmente alla gravità della compromissione emodinamica (1).
Oltre l’estensione dell’area infartuata la progressione verso l’insuffi cienza ventricolare sinistra è data dai meccanismi alla base dello sviluppo del rimodellamento ventricolare sinistro.
Il rimodellamento miocardico è il termine usato per descrivere una serie di cambiamenti nella struttura cardiaca che accade in risposta ad una lesione (per es. ischemica) o ad un prolungato incremento del lavoro cardiaco. Il rimodellamento ventricolare sinistro è un processo attraverso il quale la dimensione ventricolare sinistra (VS), la sua forma e la sua funzione sono regolati da fattori meccanici, ge-netici e neurormonali (2-3). Le risposte all’in-farto miocardio sono numerose e coinvolgono cambiamenti a livello cellulare e molecolare. La morte cellulare dei miocardiociti determina,
infatti, modifi che del carico lavorativo anche nelle aree remote non colpite dall’evento ische-mico. Il rimodellamento ventricolare sinistro include, pertanto, dilatazione, ipertrofi a, cica-trizzazione, risposta neurormonale, attivazione di citochine e stress ossidativo (4-6).
Il rimodellamento ventricolare sinistro post-infarto miocardico deve essere considerato un target primario nel trattamento del paziente infartuato, considerata l’enorme implicazione prognostica.
Le terapie messe in campo devono mirare a ridurre e rallentare la progressione verso lo scompenso cardiaco refrattario del paziente infartuato (7). Accanto alla terapia medica, un ruolo importante potrebbe essere rivestito anche dal training fi sico.
Training fi sico
Il training fi sico è il cardine del programma riabilitativo.
Esso, infatti, si è dimostrato essere sicuro e di importanza rilevante anche nei soggetti con disfunzione ventricolare sinistra.
È inoltre anche estendibile ai pazienti più anziani .
Sono noti gli effetti favorevoli dell’attività fi sica sul miglioramento della capacità fun-zionale, sui più importanti fattori di rischio cardiovascolare (diabete mellito, dislipidemia, ipertensione arteriosa, sovrappeso/obesità e sul versante emostatico-coagulativo), sulla riduzione della mortalità e morbilità.
Il training fi sico è stato proposto ed utiliz-zato nel trattamento non farmacologico dello scompenso cardiaco da circa 20 anni, malgrado solo recentemente sia stato riconosciuto come un vero e proprio strumento terapeutico (8) e

83
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
sia entrato a far parte delle raccomandazioni delle principali Società Cardiologiche inter-nazionali (9).
Riabilitazione in ambiente termale
Da sempre l’ambiente termale è stato con-siderato particolarmente idoneo, per alcune proprietà fi siche (temperatura, umidità, altez-za) e chimica dei suoi prodotti (acque,aerosol, inalazioni vapori, fanghi ecc.) al trattamento delle patologie croniche (10-13).
La medicina termale è quella “medicina scientifi ca”, ai sensi delle recenti normative vigenti oggi nella legislazione italiana, che si inserisce a pieno titolo nei protocolli e nei percorsi riabilitativi (14).
Da non trascurare anche il buon grado di accettazione dei pazienti grazie all’amplissima disponibilità di risorse ed alla abituale assenza di effetti indesiderati rilevanti.
La stazione termale è oggi un presidio me-dico a tutti gli effetti dove la combinazione di progresso tecnologico, mezzi e tecniche terma-li, fattività ambientale garantiscono trattamenti e prestazioni di alta effi cacia (15-16)
Un’attenzione sempre maggiore viene inol-tre riposta nell’offerta termale anche ad aspetti di importanza quali la corretta alimentazione, l’attività fi sica ed in generale il ripristino del benessere del paziente.
Il mezzo termale e le particolari metodiche di impiego, le modalità d’azione ed i risultati ottenibili sono elementi che fanno della cre-noterapia riabilitativa un mezzo terapeutico per eccellenza.
Con la terapia termale (balneoterapia, fan-goterapia, terapia idroponica ed inalatoria) si sfruttano le proprietà fisiche del mezzo
termale (calore, galleggiamento e pressione) cui si sommano gli effetti specifi ci delle acque minerali che grazie alla loro composizione sono in grado di indurre effetti farmacologici. (17-19).
Una attrezzata stazione termale offre per-tanto la possibilità di sviluppare percorsi di trattamento attraverso l’applicazione di:– Metodiche associate che comprendono
tutte quelle tecniche di terapia fisica e kinesiterapia che possono essere associate alla crenoterapia, ma che da questa sono di-sgiunte: massoterapia, fi sioterapia a secco, ultrasuonoterapia, laserterapia, magnetote-rapia ecc.
– Metodiche integrate che comprendono tutte le caratteristiche della stretta integrazione di mezzo fi sico e termale, che applicate assie-me danno luogo ad un sinergismo d’azione: idrokinesiterapia in acqua termale, idromas-saggio termale, percorso vascolare ecc.Il sinergismo d’azione dell’utilizzo di
quanto detto costituisce il razionale per l’at-tuazione di programmi riabilitativi in sede termale (20).
A ciò va aggiunta la necessaria parteci-pazione di fattori come l’ecoambiente della terma propriamente detta e l’educazione sanitaria che il paziente riceve con soluzioni personalizzate (dieta, educazione alimentare, cessazione dell’abitudine al fumo, attività fi -sica aerobica spontanea, programmi specifi ci personalizzati).
È proprio questo divenire del progresso nella prevenzione e nella salute globale della persona che rappresenta una delle sfi de più importanti che il termalismo si è proposto di affrontare in questi ultimi anni.
La possibilità di usufruire di controlli me-dici adeguati, del trattamento delle frequenti

84
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
comorbilità nel paziente con cardiopatia ischemica cronica e la sempre più frequente associazione di centri riabilitativi (anche car-diologici) con le strutture termali sono altri elementi rilevanti nell’ambito della gestione del paziente post-infartuato. Il loro utilizzo è chiaramente condizionato da un adeguato controllo sanitario e nel corretto rispetto delle indicazioni e controindicazioni da applicare ad ogni singolo soggetto.
Studio clinico
Alla luce di queste evidenze abbiamo voluto osservare l’effetto del proseguimento della riabilitazione cardiologica in ambiente termale basato su un trattamento misto idrokinesiotera-pico e fi sioterapico convenzionale in un gruppo di 10 pazienti con cardiopatia ischemica e depressione di grado moderato-severo della funzione sistolica ventricolare sinistra, dopo un primo periodo di riabilitazione Cardiologica Convenzionale svolta presso la U.O.N.A. di Riabilitazione Cardiologica dell’Ospedale SS Trinità di Fossano (CN).
A tali pazienti, alla dimissione veniva proposto il proseguimento del trattamento ri-abilitativo presso le Strutture termali di Acqui Terme o di Valdieri, scelte a tale proposito per la comoda collocazione geografi ca riguardo al domicilio della maggior parte della popolazio-ne ricoverata presso il Centro di Riabilitazione Cardiologica di riferimento. È stato quindi predisposto un programma di Riabilitazione Cardiologica con un gruppo di fi sioterapisti in servizio presso i Centri termali prescelti che comprendesse una fase di idrokinesiterapia svolta in piscina ed una fase di fi sioterapia svolta in palestra, personalizzato in base alla
capacità funzionale del paziente valutata con Elettrocardiogramma da sforzo.
I pazienti avevano inoltre la facoltà di gio-varsi delle terapie crenoterapiche disponibili presso la struttura termale in base all’eventuale presenza di comorbilità respiratoria, osteoarti-colare o vascolare.
È stato individuato come indice della ca-pacità funzionale del soggetto il six minute walking test e come indice del compenso emodinamico i valori plasmatici di BNP.
Peptide natriuretico atriale di tipo B (BNP)
La sigla deriva da Peptide Natriuretico di tipo B (B, originariamente, si riferiva a Brain). Come gli altri peptici natriuretici, il BNP ha azione diuretica, natriuretica e vasodilatatrice, esercitando un effetto favorevole in caso di scompenso cardiaco. Il BNP è prodotto quasi esclusivamente dalle cellule del miocardio ventricolare in risposta all’aumento di volume ventricolare e all’aumento della pressione di fi ne diastole all’interno del ventricolo stesso.
Il BNP aumenta soprattutto in caso di disfunzione ventricolare, ma può elevarsi sia nelle patologie edematose che comportino un aumento della pressione atriale e ventricolare quali insuffi cienza renale, cirrosi epatica con ascite, ecc. ed anche in presenza di angina instabile ed ipertensione polmonare (21-22).
Da quando è stato documentato il valore predittivo positivo del 70% e negativo del 98%, l’attenzione si è concentrata sul Brain Natriuretic Peptide ed in particolare, recente-mente, sul N-Terminal proBNP (NT-BNP), più stabile e presente in maggiori concentrazioni in circolo.
Le recenti linee guida della Società Euro-pea di Cardiologia (23) hanno introdotto la

85
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
determinazione del BNP nell’iter diagnostico dello scompenso, indicandone l’esecuzione “se disponibile” insieme agli altri esami ematochimici ed all’ECG. L’utilizzo del BNP, suggerito da queste linee guida, è legato alla possibilità di escludere con elevato grado di probabilità la presenza di disfunzione ventri-colare in caso di valori di BMP non elevati. L’utilità del BNP nei soggetti anziani nella pratica della Medicina Generale era già stata evidenziata da studi osservazionali ed è stata recentemente riconfermata da Hobbs et al. (24) che hanno dimostrato la validità dell’NT-BNP nella diagnosi di SC da “disfunzione sistolica” in una popolazione non selezionata del West Midlands, in Inghilterra; in questi soggetti valori superiori a 36 pmol/l mostra-vano un valore predittivo negativo tra il 97 ed il 100%, anche in soggetti ad alto rischio per scompenso.
Anche in Italia, è stato avviato uno studio (effettuato in collaborazione tra Istituto Mario Negri, ANMCO e SIMG) per la valutazione dell’accuratezza NT-BNP per il riconoscimen-to dello scompenso cardiaco di nuova diagnosi utilizzando come gold standard una diagnosi basata sui criteri della Società Europea di Cardiologia.
Un’altra applicazione interessante è la diagnosi differenziale delle dispnee acute. Il test rapido, al letto del paziente nel diparti-mento d’emergenza, ha mostrato un valore predittivo negativo del 96%, dimostrandosi utilissimo per differenziare la dispnea di origine cardiaca da quella derivante da altre patologie (25).
I livelli di BNP sono correlati alla gravità dello scompenso ed alla prognosi e potranno probabilmente essere utilizzati, in un prossimo futuro, anche per modulare la terapia.
Six-minute walking test (SMWT)
Il test del cammino per 6 minuti (six-minute walking test) è un esame inizialmente utilizza-to nella valutazione di pazienti con patologie croniche dell’apparato respiratorio, quali la BPCO e l’insuffi cienza respiratoria, e che ha poi destato l’interesse dei cardiologi per la sua semplicità di esecuzione e di interpretazione, per cui è stato largamente indagato il suo ruolo nella quantifi cazione della limitazione fun-zionale, nella valutazione dell’effi cacia degli interventi terapeutici e nella stratifi cazione prognostica dei pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico.
Il six-minute walking test (SMWT) consi-ste nel far percorrere al soggetto in esame la massima distanza possibile nell’intervallo di tempo prestabilito di sei minuti, lasciandogli comunque la possibilità di fermarsi o rallentare e quindi riprendere la marcia sulla base della propria percezione del grado di affaticamen-to raggiunto (per le modalità di esecuzione del test vedi avanti). Sebbene vari parametri possano essere valutati durante il test, quali il comportamento della pressione arteriosa e/o della frequenza cardiaca, il numero di soste necessarie, la velocità della deambulazione o addirittura il comportamento dei gas respiratori (misurati con una strumentazione portatile), tuttavia la distanza percorsa in 6 minuti rap-presenta il parametro solitamente considerato nella pratica clinica e quello che comunque ha dimostrato una potenziale utilità in quasi tutti gli studi pubblicati.
La possibilità che la distanza percorsa al test del cammino possa essere un indicatore prognostico nei pazienti con scompenso car-diaco cronico è stata esplorata in numerosi studi. Livelli minori di tolleranza allo sforzo,

86
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
generalmente espressi da una distanza <300 metri al 6MWD, si sono dimostrati predittivi di mortalità (totale e cardiovascolare) e mor-bilità (ospedalizzazioni per scompenso) sia nei pazienti con disfunzione sistolica ventri-colare sinistra asintomatica e/o con scompenso lieve-moderato (26-29), che nei pazienti con scompenso cardiaco avanzato (30-31).
Il test del cammino per 6 minuti, pur con i limiti in precedenza segnalati (ed altri che potranno emergere da una sua più ampia diffusione), sembra rappresentare un esame con caratteristiche particolarmente favorevoli nello studio dello scompenso cardiaco croni-co. Non a caso le Linee Guida dell’American Thoracic Society sul SMWT, recentemente pubblicate (32), raccomandano l’impiego del test del cammino per la valutazione funzionale, la valutazione dell’effi cacia della terapia e la stratifi cazione prognostica del paziente con scompenso cardiaco.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati 10 pazienti (6 maschi e 4 femmine) (età 68,6 ± 6,3 anni) consecutivi provenienti dalla U.O.N.A. di Riabilitazione Cardiologica di Fossano affetti da cardiopatia ischemica nota, con depressione della EFVS di grado moderato-severo all’ecocardiogramma (EFVS< 45%), in assenza di controindicazioni generali al ciclo riabilitativo (Tab. 2) valutate da un Cardiologo e che fornissero il proprio consenso al proseguimento del ciclo riabilita-tivo presso le Strutture termali individuate pre-cedentemente. Vedi Tab. 3 per le caratteristiche della popolazione. Tutti i pazienti erano affetti da cardiopatia ischemica nota come richiesto dallo studio. Nove pazienti avevano presentato pregresso infarto miocardico acuto; di questi 2
erano stati sottoposti ad intervento di rivascola-rizzazione miocardica chirurgica (CABG), uno a CABG e valvuloplastica mitralica, quattro erano stati sottoposti a rivascolarizzazione miocardica con metodica percutanea (PTCA), in due era stata posta indicazione a terapia me-dica in assenza di ischemia miocardica induci-bile. Un paziente aveva presentato episodio di scompenso cardiaco in presenza di alterazioni della cinesi segmentaria del ventricolo sinistro con quadro coronarografi co sfavorevole per rivascolarizzazione miocardica percutanea ed assenza di ischemia inducibile all’Ecostress con dobutamina.
Nella popolazione presa in esame la frazio-ne di eiezione del ventricolo sinistro (EFVS) all’ecocardiogramma era 39,00 ± 4,2%.
Tutti i pazienti proseguivano la terapia me-dica impostata al momento della dimissione salvo variazioni terapeutiche imposte dalla valutazione clinica eseguita da un Cardiologo dello stesso Centro di Riabilitazione Cardiolo-gica a cui era deputato il proseguimento della valutazione clinica del paziente con cadenza settimanale.
Tutti i pazienti venivano sottoposti al mo-mento della dimissione dal Centro di Riabili-tazione Cardiologica ad elettrocardiogramma da sforzo per la valutazione della capacità funzionale e per l’esclusione della presenza di ischemia inducibile da sforzo e ad ecocar-diogramma transtoracico per la valutazione della funzione sistolica globale del Ventricolo sinistro assumendo come indice la Frazione di eiezione ventricolare sinistra (EFVS).
In tutti i pazienti veniva eseguito al mo-mento della dimissione dal Centro di Riabili-tazione Cardiologica il six-minute walking test (SMWT) come indice valutativo della capaci-ta’ funzionale e la determinazione dei valori

87
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
plasmatici di BPN come indice di valutazione obiettivo del compenso emodinamico.
I pazienti venivano quindi avviati ad un ciclo di riabilitazione cardiologica della durata di due settimane consistenti in una seduta di te-rapia fi sica in piscina al mattino e una seduta di terapia fi sica in palestra da svolgersi presso uno dei due Centri termali individuati ed eseguite da un gruppo di fi sioterapisti adeguatamente formati ed in presenza di un medico dedicato nella Struttura.
Al termine del ciclo riabilitativo svolto in ambiente termale veniva ripetuta la determina-zione del BNP ed il six-minute walking test.
Il disegno dello studio è rappresentato in Fig. 1.
Training
Per la durata di due settimane i pazienti sono stati sottoposti per cinque giorni alla settimana (riposo di due giorni consecutivi a settimana) ad una seduta giornaliera di idrokinesiterapia svolta in piscina nella mattina e ad una seduta di fi sioterapia svolta in palestra. In entrambi i casi lo svolgimento della seduta veniva impostato sulla base di un programma individualizzato che teneva conto del precedente ciclo riabili-tativo ospedaliero e del risultato dell’elettro-cardiogramma da sforzo. Le sedute venivano monitorizzate mediante cardiofrequenzimetro
Tabella 2. Criteri di esclusione
Angina instabile
Assenza di segni clinici di scompenso
PAS >160 mmHg e PAD >100 mmHg, a riposo
Stenosi aortica severa
Malattie sistemiche in fase acuta; febbre
Aritmie atriali e ventricolari non controllate
Tachicardia a riposo
Fig 1. Disegno dello Studio.

88
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
da polso resistente all’acqua Oregon Scienti-fi c SE211. Il controllo pressorio veniva eseguito all’inizio, durante ed alla fi ne della seduta. Cia-scuna seduta era composta da una prima fase di esercizi respiratori e calistenici della durata di 20-30 minuti e da training con cicloergometro (acqua bike) effettuato con modalità interval-training (ogni 3-5 minuti veniva variata la resi-stenza in modo da alternare periodi di lavoro a carico moderato a periodi di recupero a basso carico della stessa durata). Il carico allenante (durata-intensità) veniva progressivamente au-mentato in base alla tolleranza allo sforzo del paziente e agli obiettivi per lui previsti. Si e’ cercato di raggiungere l’80% della frequenza cardiaca massimale per l’età senza comunque superare il valore di doppio prodotto ottenuto al test ergometrico).
Analisi statistica
Sono state calcolate come medie e devia-zioni standard le variabili continue. I confronti tra i dati basali e quelli dopo trattamento con il test t di Student per i dati appaiati. Un valore di p<0.05% è stato considerato statisticamente signifi cativo.
Risultati
Tutti i pazienti hanno portato a termine il periodo di training previsto. Nessun paziente ha presentato complicanze signifi cative sul piano emodinamico o aritmico. In un paziente e’ stato necessaria la riduzione del dosaggio di ace-inibitore per riduzione dei valori pressori sistolici stabilmente < 90 mmHg in assenza
Tabella 3. Caratteristiche della popolazione
paziente sesso anni PTCA CABG VALV CAD LVEF LVEDD LVESD
1 f 64 0 + + + 42 52 45
2 m 74 0 + 0 + 40 58 49
3 f 76 + 0 0 + 32 59 49
4 f 74 0 0 0 + 35 53 42
5 m 70 + 0 0 + 41 62 49
6 m 76 0 0 0 + 44 53 40
7 m 65 + 0 0 + 38 58 42
8 f 66 0 0 0 + 40 59 43
9 m 63 + 0 0 + 44 52 40
10 m 58 0 + 0 + 34 62 50
PTCA: angioplastica coronaria per cutaneaCABG: rivascolarizzazione miocardia chirurgicaVALV: riparazione valvolare chirurgicaCAD: cardiopatia ischemica post-infartuale notaLVEF: frazione di eiezione ventricolare sinistraLVEDD: diametro telediastolico ventricolare sinistroLVESD: diametro telesistolico ventricolare sinistro

89
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
di sintomi e ben tollerata emodinamicamente. In base ai valori pressori e della frequenza cardiaca l’ottimizzazione della posologia di ace-inibitore e’ stata effettuata in un paziente mentre in due pazienti è stata ottimizzata la terapia con ace-inibitore e b-bloccante.
Six-minute walking test
Nella nostra popolazione il Six minute walking test basale variava tra i 255 ed i 420
metri (media 341,30 ± 57,21 m). Al termine del ciclo riabilitativo la media risultava di 391,70 ± 62,17 m (p=0.075). Seppur non si raggiun-geva la signifi catività statistica si evidenziava in tutti i pazienti il miglioramento del dato basale (Fig. 2).
Nella popolazione considerata i valori pla-smatici basali di BNP oscillavano tra 72 e 214 pg/ml (media 133,60 ± 51,47 pg/ml). Al termi-ne del periodo considerato la media risultava di 123,80 ± 39,30 pg/ml (p=0,64 n.s.) (Fig 3).
Fig. 2.

90
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
Discussione
In Italia la prevalenza di infarto miocardico è di circa 110.000 casi/anno. La disfunzio-ne ventricolare sinistra è il più importante predittore singolo di mortalità dopo infarto miocardio.
È noto che il trattamento dell’infarto mio-cardico successivo al superamento della fase acuta comprende, accanto a una adeguata terapia medica, anche una serie di interventi di tipo non farmacologico. Tali misure devono essere instaurate il più precocemente possi-
bile con l’obiettivo di avviare una adeguata informazione sanitaria, controllare la labilità emotiva, prevenire le complicanze.
In questa ottica và intesa l’attuale con-cezione di riabilitazione cardiologica omni-comprensiva. L’intervento riabilitativo basato sull’individuazione dei fattori correlati con le attuali condizioni del soggetto, sul rischio di deterioramento della qualità di vita, su una adeguata informazione del paziente, sull’im-postazione di un programma di riabilitazione fi sica individualizzato e sull’avvio delle regole di prevenzione secondaria, si è dimostrato utile
Fig. 3

91
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
nel prevenire le complicanze e la mortalità nel soggetto post-infartuato, nonchè nel migliorare la successiva qualità di vita del paziente.
Il training fi sico aerobio possiede la funzio-ne di migliorare la frazione di eiezione ven-tricolare sinistra nei pazienti con disfunzione sistolica, riducendo la naturale tendenza alla dilatazione dei diametri ventricolari. L’effetto positivo del training fi sico sul rimodellamento ventricolare sinistro potrebbe essere correlato all’azione positiva sul sistema neuroendocrino, ma probabilmente anche ad altri meccanismi come il miglioramento della componente mi-crocircolatoria della perfusione miocardica e l’effetto favorevole sulla funzione endoteliale. È da considerare che se il training fi sico sembra avere una azione positiva sul rimodellamento ventricolare, tale effetto si possa verifi care in presenza di una condizione neurormonale ‘fa-vorevole’, come quella che si realizza in conco-mitanza con un’ottimale terapia farmacologia, condizione imprescindibile per ottenere un miglioramento emodinamico.
In passato il soggetto cardiopatico è stato spesso accostato con diffi denza al progetto riabilitativo termale per le temute azioni emo-dinamiche sfavorevoli del mezzo termale.
Nel nostro Studio sebbene eseguito su un piccolo campione, soggetti affetti da cardio-patia ischemica con depressione di grado moderato-severo della funzione ventricolare sinistra hanno mostrato una buona tolleranza di un ciclo riabilitativo basato sull’idrokinesitera-pia svolto in ambiente termale. Ci permettiamo pertanto di inserirlo come dato preliminare.
Nel nostro studio il miglioramento del SMWT, pur verifi candosi in tutti i pazienti, si avvicinava ma non raggiungeva la signifi cativi-tà statistica probabilmente a causa della piccola numerosità della popolazione. Questo dato và
comunque ritenuto, a nostro avviso, piuttosto rilevante anche se, a causa del disegno dello studio, non è possibile individuare quanta parte del merito di questo risultato sia da attribuire alle caratteristiche dell’ambiente termale in cui il training e’ stato svolto e quanto all’effi cacia della terapia fi sica in piscina di per sè.
L’ottima tolleranza anche dal punto di vista emodinamico testimoniata dall’assenza di una signifi cativa variazione del valore del BNP basale rispetto a quello fi nale lascia comunque intravedere la notevole potenzialità anche in ambito cardiologico della terapia riabilitativa in ambiente termale, già nota in campo respi-ratorio, vascolare e neuromotorio.
Infatti, limitatamente al piccolo gruppo di soggetti affetti da cardiopatia ischemica nota con depressione dalla frazione di ejezione di grado moderato-severo esaminata nel nostra studio, si è osservato il miglioramento signi-ficativo della capacità funzionale espressa dal six-minute walking test dopo un ciclo di riabilitazione fi sica svolto con metodica mista (attraverso il mezzo termale unito a cicli di terapia fi sioterapica convenzionale).
Questo risultato è verosimilmente da asso-ciare anche all’ottimale controllo emodinamico con terapia medica dei soggetti sottoposti allo studio e all’esclusione preventiva di controin-dicazioni note alla riabilitazione cardiologica basata sul training fi sico che verosimilmente si possono estendere con sicurezza anche al training svolto in ambiente termale.
Ovviamente, data l’esiguità del campio-ne, riteniamo tali risultati come un’indica-zione solamente preliminare e necessitante di ulteriori verifiche sperimentali. Appare comunque estremamente importante il ruolo che l’ambiente termale nel suo insieme po-trebbe svolgere nell’aiutare il soggetto con

92
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
cardiopatia ischemica a mantenere e a verifi -care periodicamente l’adesione al progetto di prevenzione secondaria inteso oltre che come training fi sico anche come l’insieme delle misure igienico-sanitarie (controllo del peso, dieta corretta, cessazione dell’abitudine al fumo, svezzamento dallo stress) che assieme ai periodici controlli clinici e all’adesione alla terapia medica è indispensabile vengano mantenuti a tempo indeterminato.
A nostro avvivo è da evidenziare anche l’utilità della riabilitazione termale per il soggetto cardiopatico in considerazione della frequente comorbilità di patologie respiratorie, vascolari periferiche e neuromotorie.
In conclusione l’ecosistema termale po-trebbe rivelarsi come una risorsa di rilievo nella gestione della popolazione dei soggetti cardiopatici la cui epidemiologia và spostan-dosi verso un’età sempre più avanzata e in cui l’aumento della storia clinica della malattia dovuto agli straordinari progressi delle terapie convenzionali impongono una lunga adesio-ne ad un progetto di prevenzione secondaria inteso come “Somma d’interventi richiesti per garantire le migliori condizioni fi siche, psicologiche e sociali in modo che i pazienti con cardiopatia cronica o post-acuta possano, con i propri mezzi, conservare o riprendere il proprio posto nella società”.
Bibliografi a
1. ZIPES D, LIBBY P, BONOW R, et al. Ma-lattie del Cuore di Braunwald - Trattato di medicina cardiovascolare. Settima edizione 2007; 47:1218
2. PFEFFER MA, BRAUNWALD E. Ventricu-lar remodeling after myocardial infarction:
experimental observations and clinical impli-cations. Circulation 1990; 81:1161-72
3. ROULEAU JL, DE CHAMPLAIN J, KLEIN M et al. Activation of neurohumoral systems in postinfarction left ventricular dysfunction. J Am Coll Cardiol 1993; 22:390-8
4. SUTTON MG, SHARPE N. Left ventricular remodelling after myocardial infarction: pa-thophysiology and therapy. Circulation 2000; 101:2981-8
5. COHN JJ, FERRARI R, SHARPE N. Cardiac remodelling-concepts and clinical implica-tions: a consensus paper from an international forum on cardiac remodelling. Behalf of an International Forum on Cardiac Remodeling. J Am Coll Cardiol 2000; 35:569-82
6. TIYYAGURA SR, PINNEY SP.Left ven-tricular remodelling after myocardial infarction:past, present and future. Mt Sinai J Med 2006; 73:840-51
7. ISIS-4 Collaborative Group. ISIS-4: a randomized factorial trial assessing early oral captopril, oral nitrate and intravenous magnesium sulphate in 58050 patients with suspected acute myocardial infarction. Lancet 1995; 345:669-82
8. CORRÀ U, MEZZANI A, BOSIMINI E, et al. Prognostic value of time-related changes of cardiopulmorary exercise testing indices in stable chronic heart failure: a pragmatic and operative scheme. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006; 13:186-92
9. KAVANAGH T, MERTENS DJ, HAMM LF, et al. Prediction of long-term prognosis in 12,169 men referred for cardiac rehabilitation. Circulation 2002; 106:666
10. AGOSTINI G. Ecologia delle Stazioni termali. Atti Accademia S.A.S. 1998; 3:37
11. AGOSTINI G. Manuale di medicina termale. Archimedia Ed Torino 2000

93
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
12. LAMPA E, CAZZOLA M, MARMO M, et al. Effetti sulla broncoreattività aspecifi ca di un'acqua termale salso-alcalina. Med Clin Term 1992; 6:83-7
13. MIRAVALLE C. MATERA MG, FALZA-RANO C, et al. Applicazione di modelli ma-tematici per l'interpretazione di dati biologici nella ricerca farmacologica. Rend Atti Accad Sc Med Chir Soc Naz Scienze Lettere ed Arti - Napoli 1991; 145:165-80
14. M.I.U.R Dalla salute al benessere: i contributi istituzionali, 2007
15. MESSINI M. L’ambiente della Stazione ter-male. Terme e Riviere 1975, marzo-aprile: 3-4
16. MESSINA B. Rapporti tra salute, clima e ambiente. Clin Term 1993; 46:3
17. GRASSI M. Le acque minerali nella terapia dell’apparato digerente. Clin Term 2003; 50: 29
18. GROSSI F. Qualità di vita e benessere in relazione alla Medicina Termale. Clin Term 2007; 54:3-4, 51-7
19. AMETRANO L, LAMPA E. ROSSI F. An-troterapia a calore secco : le stufe di San Germano. Med Clin Term 1992; 6:101-7
20. BELLOMETTI S. La Riabilitazione termale: stato dell’arte e prospettive future. Clin Term 2007; 54:3-4, 81-8
21. MAIR J, HAMMER-LERCHER A, PU-SCHENDORF B. The impact of cardiac natri-uretic peptide determination on management of heart faiulure. Clin Chem Lab Med 2001; 39:571-88
22. YOSHIMURA M, YOSHUE H, MORITA E, et al. Hemodinamic, renal, and hormonal re-sponses to brain natriuretic peptide in patients with congestive heart failure. Circulation 1991; 81:1581-8
23. REMME WJ, SWELDBERG K, et al.
Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Eur Heart J 2001; 22:1527-60
24. HOBBS FD, DAVIS RC, ROALFE AK, et al. Reliability of N-terminal pro-brain natriuretic peptide assay in diagnosis of heart failure: cohort study in representative and high risk community population. BMJ 2002; 324: 1498
25. MAISEL AS, KRISHNASWAMY P, NOVAK RM, et al. Rapid measurement of B-type natri-uretic peptide in emergency diagnosis of heart failure. N Eng J Md 2002; 347:161-7
26. BITTNER V, WEINER D, YUSUF S, et al Prediction of mortality and morbidity with a six-minute walk test in patients with left ven-tricular dysfunction. J Am Med Assoc 1993; 270:1702-7
27. ZUGCK C, KRUGER C, DURR S, et al. Is the six-minute walk test a relaible substitute for peak oxigen uptake in patients with dila-ted cardiomyoopathy? Eur Heart J 2000; 21: 540-9
28. SHAH MR, HAISSELBLAD V, GHEOR-GHIADE M, et al. Prognostic usefulness of six-minute walk in patients with advanced heart failure secondary to ischemic or non ischemic cardiomyopathy. Am J Cardiol 2001; 88:987-93
29. LUCAS C, STEVENSON LW, JOHNSON W et al. The 6-minute walk and peak of oxygen consumption in advanced heart failure: aero-bic capacity and survaival. Am Heart J 1999; 138:618-24
30. GALIÈ N, HUMBERT M, VACHIERY JL, et al. Effect of beraprost sodium, an oral prosta-cyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension : a randomized, double blind, placebo-controlled trial. J Am Coll Cardiol 2002; 346: 1845-53

94
La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia ischemica post-infartualeClin. Term. 60 (3-4):79-94, 2013
31. Abraham WT, Fisher WGG, Smith AL, et al. The MIRACLE Study Group- Cardiac resin-chroization in chronic heart failure. N Engl J Med 2002; 236:1845-53
32. ATS statement: Guidelines for the six-minute walking test. Am J Respir, Crit Care Med 2002; 166:-111-7

95
Valutazione di alcuni effetti di un’acqua cloruro so-dica solfata sulla motilità ciliare di mucosa faringo-esofagea di rana: contributo sperimentaleClin. Term. 60 (3-4):95-100, 2013
Clin. Term. 60 (3-4):95-100, 2013
Chloride sodium sulphate water’s evidences on frog’s ciliary pharyngo-esophageal motility: experimental study
Valutazione di alcuni effetti di un’acqua cloruro sodica solfata sulla motilità ciliare di mucosa faringo-esofagea di rana: contributo sperimentale
G. Gerardi1, F. Cristiano1, C. Volpe1, E. Lampa1
1Dipartimento di Medicina Sperimentale - Seconda Università degli Studi di Napoli, Via Costantinopoli, 16 -80138 Napoli
RIASSUNTO – Scopo di questo studio è valutare gli effetti di un’acqua cloruro sodica solfata ferruginosa sulla motilità ciliare di animali di laboratorio, al fi ne di valutarne la possibilità di utilizzo per cure inalatorie sull’uomo.
ABSTRACT – The aim of this study is to verify the action of chloride sodium sulphate water on ciliary motility in laboratory animals, in order to consider the possibility for human therapeutic inhalation.
PAROLE CHIAVE – acqua termale, farmacodinamica, epiteli ciliati, motilità, cure inalatorieKEY WORDS – spa water, pharmacodynamic, ciliated epithelium, motility, inhalations
Il territorio italiano, particolarmente ricco di acque dalle ben note proprietà terapeuti-che, ha consentito, fi n dai tempi più antichi, la crescita di numerosissime stazioni termali contribuendo, da sempre, in maniera signifi ca-tiva al mantenimento dello stato di salute della popolazione con importanti risvolti in termini preventivi, terapeutici, economici e sociali.
Ciò nonostante la medicina termale è stata, in tempi relativamente lontani, spesso conside-rata come se fosse una medicina alternativa o sostitutiva, a cui approdare solo come ultima
spiaggia dopo i fallimenti delle terapie con-venzionali. Fortunatamente si sta riafferman-do con piena dignità nel suo ruolo, grazie al contributo di tutti: dalle istituzioni (Ministero della Sanità e Consiglio Superiore di Sanità, Università e Scuole di Specializzazione) che già da diversi anni hanno intrapreso il cammi-no di riordino del settore termale, al territorio dove medici e pazienti, in maniera diretta, ne saggiano i benefi ci sulla salute.
In questo clima di crescente interesse socia-le per la crenoterapia, e di rilancio istituzionale

96
Valutazione di alcuni effetti di un’acqua cloruro so-dica solfata sulla motilità ciliare di mucosa faringo-esofagea di rana: contributo sperimentaleClin. Term. 60 (3-4):95-100, 2013
del settore termale, appare più che necessario promuovere la ricerca. Ciò signifi ca fronteg-giare gli ostacoli burocratici, etici, economici, amministrativi, industriali etc., con l’obbiettivo di accreditare con adeguati standard di ricerca, l’indiscutibile valore delle acque delle nostre stazioni termali.
Nella convinzione che il clima di rilancio del settore termale debba essere supportato da prove scientifi che, vogliamo dare il nostro contributo con lo studio che andiamo a pre-sentare sugli effetti farmacodinamici indotti dall’acqua in oggetto sulla motilità ciliare in animali da esperimento.
Premessa
I mezzi di cura termali vanno conside-rati alla stessa stregua dei farmaci, e come farmaci vanno studiati: dalla impostazione generale della ricerca, alla valutazione delle loro caratteristiche farmacocinetiche e far-macodinamiche (mediante prove biologiche e sperimentali in vitro e/o test su animali da laboratorio e successivamente sull’uomo), fi no alle valutazioni di farmacoeconomia (effi cacia, sicurezza, rapporto costo/benefi cio, rapporto rischio/benefi cio).
Lo studio sull’acqua in oggetto, preleva-ta presso l’Hotel Adrian Club S.r.l. sito in Pozzuoli (NA), si propone di valutarne la possibilità di utilizzo sull’uomo mediante somministrazione per via inalatoria.
In precedenti ricerche sperimentali ne è stata valutata la tossicità acuta nella cavia (gui-nea pig) per somministrazione unica mediante aerosol della durata di 60 min. Non è stata os-servata alcuna signifi cativa modifi cazione della sintomatologia respiratoria né effetti dannosi in ciascuna cavia al termine dell’aerosolizza-
zione, a 2 ore, a 6 ore ed ogni giorno sino al 10° giorno dopo il trattamento.
Analogamente la tossicità cronica è stata testata sottoponendo le cavie a somministra-zioni ripetute per aerosol della durata di 10 min al giorno, per 30 giorni. Tali animali sono stati osservati per 60 min dopo ogni aerosoliz-zazione, e poi ogni 3 giorni per 30 giorni dal termine del ciclo terapeutico.
In nessun animale, sia in seguito a som-ministrazione unica sia in seguito a sommini-strazioni ripetute, si è potuto osservare alcuna alterazione del comportamento, del consumo alimentare ed idrico, né manifestazione di sintomi di alcuna natura, né comparsa di alte-razioni macroscopiche a carico delle mucose nasali, tracheali e bronchiali. Né tantomeno si sono verifi cate alterazioni dei parametri laboratoristici ematochimici (emocromo, azo-temia, glicemia, AST, ALT, fosfatasi alcalina, bilirubina), e strumentali (E.C.G., pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria).
Materiali e metodi
L’acqua in studio presenta caratteristiche chimico-fi siche e microbiologiche che permet-tono di classifi carla come acqua ipertermale ricca di minerali, cloruro-sodica, solfata.
Premesso, quindi, che l’acqua in esame non ha mostrato alcuna tossicità né acuta né cronica nella cavia, ci siamo proposti di valutarne l’at-tività sull’epitelio ciliato della mucosa faringo-esofagea di rana utilizzando 2 metodiche: una descritta da Aulisio e coll. (metodica A) e l’altra da Bernfeld e coll. (metodica B).
Sono state utilizzate rane esculente di peso compreso tra 16-28 gr, provenienti da fornitori locali, tenute in contenitori di vetro su terreno

97
Valutazione di alcuni effetti di un’acqua cloruro so-dica solfata sulla motilità ciliare di mucosa faringo-esofagea di rana: contributo sperimentaleClin. Term. 60 (3-4):95-100, 2013
umido-paludoso. La preparazione della muco-sa faringo-esofagea è stata eseguita, sia per la metodica A che per quella B, nella seguente maniera: previa completa distruzione del si-stema nervoso centrale della rana, si isolava e si prelevava la mucosa faringo-esofagea usando la massima delicatezza; quindi la stessa veniva montata, distesa e fi ssata con piccoli spilli di acciaio inossidabile su un rettangolo di sughero.
Il preparato così approntato, veniva, nella metodica A fi ssato in maniera che la soluzio-ne di Howell (pH 7,4) in cui il rettangolo di sughero era immerso lambisse i margini della mucosa senza sommergerla, mentre nella me-todica B era fi ssato in modo che la superfi cie della mucosa fosse completamente sommersa, a circa 3-5mm sotto il pelo del liquido nutritivo costituito da soluzione Ringer (NaCl 1,30 g, KCl 0,028 g, CaC1
2 0,024 g, NaHCO
3 0,04 g,
NaH2PO
4 0,002 g, glucosio 0,4 g, H
2O 200 ml
integrato allo 0,00025% con ATP sale disodico 4H
2O (pH = 7,4).
Per il rilievo della motilità ciliare abbiamo utilizzato: nella prove in A uno scodellino di alluminio del peso di circa 14 mg e con una superfi cie di circa 11 mm2 e nelle prove in B una grossolana sospensione in Ringer di par-ticelle di carbone vegetale.
Prefi ssati due limiti sulla mucosa faringo-esofagea, uno alla estremità nasale di questa e l’altro all’estremità esofagea, si determinava il tempo impiegato (negli esperimenti in A dallo scodellino apposto con una pinzetta e in quelli in B dalle particelle di carbone deposte delicatamente con l’ausilio di una siringa ed un’agocannula) per percorrere 0,5 cm di mucosa.
In particolare, tutti gli esperimenti da noi eseguiti sono stati condotti secondo lo sche-
ma seguente: approntato il preparato, esso si lasciava a riposo per 5 min, affi nché si stabilizzasse, quindi si faceva il rilievo della velocità di base, eseguendo tre successive misurazioni.
La media delle 3 misurazioni costituiva la velocità basale di percorso. Nei preparati ap-prontati con la metodica A, durante il periodo di stabilizzazione, si instillavano di tanto in tanto 2 gocce di soluzione di Howell.
I rilievi della velocità, in tutti i preparati ritenuti idonei, sono stati ripetuti a 0, 5, 10, 15, 30 min. Ciascun rilievo è consistito in 3 successive misurazioni di cui veniva fatta la media, come detto per il rilievo di base.
In un suffi ciente numero di preparati (per entrambe le metodiche) non è stata fatta alcuna somministrazione dell’acqua oggetto di studio costituendo così i controlli della funzionalità normale dei due tipi di preparati. Solo per quelli approntati con la metodica A (in cui i margini di tessuto non venivano sommersi dalla soluzione), al 5° - 10° - 15° - 30° min dall’inizio del rilievo di base si sono seguitate a instillare sulla mucosa stessa 2 gocce di Howell per volta, iniziando le misurazioni 1 min dopo lo sgocciolamento).
Negli altri preparati al 5° - 10° - 15° - 30° min dall’inizio del test è stata somministrata l’acqua in studio secondo le seguenti moda-lità: nei preparati approntati con la metodica A instillando 2 gocce in modo da bagnare uniformemente tutta la superfi cie mucosa, quindi si attendeva 1 min prima di procedere alle 3 successive misurazioni; nei preparati approntati con la metodica B iniettando nel bagno in cui la mucosa era sommersa, di 2 ml di acqua.
I dati così ottenuti per entrambe le me-todiche, sia sui controlli che sui preparati

98
Valutazione di alcuni effetti di un’acqua cloruro so-dica solfata sulla motilità ciliare di mucosa faringo-esofagea di rana: contributo sperimentaleClin. Term. 60 (3-4):95-100, 2013
oggetto di trattamento con l’acqua in esame, opportunamente registrati su tabelle, sono stati valutati statisticamente mediante calcolo della media aritmetica (M. T.), dell’errore standard (e.s.) e della signifi catività statistica (P) eseguita secondo il “t” di Student consi-derando statisticamente signifi cativi valori di P<0.05.
Risultati
Tutti i valori relativi ai tempi di percorrenza dello scodellino di alluminio (metodica A) e delle particelle di carbone (metodica B), lungo il tratto di mucosa opportunamente preparato sono stati riportati su due tabelle, una per ogni metodica d’indagine (Tabelle 1 e 2). In calce ad ogni gruppo di preparati sono riportate la media aritmetica e l’errore standard.
Metodica AValori singoli e MT (in secondi) ± e.s. del tempo impiegato a percorrere
il tratto di mucosa ai seguenti minuti
N° campioneTipo di
TrattamentoValori basali 5 min 10 min 15 min 30 min
12345678910
MT± e.s.
Controlli
32425837494253355026
42,40 ±3,19
49523641524556385229
45,00 ±2,76
47503839504243365030
42,50 ±2,16
48513941514445355231
43,70 ±2,27
49534042524546365334
45,00 ±2,1912345678910
MT ± e.s.
ACQUA
36403440414340256455
41,80 ±3,42
32363037383936246051
38,30 ±3,26
30342935363732235547
35,80 ±2,90*
31353032333430255744
35,10 ±2,88*
30363133323332265445
35,20 ±2,60*
Tabella 1. Azione sulla motilità ciliare della mucosa faringo-esofagea di rana Metodica A (Valori singoli).
* Valori statisticamente signifi cativi rispetto ai controlli (P < 0.05)

99
Valutazione di alcuni effetti di un’acqua cloruro so-dica solfata sulla motilità ciliare di mucosa faringo-esofagea di rana: contributo sperimentaleClin. Term. 60 (3-4):95-100, 2013
Si può facilmente notare che con entrambe le metodiche, i campioni di mucosa trattati con l’acqua in esame impiegano minor tempo a trasportare sia lo scodellino (metodia A) sia le particelle di carbone (metodica B) lungo il tragitto prestabilito, indice di un trasporto ciliare più rapido. La riduzione dei tempi di percorrenza è statisticamente signifi cativa ri-spetto ai controlli con P <0.05, a conferma che l’acqua oggetto di studio agisce sulla motilità ciliare degli epiteli aumentandone la velocità di trasporto.
Conclusioni
Dallo studio sperimentale presentato, si può concludere che l’acqua esaminata è pressoché sprovvista di tossicità ed è ben tollerata dalle mucose ciliate. Inoltre essa è stata in grado di incrementare in maniera statisticamente signifi cativa (P<0.05) la motilità dell’epitelio ciliare nella rana senza determinare comparsa di alterazioni a carico delle mucose.
Le stazioni termali e le loro acque, rappre-sentano una risorsa ed una ricchezza da non
Tabella 2. Azione sulla motilità ciliare della mucosa faringo-esofagea di rana Metodica B (Valori singoli).
Metodica BValori singoli e MT (in secondi) ± e.s. del tempo impiegato a percorrere
il tratto di mucosa ai seguenti minuti
N° campioneTipo di
trattamentoValori basali 5 min 10 min 15 min 30 min
12345678910
MT ± e.s.
Controlli
14101618191416101118
14.60 ±1.07
15131718211317111219
15.60 ±1.05
16121817221318101120
15.70 ±1.27
15131916221419111018
15.70 ±1.21
17122015201520101217
15.80 ±1.1512345678910
MT ± e.s.
ACQUA
16111013141719132214
14.90 ±1.16
13879111415101911
11.70 ±1.15 *
12987101514102010
11.50 ±1.23 *
12898101613111911
11.70 ±1.12 *
13999101514112011
12.10 ±1.11 *
* Valori statisticamente signifi cativi rispetto ai controlli (P < 0.05)

100
Valutazione di alcuni effetti di un’acqua cloruro so-dica solfata sulla motilità ciliare di mucosa faringo-esofagea di rana: contributo sperimentaleClin. Term. 60 (3-4):95-100, 2013
trascurare e sottovalutare, oggi ancor più che in passato. Difatti il progressivo allungamento della aspettativa di vita media cui stiamo as-sistendo negli ultimi decenni, ha contribuito a determinare il netto aumento di prevalenza e incidenza delle patologie cronico-degenerative comprese quelle di interesse respiratorio, ov-vero proprio di quelle patologie che trovano nelle cure termali le maggiori indicazioni in relazione alle loro proprietà curative, preven-tive e riabilitative.
Nel moderno clima di rilancio del termali-smo, è pertanto di comune interesse dare ampia diffusione a tutte le conoscenze su dettagli fi siopatologici e terapeutici che possano, sulla base di presupposti scientifi ci validati, da un lato contribuire ad arricchire le conoscenze, dall’altro giustifi care e supportare le scelte terapeutiche. Solo la corretta prescrizione terapeutica porta al massimo benefi cio per la salute dei pazienti con il minimo degli effetti collaterali in accordo con quanto stabilito dall’OMS secondo cui la salute del paziente non è semplice assenza di malattia, bensì com-pleto benessere psico-fi sico e sociale.
Bibliografi a
1. BERNFELD P, NIXON CW, HOMBURGER F. Toxicol. appl. Pharmacol. 1964; 6:103
2. BORTOLOTTI M, VEZZAINI P, et al. Mo-difi cazioni indotte dalla assunzione di un’ac-qua bicarbonato-calcica-alcalino-terrosa su alcuni parametri secretivo-motori, gastrici, ecc. Cl Term 1980; 23:165
3. COSTANTINO M, NAPPI G, DE LUCA S, et al. Crenoterapia inalatoria con acqua oligominerale radioemanativa: effetti in campo otorinolaringoiatrico studio clinico-sperimentale. Med Clin Term 2001; 47:211
4. GIARDINO A, NAPPI G. Effetti sul meta-bolismo purinico e meccanismi d’azione di un’acqua oligominerale bicarbonato-solfato alcalino-terrosa. Med Clin Term 1983; 59
5. LAMPA E. Modelli sperimentali per la ricerca in Medicina Termale. In Terme in Campania. Il ruolo della ricerca scientifi ca. Valentino Editore Ischia 1998; 41-6
6. LAMPA E, ROSSI F, FOGLIA A, et al. Cure termali e broncoreattività. III Incontro di Me-dicina Geriatrica “Problemi specialistici in età senile : ruolo delle cure termali”. Ed Coppola L, Grassia A, Varricchio M. 1996
7. MARCHI S, POLLONI A, BELLIN M, et al. Evaluation of the effi cay of bicarbonate-alkaline water action on gall bladder motility. Minerva Med, 1992; 83(1-2): 69-72
8. MASCIOCCHI MM, TITTOBELLO A. Azio-ni biologiche dell’ acqua minerale naturale “Sorgente Umbra Rocchetta”. Gualdo Tadino (PG). Med Clin Term 1995; 31-2:7381
9. MESSINA B, D’ASCENZIO G, BIANCIFIO-RI M. Attualità in tema di oligoelementi. Cl Term 1980; 33:6
10. MURATORI P, VALENTINI P, CATALETA M, et al. Studio degli effetti fi siologici di un carico di acqua Briosa: effetti sulla pressione arteriosa, sulla diuresi e sulla contrattilità colecistica. Med Clin Term 1995; 93-5

101
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
Clin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
Menopause and osteoporosis: clinical study on spa therapy
prevenction
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termale
G. Gerardi1, E. Lampa1, S. Andreozzi2, A. Calvanese2, M. Romano2
1Dipartimento di Medicina Sperimentale Sezione di Farmacologia Seconda Università degli Studi di Napoli;2AMIITTF Sezione Campania
Introduzione
L’ampliarsi delle conoscenze scientifi che contribuisce da sempre ad allungare la vita media della popolazione; diretta conseguenza di ciò è il continuo aumento di prevalenza (nu-mero di “eventi” presenti in una popolazione in un dato momento) delle patologie cronico-degenerative. Si assiste, pertanto ad un costante
RIASSUNTO – Scopo di questo studio clinico è riconoscere i fattori di rischio dell’osteoporosi e di valutare gli effetti delle cure termali, mettendo a confronto due gruppi omogenei di donne autosuffi cienti ed in menopausa. Ad un gruppo afferiscono donne residenti in case di riposo; nell’altro gruppo donne residenti nelle proprie abitazioni e con abitudine alla frequentazione delle terme. L’anamnesi clinica, l’analisi delle attività quotidiane, la valutazione della densità ossea mediante scansioni DEXA, hanno confermato il ruolo preventivo delle terapie termali e dell’attività fi sica del vivere quotidiano.
ABSTRACT – The purpose of this study is to recognize risk factors for osteoporosis and to evaluate s.p.a. therapeutic effects. We compared two groups of self-suffi cient women in menopause. First group of women living in nursing home; the other group of women living in their own homes and used to s.p.a. cares. Medical history, day life activities, bone’s DEXA scan, confi rmed the rule of thermal therapy and physical day life activity in osteoporosis prevention.
PAROLE CHIAVE – s.p.a. terme, osteoporosi, prevenzione, menopausa, DXAKEY WORDS – s.p.a. thermal, osteoporosis, prevention, menopause, DXA
incremento del numero di soggetti che per patologie invalidanti (ad esempio accidenti cerebro- o cardio-vascolari), ma anche per condizioni socio economiche ed ambientali (ad esempio istituzionalizzazione presso case di riposo), hanno ridotto la propria attività fi sica.
La riduzione dell’attività fi sica si associa ad un aumentato rischio di osteoporosi, una

102
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
delle più frequenti patologie dell’anziano. Essa è causa di disabilità dell’anziano in quanto la riduzione della massa ossea associata al sovvertimento della sua microarchitettura, espone ad un aumentato rischio di fratture, in particolare femorali e vertebrali. I principali fattori di rischio conosciuti per questa pato-logia sono l’età avanzata, il sesso femminile, la razza caucasica, la menopausa prematura o chirurgica ed alcune abitudini di vita tra cui l’insuffi ciente apporto di calcio con la dieta, la scarsa attività fi sica, il fumo di sigarette e l’abuso di alcool.
È noto che gli anziani residenti in case di riposo, anche se del tutto autosuffi cienti, svol-gono una ridotta attività motoria (camminare, cucinare, attendere alle attività domestiche e ludiche). È probabile che le quotidiane atti-vità fi siche legate alla vita sociale e familiare dell’anziano residente nella propria abitazione siano suffi cienti a ridurre il rischio di osteo-porosi e fratture ossee rispetto a quello degli anziani residenti in case di riposo, che svol-gono una minore attività fi sica. Questi ultimi, anche se autosuffi cienti, sarebbero a maggior rischio di fratture. Se questa valutazione fosse confermata diventerebbe importante, pertanto, programmare per gli anziani sani, che per ragioni sociali ed economiche risiedono in casa di riposo, una minima attività fi sica, da svolgere in palestra e/o in comunità, ed in ambiente termale.
Materiali metodi
Nel presente lavoro abbiamo messo a con-fronto due gruppi di donne autosuffi cienti ed in età menopausale, omogenei per età e condi-zioni cliniche, al fi ne di valutare come l’attività
fi sica svolta con le semplici e comuni attività di vita quotidiana, soprattutto se associata alle cure termali, possa essere un fattore protettivo per lo sviluppo di osteoporosi.
Nel primo gruppo, a modello di persone che svolgono ridotta attività fi sica, sono state inserite donne anziane autosuffi cienti residenti in casa di riposo; nel gruppo di confronto, invece, afferivano donne anziane (sempre au-tosuffi cienti) residenti nelle proprie abitazioni e che avevano effettuato per lo meno un ciclo di cure termali all’anno per almeno tre anni presso l’Hotel Giardino delle Ninfe e la Fenice in Via Nuova Cartaromana n°125 Ischia. Le acque termali in questione si caratterizzano per essere acque salso bromo iodiche ricche in ferro e zolfo.
In totale abbiamo arruolato 64 donne (età media 76 anni; intervallo 67-88 anni) di cui 32 provenienti da casa di riposo e 32 residenti nelle proprie abitazioni del Comune di Napoli utilizzate come controlli.
I criteri di inclusione prevedevano donne autosuffi cienti di razza caucasica in meno-pausa, la cui autosuffi cienza è stata valutata mediante la scala di valutazione “Activity of Daily Living” (ADL).
Sono state escluse dallo studio le donne che presentavano: menopausa precoce o chirurgica, perdita dell’autosuffi cienza (parziale o totale) per qualsiasi patologia, presenza di schiaccia-menti dei corpi vertebrali lombari o di altera-zioni interferenti con un’accurata valutazione densitometrica di almeno tre vertebre lombari, tre o più schiacciamenti o fratture dei corpi ver-tebrali dorso-lombari, patologie o assunzione di farmaci con azione nota sul metabolismo osseo, abuso di alcool (più di cento ml/alcool al dì), impossibilità di corretto posizionamento per l’esame mineralometrico.

103
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
I dati ricavati dallo studio sono stati elabo-rati al fi ne di ampliare le conoscenze dei fattori predisponenti l’osteoporosi, valutare il grado di mineralizzazione ossea lombare e femorale in relazione alle attività di vita quotidiana, al fi ne di valutare l’utilità di programmare l’atti-vità fi sica in palestra o ludica, ed in ambiente termale per rallentare la progressiva riduzione della massa ossea.
Ogni soggetto, dopo aver dato il proprio consenso informato alla partecipazione, è stato sottoposto a:– Visita medica e questionario inerente in-
formazioni socio-demografi che, anamnesi medica familiare e personale, anamnesi far-macologica, dati sulle abitudini voluttuarie (fumo, consumo di caffè, vino, liquori).
– Misure antropometriche (peso ed altezza misurati, peso ed altezza riferiti, plica sot-toscapolare e tricipitale).
– Valutazione dell’attività fi sica, organizzata in due questionari: nel primo veniva chiesto all’anziano di esprimere un giudizio sull’in-tensità della sua attività fi sica in diversi periodi della vita; nel secondo si cercava di quantifi care tale dato chiedendo quante volte al mese, nei vari periodi della propria vita, l’anziano svolgeva determinate attività elencate.
– Prelievo ematico ed urinario.– Misurazione mediante densitometria a raggi
X (DEXA): – della densità minerale ossea (BMD) a
livello lombare (L1-L4) ed a livello femo-rale prossimalmente.
– dell’indice di Ward (BMD del punto di minore densità del collo femore).
– dello z-score della densità minerale ossea di ogni paziente, calcolato come la differenza in termini di derivazioni standard
della media della popolazione generale di pari sesso e pari età.Per tutte le variabili sono state calcolate
media ed errore standard (ES). Nei due gruppi le differenze sono state analizzate secondo la distribuzione t di Student.
Risultati
Nella Tabella 1 sono stati riportati i va-lori medi delle principali variabili studiate. Tra queste, il calcolo della distribuzione t di Student ha mostrato delle variazioni statisti-camente signifi cative (p<0.05) sia della diffe-renza tra altezza misurata ed altezza riferita, sia della prevalenza di fratture pregresse nei due gruppi.
La Tabella 2 riporta, invece, i valori medi delle variabili di densità minerale ossea (BMD) rilevati a livello del collo femore e della co-lonna lombare mediante MOC-DEXA. I dati rilevati mostrano chiaramente che nel grup-po di anziani residenti in casa di riposo si è messa in evidenza una signifi cativa riduzione della densità minerale ossea di circa il 10% a livello del collo femore rispetto ai controlli (p<0.05), mentre per la colonna lombare tale variazione è meno spiccata (statisticamente non signifi cativa, p>0.05). Molto marcata e statisticamente signifi cativa (p<0.05) è anche la riduzione dello z-score del collo del femore negli anziani istituzionalizzati.
Infi ne in Tabella 3 abbiamo riportato i valori medi delle variabili fumo, uso di supe-ralcolici e patologie associate. I dati riportati e le analisi statistiche mostrano come nel gruppo di anziani residenti in casa di riposo si è osservata una variazione statisticamen-te signifi cativa sia dell’abitudine al fumo

104
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
Tabella 1. Valori medi (+/- ES) delle principali variabili sotto indicate
Residenti incasa di riposo
Residenti inpropria abitazione
Età media (anni) 76.06 (+/- 1.63) 76.19 (+/- 1.43)
Altezza (cm) 146.4 (+/- 2.17) 151.8 (+/- 1.59)*
Altezza riferita (cm) 153.6 (+/- 2.12) 153.7 (+/- 1.41)
Peso (Kg) 68.38 (+/- 4.74) 70.13 (+/- 3.12)
Prevalenza fratture pregresse 0.44 (+/- 0.13) 0.25 (+/- 0.11)*
IMC (in Kg/m2) 31.76 (+/- 2.02) 29.88(+/- 1.18)
Anni dalla menopausa 28.44 (+/- 1.66) 25.13 (+/- 1.59)
Plica sottoscapolare (mm) 24.41 (+/- 2.45) 28.54 (+/- 2.77)
Plica tricipitale (mm) 23.48 (+/- 1.99) 28.35 (+/- 2.51)
Percentuale grasso corporeo (%) 50.30 (+/- 2.38) 48.08 (+/- 1.34)
Punteggio attività fi sica pregressa 4.63 (+/- 0.41) +/- 0.29)
* p < 0.05
Tabella 2. Valori densitometrici medi ( g/cm2 +/- ES)
Residenti in casa di riposo
Residenti in propria abitazione
BMD lombare (L1-L4) 0.891 (+/- 0.06) 0.889 ( +/- 0.03)
BMD collo femore 0.645 ( +/- 0.04) 0.694 ( +/- 0.03)*
BMD Ward’s 0.425 ( +/- 0.03) 0.446 ( +/- 0.03)
Z-score lombare (DS) 0.974 ( +/- 0.53) 1.025 ( +/- 0.32)
Z-score collo femore (DS) 0.171 ( +/- 0.33) 0.631 ( +/- 0.30)*
Z-score ward (DS) 0.327 ( +/- 0.21) 0.251 ( +/- 0.35)
* p < 0.05DS = deviazione standard
Tabella 3. Valori medi delle variabili fumo, uso di superalcolici e patologie associate
Residenti in casa di riposo
Residenti in propria abitazione
fumatori 0.25 (+/- 0.11) 0*
uso di superalcolici 0.06 ( +/- 0.06) 0
patologie associate 0.81 ( +/- 0.10) 0.44 ( +/- 0.13)*
*p < 0.05

105
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
(p<0.05) sia della prevalenza di patologie associate (p<0.05).
Non abbiamo riscontrato differenze degne di nota tra i gruppi per tutte le altre variabili esaminate e riportate nelle tabelle 1, 2, 3.
Discussione
L’osteoporosi è caratterizzata dalla ridu-zione della massa ossea e dal deterioramento della sua microarchitettura, con conseguente aumento del rischio di frattura.
Lo scheletro termina il suo accrescimento verso i 35 anni, epoca in cui viene raggiunto il picco di massa ossea (massima densità mine-rale ossea). Dopo una fase di plateau (dai 35 ai 45 anni circa) inizia una fase fi siologica di perdita graduale della massa ossea per preva-lenza dei fenomeni di riassorbimento su quelli rigenerativi.
La massa ossea è il più importante fattore predittivo delle fratture; essa, dopo la maturità scheletrica, tende gradualmente a ridursi ed il suo valore è funzione del picco di massa ossea acquisito al termine della maturazione schele-trica e della velocità della perdita ossea.
Tale riduzione è più marcata con il progre-dire degli anni ed in particolare nelle donne in menopausa.
L’osso è un tessuto dinamico con intenso metabolismo ed intensa e continua attività di rimodellamento (fasi di riassorbimento e di sostituzione con tessuto neoformato).
Tale rimodellamento osseo è condizionato da numerosi fattori, tra questi l’attività fi sica ha un’importanza fondamentale.
Diversi autori hanno cercato di quantifi care percentualmente la quota di tessuto minera-
lizzato che può perdersi con l’inattività fi sica. In esperimenti condotti con la tecnica di im-mobilizzazione di un arto (in caso di modelli animali) o con il riposo forzato a letto (volon-tari sani) si è calcolato che la riduzione della mineralizzazione può variare del 16% circa dopo 42 giorni in ratti, del 30-50% in cani dopo quaranta settimane e del 25-40% dopo trentasei settimane in volontari sani.
Nell’uomo in condizioni di immobilizza-zione il bilancio del calcio mostra una perdita netta costante di circa 200 mg/die.
L’importanza dell’esercizio fi sico nel man-tenere una adeguata massa ossea è stata con-fermata dagli studi condotti su astronauti russi ed americani, che presentavano dopo una lunga permanenza nello spazio, alterazioni involutive muscolo-scheletriche con marcata perdita di mineralizzazione ossea ed ipotrofi a musco-lare. Tali alterazioni erano prevalenti agli arti inferiori, a livello cioè delle strutture portanti, normalmente soggette al carico del peso corpo-reo. In assenza di gravità il lavoro muscolare di tali segmenti era minimo ed ineffi cace, e veniva meno lo stimolo osteogenico legato alla forza tensiva muscolare ed alla forza di gravità.
Tali forze inducono sull’osso un vero e proprio effetto piezoelettrico: lo stimolo mec-canico viene tradotto in stimolo elettrico che determina l’orientamento delle fi brille ed il depositarsi di cristalli di calcio e fosforo sulle superfi ci sottoposte a sollecitazioni meccani-che (sia gravitarie che muscolari).
Sulla base di quanto detto, ci preme sotto-lineare l’importanza e la specifi ca bontà tera-peutica nel trattamento dell’osteoporosi della crenokinesiterapia (riabilitazione motoria in acqua termale) e della lutoterapia (terapia con fanghi termali).

106
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
La crenokinesiterapia offre numerosi effetti benefi ci. L’acqua già di per sé stessa favorisce il ripristino motorio, in quanto la spinta gal-leggiante antigravitaria e la resistenza opposta, offrono condizioni ottimali di sforzo con ridotto affaticamento, agevolando il recupero della performance motoria e delle masse muscolari (importanti al mantenimento del trofi smo os-seo). L’alleggerimento ponderale riduce anche il rischio di possibili ripercussioni strutturali a livello dei segmenti scheletrici osteoporotici, soprattutto rachidei, non più perfettamente va-lidi nel sopportare carichi, anche non eccessivi. Inoltre l’iperbarismo idrostatico, cioè dell’azio-ne pressoria esercitata dall’acqua sulle zone cor-poree immerse, dai tessuti più superfi ciali fi no a quelli più profondi come il tessuto osseo stesso, contribuisce a stimolare il tessuto osseo.
Alle suelencate proprietà dell’acqua si ag-giungono quelle specifi che della componente idrica termale, quali la composizione chimica, la temperatura e la eventuale radioattività, che garantiscono ulteriori vantaggi terapeutici da sfruttare nella terapia preventiva e riabilitativa dell’osteoporosi.
Prima fra tutte la temperatura che agendo a livello locale e generale (mediante aspetti neurorifl essi) favorisce i processi biochimici cellulari di utilizzazione e fi ssazione delle so-stanze energetiche. Il fenomeno chiaramente sostenuto da fenomeni vasodilatatori, inizial-mente locali, ha la proprietà di propagarsi in profondità e di migliorare la circolazione sanguigna periostea ed ossea, con ripercussioni sul turnover osseo. L’apporto di calore, inoltre, favorisce il rilasciamento del tessuto muscolare spesso contratto e dolente soprattutto nelle regioni paravertebrali interessate dal sovrac-carico, riducendo la limitazione funzionale su base algica.
In secondo luogo gli elementi chimici propri della composizione dell’acqua termale (salso, bromo, iodica) riequilibrano i processi metabolici cellulari.
Ultima, ma non meno importante la radio-attività che, interagendo a livello cellulare, in-fl uenza l’orientamento delle cariche elettriche con l’effetto fi nale di incrementare i processi riparativi di apposizione ossea.
In tale contesto, non va dimenticato l’ap-porto dato dall’idropneumomassaggio che, grazie alle numerose sollecitazioni meccani-che, da un lato stimola il trofi smo muscolare, dall’altro induce un’azione analgesica locale per innalzamento della soglia dei sensori periferici.
L’ambiente termale, oltre alla crenokine-siterapia, offre i vantaggi della lutoterapia che, specialmente se parziale, contribuisce, mediante le componenti termica e sulfurea (presente nell’acqua in esame), al trattamento preventivo-riabilitativo dell’osteoporosi. Re-centi studi sembrano dimostrare che l’idro-geno solforato, mediante una stimolazione parasimpatica, promuove variazioni funzionali circolatorie con benefi ci effetti preventivi sulla progressione dell’osteoporosi.
Non va infi ne trascurata la stimolazione di tipo estrogenica delle terapie fango balneari (soprattutto con acque radioattive), utili in età menopausale.
Negli anziani osteoporotici la frattura del femore è la causa principale di mortalità e di morbilità per perdita di funzione e quindi dell’autosuffi cienza. Il 12-20% dei soggetti con frattura del femore muore entro un anno dall’evento e la mortalità aumenta progres-sivamente con il crescere dell’età. È stato riportato che i pazienti istituzionalizzati non autosuffi cienti hanno un rischio di frattura o

107
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
di mortalità secondaria superiore a quello dei controlli di pari età e sesso.
Nel nostro lavoro abbiamo messo a con-fronto donne anziane autosuffi cienti residenti in casa di riposo e quindi ad attività fi sica ridotta, con donne anziane autosuffi cienti di pari età residenti nelle proprie abitazioni del Comune di Napoli.
Tra i due gruppi non esistono differenze signifi cative per quanto riguarda altri fattori determinanti la mineralizzazione: epoca di insorgenza della menopausa, intensità dell’at-tività fi sica pregressa, numero di gravidanze, mesi di allattamento complessivo, spessore della plica tricipitale e sottoscapolare.
Lo studio mineralometrico eseguito con tecnica MOC-DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry) ci ha permesso di valutare la densità minerale ossea a livello del collo fe-morale e del triangolo di Ward (la zona interna del collo femore, soggetta a maggior carico), le aree cioè a maggior contenuto percentuale di osso trabecolare.
I dati ottenuti evidenziano una riduzione sta-tisticamente signifi cativa (p<0.05) della densità minerale ossea (di circa il 10%) nelle anziane istituzionalizzate rispetto ai controlli.
Un altro dato emerso da questo studio riguarda la differenza tra altezza riferita ed altezza misurata, che può essere considerata un indice grossolano della differenza della BMD. Come si vede, infatti, la media delle altezze dichiarate in entrambi è di 153 cm, mentre il valore medio reale è stato di 146,4 cm nei soggetti istituzionalizzati e 151,8 cm nel gruppo di controllo. Tale differenza è risultata statisticamente signifi cativa al test t di Student.
Questa diversità di altezza rispetto al valore dichiarato da parte delle donne istituzionaliz-
zate (6,6 cm), associato ad una più alta preva-lenza di fratture ed a riduzione di BMD, sug-gerisce la possibilità che la demineralizzazione (più accentuata nelle donne istituzionalizzate rispetto ai controlli) abbia potuto determinare una diminuzione di altezza dei corpi vertebrali con successivo decremento staturale.
Probabilmente a ciò contribuisce la mag-giore attitudine al fumo di sigaretta (fattore di rischio osteoporotico) e la più alta percentuale di patologie associate riscontrate nelle donne istituzionalizzate con rilevanza statisticamente signifi cativa (p<0.05). Probabilmente il mag-gior numero di patologie riferite è secondario ad un controllo medico assiduo da parte del personale sanitario delle case di riposo che da una parte assicura migliore controllo di patologie croniche dell’anziano ma dall’altra aumenta la prescrizione di farmaci talvolta dannosi nella terza età.
Conclusioni
I residenti in case di riposo sono mag-giormente esposti al rischio osteoporotico in quanto più propensi ad uno stile di vita predi-sponente l’osteoporosi (maggiore attitudine al fumo, minore attività fi sica). Difatti da questo studio emerge che il grado di mineralizza-zione ossea è mediamente del 10% inferiore rispetto alle donne che svolgono le semplici attività della vita di tutti i giorni nelle proprie residenze e che praticano abitualmente cure termali, rispetto alle donne istituzionalizzate in case di riposo che sono più soggette a vita sedentaria e che diffi cilmente possono godere dei benefi ci delle cure termali. Proprio queste ultime, anche se autosuffi cienti, hanno gradi più marcati di osteoporosi e, quindi, sono

108
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
esposte ad un maggiore rischio di fratture, in particolare del femore, rispetto a quello di donne sempre autosuffi cienti, ma residenti nelle proprie abitazioni.
Appare ovvio, sulla base delle differenze riscontrate nei due gruppi oggetto di studio, che la più valida arma nella lotta all’osteopo-rosi è la prevenzione. I più importanti fattori di protezione messi in evidenza da questo studio sono, senza dubbio l’attività fi sica, le cure termali, ed un sano stile di vita. Sarebbe pertanto opportuno inserire la popolazione a rischio, anche se autosuffi ciente, in programmi di attività fi sica e/o ludica, meglio se in am-biente termale, al fi ne di mantenere un migliore metabolismo osseo per prevenire e rallentare l’evoluzione dell’osteoporosi.
Bibliografi a
1. DONALDSON CL, HULLEY SB, VOGEL JM, et al. Effect of prolonged bed rest on bone mineral. Metabolism 1970; 19:1071-84
2. UHTHOFF HK, JAWORSKI ZFG. Bone loss in response to long-term immobilization. J Bone Joint Surg 1978; 60-B:420-9
3. WHEDON GD. Disuse Osteoporosis: Phy-siological aspects. Calcif Tissue Int 1984; 36: 146-50
4. RAMBAUT PC, GOODE AW. Skeletal changes during space fl ight. Lancet, 1985; ii: 1050-52
5. MAZESS RB: Bone densitometry of the axial Skeleton. Orthop Clin North Am 1990; 21:51-63
6. AVIOLI LV: Signifi cange of osteoporosis: a growing international health care problem. CalcifTissue Int 1991; 49 Suppl: S5-7
7. DARGENT P, BREART G. Epidemiology and risk factors of osteoporosis. Curr Opin Rheumatol 1993; 5:339-45
8. GUTIN B, KASPER MJ. Can Vigorous exer-cise play a role in osteoporosis prevention? A review. Osteoporos Int 1992; 2:55-69
9. AGRE JC. Risk of osteoporosis in women: importance of distinguishing between physical activity and aerobic capacity. Mayo Clin Proc 1993; 68:821-2
10. PERPIGNANO G, BOGLIOLO A, MELA Q, et al. Physical activity and osteoporosis. Clin Ter 1993; 142:201-6
11. ORIENTE P, DEL PUENTE A. Fattori di rischio e fattori protettivi nell’osteoporosi senile. Reumatismo 1994; 46:128-30
12. DEL PUENTE A, ORIENTE P. Fratture di osteoporosi: un’emergenza sociale. Aggior-namento Medico, Settembre 1994
13. ROBERT L: Prevention and treatment of osteoporosis. The Lancet 1993; i: 341:801-5
14. ORTOLANI S. Osteoporosi. Piccin Nuova Libraria, Padova, 1990; 1-112
15. MESSINA B, GROSSI F. Elementi di Idrolo-gia Medica. Società Editrice Universo, Roma, 1983; 3-359
16. SARTORI L, GIANNINI S, MALVASI L, et al. Incidenza di fratture in una popolazione anziana non autosuffi ciente istituzionalizza-ta. Italian Journal of clinical and electrolyte metabolisme 1990; 4:49
17. TINETTI MR et al. A multifactorial interven-tion to reduce the risk of falling among elderly people living in a community. New Engl J Med 1994; 331:821-7
18. DE ZANCHE P. La terapia termale nel bacino euganeo. Terme Euganee, Abano, 1988; 12-96
19. LO SCALZO B. Bioclimatologia ed idrotera-pia. La buona Stampa, Napoli, 1986; 9-123

109
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013
20. GUASCHINO S, GRIMALDI E. Il climaterio femminile. Edimes, Pavia, 1999; 131-71
21. PASSERI G, PASSERI M. Clinical surveil-lance of osteoporotic patients. Recenti Prog Med 2003; 94(5):211-6
22. http://www.reumaonline.it,13 October, 200923. ALBANESE V, PASSARIELLO R. Osteo-
porosi e malattie metaboliche dell’osso (II Edizione); Ed. Springler 2009

110
Osteoporosi e menopausa: studio clinico degli effetti preventivi della terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):101-109, 2013

111
Ambiente e organismo umanoClin. Term. 60 (3-4):111-115, 2013
Clin. Term. 60 (3-4):111-115, 2013
Environment and human body
Ambiente e organismo umano
G. F. Strani1, G. Levra1, S. Levra2
1AMIITTF Sezione Piemonte Valle d’Aosta e Liguria; 2II Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Torino, San Luigi Gonzaga Orbassano
Introduzione
Le infl uenze dell’ambiente nei confronti dell’organismo umano costituiscono un ar-gomento vasto e complesso, rappresentato da numerose componenti.
Tratteremo a grandi linee due aspetti di strettissima competenza ambientale, e cioè l’inquinamento ed il clima, parametri di pri-
RIASSUNTO – Le infl uenze dell’ambiente nei confronti dell’organismo umano costituiscono un argomento vasto e complesso, rappresentato da numerose componenti.
Tratteremo a grandi linee due aspetti di strettissima competenza ambientale, e cioè l’inquinamento ed il clima, parametri di primaria importanza per i risvolti che possono rivestire nell’ambito di varie patologie.
ABSTRACT – The infl uences of the environment against the human organism constitute a large and complex subject, represented by a number of components.
We will cover roughly two aspects of environmental narrow competence, namely pollution and climate parameters of primary importance for the implications that can play in the context of various human diseases.
PAROLE CHIAVE – ambiente, clima, patologia umanaKEY WORDS – environment, climate, human diseases
maria importanza per i risvolti che possono rivestire nell’ambito di varie patologie, anche dermatologiche.
L’inquinamento
L’inquinamento è l’alterazione dei parame-tri chimici, fi sici e biologici di un ambiente che

112
Ambiente e organismo umanoClin. Term. 60 (3-4):111-115, 2013
si trova in stato di equilibrio. Può interessare il suolo, l’aria e l’acqua. L’uomo ne è il massimo, quasi sempre l’unico, responsabile (1).
Distinguiamo:
– un inquinamento “indoor” che si riferisce ad ambienti chiusi (casa, luogo di lavoro, sale di attesa, uffi ci, cinematografi , disco-teche, mezzi di trasporto, ecc.). In questi casi gli agenti inquinanti sono soprattutto il fumo di sigaretta, gli acari, i peli di ani-mali domestici, agenti microbici e micotici ecc.
– un inquinamento “outdoor”, caratteristico delle zone più industrializzate. Qui sono chiamate in causa soprattutto sostanze chimiche (idrocarburi, metalli pesanti, composti organici volatili ecc.) ed ancora fattori microbici e micotici, ecc.
Cute e mucose, in quanto organi-barriera, sono direttamente e continuamente esposte agli effetti dannosi degli inquinanti, con infl uenze negative per quanto riguarda alcune patologie come atopia, eczemi da contatto diretto o ae-rotrasmessi, infezioni, infestazioni ecc. (2).
Il clima
Le strette relazioni tra ambiente climatico e fi siopatologia umana erano già note nell’anti-chità “Non giudicare quando soffi a lo sharav” ammonisce la Bibbia, lasciando intendere che questo arido e secco vento del deserto è in grado di alterare le capacità critiche dell’ in-dividuo. Ma le osservazioni dapprima fondate sull’empirismo hanno successivamente rice-vuto conferma dalle indagini di generazioni di studiosi e dai progressi della ricerca tecno-
logica e biologica (3-5). È nata così la clima-toterapia, la scienza cioè che studia le risorse climatiche in rapporto alla patologia umana allo scopo di sfruttarne al massimo le indi-scusse potenzialità terapeutiche che – occorre sottolineare – ci sono fornite esclusivamente dalla natura. Ci troviamo di fronte quindi ad una terapia naturale vera e propria.
Però vi sono anche elementi climatici non propriamente favorevoli al nostro benessere: esistono ad esempio alcuni venti in grado di determinare una serie di disturbi nel quadro di patologie defi nite appunto sindromi ane-mopatiche (6-9).
ANEMOPATIE: sintomatologia
Irrequietezza o irritabilità EmicraniaPalpitazioni Ipotensione arteriosaStati ansiosi Crisi asmaticheInsonnia PessimismoColiche epatiche o renali (in pazienti litiasici)Minor capacità di concentrazioneSecchezza cutanea Prurito
Oltre allo sharaw, autorevolmente citato dalla Bibbia, vi sono altri venti responsabili di sindromi anemopatiche:– lo scirocco, che dal Sahara Africano soffi a
verso l’Italia meridionale e la Grecia la tramontana;
– il phoen, frequente nelle Alpi sul versante svizzero e germanico, da dove poi può giungere nella Pianura Padana;
– il vento dell’est, tipico della regione fran-cese di Lione e Montpellier. Ma veniamo agli aspetti positivi del clima
e alle sue applicazioni all’organismo umano (10,11), non tralasciando i risvolti riguardanti alcune affezioni cutanee in particolare.

113
Ambiente e organismo umanoClin. Term. 60 (3-4):111-115, 2013
L’accurata applicazione dei principi clima-toterapici (purtroppo non sempre agevolmente attuabili) ha la fi nalità di:1) In primo luogo allontanare il soggetto da
una zona di residenza non confacente alla sua salute.
2) In secondo luogo individuare la località più adatta per favorire il ristabilimento delle normali attività biologiche del paziente, stimolando e modifi cando in modo più favo-revole la funzionalità di organi ed apparati ed esaltandone i poteri di difesa.
La principali tipologie climatiche sfruttabili in climatoterapia sono le seguenti:– Ambiente di montagna e di mezza monta-
gna– Ambiente marino– Ambiente di lago
In questo nostro lavoro, per motivi di bre-vità, ci occuperemo dei primi due.
Iniziamo a trattare l’ambiente climatico di montagna, ricordando che il termine di mezza montagna fa riferimento a zone di minor ele-vazione, riservate a coloro in cui la presenza di cardiopatie o di grave ipertensione incita a maggior prudenza nei riguardi dell’altitu-dine.
L’ambiente di montagna è caratterizzato da:– Intensità della radiazione solare – Bassa temperatura e ridotto grado di umi-
dità – Purezza e luminosità dell’ atmosfera– Aria più rarefatta, povera di pulviscolo
e di microrganismi, ma ricca di essenze balsamiche.
Ambiente climatico marino Il clima marino – al di là delle differenze
determinate dalla posizione geografi ca – pre-senta caratteristiche peculiari nei confronti di quello continentale. A ciò contribuiscono vari fattori, ma soprattutto:
TemperaturaIrradiazione solareUmiditàQualità dell’ariaVentiPressione atmosfericaPrecipitazioni
Sono soprattutto l’irradiazione solare, l’umidità e la qualità dell’aria che ci interes-sano in modo particolare dal punto di vista terapeutico. Esaminiamoli singolarmente:
Irradiazione solareAl mare la luminosità è maggiore in quanto
i raggi del sole vengono rifl essi in ogni dire-zione dalla superfi cie del mare, che viene a comportarsi come un gigantesco specchio in continuo movimento.
UmiditàL’ambiente marino gode in genere di mag-
gior umidità nei confronti di quello continen-tale: il calore assorbito dal mare dà origine ad una forte evaporazione, per cui viene a crearsi un aerosol ricco di sali (iodio in particolare) di provenienza marina: viene denominato ap-punto aerosol marino.
Qualità dell’ariaAl mare l’aria è caratterizzata da un elevato
grado di purezza sia per la scarsità di pulvi-scolo sia per l’azione dei venti marini (brezze

114
Ambiente e organismo umanoClin. Term. 60 (3-4):111-115, 2013
di mare e brezze di terra) che allontanano le impurità atmosferiche.
Per ottenere che il soggiorno in un nuovo
ambiente climatico o a maggior ragione che un trattamento climatoterapico vero e proprio vengano sfruttati al massimo occorre tenere presenti i seguenti parametri:– Rapporto individuo - nuovo ambiente– Indicazioni, non indicazioni e controindi-
cazioni– Possibilità di integrazione con trattamenti
termali o talassoterapici.
1) Rapporto individuo-nuovo ambienteNei primi giorni il soggetto va incontro alla
fase di acclimatazione che può essere fugace o inavvertita oppure può manifestarsi con altera-zioni dell’alvo, irritabilità, inappetenza, inson-nia (il paziente riferisce: quando cambio letto non dormo). Se l’approccio è stato condotto erroneamente o se l’organismo è incapace di reagire e di stabilire un nuovo equilibrio con l’ambiente si verifi ca la cosiddetta intolleranza climatica (con distonia ed eretismo) per cui il paziente deve essere riportato nell’ ambiente primitivo.
Se il periodo di acclimatazione è ben condotto, si giunge ad un nuovo equilibrio organismo-ambiente: è la fase di adattamento in cui i vari parametri bioumorali si stabilizza-no e si consolidano, fi no a arrivare lentamente allo stato di indifferenza ambientale i cui il soggetto è completamente assuefatto al nuovo clima e non ne risente più lo stimolo.
Talora, ma solo per stimolazioni ripetute e mal dosate di fattori associati al clima (bagni di sole o di luce, psammatoterapia) si giunge ad una vera e pro-pria saturazione climatica con ricomparsa di insonnia, astenia e nervosismo.
2) Indicazioni, non indicazioni e con-troindicazioni
Facendo riferimento alle patologie derma-tologiche, ambienti climatici caratterizzati dalla purezza dell’ atmosfera risultano utili nei riguardi della dermatite atopica(12). La presenza di un buon insoleggiamento è indi-cato in presenza di psoriasi, acne, dermatite seborroica, ecc. (13) nonché di dermatosi in cura con psoraleni (ancora la psoriasi e la vitiligine).
Sempre per rimanere in ambito dermato-logico è ovvio che un ambiente troppo secco non è particolarmente indicato nelle ittiosi e nelle xerodermie. Ed è altrettanto ovvio che non deve praticare l’ elioterapia chi è affetto da patologie cutanee fotocondizionate e tanto meno chi assume farmaci fotosensibilizzanti per affezioni sistemiche di altro tipo (14).
3) Integrazione con termalismo e talas-soterapia
L’ambiente riveste una notevole importanza sia nell’ambito dei trattamenti termali sia nelle pratiche talassoterapiche (15), cioè le cure con mezzi marini. Non dimentichiamo a quest’ul-timo proposito che l’acqua di mare è una vera e propria acqua minerale, con le caratteristiche di acqua salso-iodica (16).
Conclusioni
Per concludere, una terapia climatica ben impostata, con accurata scelta della patologia da trattare e del luogo ove inviare il paziente nonché ben dosata (non troppo corta al fi ne di superare la fase di acclimatazione ma non troppo lunga per evitare di giungere alla sa-turazione climatica) può fornire al bagaglio

115
Ambiente e organismo umanoClin. Term. 60 (3-4):111-115, 2013
terapeutico del medico una opzione curativa del tutto naturale, effi cace e spesso non con-siderata come meriterebbe.
Bibliografi a
1. WHO Parma. Declaration on Environment and Health, Final Draft 8 March 2010, WHO
2. D’AMATO G. Inquinamento atmosferico, variazioni climatiche e patologie respiratorie. Ed. AIPO Ricerche, Milano, 2011
3. WEHIE WH. Climat, santé et morbiditè, Conference Mondiale sur le climat, OMS, Ginevra, 1979
4. PANTALEONI G. Climatoterapia, termalismo ed inquinanti ambientali: sintesi scientifi ca e proposte di provvedimenti. Clin Term 2010;57(1-2):3-9
5. AGOSTINI G, PINNA M, PINNA S, et al. Bioclimatologia Umana. UTET, 2005
6. GIULIACCI M, CORAZZON P, GIULIACCI E. Dottore mi fa male il tempo. Ed Alpha Test, 2008
7. SOLIMENE U, BRUGNOLI A, MANNELLI E. Meteropatie, Edizioni Red, 2002
8. WATSON L. Il libro del vento, Sperling and Kupfer, 2002
9. CONDEMI V. Bioclimatologia e distribuzione dei climi in Italia, in Come e perché prescri-vere una cura termale di Pasini W, Moruzzi’s Group Edizioni, Bologna, 2004
10. FAUCCI A, CERVADORO E, UBIGLIA S. Cute e climatoterapia, Clin Term 2012; 59 (1-2):73-5
11. AAVV. Qualità dell’aria e salute. ERS, AIPO Ricerche ed, 2010
12. ROTONDO G. Ecobioclimatologia II, I.I.M.S. Litografi a Roma, 2001
13. AGOSTINI G. Manuale di Medicina Termale, Archimedica Ed. Torino, 2000
14. SANTOIANNI P, MONFRECOLA G. Fo-todermatologia, CIC Edizioni Internazionali Roma, 2003
15. LALAGUE S. Talassoterapia curarsi con il mare. Red Edizioni, Como, 1990
16. HOREAU D. Les terapie marines Ed. Dan-gles, Parigi, 2002

116
Ambiente e organismo umanoClin. Term. 60 (3-4):111-115, 2013

117
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
Clin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
The sulphurous waters thermal therapy in the rehabilitation of
pathologies of the upper respiratory tracts
La crenoterapia solfurea nella riabilitazionedelle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed Orl
P. Lucchi1, M.E. Baiardi2, F. Bortolotti3, P. Barbieri1
1Centro Ricerche e Studi Termali, Terme di Salice, Salice Terme (PV); 2Consulente Pneumologo Terme di Salice, Salice Terme (PV); 3Consulente ORL Terme di Salice, Salice Terme (PV)
La crenoterapia con le acque solfuree
Le acque solfuree sono considerate le ac-que minerali più effi caci nella prevenzione e nella cura delle fl ogosi ad andamento cronico-recidivante delle alte vie respiratorie. Possono essere prescritte in sostituzione dei farmaci oppure come supporto alla terapia medica e
RIASSUNTO – Le affezioni croniche e recidivanti delle vie aeree superiori condizionano in manie-ra rilevante la qualità e la quantità della vita Questo studio condotto presso le Terme Salice (PV) su 130 pazienti affetti da patologie delle alte vie respiratorie ha accertato il ruolo della terapia inalatoria termale con acqua sulfurea nel ridurne le componenti sintomatologiche e fl ogistiche.
AB STRACT – The chronic and relapsing diseases of the upper respiratory tracts infl uence con-siderably the quality and quantity of life. This research was carried out at the spa resort of Terme di Salice, Salice Terme (PV) on 130 patients suffering from pathologies of the upper respiratory tracts. The results showed the positive effect of the inhalation therapy with thermal sulphurous waters in reducing the signs and symptoms of pathology.
PAROLE CHIAVE – acque termali solfuree, terapia inalatoria, fl ogosi alte vie respiratorieKEY WORDS – thermal sulphurous waters, inhalation therapy, diseases of the upper respiratory tracts
chirurgica. Nel secondo caso integrano e po-tenziano le terapie convenzionali rientrando in quel protocollo terapeutico, a volte molto articolato e complesso, fi nalizzato a migliorare lo stato di salute e quindi la qualità di vita del paziente. (1, 2).
Le acque minerali solfuree per la creno-terapia delle Terme di Salice hanno un alto

118
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
contenuto in zolfo con grado solfi drometrico che raggiunge il valore di circa 65 mg/l (3, 4). Lo zolfo conferisce a queste acque molteplici funzioni: mucoregolatrici, immunostimolanti, eutrofi che, plastico-protettive. Lo zolfo inoltre migliora la funzione olfattiva e, favorendo la produzione di energia, attiva il metabolismo cellulare (1, 2, 3).
La crenoterapia con acque sulfuree indicata nella prevenzione e nel trattamento delle in-fi ammazioni croniche di orecchio, naso e gola può essere suddivisa in: secca e umida:– La crenoterapia secca (a bassa componente
idrica) è rappresentata da: humage ed insuf-fl azioni endotimpaniche (4, 5).
– La crenoterapia umida (ad alta componente idrica) è rappresentata da: inalazioni, nebu-lizzazioni e docce nasali Humage ed aerosol e l’aerosol sonico (particelle aerosoliche a maggiore energia cinetica impressa da vi-bratori sonici) hanno particelle a diametro ridotto (12 micron) capaci di raggiungere i distretti l’orecchio medio e i seni parana-sali superando le resistenze opposte dagli osti tubarici e sinusali. Humage ed aerosol e l’aerosol sonico sono indicati nell’otite media catarrale, nella sinusite, nelle ade-notonsilliti ed in alcune forme di rinite e faringite.Le insuffl azioni endotimpaniche sono indi-
cate nell’otite media catarrale. i principi attivi contenuti nelle acque minerali raggiungono l’orecchio medio dove espletano la loro azione terapeutica. Inoltre il gas termale a pressione favorisce la mobilizzazione del sistema timpa-no-ossiculare limitandone quindi la rigidità.
Anche l’otite media purulenta cronica non colesteatomatosa, tuttavia, può trarre giova-mento dalle insuffl azioni endotimpaniche in quanto i principi attivi, raggiunto l’orecchio
medio, esercitano un’azione immunostimo-lante, eutrofi ca e antisettica favorendo la riso-luzione dell’otorrea o riducendone le recidive. Nelle inalazioni le particelle presentano grandi dimensioni (difficilmente inferiori a 8-12 micron). Risultano, di conseguenza, poco pe-netranti arrestandosi a livello del primo tratto delle vie aerodigestive. Le inalazioni trovano, pertanto, indicazione elettiva nelle faringiti, nelle tonsilliti e nelle laringiti.
Le nebulizzazioni sono caratterizzate da particelle il cui diametro è di 3-10 micron. Si distribuiscono più o meno uniformemente lun-go le vie respiratorie. Limitate sono, tuttavia, le patologie fl ogistiche ORL che impongono l’inclusione delle nebulizzazioni nel protocollo terapeutico di base (5, 6).
Le docce nasali risultano particolarmente utili nel migliorare lo stato anatomofunzionale del naso in quanto l’acqua minerale, defl uendo attraverso le cavità nasali, svolge la duplice azione di apportare in sede gli elementi te-rapeuticamente attivi in essa disciolti e nel contempo di esercitare una detersione mecca-nica da eventuali secrezioni e falde crostose giovando di conseguenza anche allo stato di salute dell’orecchio medio, dei seni paranasali, della faringe e di tutto l’albero respiratorio. Il benessere di questi distretti è infatti correlato e in stretta dipendenza dalla funzione nasale. Le docce nasali hanno un’intensa azione tera-peutica soprattutto in alcune forme di rinite, di rinosinusite e di sordità rinogena (6, 7, 8).
L’intervento termale nella riabilitazione
La medicina termale è utilizzata con fi nalità di prevenzione, cura e riabilitazione (Tabella 1 e Tabella 2) si rivolge oggi prevalentemente

119
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
all’aspetto qualitativo al fi ne di ottenere un apporto idrico utile non solo quantitativamen-te ma in relazione all’apporto elettrolitico, al tamponamento delle valenze acide, allo smaltimento dei cataboliti e, non da ultimo, all’integrazione di alcuni costituenti minerali fondamentali (1, 2, 3, 4).
Gli obiettivi di prevenzione s’identifi cano fondamentalmente in tutti i provvedimenti per ottenere (o recuperare) e mantenere la forma fi sica (10). La prevenzione e la terapia interessano lo stato di salute soprattutto attra-verso l’intervento su: forma fi sica, patologie ricorrenti o cronico recidivanti.
Nel nostro studio le caratteristiche ed esigenze del paziente sono schematizzate in (Tabella 1), in (Tabella 2) sono evidenziati i fattori variabili, che possono essere infl uenzati in misura maggiore o minore dalla terapia termale o dai cofattori termali, tra i quali in particolare il clima e le comorbidità.
Le patologie ricorrenti
La terapia termale che si è dimostrata in grado di ridurre sensibilmente le recidive fl o-gistiche sia a carico nelle patologie delle vie aeree superiori (VAS).
Alla riduzione degli episodi acuti riscon-trabile nelle casistiche (con evidenza nel calo dell’assenteismo lavorativo e nel consumo di
farmaci). Anche in caso di pazienti nei quali le recidive si manifestano in conseguenza di una patologia cronica (asma bronchiale, bronchite cronica, broncopneumopatie croniche ostrut-tive o restrittive) l’intervento di prevenzione secondaria riduce il numero delle recidive e si oppone all’evoluzione della compromissione anatomo-patologica e funzionale di base (8, 9, 10, 11, 12). In (Tabella 3) sono schematizzate le azioni della terapia termale sulle vie aeree superiori e inferiori, in (Tabella 4) gli obiettivi
Organismo in buona salute
Organismo in buona forma fi sica
Resa ottimale
Recupero veloce patologia
Recupero veloce dal trauma o dall’handicap
Tabella 1. Caratteristiche ed esigenze del paziente
Tabella 2. Fattori invariabili e variabili propri del paziente e dell’ambiente
Caratteristiche invariabili (Ereditarie)
CostituzioneFisica caratteristicheAntropometricheCaratteristiche fi siologiche
Fattori contingentied ambientali
Equipaggiamento e materialiAlimentazioneStato di saluteStaff medico e paramedico Ambiente di cura
Livello della cura AltoMedio Basso
Caratteristiche variabili (Acquisite)
Condizione fi sica (forza, resistenza)Tecnica e tatticaCondizione psicologicaStato di salute
Esito dell acura (Qualità e Quantità)
OttimoDiscretoSuffi cienteInsuffi ciente
Tabella 3. Ruolo della terapia termale nelle V.A.S.
Funzioni delle V.A.S. Azioni della crenoterapia
DifesaDesensibilizzante, Potenziamento Attività Immunitaria
DetersioneProduzione E Qualità Del Muco E Motilità Ciliare
Riscaldamento Umidifi cazione Eutrofi ca Sulle Mucose

120
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
ricercati e conseguibili (13, 14, 15). Conside-riamo che:1. Gli attacchi alle VAS sono oggi moltiplicati
(polluzione atmosferica, etc.); tali attacchi (fi sici e chimici) compromettono le difese immunitarie predisponendo le VAS a pato-logie infettive.
2. Le patologie fl ogistiche delle VAS ricono-scono con grande frequenza un’etiologia virale (terapia non attuabile), la prevenzione primaria è attualmente diffi coltosa, la tera-pia medica delle fl ogosi batteriche è a volte poco effi cace (sinusiti).
3. Sono frequenti condizioni di relativa im-munocarenza di base (e da sforzo) nel paziente.
4. Uno stato cronico d’indebolimento delle difese o di alterata dinamica del respiro a livello delle VAS coinvolge quasi inevitabil-mente anche le basse vie respiratorie VAI.
Consideriamo che:1. Gli attacchi alle VAS sono oggi moltiplicati
(polluzione atmosferica, etc.); tali attacchi (fi sici e chimici) compromettono le difese immunitarie predisponendo le VAS a pato-logie infettive.
2. Le patologie fl ogistiche delle VAS ricono-scono con grande frequenza un’etiologia virale (terapia non attuabile), la prevenzione primaria è attualmente diffi coltosa, la tera-pia medica delle fl ogosi batteriche è a volte poco effi cace (sinusiti).
3. Sono frequenti condizioni di relativa immu-nocarenza di base (e da sforzo) nella terapia riabilitativa.
4. Uno stato cronico d’indebolimento delle difese o di alterata dinamica del respiro a livello delle VAS coinvolge quasi inevita-bilmente anche le VAI.Il trattamento termale è accreditato dalla
ricerca per un potenziamento delle attività di difesa immunitaria (18, 19), sembra accertato che un defi cit alle VAS induca modifi cazioni del sistema immunitario con defi cit immuno-logici (16, 17).
In questi pazienti si sono osservati fenomeni di leucocitosi dopo sforzo ma con decremento signifi cativo della blastizzazione leucocitaria sia granulocitica-macrofagica che linfocitaria. Un defi cit immunitario, seppure transitorio, potrebbe presentarsi come rischio nella popo-lazione, di manifestazioni febbrili di origine probabilmente virale, e conseguenti stati de-bilitativi (16, 17).
Sembra inoltre accertato che la carenza (indotta dallo sforzo) della concentrazione intralinfocitaria di enzimi del metabolismo purinico (ADA-adenosinadeaminasi e PNP-purinonucleotidefosforilasi) sia strettamente correlata con il defi cit dell’attività linfocita-ria. Sembra esistere una stretta correlazione tra defi cit immunitario e difetti metabolici correlati soprattutto con una insolita riparti-zione enzimatica tra i compartimenti intra ed extracellulari.
Migliorare l’efficienza respiratoria e la ventilazione massima volontaria(Esercizi preparatori che interessano i muscoli respiratori)
Innalzare VO2 (max) e A.T.(Soglia Anaerobica)
Contrastare le malattie respiratorie da immunocarenze da sforzo
Contrastare la tendenza all’evolvesi delle patologie(Recidive - Cronicizzazione - Estensione)
Tabella 4. Obiettivi della terapia termale nel paziente

121
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
Obiettivi dell’indagine
Questo studio ha lo scopo d’accertare il ruolo della crenoterapia inalatoria per l’azione curativa sulle patologie croniche e/o recidivanti delle vie aeree superiori. Determinando una riduzione delle componenti fl ogistiche con conseguente miglioramento della qualità della vita per riduzione della compromissione dello stato generale e della funzione respiratoria Per poter accertare l’azione della terapia termale in relazione agli obiettivi espressi è necessario procedere alle seguenti verifi che: 1. Azione terapeutica della terapia termale
inalatoria sulle patologie croniche delle vie aeree superiori
2. Miglioramento conseguente dello stato di forma.
Casistica
Presso le terme Salice (PV), nel corso delle ultime stagioni termali è stato selezionato un campione di 130 pazienti (Tabella 5) che acce-
devano alle terapie perché affetti da patologie croniche e recidivanti delle prime vie aeree.
Protocollo di trattamento
I pazienti sono stati sottoposti ad un ciclo terapeutico di 12 giorni che comprendeva giornalmente:1. Inalazione a getto di vapore con acqua sul-
furea della durata di 10 minuti;2. Aerosol nasale o faringeo della durata di 10
minuti;3. Ventilazione polmonare della durata di 15
minuti;4. Rieducazione respiratoria della durata di 30
minuti.
Indici d’ esito
Prima e dopo il ciclo terapeutico i pazienti sono stati valutati in base ai parametri relativi () e contemporaneamente sono stati rilevati i dati che permetteranno di valutare l’effi cacia a distanza e che verranno elaborati in una fase successiva, a studio completato.
Risultati
La (Fig. 1) evidenzia i risultati ottenuti sui sintomi soggettivi dopo 12 giorni di terapia analizzando i dati con il test di simmetria, L’intensità è stata espressa su scala nominale (assente, lieve, moderata, forte). Per leggere la rappresentazione dei dati occorre considerare che i numeri espressi in (Fig. 2) sulla linea obli-qua gialla sono riferiti ai sintomi invariati, i rife-rimenti numerici sottostanti ai dati peggiorati e quelli sovrastanti ai dati migliorati (Fig. 3).
Tabella 5. Caratteristiche dei pazienti
Numeropz.
130
Età (anni) Media 65
DS+ ES 9,55 + 0.9
Mediana 68
Massimo 75
Minimo 55
Sesso Maschi 70 (53,85%)
Femmine 60 (46,15%)
Patologia prevalente
Rinopatia cronica 67 (51,54%)
Sinusopatia cronica 71 (54,62%)
Faringopatia cronica 59 (45,38%)

122
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
DISFAGIA VOLUME ESSUDATO CEFALEAns prima p <0,01 prima p< 0,001 prima
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
dopo
0 98 3 5 1
do
po
0 22 6 15 14
do
po
0 53 2 20 14
1 0 0 2 2 1 0 9 19 22 1 0 2 6 6
2 0 0 0 0 2 1 0 8 9 2 0 0 2 1
3 0 0 0 0 3 0 0 0 10 3 0 0 0 1
SCOLO RETRONASALE DEGLUTIZIONE FREQUENTE FARINGODINIA
p<0,001 prima p> 0,05 prima p <0,001 prima
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
do
po
0 81 8 7 3
do
po
0 91 2 7 3
do
po
0 71 9 19 12
1 0 0 7 5 1 0 1 4 1 1 0 1 7 2
2 0 0 3 1 2 1 0 5 1 2 0 0 0 1
3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 3 0 0 0 4
Fig. 1. Analisi statistica degli indicatori di esito (sintomatologia soggettiva) con “Test of simmetry” legenda: 0 = assente 1 = lieve 2 = moderata 3 = forte
Fig. 2. Analisi statistica degli indicatori di esito (sintomatologia soggettiva) con “Test of simmetry” legenda: 0 = assente 1 = lieve 2 = moderata 3 = forte
RASCHIAMENTO TOSSE CARATTERE TOSSE
p < 0,002 prima p<0,001 prima p<0,05 prima
0 1 2 3 0 1 2 3
do
po
0 67 24 20 7
do
po
0 61 16 13 6
do
po
secca produttiva
1 1 3 8 2 1 0 3 8 2 secca 18 1
2 0 0 1 4 2 0 0 3 1 produttiva 12 16
3 0 0 0 3 3 0 0 0 2

123
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
Quasi tutti gli indici sono signifi cativamente migliorati (p<0.05) tranne che per il parametro “Deglutizione frequente” e “Disfagia” ma solo per la bassa frequenza iniziale dei sintomi, assenti rispettivamente in 98 e 95 pazienti. I risultati sono confermati dalle osservazioni
dell’aspetto della mucosa e della secrezione nasale e faringea (Fig. 4) dove si nota la ri-duzione delle secrezioni crostose, vischiose e purulente a favore della normalizzazione o del viraggio verso l’aspetto siero-mucoso
Fig. 3. Analisi statistica degli indicatori di esito (sintomatologia obiettiva) con “Test of Simmetry” legenda: 0= normale 1= iperemica 2= pallida 3= edematosa 4= ipertrofi ca 5= granulosa
ASPETTO MUCOSA NASALE ASPETTO MUCOSA FARINGEA
p< 0,001 prima p<0,01 prima
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
do
po
0 25 48 0 18 1 0
do
po
0 49 35 0 2 5 1
1 2 10 0 4 1 0 1 4 18 0 0 0 0
2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
3 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 3 0
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Fig. 4. Analisi statistica degli indicatori di esito (sintomatologia obiettiva) con “Test of Simmetry” legenda: 0= normale 1= sierosa 2= mucosa 3= mucopurulenta 4= vischiosa 5= crostosa
SECREZIONE NASALE SECREZIONE FARINGEA
p<0,001 prima p<0,001 prima
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
do
po
0 41 9 12 10 2 4
do
po
0 53 1 17 9 1 0
1 2 4 3 3 0 3 1 1 2 9 2 1 0
2 0 1 2 0 1 3 2 0 0 6 3 0 1
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0

124
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
Conclusioni
Lo studio ha evidenziato le notevoli e signi-fi cative azioni terapeutiche della crenoterapia inalatoria solfurea presso le Terme Salice nelle patologie delle VAS.
L’azione antiinfiammatoria, trofica, de-congestionante analgesica sono provate dalla riduzione o scomparsa dei sintomi e dei segni caratteristici e propri del quadro patologico delle affezioni in esame. Anche l’azione mu-colitica è stata ulteriormente convalidata: su 30 pazienti che accusavano tosse “secca” e stizzosa in 16 il carattere della tosse è mutato in “produttiva”.
È importante notare come la variazione dei dati obiettivi testimoni un miglioramento reale, non attribuibile esclusivamente al giudizio del paziente.
BIBLIOGRAFIA
1. HEANEY RP, NAPPI G. Assorbibilità del calcio contenuto nell'acqua Sangemini. Med Clin e Term 1994; 83:28-9
2. CAUDAS V, LIBERT JP, BRANDERBER-GER G, et al. Hydratation during exercise. Eur J Appl Physiol 1986; 55:113
3. GUERRINI L, CIANI G. Ionizzazione, tran-quillanti e rendimento muscolare in animali allenati. II Congr. naz. Soc. Ital. di Aeroiono-biologia e Aeroionoterapia. Lignano (Ud), 31 maggio 1968
4. GUERRINI L, SEVERGNINI B. Modifi ca-zioni indotte dalla temperatira e dagli ioni gassosi sulla resistenza allo sforzo fi sico. II Congr. naz. Soc. Ital. di Aeroionobiologia e Aeroionoterapia. Lignano (Ud), 31 maggio 1968
5. ROI GS, LARIVIERE G. La valutazione funzionale dello paziente. Presupposti teorici ed implicazioni pratiche. Coaching & Sport Science Journal 1997; 37: 2,1
6. RE A, DE BERNARDI M, PASSARONI L, et al. L'azione diretta sulle mucose delle acque minerali; studio sperimentale sulle acque solfate. Clin Term 1983; 36, 187: 5-6
7. BERIOLI ME, STRINATI F, NAPPI G, et al. Terapia inalatoria termale ed asma bronchia-le. Med Clin e Term 1995; 33:103
8. NAPPI G, CALCATERRA P, MASCIOCCHI MM, et al. Risultati a breve termine della cre-noterapia inalatoria con acqua solfato-calcica "Sorgente Vita" (San Pellegrino) nelle fl ogosi croniche delle prime vie aeree. Med Clin e Term 1994; 27:67
9. NAPPI G, DE LUCA S, MASCIOCCHI MM, et al. Risultati a distanza della crenoterapia inalatoria solfurea in ORL: presupposti per la riduzione della spesa socio-sanitaria. Med Clin e Term 1995; 33:129
10. AGOSTINI G. Manuale di Medicina Termale. Ed Guidotti, 2000
11. CASIELNUOVO P. Attualità nella rinosinu-site. Argomenti di Acta otorhinolaringologica Italica Paci Ed 2008; 11:2
12. GUARNIERI G, FERRAZZONI S, SCARPA MC, et al. Effects of inhalation of thermal wa-ter on exhaled breath condensate in chronic obstructive pulmonary disease. Respiration 2010; 79(3):216-21. Epub 2009 Jul 3
13. SERINKEN M, KARCIOGLU O, EVYAPAN F, et al. Bilateral pneumothorax following acute inhalation injury. Clin Toxicol (Phila). 2009; 47(6):595-7
14. PALACIN A, VARELA J, QUIRCE S, et al. Recombinant lipid transfer protein Tri a 14: a novel heat and proteolytic resistant tool for the diagnosis of baker's asthma. Clin Exp Allergy.

125
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013
2009 Aug; 39(8):1267-76. Epub 2009 May 26
15. PANTELIC J, SZE-TO GN, THAM KW, et al. Personalized ventilation as a control measure for airborne transmissible disease spread. J R Soc Interface. 2009 Dec 6; 6 Suppl 6:S715-26. Epub 2009 Oct 7
16. MEZZENA M, SCALIA S, YOUNG PM, et al. Solid lipid budesonide microparticles for controlled release inhalation therapy. AAPS J. 2009 Dec;11(4):771-8. Epub. 2009 Nov 12
17. SAYES CM, REED KL, GLOVER KP, et al. Changing the dose metric for inhalation toxicity studies: Short-term study in rats with engineered aerosolized amorphous silica na-noparticles. Inhal Toxicol
18. GUARNIERI G, FERRAZZONI S, SCARPA MC, et al. Effects of inhalation of thermal water on exhaled breath condensate in chronic obstructive pulmonary disease. Respiration. 2010; 79(3):216-21
19. SERINKEN M, KARCIOGLU O, EVYAPAN F, et al. Bilateral pneumothorax following acute inhalation injury. Clin Toxicol (Phila). 2009 Jul; 47(6):595-7
20. PALACIN A, VARELA J, QUIRCE S, et al. Recombinant lipid transfer protein Tri a 14: a novel heat and proteolytic resistant tool for the diagnosis of baker's asthma. Clin Exp Allergy. 2009 Aug;39(8):1267-76. Epub 2009 May 26
21. REYCHLER G, BOSSCHAERTS M, CHE-VAILLIER J, et al. Belgian CF Physio-Group. Inhalation equipment hygiene: a belgian national survey. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2009 Sep; 22(3):239-43
22. HARBURGUER LV, SECCACINI E, MA-SUH H, et al. Thermal behaviour and biolo-gical activity against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) of permethrin and pyriproxyfen in a smoke-generating formulation. Pest Manag Sci 2009; 65(11):1208-14
23. LIGHT TD, LATENSER BA, KEALEY GP, et al. The effect of burn center and burn center volume on the mortality of burned adults--an analysis of the data in the National Burn Repository. J Burn Care Res 2009 Sep-Oct; 30(5):776-82
24. MEZZENA M, SCALIA S, YOUNG PM, et al. Solid lipid budesonide microparticles for controlled release inhalation therapy. AAPS J 2009 Dec; 11(4):771-8. Epub. 2009 Nov 12
25. SAYES CM, REED KL, GLOVER KP, et al. Changing the dose metric for inhalation toxicity studies: Short-term study in rats with engineered aerosolized amorphous silica na-noparticles. Inhal Toxicol ANNO ??????.
26. NADAL M, SCHUHMACHER M, DOMIN-GO JL. Cost-benefi t analysis of using sewage sludge as alternative fuel in a cement plant: a case study. Environ Sci Pollut Res Int 2009 May;16(3):322-8
27. SALAMI A, DELLEPIANE M, CRIPPA B, et al. Sulphurous water inhalations in the prophylaxis of recurrent upper respiratory tract infections. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72(11):1717-22
28. SUURONEN K, HENRIKS-ECKERMAN ML, RIALA R, et al. Respiratory exposure to components of water-miscible metalworking fl uids. Ann Occup Hyg. 2008; 52(7):607-14

126
La crenoterapia solfurea nella riabilitazione delle patologie fl ogistiche delle alte vie respiratorie ed OrlClin. Term. 60 (3-4):117-125, 2013

127
Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemiaClin. Term. 60 (3-4):127-134, 2013
Clin. Term. 60 (3-4):127-134, 2013
Gaudenziana of Bognanco oligomineral water effect on nitrogen, uric acid and glucose blood levels
Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemia
G. R. Marini, G. Calosso, G. Levra
AMIITTF - Sezione Piemonte Valle d’Aosta Liguria Insubria
RIASSUNTO - L’assunzione quotidiana di 2-3 bottiglie di acqua minerale bicarbonato-calcica Fonte Gaudenziana di Bognanco sembra in grado di determinare, in tutti i 63 soggetti studiati, arruolati a prescindere da sesso, età, farmaci assunti e patologie in atto, una evidente riduzione dei livelli sierici di acido urico, azotemia e glicemia; tale riduzione avviene in modo statisticamente signifi cativo già dopo i primi due mesi di trattamento.
ABSTRACT - A daily intake of 2-3 bottles of bicarbonate-calcium mineral water from Gaudenziana spring in Bognanco seems to be able to determine a remarkable reduction in uric acid, nitrogen and glucose blood levels in all 63 subjects enrolled in study, regardless of sex, age, drugs and disease; this reduction takes place after two months from the beginning of therapy.
PAROLE CHIAVE - Acqua oligo-minerale, Bognanco, azotemia, glicemia, uricemia.KEY WORDS - Oligomineral water, Bognanco, nitrogen, glucose, uric acid.
Premessa
L’acido urico è il prodotto fi nale del ca-tabolismo delle purine esogene ed endogene (adenina, guanina) attraverso l’ossidazione della xantina e della ipoxantina; è scarsamente solubile in ambiente acquoso ed è presente nel sangue in forma di urato monosodico e legato a proteine (albumina, alfa¹ e alfa² globuline).
Viene escreto per via renale (400-450 mg/die) e per via intestinale (200 mg/die); l’escrezione per via renale coinvolge la quota non legata (90%) ed avviene attraverso i meccanismi di fi ltrazione glomerulare, riassorbimento e secrezione prossimale, riassorbimento dista-le; nei casi di aumentata escrezione urinaria, in concomitanza a pH urinario acido, si può manifestare nefrolitiasi. L’acido urico sierico

128
Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemiaClin. Term. 60 (3-4):127-134, 2013
è considerato normale nell’adulto per valori di 4-8 mg/dl (238-476 µmol/litro) nell’uomo e di 3-7 mg/dl (178-416 µmol/litro) nella donna; il suo aumento può dipendere da un aumentato apporto alimentare, da aumentata produzione endogena (gotta, iperparatiroidismo, malattie linfo-mieloproliferative, neoplasie, radio-che-mioterapia, ustioni, psoriasi etc.) o da ridotta escrezione (digiuno, etilismo, IRC, assunzione di farmaci come diuretici dell’ansa e salicilati <2 g/die, etc.); è invece diminuito in alcune nefropatie croniche, M. di Wilson, acromega-lia, xantinuria (defi cit di xantina ossidasi), as-sunzione di farmaci (allopurinolo, probenecid, salicilati >4 g/die, cortisonici), etc.
Sebbene l’iperuricemia asintomatica, in considerazione del costo e della potenziale tossicità dei farmaci da una parte, e della scarsa probabilità di una evoluzione sfavore-vole dall’altra, di regola non si tratti (Am. J. Med. 82:421, 1987), tuttavia è bene conside-rare, oltre alla possibilità relativamente poco frequente di nefropatia gottosa dovuta alla deposizione di cristalli di urato nel parenchi-ma renale, anche l’importanza che il livello
di acido urico sierico assume come fattore di rischio per le malattie cardiovascolari atero-sclerotiche.
Materiali e metodi
Lo studio di tipo statistico-osservazionale è stato condotto, tra gennaio e maggio 2003, su una popolazione adulta di 63 soggetti (31 uomini e 32 donne) di età compresa tra 29 e 81 anni (Tabella 1), allo scopo di studiare se e come l’uso costante e continuo di un’acqua oli-gominerale bicarbonato-calcica possa infl uire sui livelli sierici di acido urico della popolazio-ne (riducendo così di conseguenza anche tutti i rischi correlati a valori crescenti di uricemia compreso quelli della iperuricemia asintoma-tica e border-line) e su Azotemia e Glicemia. I pazienti sono stati arruolati a prescindere da sesso, età, farmaci assunti, patologie in atto secondo un criterio che escludesse soltanto i soggetti affetti da insuffi cienza renale, scom-penso cardio-circolatorio, ipertrofi a prostatica e gravi patologie invalidanti.
Tabella 1. Distribuzione del campione per sesso ed età

129
Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemiaClin. Term. 60 (3-4):127-134, 2013
I pazienti sono stati invitati dal proprio medi-co di famiglia ad eseguire esami emato-chimici che comprendessero l’Uricemia, l’Azotemia e la Glicemia, i cui valori sono stati registrati in apposita scheda personale in maniera rigoro-samente anonima e riservata nel rispetto della vigente normativa sul rispetto della privacy (legge 675/96). Prima di iniziare la raccolta dei dati richiesti dal protocollo, al paziente è stato consegnato il modulo che spiega la fi nalità della ricerca ed è stato richiesto il consenso informato debitamente sottoscritto dal paziente stesso e conservato a cura del medico.
Ai pazienti è stata poi prescritta l’assunzio-ne di 2-3 bottiglie al giorno (1800-2700 cc/die) di acqua minerale della Fonte Gaudenziana di Bognanco (acqua oligo-minerale bicarbonato-calcica con residuo fi sso a 180° pari a 93,40 mg/l), in alternativa all’acqua da tavola già utilizzata, a dosi refratte in più somministra-zioni giornaliere.
Si sono poi rivalutati gli stessi pazienti a distanza di due e quattro mesi facendo loro eseguire ogni volta un’esame di Uricemia, Azotemia e Glicemia e registrandolo nelle rispettive schede. Su ogni scheda risultava, oltre all’età e al sesso del paziente, anche un
elenco dei farmaci assunti durante lo studio allo scopo di evidenziare una possibile ridu-zione di dosaggio degli stessi. Alla fi ne è stata eseguita un’analisi statistica dei dati rilevati per ciascun paziente e valutata la signifi catività prendendo in considerazione tre periodi: il primo al tempo zero, il secondo dopo due mesi ed il terzo dopo quattro mesi. Relativamente al valore di uricemia, azotemia e glicemia, oltre allo score relativo, è stato valutato uno score totale medio delle somme dei singoli valori. I parametri sono stati valutati mediante lo studio dell’analisi della varianza.
Caratteristiche dell’acqua della Fonte Gaudenziana di Bognanco
L’acqua della fonte Gaudenziana di Bo-gnanco, stazione termale in provincia di Verba-nia a 7 chilometri ad Ovest di Domodossola, è oligominerale bicarbonato-calcica con residuo fi sso a 180° pari a 93,40 mg/l e sgorga ad un’al-titudine di 900 metri sul livello del mare.
Per le caratteristiche terapeutiche dovute alla composizione (Tabella 2), trova particolari indicazioni nella prevenzione e nel trattamento
Temperatura alla sorgente °C +10,2
pH a 20 °C 7,88
Residuo fi sso a 180 °C (mg/l) 93,40
Magnesio 1,90 Litio 0,6
Calcio 25,40 Bicarbonato 73,70
Sodio 1,70 Solfato 12,70
Potassio 1,70 Cloruro 0,50
Ferro tracce Fluoruro tracce
Stronzio tracce Silice 8,10
Manganese tracce Nitrato 3,20
Tabella 2. Proprietà dell’acqua della fonte Gaudenziana

130
Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemiaClin. Term. 60 (3-4):127-134, 2013
di tutte le manifestazioni della diatesi uratica renale (calcolosi) ed extrarenale delle vie uri-narie, nel mantenimento dopo litotrissia, e può essere impiegata allo scopo di promuovere la diuresi come coadiuvante nei disturbi disme-tabolici (iperuricemia) di origine renale; ha inoltre un’azione antinfi ammatoria sulle vie urinarie e una prolungata somministrazione di questa acqua può avere valore profi lattico verso la cistite ricorrente. L’azione si esplica a livello del tubulo contorto prossimale ini-bendo il riassorbimento di ioni sodio e acqua e promovendo una maggiore diluizione della preurina che raggiunge e oltrepassa l’ansa di Henle fi no al segmento diluente midollare; l’effetto, dovuto ad una probabile stimola-zione neuro-umorale sui glomeruli e sulle cellule epiteliali renali, viene completato da un aumento della peristalsi pielo-ureterale che stimola il defl usso dell’urina dal bacinetto alla vescica con un aumento costante della diuresi
fi no ad un plateau che si mantiene più o meno stabile per alcuni giorni. La sua spiccata azio-ne diuretica, oltre a favorire l’eliminazione di tutte le scorie metaboliche, trova indicazione particolare anche nel periodo premestruale quando la ritenzione idrica è maggiore. Da vari studi ed indagini cliniche, si è potuto accertare come l’acqua Gaudenziana sia ben tollerata ed esente da reazioni tossiche anche se som-ministrata in forti quantitativi per prolungati periodi di tempo.
Risultati
Il trattamento idropinico ha portato dopo due mesi di cura ad una riduzione signifi cativa del livello sierico di acido urico, di azotemia e di glicemia per tutti i pazienti trattati (Tabella 3); la riduzione avviene in modo statistica-mente signifi cativo per tutti i tre parametri
Tabella 3.

131
Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemiaClin. Term. 60 (3-4):127-134, 2013
considerati, con una p < 0,001 per uricemia e azotemia ed una p < 0,003 per la glicemia, e si mantiene pressoché costante nei mesi suc-cessivi (Tabella 4). Il risultato dei valori dopo quattro mesi deve ancora essere completato.
Conclusioni e Discussione
I primi dati del presente studio sembrano evidenziare come un’acqua oligominerale bi-carbonato-calcica, utilizzata quotidianamente a dosi defi nite, possa essere in grado di deter-minare una signifi cativa riduzione dei livelli sierici di acido urico, azotemia e glicemia.
Questi risultati, se confermati, saranno in grado di confermare che il trattamento idropi-nico può essere un ottimo ausilio terapeutico, del tutto naturale e gradito ai pazienti, in grado di prevenire complicanze nefropatiche dovute alla deposizione di cristalli di urato nel paren-chima renale e di ridurre il fattore di rischio delle malattie cardiovascolari aterosclerotiche per tutti quei soggetti che abbiano un livello di uricemia border-line o una iperuricemia asintomatica oppure che assumano farmaci iperuricemizzanti, tra cui soprattutto i salici-
lati a basso dosaggio; inoltre l’idropinoterapia potrebbe contribuire molto opportunamente alla riduzione del dosaggio dei farmaci ipou-ricemizzanti in considerazione non solo del costo farmaceutico, relativamente basso, ma anche della alta potenziale tossicità di questi prodotti.
Naturalmente è opportuno attendere la fi ne dello studio e verifi care se dopo ulteriore Tem-po risultano gli stessi dati, in particolare per quanto riguarda la Glicemia, ed è comunque necessario ampliare lo studio ad una casistica signifi cativamente più vasta.
Sin d’ora però, alla luce dei primi risultati, è lecito sostenere che vi siano le basi per poter programmare uno studio in doppio cieco con controllo versus acqua potabile, eventualmente anche per altri parametri emato-chimici.
Bibliografi a
1. ACKERMANN D, BAUMANN JM, FUT-TERLIEB A, et al. Influence of calcium content in mineral water on chemistry and crystallization conditions in urine of calcium stone-formers. Eur Urol 1988; 14:305-8
2. ALBERTAZZI A, et al. Modificazioni dell’equilibrio idro-eletrolitico dopo sommi-nistrazione di acqua oligominerale in pazienti nefrolitiasici. La Clin Terapeutica 1985; 1-12
3. ASPLIN J, DE GANELLO S, NAKAGAWA Y, et al. Evidence that nephrocalcin and urine inhibit nucleation of calcium oxalate mono-hydrate crystals. Am J Physiol 1991; 261: 824-30
4. BATAILLE P, et al. Effect of calcium restric-tion on renal excretion of oxalate and probabi-lity of stones in the various pathophysiological
Tabella 4.

132
Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemiaClin. Term. 60 (3-4):127-134, 2013
groups with calcium stones. The J Urol 1983; 130:218-23
5. BERTRAND D, SHULE J, VAQUELINE L, et al. Le vrai problème des oligo-éléments. Leurs applications thérapeutiques. Centre de Recherches et d’Applications sur les Oligo-éléments. Bursius 1978
67. BORGHI L, GUERRA A, MESCHI T, et al. Rischio litogeno in lavoratori esposti a stress termico. Acta Medica 1989; II, 3-4:1205-9
7. CHURCHILL D, BRYANT D, FODOR G, et al. Drinking water hardness and urolithiasis. Annals Int Med 1978; 88, 4:513-4
8. CORDELLI A, SPADA S. Modificazione del tempo di transito attraverso l’uretere, di pseudocalcoli in conigli trattati con un’acqua oligominerale. Nota seconda. Clin Term 1968; 21:596-9
9. COTTET J. Cures de diurèses et traitement des calculs urétéraux ayant un diamètre ra-diologique supérieur a 4 mm. Presse Therm Clim 1, 1979
10. COTTET J, AUVERT J. Traitement expulsif des calculs urinaires par une association de cure de diurèse et d’actions mécaniques. J Urol Nephrol 1969; 75: 672-7
11. DI SILVERIO F, GALLUCCI M. La litotrissia extracorporea ad onde d’urto. Acta Urol Ital 1986; 43-7
12. DORMIA G, RUOPPOLO M, MANDRESSI A, et al. L’effi cacia della terapia idropinica nei soggetti calcolotici e nei normali. Confronti fra tre tipi di acque. Arch It di Urol e Nefrol 1985; 57(5):381-400
13. ELIA GF, GUERRA A, MESCHI T, et al. Modifi cazioni della saturazione urinaria dei sali litogeni indotte da elevati apporti di acqua oligominerale. Acta Bio-Medica de “L’Ateneo Parmense” 1988; 59,1/2
14. FRAIOLI A, GRASSI M, RANALDO A,
GOTTUSO M, GIMMINUTI R, ROSSI A. Possibilità di trattamenti crenoterapici nella calcolosi idiopatica urinaria: gli inibitori della cristallizzazione. Clin Term 1985; 38: 141-50
15. FROSSARD C, VIEILLEFOND H, CAILLENS H, et al. Action comparée de quelques eaux minérales diurétiques embou-teillées. Presse Therm Clim 2, 1975
16. GERBAULET CT, POZET N, LABEEUW M. Action de l’hyperdiurese sur l’urine des lithisiasiques: approche par l’étude des sa-turations relatives. Presse Therm Clim 1979; 116:120-2
17. GROSSI F. Le acque oligominerali nella calcolosi urinaria. Clin Term 1980; 23:I-III: 66-71
18. HIATT RA, FRIEDMAN GD. The frequency of kidney and urinary tract diseases in a de-fi ned population. 1982; 22:63-8
19. HOWARD JE, THOMAS WC Jr. Control of crystallization in urine. Am I Med 1968; 45: 693-9
20. KHAN SR, SHEVOCK PN, HACKETT RL. Magnesium oxide administration and preven-tion of calcium oxalate nephrolithiasis. J Urol 1993; 149:412-6
21. KLEMPEKER, HAMMARSTEN, GER-SHOFF, et al. Il rapporto magnesio-calcio in soggetti con litiasi renale trattati con l’acqua di Fiuggi. Clin Term 19701; 23:3
22. LINARI F, et al. Le basi metaboliche della ne-frolitiasi idiopatica. Fed Med 1983; 36: 676
23. MARANGELLA M, FRUTTERO B, BRUNO M, et al. Hyperoxaluria in idiopathic calcium stone disease: further evidence of intestinal hyperabsorption of oxalate. Clin Science 1982; 63:381-5
24. MARANGELLA M, VITALE C, PETRARU-LO M, et al. Effects of mineral composition

133
Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemiaClin. Term. 60 (3-4):127-134, 2013
of drinking water on risk for stone formation and bone metabolism in idiopathic calcium nephrolithiasis. Clin Science 1996; 313-8
25. MARINI GR, TALDONE G, CALOSSO G, et al. Effetti dell’acqua oligo-minerale Gauden-ziana di Bognanco sui livelli serici di Acido urico, Azotemia e Glicemia. La vocazione termale della Regio Insubria: immagini di salute senza confi ni, I: 123-129, 2008
26. MARSHALL RW, COCHRAN M, HODG-KINSON A. Relationship between calcium and oxalic intake in the diet and their excretion in the urine of normal and renal stone-forming subjects. Clin Science 1972; 43: 91-9
27. MESSINA B, GROSSI F. Elementi di Idrolo-gia Medica. Società Editrice Universo, Roma 1984
28. MESSINA B, MAMMARELLA A, SPA-GNOLETTO P. Osservazioni sul comporta-mento della diuresi dopo carico idrico con acqua oligominerale (Levissima) e con so-luzione salina isosmotica mediante lo studio dell’osmolarità plasmatica ed urinaria. Clin Term 1978; 4, 31:143-57
29. MESSINI M. Cura di diuresi nella calcolosi renale e nella gotta, Ente Fiuggi, 1970
30. MESSINI M. Uricemia, glicemia ed elimi-nazione urinaria dell’acido urico sotto l’in-fl uenza delle acque di Montecatini, Vallardi, Milano 1931
31. MESSINI M. Uricemia, glicemia ed elimi-nazione urinaria dell’acido urico sotto l’in-fl uenza delle acque cloruro e solfato sodiche, Vallardi, Milano 1932
32. MIANO L, et al. Il trattamento in posizione prona o supina della calcolosi dell’uretere. Acta Urol Ital 1990; 6 (suppl 1):103-7
33. MOTTA M, et al. Fisiopatologia del trasporto urinario. Acta Urol Ital 1990; 6 (suppl 1): 599-601
34. NAPPI G, MASCIOCCHI MM, CALCA-TERRA P, et al. La terapia idropinica oli-gominerale alla fonte S. Bernardo: studio clinico-sperimentale. Med Clin Term 1993; 22: 33-42
35. NAPPI G, MASCIOCCHI MM, DE LUCA S, et al. Indagine sulla litoespulsione indotta da idropinoterapia oligominerale alla fonte. Med Clin Term 1994; 28/29:99-105
36. NAPPI G, RUOPPOLO M, DE BELLIS M, et al. Effi cacia della idropinoterapia in pazienti portatori di calcoli ed in soggetti sani trattati con tre tipi di acque diverse. Med Clin Term 1, 1987
37. NAPPI G, RUPPOLO M, TOMBOLINI P, et al. Idropinoterapia dopo litolapassi percuta-nea. Med Term Clim 1986; 69:5-11
38. PAK CYC, et al. Evidence justifying a high fl uid intake in treatment of nephrolithiasis. Ann Inter Med 1980; 93:36
39. PIACENTINI G. Ricerche sull’azione atti-vante della funzionalità renale ad opera delle acque solfato-calciche in rapporto alla elimi-nazione dell’acido urico e dell’urea, La Cli-nica Termale, vol. III, n. 4, ottobre-dicembre 1950
40. PIACENTINI G. Ricerche sull’azione urico-litica e diuretica delle acque solfato calciche, La Clinica Termale vol. III, n. 2/3, aprile-settembre 1950
41. POZET N, HABJ-AISSA A, LABEEUW M, et al. Le comportement rénal est-il infl uence par la composition d’une charge hydrique? Presse Therm Clim 1994; 131:5-9
42. SCHUSTER J, et al. Primary liquid intake and urinary stone disease. J Chron Dis 1985; 38(11):907-14
43. SCHUSTER J, FINLAYSON B, SCHEAF-FER R, et al. Water hardness and urinary stone disease. J Urol 1985; 128

134
Effetti dell’acqua oligo-minerale Gaudenziana di Bognanco su azotemia, glicemia e uricemiaClin. Term. 60 (3-4):127-134, 2013
44. SIERAKOWSKI R, FINLAYSON B, HEMP G. Water hardness and the incidence of uri-nary calculi. In: Colloquim of renal lithiasis. Edited by B. Finlayson and W.C. Thomas, Gainesville, Florida. University Presses of Florida, chpt. 22, 1976
45. SOMMARIVA M, RIGATTI P, VIOLA MR. Studio delle condizioni di cristallizzazione dell’urina di pazienti affetti da litiasi ossalica dopo trattamento con bevande ad alto tenore di calcio. Min Med 1987; 78(24):1823-9
46. SPADA S, CORDELLI A, GRASSI M. Mo-difi cazione del tempo di transito attraverso l’uretere di pseudocalcoli in conigli trattati con un’acqua oligominerale. Nota prima. Clin Term 1968; 21:559-65
47. SPANDRI P. L’idropinoterapia con acque oligominerali. Premesse teoriche e sperimen-tazione clinica con un’acqua bicarbonato-calcica. Clin Term 1974; 6:293-300
48. THOMAS J. Interet de la cure thermale de Vittel dans le traitement de la lithiase rénale. Presse Therm Clim 3, 1978
49. TOKI N, SUMI H. Urinary tryspin inhibitor and urokinase activities in renal diseases. Acta Haemat 19852; 67:109
50. WALSH, RETIK, STAMEY, et al. Campbell’s Urology. 2085-2136. W.B.Saunders Company, Philadelphia 1992
51. WILLIAMS RE. Longterm survey of 538 patients with upper urinary tract stone. Brit J Urol 1963; 35:416-37

135
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
Clin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
Effi cient use of probiotics in spa therapy
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termale
G. R. Marini, A. Puccio
AMIITTF - Sezione Piemonte Valle d’Aosta Liguria Insubria
RIASSUNTO - Analizzando gli effetti ed i meccanismi d’azione dei probiotici, da oltre un secolo considerati benefi ci per la salute dell’uomo, si deduce che sono simili e sovrapponibili a quelli delle cure termali e della fangotetapia in particolare, e se ne ipotizza pertanto un appropriato uso razionale durante la terapia termale ad integrazione e miglioramento della stessa.
ABSTRACT - After an analysis of the effects and action mechanisms of probiotics, for over a century regarded as benefi cial to human health, it can be deduced that are similar and comparable to those of thermal treatments and mud therapy in particular, and it is therefore assumed a proper rational use, supplementing and improving spa therapy.
PAROLE CHIAVE - Cure termali, probiotici, fangoterapia, crisi termaleKEY WORDS - SPA therapy, probiotics, mud therapy, SPA illness
La fl ora batterica intestinale, dal cavo orale al retto, è formata da circa 50 generi diversi con più di 500 specie batteriche, distribuite su un’area mucosa di 250-400 m2, alcune delle quali possono essere anche potenzialmente dannose (Tabella 1); la sua concentrazione varia moltissimo in base ai vari tratti anatomici del tubo gastro-intestinale (Tabella 2). Essa è infl uenzata qualitativamente e quantitativa-mente da età, ormoni, dieta, uso di farmaci, infezioni, stato immunitario, acidità gastrica,
motilità intestinale, igiene, habitat (Goldin, 1978; Bertazzoni-Minelli, 1993) e riduce la permeabilità intestinale aumentandone l’ef-fetto barriera (Isolauri, 1993; Probert, 2002; Rosenfeldt, 2004; Llopis, 2005).
Soltanto nel 1907 Metchinkoff cominciò ad ipotizzare che la presenza dei batteri nell’inte-stino dell’uomo potesse infl uenzarne positiva-mente la salute e la longevità; nasceva così il concetto di probiotico, ovvero microbo favo-revole alla vita dell’ospite. Più recentemente si

136
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
Tabella 1. Concentrazione di alcuni generi di batteri nell’intestino
Tabella 2. Concentrazione batterica nel tubo digerente

137
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
è defi nito il probiotico come “batterio vivente che una volta ingerito è in grado di esercitare effetti benefi ci sull’uomo” (Guandalini, 1996; Guarner, 1998; McNaught, 2001).
Varie sono le caratteristiche che un probioti-co deve avere per poter essere considerato tale; oltre ad esercitare effetti benefi ci sull’uomo, non deve essere patogeno né tossico, deve po-ter superare la barriera gastrica, avere adesività alle pareti intestinali, mostrare una duratura colonizzazione dell’intestino e poter essere conservato senza perdere le proprie caratteri-stiche (Isolauri, 2001; Gorbach, 2002).
I principali probiotici usati abitualmente nella clinica sono: Lactobacillus acidophilus, bulgaricus, casei, Bifi dobacterium bifi dum, Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Saccharomyces boulardii (Castellazzi, 2003). Tra questi, quello di gran lunga più studiato ed utilizzato in lavori sia clinici sia sperimentali è il Lactobacillus casei sp rhamnosus GG (Saxelin, 1991; Gol-din, 1992; Guarino, 2001).
I probiotici sono principalmente indicati nella terapia e nella prevenzione delle affezioni gastro-intestinali (Pelosini, 2003), soprattutto in età pediatrica (Oberhelman, 1999; Cucchia-ra, 2002; Huang, 2002; Markowitz, 2002); in particolare nelle Gastroenteriti essi riducono signifi cativamente la durata e la gravità della diarrea acuta (Guarino, 2000; Pedone, 2000; Agarwal, 2001; Van Niel, 2002; Isolauri, 2003), in particolare quella da Rotavirus (Iso-lauri, 1993 e 1995; Majamaa, 1995; Guarino, 1997; Phuapradit, 1999; Mastretta, 2002) e la colite pseudomembranosa (Gorbach, 1987; Biller, 1995; Pochapin, 1998), prevengono significativamente la diarrea nosocomiale nei bambini (Isolauri, 1991; Saavedra, 1994; Szajewska, 2001) e riducono la durata dei ricoveri pediatrici per diarrea (Guandalini, 2000; Simakachorn, 2000; Rosenfeldt, 2002), migliorano il quadro clinico della diarrea del viaggiatore (Oksanen, 1990) e sono effi caci nelle diarree acute non ematiche (Raza, 1995); prevengono e riducono significativamente
Tabella 3. Patologie su cui i probiotici hanno effi cacia.

138
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
anche l’incidenza della diarrea da antibiotici (Gotz, 1979; Surawicz, 1989; Siitonen, 1990; McFarland, 1995; Vanderhoof, 1999; Arvola 1999; Bergogne-Bérérin, 2000; Armuzzi, 2000 e 2001; Cremonini 2002; D’Souza 2002; Sza-jewska, 2003 e 2005; Hickson, 2007).
Alla base dell’effi cacia del probiotico nelle infezioni gastro-intestinali vi sono meccanismi d’azione di tipo diretto ed indiretto; tra i primi vi sono l’antagonismo diretto nei confronti dei batteri patogeni, la produzione di sostanze anti-batteriche, la competizione per alcuni nutrienti e la competizione adesiva e recettoriale dei siti cellulari, la soppressione degli enzimi batterici nocivi; tra quelli indiretti vi sono la stimola-zione della produzione di mucine, l’effetto trofi co sull’epitelio intestinale, il ripristino dell’integrità della mucosa e la stimolazione della risposta immunitaria con aumento delle IgA secretorie, dell’attività fagocitaria, dei linfociti, e dell’interferone gamma (Capurso, 2000; Erickson, 2000).
Ma recentemente un numero sempre cre-scente di dati indica che i probiotici hanno effi cacia in numerose altre patologie, anche di apparati diversi da quello gastro-intestinale (Guarino, 2002; De Vrese, 2002) (Tabella 3). In particolare nelle Malattie infi ammatorie croniche intestinali (Shults, 2000; Aratari, 2001; Gionchetti, 2002; Guarino, 2003; Hart, 2003; Kanauchi, 2003; Kuisma, 2003; Kwon, 2003) essi riducono le riacutizzazioni del Morbo di Crohn (Kruis, 1997; Pantera, 2002; Carol, 2006) e della RCU (Rembacken, 1999) e ripristinano la permeabilità intestinale con riduzione dei sintomi clinici nei bambini con Morbo di Crohn (Gupta, 2000; Guandalini, 2002) producendo l’aumento delle IgA e della IL-10 (Malin, 1996; Steidler, 2000 e 2003). Anche relativamente all’Helicobacter pilori
inibiscono la sua crescita e la sua adesività (Aiba, 1998), ne riducono la carica batterica e l’attività ureasica (Coconnier, 1998) e riduco-no l’incidenza e l’intensità della gastrite HP+ (Felley, 2001; Cats, 2003).
Riguardo invece alle patologie infettive di altri organi ed apparati essi sono in grado di determinare una riduzione di incidenza di otiti, sinusiti, bronchiti e polmoniti (Guarino, 2001; Glück, 2003; Chennaoui, 2005) e di riacutizzazioni di asma e rinite allergica nei bambini (Giovannini, 2007), una riduzione dei giorni di assenza da scuola e di prescrizione di antibiotici (Hatakka, 2001) e una riduzione di otite ricorrente in soggetti ‘ricolonizzati’ per via inalatoria (Roos, 2001); riducono inoltre le infezioni ricorrenti delle vie urinarie (Reid, 2001) e inibiscono la crescita e l’adesività dei batteri alle cellule dell’epitelio vaginale (Osset, 2001). Anche nelle infezioni da HIV sembrano poter determinare un recupero ponderale e un miglioramento delle condizioni cliniche gene-rali e stimolare la risposta immune specifi ca con aumento dei linfociti T (Cunningham-Rundles, 2000).
Un numero sempre crescente di studi clinici rilevano che i probiotici hanno effi cacia anche in diverse patologie allergiche (Laiho, 2002; Miniello, 2003; Romei, 2003); in particolare è stata dimostrata una riduzione signifi cativa dell’intensità e dell’estensione della dermatite atopica (Majamaa, 1997; Isolauri, 2000; Mi-raglia, 2002; Rosenfeldt, 2003) ed una ridu-zione signifi cativa dell’incidenza di dermatite atopica ai fi gli di madri trattate in gravidanza (Kalliomaki, 2001; Rautava, 2002). Esiste in-fatti un’associazione tra microfl ora intestinale (riduzione dei Bifi dobatteri e aumento dei Clo-stridi) e patologie allergiche (Kalliomaki, 2001 e 2003) che induce la riduzione dell’espressio-

139
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
ne dei recettori di membrana dei neutrofi li nei soggetti intolleranti e l’aumento nei soggetti sani, modulante tutta la risposta immune (Per-digon, 1995 e 2001; Pelto, 1998; Ouwehand, 2002); si ha così una riduzione dei marcatori di infi ammazione cronica (sCD4) e allergica (EPX) (Isolauri, 2000) e una riduzione delle IgE totali e specifi che (Matsuzaki, 1998) e dei livelli di IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10 (Pessi, 2000) con aumento dei livelli di IFNγ e IL-2 (Miettinen 1998; Tejada-Simon 1999).
L’evidenziazione di una correlazione fra artrite reumatoide giovanile e alterata micro-fl ora intestinale (Malin, 1996), ha portato ad ipotizzare un uso effi cace dei probiotici anche nelle Connettiviti; nell’artrite reumatoide mi-gliorano infatti la permeabilità intestinale e aumentano la risposta immune locale di tipo
IgA e IgM (Malin, 1997), riducendo la seve-rità dei sintomi soggettivi quali il dolore, la tumefazione articolare e la rigidità mattutina (Nenonen, 1998).
Alcuni Autori hanno descritto effetti benefi -ci dei probiotici anche nella fi brosi cistica (Di Benedetto, 1998), nel cancro del colon (Elo, 1991; Abdelai, 1995; Goldin, 1996), nel dan-no epatico da alcool (Gorbach, 1996) e anche nella carie dentale (Nase, 2001).
I meccanismi d’azione evidenziati con cui i probiotici esercitano la propria effi cacia por-tano tutti alla conversione di una stimolazione della risposta Th1, protettiva dalle infezioni, nelle condizioni patologiche in cui prevale le risposta Th2, coinvolta nell’allergia (Guarino, 2001). (Tabella 4) Anche per le cure termali, in particolare per la fangoterapia, è stato re-
Tabella 4. Meccanismo d’azione dei probiotici.

140
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
centemente dimostrato un meccanismo simile che porta ad una modulazione della risposta immunitaria da Th2 a Th1 mediante l’aumen-to di IL-1, TNFα e IGF-1 e la riduzione di PGE
2 e LBT
4 (Bellometti, 1998; 2001; 2003).
(Tabella 5)Si può pertanto concludere ipotizzando
che una integrazione di probiotici durante, ma anche prima e dopo, la cura termale, possa amplifi carne gli effetti, aumentando l’effi cacia e migliorando i benefi ci, riducendone anche quelli che possono essere gli effetti collaterali specifi ci ed aspecifi ci, primo fra tutti la crisi termale.
Bibliografi a
1. ABDELAI H, et al. Effect of diary products on initiating lesions of colon cancer. Nutrition Cancer, 1995.
2. AGARWAL KN, BHASIN SK, FARIDI MM, et al. Lactobacillus casei in the control of
acute diarrhoea: a pilot study. Indian Pediatr 2001; 38(8):905-10
3. AIBA Y, SUZUKY N, KABIR AM, et al. Lactic acid-mediated suppression of Heli-cobater pylori by the oral administration of Lactobacillus salivarius as a probiotic in a gnotobiotic murine model. Am J Gastroenterol 1998; 93:2097-101
4. ARATARI A, GUAGNOZZI D,VISCIDO A, et al. Microfl ora, probiotici e IBD. Giorn Gastroent 2002; 7:63-9
5. ARMUZZI A, CREMONINI E, BARTOLOZ-ZI E, et al. The effect of oral administration of Lactobacillus GG on antibiotic associated gastrointestinal side effects during Helico-bacter pylori eradication therapy. Aliment Pharmacol Ther 2001; 15:163-9
6. ARMUZZI A, CREMONINI E, OMETTI V, et al. Effect of Lactobacillus GG supplementa-tion on antibiotic-associated gastrointestinal side effects during Helicobacter pylori eradi-cation therapy: a pilot study. Digestion 2000; 63:1-7
7. ARVOLA T, LAIHO K, TORKKELI S, et al. Prophylactic Lactobacillus GG reduces antibiotic-associated diarrhoea in children with respiratory infections: a randomised study. Pediatrics 1999; 104:64-8
8. BELLOMETTI S, GALZIGNA L. Serum levels of a prostaglandin and a leukotriene after thermal mud pack therapy. J Invest Med 1998; 46:140-5
9. BELLOMETTI S, CECCHETTIN M. Mud pack therapy in osteoarthrosis: changes in serum levels of chondrocyte markers. Clinica Chimica Acta 2001; 268:101-6
10. BELLOMETTI S, GALZIGNA L, RICHEL-MI P, et al. Both serum receptors of tumour necrosis factor are infl uenced by mud pack treatment in osteo-arthritic patients. Int J
Tabella 5. Meccanismo d’azione della fangoterapia

141
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
Tissue React 2002; XXIV (2):57-6411. BERGOGNE-BÉRÉRIN E. Treatment and
prevention of antibiotic associated diarrhoea. Int J Antimicrob Agents 2000; 16:521-6
12. BERTAZZONI-MINELLI E, BENINI A, BEGHINI A, et al. Bacterial fl ora in healthy women of different ages. Microb Ecol Health Dis 1993; 6:43-52
13. BILLER JA, KATZ AJ, FLORES AF, et al. Treatment of recurrent C. diffi cile colitis with Lactobacillus GG. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995; 21:224-6
14. CAPURSO L. I Probiotici. Ospedale & Ter-ritorio 2000; V.1 N.2:65-74
15. CAROL M, BORRUEL N, ANTOLIN M, et al. Modulation of apoptosis in intestinal lym-phocytes by a probiotic bacteria in Crohn’s disease. J Leukoc Biol 2006; 79(5):917-22
16. CASTELLAZZI AM, OLIVIERI M, AVAN-ZINI MA. Ecosistema intestinale e immunità. Atti 59° Congresso Nazionale di Pediatria, Roma 2003; 2:251-2
17. CATS A, KUIPERS EJ, BOSSCHAERT MA, et al. Effect of frequent consumption of a Lactobacillus casei-containing milk drink in Helicobacter pylori-colonized subjects. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17:429-35
18. CHENNAOUI M. Intense training: mucosal immunity and incidence of respiratory infec-tions. Eur J Appl Physiol 2005; 93(4):421-8
19. COCONNIER MH, LIEVIN V, HEMERY E, et al. Antagonistic activity against Helico-bacter infection in vitro and in vivo by human Lactobacillus acidophilus strain LB. Appl Environ Microbiol 1998; 64:4573-80
20. CREMONINI F, DI CARO S, NISTA EC, et al. Meta-analysis: the effect of probiotic administration on antibiotic-associated diar-rhoea. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16(8): 1461-7
21. CUCCHIARA S, FALCONIERI P, DI NAR-DO G, et al. New therapeutic approach in the management of intestinal disease: probiotics in intestinal disease in paediatric age. Dig Liver Dis 2002; 34:44-7
22. CUNNINGHAM-RUNDLES S, AHARNE S, BENGMARK S, et al. Probiotics and immune response. Am J Gastroenterol 2000; 95: S22-S25
23. D’SOUZA AL, RAJKUMAR C, COOKE J, et al. Probiotics in prevention of antibiotic associated diarrhoea: meta-analysis. BMJ 2002; 324(7350): 1361-6
24. DE VRESE M, SCHREZENMEIR J. Probi-otics and non-intestinal Infections. Br I Nutr 2002; 88:S59-S66
25. DI BENEDETTO L, RAIA V, PASTORE A, et al. Lactobacillus casei strani GG as adjunc-tive treatment to children with cystic fi brosis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998; 26:542
26. ELO S, SAXELIN M, SALMINEN S. At-tachment of Lactobacillus casei strain GG to human colon carcinoma cell line Caco-2: comparison with other dietary strains. Lett Appl Microbiol 1991; 13:154-6
27. ERICKSON KL, HUBBARD NE. Probiotic immuno-modulation in health and disease. J Nutr 2000; 130S:403-9
28. FELLEY CP, CORTHESY-THEULAZ I, RIVERO JL, et al. Favourable effect of an acidifi ed milk (LC-1) on helicobacter pylori gastritis in man. Eur J Gastroenterol Hepatol 2001; 13:25-9
29. GIONCHETTI P, AMADINI C, RIZZELLO F, et al. Probiotics-role in infl ammatory bowel disease. Dig Liver Dis 2002; 34:58-62
30. GIOVANNINI M, AGOSTONI C, RIVA E, et al. A randomised prospective double blind controlled trial on effects of long-term consumption of fermented milk containing

142
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
Lactobacillus casei in pre-school children with allergic asthma and/or rhinitis. Pediatr res 2007
31. GLÜCK U, GEBBERS JO. Ingested probiot-ics reduce nasal colonization with pathogenic bacteria (Staphylococcus aureus, Streptococ-cus pneumoniae, and ß-haemolytic strepto-cocci). Am J Clin Nutr 2003; 77:517-20
32. GOLDIN BR, DWYER J, GORBACH SL, et al. Infl uence of diet and age on faecal bacterial enzymes. Am J Clin Nutr 1978; 31:S136-S140
33. GOLDIN BR, GORBACH SL, SAXELIN M, et al. Survival of Lactobacillus species (strain GG) in human gastrointestinal tract. Dig Dis Sci 1992; 37:121-8
34. GOLDIN BR, GUALTIERI L, MOORE RP. The effect of Lactobacillus GG on the initiation and promotion of dimethylhydrazine-induced intestinal tumours in the rat. Nutr and Cancer 1996
35. Gorbach SL. Probiotics and their advantages for health. Medic 1996; 4:166-9
36. GORBACH SL. Probiotics in the third mil-lennium. Dig Liver Dis 2002; 34:S2-7
37. GORBACH SL, CHANG T, GOLDIN BR. Successful treatment of relapsing Clostridium diffi cile colitis with Lactobacillus GG. Lancet 1987; 2:1519
38. GOTZ V, ROMANKIEWICZ JA, MOSS J, et al. Prophylaxis against ampicillin-associated diarrhoea with a Lactobacillus preparation. Am J Hosp Pharm 1979; 36:754-7
39. GUANDALINI S. Use of Lactobacillus-GG in paediatric Crohn’s disease. Dig Liver Dis 2002; 34:63-5
40. GUANDALINI S, GABRIELE A, PENSABE-NE L. Usefulness of probiotics in acute diar-rhoea in childhood. M&B 1996; 7:423-7
41. GUANDALINI S, PENSABENE L, ZIKRI
MA, et al. Lactobacillus GG administered in oral rehydration solution to children with acute diarrhoea: a multicenter European trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 30: 54-60
42. GUARINO A, ALBANO F. Guidelines for the approach to outpatient children with acute diarrhoea. Acta Pediatr 2001; 90:1087-95
43. GUARINO A, ALBANO F. Proposte di linee guida per l’approccio ambulatoriale al bam-bino con diarrea acuta. Riv Ital Pediatr 2000; 26:1036-42
44. GUARINO A, ALBANO F, BRUZZESE E. Linee guida per l’approccio al bambino con gastroenterite acuta. Riv Ital Infettivol Pediatr 2001; 3:61-7l
45. GUARINO A, BERNI CANANI R, SPA-GNUOLO MI, et al. Oral bacterial therapy reduces the duration of diarrhoea and of viral excretion in children with mild diarrhoea. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997; 25:516-9
46. GUARINO A, BRUZZESE E. I probiotici: indicazioni cliniche certe e potenziali e mecca-nismi d’azione. Prospettive in Pediatria 2001; 31:311-23
47. GUARINO A, BRUZZESE E, BERNI CA-NANI R. Microfl ora in infl ammatory bowel disease. Atti 2nd Probiotics & Prebiotics, New Foods, Roma 7-9 settembre 2003; 172-93
48. GUARINO A, BRUZZESE E, DE MARCO G. Effi cacia dei probiotici nelle infezioni in-testinali ed extraintestinali. Atti 3° Congresso Nazionale Società Italiana Infettivologia Pe-diatrica, Napoli 2002; 13-25
49. GUARNER F, SCHAAFSMA GJ. Probiotics. Int J Food Microbiol 1998; 39:237-8
50. GUPTA P, ANDREW H, KIRSCHNER BS, et al. Is Lactobacillus GG helpful in children with Crohn’s disease? Results of a prelimi-nary, open-label study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 31:453-7

143
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
51. HART AL, STAGG AJ, KAMM MA. Use of probiotics in the treatment of infl ammatory bowel disease. J Clin Gastroenterol 2003; 36: 111-9
52. HATAKKA K, SAVILAHTI E, PONKA A, et al. Effect of long term consumption of pro-biotic milk on infections in children attending day care canters: double blind, randomised trial. Br Med J 2001; 322:1327-31
53. HICKSON M, D’SOUZA AL, MUTHU N, et al. Use of probiotic Lactobacillus prepa-ration to prevent diarrhoea associated with antibiotics: randomised double blind placebo controlled trial. BMJ 2007; 335(7610):80-5
54. HUANG JS, BOUSVAROS A, LEE JW, et al. Effi cacy of probiotic use in acute diarrhoea in children: a meta-analysis. Dig Dis Sci 2002; 47(11):2625-34
55. Isolauri E. Probiotics for infectious diarrhoea. Gut 2003; 52: 436-437.
56. Isolauri E. Probiotics: from anecdotes to clini-cal demonstration. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 1062-1064.
57. ISOLAURI E, ARVOLA T, SUTAS Y, et al. Probiotics in the management of atopic eczema. CIin Exp Allergy 2000; 30:1604-10
58. ISOLAURI E, JOENSUU J, SUOMALAI-NEN H, et al. Improved immunogenicity of oral D x RRV reassortant rotavirus vaccine by Lactobacillus casei GG. Vaccine 1995; 13: 310-2
59. ISOLAURI E, JUNTUNEN M, RAUTANEN T, et al. A human lactobacillus strain (L. casei sp strain GG) promotes recovery from acute diarrhoea in children. Pediatrics 1991; 88: 90-7
60. ISOLAURI E, KAILA M, ARVOLA T, et al. Diet during rotavirus enteritis affects jejunal permeability to macromolecules in suckling rats. Pediatr Res 1993; 33:548-53
61. ISOLAURI E, MAJAMAA H, ARVOLA T, et al. Lactobacillus casei strain GG reverses increased intestinal permeability induced by cow milk in suckling rats. Gastroenterol 1993; 105:1645-50
62. KALLIOMAKI M, KIRJAVAINEN P, EE-ROLA E, et al. Distinct patterns of neonatal gut microfl ora in infants in whom atopy was and was not developing. J Allergy Clin Im-munol 2001; 107:129-34
63. KALLIOMAKI M, SALMINEN S, AR-VILOMMI H, et al. Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2001; 357: 1076-9
64. KALLIOMAKI M, SALMINEN S, POUSSA T, et al. Probiotics and prevention of atopic disease: 4-year follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003; 361: 1869-71
65. KANAUCHI O, MITSUYAMA K, ARAKI Y, et al. Modifi cation of intestinal fl ora in the treatment of infl ammatory bowel disease. Curr Pharm Des 2003; 9:333-46
66. KRUIS W, SCHUTZ E, FRIC P, et al. Double-blind comparison of an oral Escherichia coli preparation and mesalazine in maintaining remission of ulcerative colitis. Aliment Phar-macol Ther 1997; 11:853-8
67. KUISMA J, MENTULA S, JARVINEN H, et al. Effect of Lactobacillus rhamnosus GG on ileal pouch infl ammation and microbial fl ora. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17:509-15
68. KWON J, FARRELL R. Probiotics and in-fl ammatory bowel disease. Bio Drugs 2003; 17:179-86
69. LAIHO K, HOPPU U, OUWEHAND AC, et al. Probiotics: on-going research on atopic individuals. Br J Nutr 2002; 88:S19-27
70. LING WH, HANNINEN O, MYKKANEN et

144
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
al. Colonization and faecal enzyme activities after oral Lactobacillus GG administration in elderly nursing residents. Ann Nutr Metab 1992; 36:162-6
71. LLOPIS M, ANTOLIN M, GUARNER F, et al. Mucosal colonisation with Lactobacil-lus casei mitigates barrier injury induced by exposure to trinitronbenzene sulphonic acid. Gut 2005; 54(7):955-99
72. MAJAMAA H, ISOLAURI E. Probiotics: a novel approach in the management of food allergy. J Allergy Clin Immunol 1997; 99: 179-84
73. MAJAMAA H, ISOLAURI E, SAXELIN M, et al. Lactic acid bacteria in the treatment of acute Rotavirus gastroenteritis. J Pediatr Gastroenterol Nut 1995; 20:333-8
74. MALIN M, SUOMALAINEM H, SAXELIN M, et al. Promotion of IgA immune response in patients with Crohn’s disease by oral bac-teriotherapy with Lactobacillus GG. Ann Nutr Metab 1996; 40:137-45
75. MALIN M, VERRONEN P, KORHONEN H, et al. Dietary therapy with Lactobacillus GG, bovine colostrum of bovine immune colostrum in patients with juvenile chronic arthritis: evaluation of effect on gut defence mechanism. Infl ammopharmacol 1997; 5:219-36
76. MALIN M, VERRONEN P, MYKKANEN H, et al. Increased bacteria urease activity in faeces in juvenile chronic arthritis. Evidence of altered intestinal microfl ora?. Br J Rheu-matol 1996; 35:689-94
77. MARINI GR, MARCHISIO A, LEVRA G. Razionale d’impiego dei probiotici in corso di terapia termale. La vocazione termale della “Regio Insubrica”: oltre i confi ni della salute. 2013; II:24-33
78. MARKOWITZ JE, BENGMARK S. Probiot-ics in health and disease in the paediatric pa-
tient. Ped Clin North Am 2002; 49:127-4179. MASTRETTA E, LONGO P, LACCISAGLIA
A, et al. Effect of Lactobacillus GG and breast feeding in the prevention of rotavirus nosoco-mial infection. J Pediatr Gastr Nutr 2002; 35: 527-31
80. MATSUZAKI T, YAMAZAKI R, HASHINI-OTO S, et al. The effect of oral feeding of lactobacillus casei strain Shirota on immu-noglobulin E production in mice. J Dairy Sci 1998; 81:48-53
81. MCFARLAND LV, SURAWICZ CM, GREENBERG RN, et al. Prevention of Beta-lactam-associated diarrhoea by Saccharomy-ces boulardii compared with placebo. Am J Gastroenterol 1995; 90:439-48
82. MCNAUGHT CE, MACFIE I. Probiotics in clinical practice: a critical review of the evidence. Nutrition Res 2001; 21:343-53
83. METCHINKOFF E. The prolongation of life. Putman and Sons. 1907; 1-38
84. MIETTINEN M, MATIKAINEN S, VUO-PIO-VARKILA J, et al. Lactobacilli and streptococci induce interleukin-12 (IL-12), IL-18, and gamma interferon production in human peripheral blood mononuclear cells. Infect Immun 1998; 66:6058-62
85. MINIELLO VL, FRANCAVILLA R, NA-TILA M, et al. Probiotics: requirements and new perspectives in atopy. Atti 2nd Probiotics & Prebiotics, New Foods, Roma 7-9 settembre 2003; 196-200
86. MIRAGLIA DEL GIUDICE M JR, DE LUCA MG, CAPRISTO C. Probiotics and atopic dermatitis. A new strategy in atopic dermatitis. Dig Liver Dis 2002; 34:S68-71
87. NENONEN MT, HELVE TA, RAUMA AL, et al. Uncooked, lactobacilli-rich, vegan food and rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1998; 37:274-81

145
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
88. NASE L, HATAKKA K, SAVILAHTI E, et al. Effect of long-term consumption of a pro-biotic bacterium, Lactobacillus rhamnosus GG, in milk on dental caries and caries risk in children. Caries Res 2001; 35:412-20
89. OBERHELMAN RA, GILMARI RH, SHEEN P, et al. A placebo-controlled trial of Lactoba-cillus GG to prevent diarrhoea in undernour-ished Peruvian children. J Pediatr 1999; 134: 15-20
90. OKSANEN PJ, SALMINEN S, SAXELIN M, et al. Prevention of traveller’s diarrhoea by Lactobacillus GG. Ann Med 1990; 22:53-6
91. OSSET J, BARTOLOME RM, GARCIA E, et al. Assessment of the capacity of Lactobacil-lus to inhibit the growth of uropathogens and block their adhesion to vaginal epithelial cells. J Infect Dis 2001; 183:485-91
92. OUWEHAND A, ISOLAURI E, SALMINEN S. The role of the intestinal microfl ora for the development of the immune system in early childhood. Eur J Nutr 2002; 41S1:I32-37
93. PEDONE CA, ARNAUD CC, POSTAIRE ER, et al. Multicentric study of the effect of milk fermented by Lactobacillus casei on the incidence of diarrhoea. Int J Clin Pract 2000; 54(9):568-71
94. PELOSINI I, MOLINA E, SCARPIGNATO C. Utilizzazione clinica dei probiotici in ga-stroenterologia: stato attuale e prospettive. Gastroenterol 2003; S:28-40
95. PELTO L, ISOLAURI E, LILIUS EM, et al. Probiotic bacteria down-regulate the milk induced inflammatory response in milk-hypersensitive subjects but have an immuno-stimulatory effect in healthy subjects. Clin Exp AlIergy 1998; 28:1474-9
96. PERDIGON G, ALVAREZ I, RACHID M, et al. Immune system stimulation by probiotics. J Dairy Sci 1995; 78:1597-606
97. PERDIGON G, FULLER R, RAYA R. Lactic acid bacteria and their effect on the immune system. Curr Issues Intest Microbiol 2001; 2: 27-42
98. PESSI T, SUTAS Y, HURME M, et al. Interleukin-10 generation in atopic children following oral Lactobacillus rhamnosus GG. Clin Exp Allergy 2000; 30:1804-08
99. PHUAPRADIT E, VARAVTTHYA W, VA-THANOPHAS K, et al. Reduction of rotavirus infection in children receiving bifi dobacteria-supplemented formula. J Med Assoc Thai 1999; 82:543-8
100. POCHAPIN MB, OLTIKAR A, PRINGE-SMITH R, et al. A prospective randomised placebo-controlled trial of Lactobacillus GG in combination with standard antibiotics for the treatment of Clostridium diffi cile infec-tion. Am J Gastroenterol 1998; 93:1697
101. PRANTERA C, SCRIBANO ML. Probiotics and Crohn’s disease. Dig Liver Dis 2002; 34: 66-7
102. PROBERT HM, GIBSON GR. Bacterial bio-fi lms in the human gastrointestinal tract. Curr Issues Intest Microbiol 2002; 3:23-7
103. RAUTAVA S, ISOLAURI E. The development of gut immune responses and gut microbiota: effects of probiotics in prevention and treat-ment of allergic disease. Curr Issues Intest Microbiol 2002; 3:15-22
104. RAUTAVA S, KALLIOMAKI M, ISOLAURI E. Probiotics during pregnancy and breast feeding might confer immuno-modulatory protection against atopic disease in the infant. J Allergy Clin Imm unol 2002; 109:119-21
105. RAZA S, GRAHAM SM, ALLEN SJ, et al. Lactobacillus GG promotes recovery from acute non-bloody diarrhoea in Pakistan. Pe-diatr Infect Dis 1995; 14:107-11
106. REID G, BRUCE AW, et al. Oral probiotics

146
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
can resolve urogenital infections. FEMS Im-munol Med Microbiol 2001; 30:49-52
107. REMBACKEN BJ, SNELLING AM, et aL. Non-pathogenic E. coli vs. mesalazine for the treatment of ulcerative colitis: a randomised trial. Lancet 1999; 354:635-9
108. ROMEI I, BOSEGGIA B, MILANESI E, et al. Probiotici e allergie. Atti 59° Congresso Nazionale di Pediatria, Roma 2003; 2: 259-63
109. ROOS K, HAKANSSON EG, HOLM S. Effect of recolonisation with “interfering” alpha-streptococci on recurrences of acute and secretory otitis media in children: ran-domised placebo controlled trial. BMJ 2001; 322:210-202
110. ROSENFELDT V, et al. Effects of probiot-ics on gastrointestinal symptoms and small intestinal permeability in children with atopic dermatitis. J Pediatr 2004
11. ROSENFELDT V, BENFELDT E, NIELSEN SD, et al. Effect of probiotic Lactobacillus strains in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2003; 111:389-95
112. ROSENFELDT V, MICHAELSEN KF, JA-KOBSEN M, et al. Effect of probiotic Lacto-bacillus strains in young children hospitalised with acute diarrhoea. Pediatr Infect Dis J 2002; 21:411-6
113. ROSENFELDT V, MICHAELSEN KF, JA-KOBSEN, et al. Effect of probiotic Lactobacil-lus strains on acute diarrhoea in a cohort of non-hospitalised children attending day-care centres. Pediatr Infect Dis J 2002; 21:417-9
114. SAAVEDRA JM, BAUMANN NA, et Al. Feeding of Bifi dobacterium Bifi dum and Strep-tococcus Thermophilus to infants in hospital for prevention of diarrhoea and shedding of Rotavirus. Lancet 1994; 344:1046-9
115. SAXELIN M, ELO S, SALMINEN S. Dose response colonization of faeces after oral ad-ministration of Lactobacillus casei strain GG. Microbiol Ecol Health Dis 1991; 4:209-14
116. SHULTS C, et al. Probiotics in infl ammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2000
117. SIITONEN S, VAPAATALO H, SALMINEN S, et al. Effect of Lactobacillus GG yoghurt in prevention of antibiotic associated diarrhoea. Ann Med 1990; 22:57-9
118. SIMAKACHORN N, PICHAIPAT V, et al. Clinical evaluation of the addition of lyophilised, heat-killed Lactobacillus acido-philus LB to oral rehydration therapy in the treatment of acute diarrhoea in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 30:68-72
119. STEIDLER L. Lactobacillus Lactis secreting IL-10. Atti 2nd Probiotics & Prebiotics, New Foods, Roma 7-9 settembre 2003; 15-22
120. STEIDLER L, HANS W, SCHOTTE L, et al. Treatment of murine colitis by Lactococcus lactis secreting interleukin-10. Science 2000; 289:1352-5
121. SURAWICZ CM, ELMER GW, SPEELMAN P, et al. Prevention of antibiotic associated diarrhoea by Saccharomyces boulardii. Gas-troenterol 1989; 96:981-8
122. SZAJEWSKA H, KOTOWSKA M, MRU-KOWICZ JZ, et al. Effi cacy of lactobacillus GG in prevention of nosocomial diarrhoea in infants. J Pediatr 2001; 138:361-5
123. SZAJEWSKA H, MRUKOWICZ JZ. Probiot-ics in prevention of antibiotic-associated diar-rhoea: meta-analysis. J Pediatr 2003; 142(1): 85
124. SZAJEWSKA H, MRUKOWICZ JZ. Probi-otics in the treatment and prevention of acute infectious diarrhoea in infants and children: a systematic review of published randomized,

147
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013
double-blind, placebo-controlled trials. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 33:S17-S25
125. SZAJEWSKA H, MRUKOWICZ JZ. Meta-analysis: non-pathogenic yeast Saccharomy-ces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22(5):365-72
126. TEJADA-SIMON MV, USTUNOL Z, PE-STKA JJ. Ex vivo effect of lactobacilli, strep-
tococci, bifi dobacteri ingestion on cytokine and nitric oxide production in a murine model. J Food Prot 1999; 62:162-9
127. VANDERHOOF JA, WHITNEY DB, AN-TONSON DL, et al. Lactobacillus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea in children. J Pediatr 1999; 135:564-8
128. VAN NIEL CW, FEUDTNER C, GARRISON MM, et al. Lactobacillus therapy for acute infectious diarrhoea in children: a meta-analysis. Pediatrics 2002; 109(4):678-84

148
Razionale d’impiego dei probiotici nella terapia termaleClin. Term. 60 (3-4):135-147, 2013

1
GRUPPO PERIODICI
LA CLINICA TERAPEUTICA: Rivista bimestrale di clinica e terapia medica, diretta da P. Cugini e M. Lopez.
MEDICINA PSICOSOMATICA: Rivista trimestrale di medicina psicosomatica, psicologia clinica e psicoterapia, diretta da M. Biondi, redatta da R. Delle Chiaie.
ANNALI DI IGIENE, MEDICINA PREVENTIVA E DI COMUNITÀ: Rivista bimestrale, diretta da G.M. Fara,A. Gullotti, V. Leoni, A. Panà, A. Simonetti D’Arca.
ZACCHIA - Archivio di Medicina Legale, sociale e criminologica: Rivista trimestrale, diretta da P. Arbarello, L. Macchiarelli, S. Merli.
LA CLINICA TERMALE: Rassegna trimestrale di idrologia e climatologia medica, fondata da M. Messini.
SCIENZA DELLA RIABILITAZIONE: Rivista trimestrale, diretta da V. M. Saraceni.
SOCIETÀ EDITRICE UNIVERSO S.R.L.Via G.B. Morgagni 1 - 00161 Roma
Tel. 064402053/4 - 0644231171 – Fax 064402033E-mail: [email protected] - Indirizzo Web: http://www.seu-roma.it
Il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale N° 925008, a mezzo vaglia po stale o as-segno bancario intestati alla Società Editrice Universo - via G. B. Morgagni, 1 - 00161 Roma, a mezzo bo ni co bancario c/o- UNICREDIT S.p.A. AG. 713 - Roma - IBAN IT30 F 02008 05212 000004119717- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. 90 - IBAN IT84R0103003268000001001854
I supplementi di ogni rivista si spediscono in contrassegno su richiesta al prezzo di euro 25,00 + 5,00 euro di spese spedizione.I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere richiesti entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo successivo, decorso tale termine si spediscono, se disponibili, soltanto dietro pagamento.Per altre informazioni rivolgersi a: Società Editrice Universo, Via Morgagni 1, 00161 RomaTel. 064402054 - 064402053 - 0644231171 - Fax 064402033 - E-mail: [email protected]
ABBONAMENTI ANNO 2014
Italia Estero + sp.postali
LA CLINICA TERAPEUTICA € 60,00 € 120,00 + € 150,00
LA CLINICA TERAPEUTICA ... on-line + accesso agli articoli e-pub completi
€ 58,00 + Iva 22% € 58,00
MEDICINA PSICOSOMATICA € 45,00 € 90,00 + € 35,00
MEDICINA PSICOSOMATICA ... on-line € 40,00 + Iva 22% € 40,00
ANNALI DI IGIENE, MEDICINA PREVENTIVA E DI COMUNITÀ € 72,00 € 144,00 + € 100,00
ANNALI DI IGIENE .... on-line € 60,00 + Iva 22% € 60,00
ZACCHIA € 55,00 € 110,00 + € 150,00
ZACCHIA ...... on line € 45,00 + Iva 22% € 45,00
LA CLINICA TERMALE € 32,00 € 64,00 + € 25,00
SCIENZA DELLA RIABILITAZIONE ...... on line € 25,00 + Iva 22% € 20,00
A RICHIESTA SI INVIANO FASCICOLI DI SAGGIO
PER GLI ABBONAMENTI SI RICHIEDE IL PAGAMENTO ANTICIPATO
ABBONAMENTO (I GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014) CON RICONOSCIMENTO DELL'INDIRIZZO
IP PER BIBLIOTECHE ED UNIVERSITÀ: – permette l'accesso ai contenuti on line di tutte le nostre riviste, la possibilità di consultare le annate precedenti e di ricevere il periodico in formato cartaceo € 300,00 + Iva 22%
– senza ricevere il periodico in formato cartaceo € 180,00 + Iva 22%

La Clinica TermaleDirettore Resp.: C. Volpe
Autorizzazione del Tribunale di Roma
N. 230 del 14.05.2003
Spedizione in abbonamento postale - 45%
NORME DI REDAZIONE
La rivista è posta sotto la tutela delle leggi internazionali sulla stampa. I lavori saranno esaminati dalla Redazione ed insindaca-
bilmente accettati o respinti; la redazione si riserva il diritto di apportare modifi che al testo, senza alterare minimamente la sostanza
dell’articolo, per uniformarlo alle consuetudini della rivista; gli articoli saranno pubblicati nel più breve tempo possibile, compatibilmente
con lo spazio disponibile in ogni fascicolo.
I lavori debbono pervenire in redazione sia in copia cartacea che in dischetto (fl oppy disk 3,5”) o tramite la nostra casella e-mail
su Internet ([email protected] oppure [email protected]). Sulla etichetta dovranno essere riportati: il tipo di computer usato,
il sistema ed il programma adattati, il nome dell’autore: le fi gure dovranno essere in originale («in negativo» se pellicole), idonee ad
essere riprodotte in clichés e delle dimensioni consentite dal formato della rivista (cm 7 di base e cm 15 di altezza massima oppure cm
15 di base massima e cm 15 di altezza massima). Analoghe norme vanno rispettate anche per le Tabelle e gli schemi vari. Le fi gure
originali (non in fotocopia) devono essere allegate a parte e non incollate sul dattiloscritto.
Ogni lavoro dovrà essere corredato dal titolo in italiano e in inglese, Key words in inglese, un breve riassunto, anche in inglese, e
del preciso indirizzo privato di ciascun autore. Le citazioni bibliografi che saranno riunite alla fi ne dell’articolo: esse saranno in ordine
alfabetico e numerate nel testo della memoria. Ogni citazione deve comprendere: il cognome dell’autore, l’iniziale del nome, il titolo
del lavoro, il nome del periodico con l’indicazione di volume, pagina ed anno di pubblicazione.
Le dosi delle ricette saranno date in grammi (g e non gr che per gli anglosassoni indica il grano: 1 gr cioè 1 grano = 0,06 g). Diamo
di seguito le abbreviazioni più comuni: chilogrammo = kg; milligrammo = mg; millesimo di mg = mcg; metro = m; centimetro = cm;
millimetro = mm; micron = m centrimetro cubo = ml; pH e non ph.
La correzione delle bozze dovrà essere limitata alla semplice revisione tipografi ca. Le bozze di stampa, diligentemente corrette e
defi nitivamente licenziate dall’autore debbono essere restituite alla Redazione a stretto giro di posta. In caso contrario verranno corrette
in redazione; esse vengono inviate in genere una sola volta all’autore. Il modulo che accompagna le bozze deve essere dall’autore
accuratamente compilato in tutte le sue parti: indica infatti il numero di estratti desiderati, le varie osservazioni ecc.
Gli articoli pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli Autori. Viene indicato il giorno in cui il lavoro è pervenuto
completo (Riassunto, Bibliografi a, Figure, Tabelle ecc.) alla Direzione della Rivista.
È riservata la proprietà letteraria di qualsiasi articolo pubblicato su «La Clinica Termale» e ne è vietata la riproduzione anche
parziale (fi gure ecc.) senza citarne la fonte.
Per i libri inviati in duplice copia alla Redazione sarà curata la segnalazione o la recensione sulla rivista.
Finito di stampare nel mese di Gennaio 2014
dalla TIPOGRAFIA CSR s.r.l. - Via di Pietralata 157, 00158 Roma