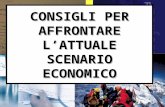INTRODUCIONE CAPITOLO PRIMO-L’ATTUALE SISTEMA...
-
Upload
phungthuan -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of INTRODUCIONE CAPITOLO PRIMO-L’ATTUALE SISTEMA...
INTRODUCIONE
CAPITOLO PRIMO-L’ATTUALE SISTEMA
COSTITUZIONALE ALBANESE
1 1. Caratteri della Costituzione
L’esame dell’ attuale sistema costituzionale albanese non puo prescinderedalla preliminare connotazione dei caratteri propri del testo costituzionale.
Si puo rilevare, invero, che esso e preceduto da una specie di preambolo,nel quale si esprimono principi, convinzioni ed aspirazioni che non hanno val-ore giuridico e che, tuttavia, costituiscono valido ausilio per l’interpretazionedel testo.
La mera lettura dei valori espressi nel preambolo, a confronto con i prin-cipi inseriti nella prima e nella seconda parte, puo anche far emergere alcunecontraddizioni che, pero, sono riassorbite dalla continua sottolineattira di al-cuni profili di fondo, i quali caratterizzano la precisa volontacostituzionale didelineare una democrazia avente particolare sensibilitaper i diritti e le libertafondamentali dell’uomo.
Non hanno, percio, grande significato i rilievi critici che sarebbe agevoleesporre, mentre appare piu significativo esperire un tentativo di razional-izzazione dell’intero testo attraverso un percorso sistematico che ponga inevidenza l’innovazione costituzionale operata nell’ordinamento albanese.
Trattasi di costituzione lunga (183 articoli), rigida (l’art. 177, infatti,prevede un meccanismo aggravato di modifica della Costituzione), elastica(carattere derivante da alcune formulazioni generiche o equivoche ovveror-ipetitive), programmatica (e sufficiente esaminare le liberta e i diritti fonda-mentali, nonche gli obiettivi sociali - art. 59 - per cogliere l’impulso modi-ficativo assunto come tendenza propositiva dell’ ordinamento costituzionale),nonche pedagogica (come emerge sin dal preambolo e dalla serie di principifondamentali - artt. 1-14 - e di principi generali - artt. 15-20).
Tali caratteri della Costituzione possono essere interpretati con piu pun-tualita, se si percorre il testo e, dopo avere esaminato il sistema delle fontinormative, si distinguono i numerosi rinvii contenutistici ad una disciplinaintegrativa di singoli istituti che viene assegnata alla legge.
Il rinvio in questo caso e differente dalla mera riserva di legge che, comepuo verificarsi, acquisisce un significato di garanzia della tutela costituzionaleapprestata con le singole disposizioni.
1
2 2. Le fonti nonnative
Il disegno costituzionale delle fonti normative costituisce espressione delladistribuzione dei poteri sia a livello centrale che a livello locale.
Sono affermati i principi della gerarchia delle fonti (art. 116), della com-petenza (regolamenti parlamentari previsti dall’art. 75, 2 comma, e 76,2comma, nonche gli atti degli Istituti centrali di cui all’art. 116, 3 comma- Corte costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte deiconti).
La successione delle leggi nel tempo viene richiamata dai principi di ir-retroattivita della legge, specie in materia penale (art. 29, 1 comma) e fiscale(art. 155), con la precisazione che la legge penale piu favorevole assume valoreretroattivo (art. 29, 3 comma), nonche ultrattivo (art. 29, 3 comma).
Nella tipologia delle fonti vi e una varieta di atti normativi che si pongonoin un’ordinata collocazione gerarchica prendendo le mosse dal vertice norma-tivo che viene identificato nella Costituzione e che, come tale, viene spesso,in diverse disposizioni, sottolineato (pur non essendovene bisogno, stante larigidita del testo); tuttavia la sottolineatura eopportuna in relazione ai diversirinvii alle leggi, non costituenti riserva di legge.
A livello di vertice sono collocate anche le leggi di revisione costituzionalepreviste dall’ art. 177, che sono limitate solo ad emendamenti; vale a direche non sono ammesse modifiche costituzionali relative a progetti organici oad interi settori della Costituzione.
Immediatamente al di sotto del testo costituzionale, ad un livello che sem-bra avere una forza giuridica quasi identica, viene collocata la Convenzioneeuropea dei diritti dell ’uomo che, secondo l’art. 17, 2 comma, costituisce ilminimo di tutela garantita, invalicabile dalle leggi che stabiliscono limitazionialle liberta ed ai diritti fondamentali dell ’uomo.
Il gradino inferiore nella gerarchia delle fonti (ma para-costituzionale)viene occupato dagli accordi internazionali (artt. 116, 117, 2 comma, 121) inapplicazione dell’art. 5, dove si afferma il principio relativo ai rapporti conl’ordinamento internazionale.
Tali accordi possono essere resi esecutivi con legge ovvero con regola-mento.
Nel primo caso, ai sensi dell’art. 122, 2 comma, l’accordo internazionaleprevale sulle leggi e, quindi, si colloca in una posizione gerarchica sovraordi-nata.
La chiarificazione costituzionale su tale priorita supera i dubbi che, in altriordinamenti, hanno determinato equivoci in merito all’effettiva vigenza degliaccordi internazionali ed alla loro reale efficacia rispetto anche alle volontapolitiche transeunti, espresse dalle diverse maggioranze che di volta in volta
2
si formano.Posizione analoga agli accordi internazionali viene assegnata, ai sensi
dell’art. 122, alle norme emanate dalle organizzazioni internazionali che sianostate previste in un accordo ratificato (3 comma).
Una espressione piu di competenza, che non di sovraordinazione gerar-chica nel sistema delle fonti, si rintraccia negli accordi aventi carattere re-ligioso, ai sensi dell’art. 10,5 comma, il quale prevede accordi tra Stato ecomunita religiose.
Rispetto a quest’ordine gerarchico, delimitato in parte dalle ipotesi dicompetenze riservate ad alcuni atti normativi, si colloca con ruolo gerar-chicamente sovraordinato, ma caratterizzato da una specifica competenza eprocedura, la serie dei provvedimenti per l’emergenza di cui agli artt. 170 esegg. che, ai sensi dell’art. 175, durante lo stato di guerra o di emergenzapossono limitare anche alcuni diritti o liberta costituzionali.
Pertanto, trattasi di provvedimenti temporanei aventi anche efficacia lim-itativa della Costituzione oltre che di tutti gli altri atti normativi; in con-seguenza, essi ricevono collocazione gerarchica sovraordinata sia pure in virtudi una competenza specifica, in quanto la procedura e particolarmente rig-orosa e dettagliata essendo riservati, in questo caso, l’iniziativa al Consigliodei Ministri, la delibera all’Assemblea e l’intervento finale al Presidente dellaRepubblica.
Rispetto agli atti normativi ora indicati che si collocano immediatamenteal di sotto del livello costituzionale viene ad essere individuato il livello delleleggi, all’interno del quale sono stabilite alcune distinzioni.
Ai sensi dell’art. 81, 2 comma, vengono individuate le leggi rinforzateper effetto della maggioranza qualificata dei tre quinti che e richiesta perla loro approvazione; altre leggi rinforzate sono: a) quelle che comportanoaumento di spesa o diminuzione di entrate (art. 82, 2 e 3 comma), stantela previsione di procedibilita; b) quelle che autorizzano l’ingresso di forzearmate straniere (art. 12, 3 comma); c) quelle che delegano compiti stataliagli organi internazionali (art. 123,2 comma); queste ultime devono essereapprovate dalla maggioranza dei componenti dell’ Assemblea.
Le altre leggi, normali, sono disciplinate dagli artt. 82 e segg. e sonosuscettibili anche di essere approvate, oltre che con maggioranza non qual-ificata, anche con procedure accelerate (art. 83); rispetto a tutte le leggi eprevisto il rinvio per riesame da parte del Presidente della Repubblica (art.85).
A livello di forza di legge si collocano sia le decisioni della Corte Costi-tuzionale (art. 132, 3 comma) che dichiarano illegittime le leggi, sia i refer-endum abrogativi (art. 150).
Nel livello immediatamente inferiore a quello legislativo e prevista una
3
pluralita di atti che, anche essi, sono gerarchicamente collocati; non vannoinclusi in tale livello gli altri atti aventi forza di legge (come i decreti legge)consentiti dall’ art. 101, che hanno pari efficacia rispetto alle leggi. Non eprevista, inoltre, la delegazione legislativa.
Gli atti normativi del Consiglio dei Ministri (art. 116) possono avereefficacia di forza di legge (art. 101 ora ricordato) e valore regolamentare (art.119) e possono distinguersi in atti aventi efficacia esterna ovvero in atti aventiefficacia interna (art. 119, 1 comma). Al di sotto di questi atti normatividel Consiglio dei Ministri si collocano anche gli atti dei Ministri (art. 102, 4comma, e art. 116, 3 comma) e poi i regolamenti ed i decreti degli Istituticentrali e del Primo Ministro (art. 119, 1 comma, e art. 102, 3 comma).
Va segnalato, a proposito di tali regolamenti e decreti, l’obbligo di osser-vare il principio di legalita (art. 119, 3 comma) nel senso che essi devonoavere fondamento in atti che hanno forza giuridica generale e cioe nelle leggi.
Il principio di legalita, peraltro, e affermato chiaramente per tutti gli attisubordinati alla eggedall′art.118, 2comma, cheprevedeunaspecificaautorizzazioneperl′adozioneditaliatti; ovviamenteautorizzazionegenerale; sicchequestiattinormativihannovaloreesecutivorispettoalleleggi.
In via ulteriormente subordinata vi sono gli atti degli organi dirigentidelle Istituzioni centrali; alcuni appartenenti alla Corte costituzionale, alConsiglio Superiore della Magistratura, alla Corte dei conti ed al Consiglio diSicurezza che riguardano i regolamenti interni e che configurano una riservadi competenza (non potendo il legislatore intervenire all’interno di questiorganismi) ed altri invece riferiti agli organi centrali dello Stato, sempre chesiano previsti da una legge.
Altra serie di fonti normative (che si collocano sotto alcuni aspetti inposizione parallela rispetto alle leggi e sotto altri profili in sede subordi-nata) e costituita dagli atti degli enti locali (art. 116, 2 comma, 120 per lenorme regionali); sono le ordinanze e i decreti circoscrizionali (cioe region-ali) previsti dall’art. 110,4 comma; ovvero i regolamenti di organizzazionee funzionamento previsti dall’art. 113, l comma; ovvero le ordinanze e ledecisioni previste dall’art. 113, 2 comma. Questi atti, ai sensi dell’ art. 117,2 comma, oltre ad avere un limite territoriale di applicazione, hanno forzadi legge entro l’ambito territoriale specifico, sicche si pone il problema dellaloro compatibilita con le leggi statali; poiche, tuttavia, non vi e uno speci-fico riparto di competenze tra gli organi centrali e gli organi locali in ordinea specifiche materie, ma solo, con riguardo alle esigenze determinate dallalegge per le necessita locali (art. 108,2 comma), si deve ritenere che taliatti normativi, salvo che per le materie di cui all’ art.113 concernenti i pro-fili squisitamente locali ed organizzativi interni, debbano restare subordinatisolo alle leggi dello Stato e non agli atti normativi del Governo, del Consigliodei Ministri o dei Ministri o degli organi centrali.
Il sistema delle fonti normative ora descritto esprime un riparto di poteri
4
tra organi centrali e organi locali, tra poteri internazionali e poteri interni,tra governo centrale e governo locale, che si proietta nel sistema descritto.
Il criterio di chiusura e la parola definitiva su tale sistema normativo esulla sua riconducibilita ”ad unum” si ritrova nell’art. 131 ed il compito diunificazione e di uniformita viene assegnato alla Corte costituzionale dall’art.131lett. a), b), c) e d), nei quali si prevedono i poteri di eliminazione delleincompatibilita degli atti normativi per violazione del principio di gerarchiaovvero del principio di competenza.
3 3. Rinvii alla legge e riserve di legge
La tecnica redazionale seguita per il testo della Costituzione pennette dicogliere due distinte tendenze nel richiamo alle fonti legislative che vieneeffettuato nelle disposizioni costituzionali.
In alcuni casi si tratta di vera e propria riserva e cioe si configura un mec-canismo di garanzia che assegna solo alla competenza legislativa la disciplinadi specifici oggetti costituzionali, con particolare riguardo ai diritti ed alleliberta.
Viceversa, in altri casi, il richiamo costituisce un mero rinvio alla potestalegislativa con la conseguenza che le leggi, richiamate, hanno rilevanza costi-tuzionale, avendo funzione integrativa della nonnativa dettata dalla Carta.
Le riserve di legge, peraltro, talvolta sono anche assolute e rinforzatequando in esse e previsto un contenuto specifico della legge senza discrezion-alita del legislatore sul punto; in altri casi trattasi di riserva semplice con meraattribuzione al potere legislativo della disciplina a fini di garanzia dell’oggettoda tutelare.
La principale riserva di legge con funzioni di garanzia ed avente naturaassoluta e rinforzata si rinviene nell’art. 17 e riguarda le limitazioni deidiritti e delle liberta; limitazioni che possono aversi solo in relazione ad uninteresse pubblico o alla tutela dei diritti dei terzi e comunque con il criteriodi proporzionalita, senza incrinare l’essenza di tali diritti e senza eccedere ilimiti previsti dalla Convenzione europea per i diritti dell ’uomo. Anche peril principio di eguaglianza le discriminazioni devono trovare fondamento inun motivo obiettivo riconosciuto dalla legge (art. 18, 3 comma).
Il diritto alla vita (art. 21) deve costituire oggetto di tutela da parte dellalegge.
Anche per il diritto all’infonnazione si riscontra una riserva di legge perquanto riguarda l’attivita degli organi statali e delle persone che esercitanole funzioni statali (art. 23).
Sulla liberta personale si riscontrano due riserve di legge, una nell’art. 27,
5
primo comma, che e assoluta e rinforzata, e l’altra nell’art. 28, terzo comma,che riguarda il diritto al giudizio o al rilascio del detenuto.
Nell’art. 34 vi e la garanzia della riserva di legge con riguardo al principiodel ne bis in idem.
La privacy, garantita dall’art. 35, viene fatta oggetto di tutela con riservadi legge relativa alla raccolta, all’uso ed alla diffusione dei dati personali.
Anche la liberta di domicilio (art. 37), viene garantita da una riservaassoluta e rinforzata (2 comma).
Nell’art. 41 la tutela della proprieta privata viene garantita anche at-traverso la riserva di legge in materia di espropriazioni e di limitazioni chedevono essere previste solo per casi di pubblica utilita.
Anche il diritto di difesa, garantito dall’art. 42, unitamente al prin-cipio del giusto processo, viene arricchito da una riserva di legge assolutariguardante la previsione di tribunali indipendenti e neutri.
Nell’ambito delle liberta e dei diritti politici la riserva di legge opera,nell’art. 46, con riferimento alle associazioni ed alle riunioni, cosı anche nell’art. 47, con riguardo ai gruppi pacifici e senz’ armi.
Per le petizioni e gli appelli agli organi pubblici la legge garantisce terminie condizioni (art. 48).
L’art.54 prevede la riserva di legge assoluta per assicurare una protezioneparticolare ai minorenni, ai giovani ed alle donne in stato interessante e allemadri giovani; mentre per l’assistenza sanitaria si ha una riserva semplice(art. 55).
L’autonomia universitaria e la liberta accademica vengono garantite conriserva assoluta (art. 57); in materia di obiettivi sociali e di diritti sociali vie anche una riserva di legge assoluta e rinforzata sulle condizioni e la misuradella realizzazione degli obiettivi stessi.
Ugualmente assoluta e rinforzata e la riserva di legge elettorale di cuiall’art. 68.
Nelle parti relative alla organizzazione dello Stato (quindi dalla parteterza sino alla fine) non vi sono riserve di legge, salvo il caso delle garanziesulla nomina, le funzioni ed il trattamento giuridico degli impiegati di cuial 3 comma dell’art. 107, che sono affidate alla legge, la quale, pertanto,assume funzione di richiamo avente natura di riserva escludente, su tali temi,l’iI1fervento di altri atti normativi e comunque dell’esecutivo o di altri organidello Stato o degli enti locali.
Nelle parti che vanno dalla terza sino alla [me il richiamo alle leggi assumeuna funzione di rinvio per integrazione del contenuto normativo; anche nellaseconda parte relativa ai diritti ed alle liberta vi sono casi di mero rinvio,come nell’art.19 in materia di cittadinanza; nell’art. 39 sull’ l’espulsionedegli stranieri; nell’ art. 40 sul diritto di asilo agli stranieri; nell’art. 52
6
sulle assicurazioni e sull’ assistenza sociale; nell’art. 53 sul matrimonio e suldivorzio; nell’art. 57 sull’istruzione scolastica obbliga toria e sulle scuole nonpubbliche; nell’art. 58 sul diritto di autore, nonche nell’ art. 60 riguardantel’avvocato del popolo a proposito del bilancio di sua competenza (30 comma).
Nelle parti successive alla seconda i rinvii non sono numerosi ma hannola funzione di integrare il testo con richiami ad una normativa dal contenutovariabile, essendovi la discrezionalita del legislatore.
CosI, secondo l’art. 69 l’ ineleggibilita degli alti funzionari e previstadalla legge; nell’art. 70, i casi di incompatibilita sono stabiliti dalla legge;nell’art. 77 le procedure cui devono attenersi le commissioni d’inchiesta sonodisciplinate dalla legge; nell’art. 80, i casi in cui sussiste l’obbligo dei dirigentidi fornire chiarimenti alle commissioni parlamentari sono determinati conlegge; nell’ art. 92, la concessione dei piu alti gradi da parte del Presidentedella Repubblica e la nomina dei presidente delle accademie delle scienze edei rettori delle universita sono previste dalla legge; secondo l’art. 94 la leggepuo integrare le competenze del Presidente della Repubblica; nell’ art. 107la disciplina dei concorsi e affidata alla legge.
Per il governo locale la legge disciplina altri eventuali organismi (art.108); stabilisce il riparto tra i vari enti locali delle funzioni di autogoverno,disciplina il referendum locale (commi 30 e 40); l’art. 111 rinvia alla legge ladisciplina sul bilancio degli enti locali; l’art. 113 rinvia alla legge la norma-tiva sulle tasse locali e sui principi relativi all’organizzazioneed al funzionz-mento degli enti locali,nonche sull’iniziativa presso gli organi previsti dallalegge;l’art.114 rinvia alla legge per le competenze del Prefetto che viene is-tituito in ogni circoscrizione (cioe in quegli enti che configurano le regionidell’Albania).
L’art. 117 rinvia alla legge per la promulgazione e la pubblicazione degliatti normativi e per quelle degli accordi; internazionali; l’art.118 rinvia allalegge per la disciplina sugli atti normativi subordinati alla legge e l’art. 120rinvia alla legge per la disciplina degli atti giuridici regionali.
Nella parte concernente la Corte costituzionale il rinvio alla legge riguardasolo le procedure di rinnova della sua composizione (art.125); nella parteconcernente la magistratura;l’art135 rınvia alla legge per la istituzione degliorgani giudiziari; l’art. 136 richiama la legge per le condizioni e le proceduredi nomina dei giudici.
L’art. 145 lascia alla legge di determinare le responsabilita di chi inter-ferisce nelle funzioni della magistratura; nell’ art. 144 la legge si occupa delbilancio delle Corti; l’art. 147 affida alla legge la disciplina dei trasferimentie dei provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati; per il Pubblico Minis-tero la legge viene richiamata per l’affidamento di altre funzioni oltre quelledi accusa.
7
L’art. 150 stabilisce che sia la legge a disciplinare principi e procedureper i referendum; l’art. 154 rinvia alla legge la normativa sul rinnovo dellacommissione centrale delle elezioni.
Nella parte concernente le finanze pubbliche la legge viene richiamata perle indicazioni delle tasse e delle imposte, dello sgravio o dell’esonero; talerinvio, sotto alcuni profili, costituisce anche una riserva di legge nella misurain cui sottrae ad altre autorita la disciplina dei prelievi fiscali; nell’art. 157 letasse e le imposte locali sono disciplinate dalla legge e nell’art. 159 il bilanciostatale viene disciplinato dalla legge.
Anche nella parte XV, relativa alle forze armate, vi sono rinvii alla leggeper quanto attiene sia al servizio militare che al servizio alternativo (art.166); ugualmente la legge assume funzione integrativa, nell’art. 169, perquanto riguarda le competenze del Presidente della Repubblica rispetto alleforze armate.
I provvedimenti di emergenza, previsti nella parte XVI dall’art. 170,rinviano alla legge per i principi, i settori e i modi di indennizzo connessi allelimitazioni dei diritti,causate dai provvedimenti di emergenza.
4 4. Forma di governo parlamentare; rapp-
resentanza e fiducia
La rassegna ora esposta della diversa tecnica di richiamo delle competenzelegislative si ricollega al Sistema delle fonti normative, che si e descritto inprecedenza e che caratterizza l’articolazione dei poteri anche se in un disegnocoordinato con prevalenza del ruolo centralistico.
La traduzione del quadro delle fonti normative, dei rinvii e delle riservedi legge, in termini di distribuzione ed articolazione dei poteri dell’ organiz-zazione costituzionale, si puo cogliere esaminando gli organi costituzionalifacenti capo alla tradizionale ripartizione dei poteri in connessione con gli al-tri organi costituzionali che integrano il quadro di riferimento, avendo alcunepeculiarita specifiche che permettono di sottolineare il significato storico dialcune disposizioni e le situazioni di contingenza che hanno caratterizzatol’evoluzione costituzionale.
Il quadro delle fonti e dei poteri normativi si radica in un’organizzazionecostituzionale che presenta profili di pluralismo istituzionale e politico, oltreche aspetti di suddivisione nei tradizionali poteri con un pluralismo di organie di competenze.
Vi e, pero, una serie di intrecci e collegamenti che pone il sistema costi-tuzionale in una situazione di continua verificabilita dell’ equilibrio politico,
8
che ispira la presenza dei rappresentanti del popolo in Parlamento e, perproiezione, in tutti gli altri organi costituzionali.
Trattasi di una forma di governo parlamentare, perche il Governo edil Parlamento sono legati da un rapporto di fiducia ed il Presidente dellaRepubblica e un organo costituzionale distinto dal Governo.
Il Parlamento dura in carica 4 anni (art. 65), mentre il Presidente dellaRepubblica dura in carica 5 anni (art. 88, Io comma) ed il Governo (il Con-siglio dei Ministri) dura in carica sino a quando non viene sostituito da unaltro Governo dotato di fiducia da parte del Parlamento (artt. 95 ss.). Inquesta scansione temporale si inseriscono i circuiti di consenso politico. Ilcircuito piu lungo e quello costituzionale previsto dagli artt. 87 e 88; questiconcernono il periodo di durata del Presidente della Repubblica; nell’art. 87,invero, vi e un meccanismo di elezione che puo determinare lo scioglimentodell’ assemblea parlamentare e, pertanto, fare riaprire un nuovo ciclo di rap-presentativita (che puo definirsi elettorale); il Presidente della Repubblica,pero, puo anche essere rieletto ed in questo caso il circuito costituzionale(diverso da quello rappresentativo), che parte dalla elezione del Presidentedella Repubblica e finisce con la sua cessazione senza possibilita di rielezione,dura normalmente 1O anni.
Si inserisce, nell’ambito del periodo presidenziale (circuito costituzionale),il circuito elettorale rappresentativo (quadriennale) del Parlamento previstodall’art. 65.
Su tale circuito elettorale e sul suo termine [male influiscono sia l’art. 87,che prevede lo scioglimento dell’Assemblea nel caso di incapacita di eleggereil Presidente della Repubblica, sia gli artt. 96, 104 e 105 che concernono ilrapporto di fiducia con il Governo e l’impossibilita di rieleggere un nuovoGoverno (con scioglimento parlamentare).
Il circuito politico specifico, che riguarda invece il rapporto fiduciarioParlamento - Governo, trova disciplina nell’ art. 96, secondo il canone classicodella forma di Governo parlamentare, con la nomina del Primo Ministro daparte del Presidente della Repubblica su indicazione dei partiti che esprimonola maggioranza in Parlamento (art. 96, Io comma); vi e pero il meccanismocorrettivo dello scioglimento dell’Assemblea qualora non venga approvatala nomina del Primo Ministro, ovvero (art.104 e 105) non venga approvatala mozione di fiducia presentata dal Primo Ministro, o (art. 105) vengaapprovata la mozione di sfiducia e non venga eletto un altro Primo Ministro.
Il circuito politico (fondato sulla fiducia) e caratterizzato dal criterio dicontinuita senza diaframmi interruttivi, perche, anche se non e prevista unasfiducia costruttiva, tuttavia e necessario che il Parlamento consenta la nom-ina ed il funzionamento di un nuovo Governo; in tal modo il ciclo elettoralerappresentativo permane fermo, solo se e quando esso mostri la sua capacita
9
di tenere in vita un circuito politico di fiducia tra Parlamento e Governo.Come si puo notare le disfunzioni concernenti il meccanismo elettorale
del Presidente della Repubblica ovvero i meccanismi di nomina e di fiduciadel Governo hanno effetti sulle tornate elettorali.
5 5. Connessioni tra gli organi costituzionali
- il Presidente della Repubblica
I tre organi costituzionali collegati dal meccanismo parlamentare: Parla-mento, Presidente della Repubblica e Consiglio dei Ministri hanno anchealtri canali di collegamento, tra di loro, che emergono in particolare nelladisciplina delle norme finanziarie di cui alla parte XIII e nei provvedimentidi emergenza di cui alla parte XVI della Costituzione; infatti nell’art. 158l’iniziativa per il bilancio appartiene al Consiglio dei Ministri e l’Assembleasi trova in condizioni di particolare collegamento con il Governo; ugualmenteper i provvedimenti di emergenza vi e una stretta connessione tra Presidentedella Repubblica, Consiglio dei Ministri e Assemblea, sia per l’adozione deiprovvedimenti dello stato di guerra o di emergenza sia per l’intervento delleforze armate.
Il Presidente della Repubblica, in questo disegno parlamentare, ha fun-zioni di iniziativa, di garanzia degli equilibri ed e titolare di specifici po-teri propri che lo collocano in condizione particolarmente significativa conriguardo, non tanto al Consiglio dei Ministri che egli nomina o al Parlamentoche, a certe condizioni, egli puo sciogliere, quanto con riferimento alla Mag-istratura, in quanto nomina i componenti della Corte Suprema (art. 136)e presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 147). Propone ilPresidente della Corte dei conti (art. 162); e Comandante delle Forze Armate(art. 168); propone lo stato di guerra (art. 171) ed emana il relativo decreto(art. 172); indice il referendum (art. 150) e promulga le leggi approvatecon il referendum (art. 151); nomina il Procuratore Generale (art. 149);dichiara decaduti i soggetti che egli concorre a nominare, con particolareprocedura; nomina i componenti della Corte costituzionale previo consensodell’ Assemblea.
Si tratta di poteri, indicati nelle diverse disposizioni i quali, esaminati con-giuntamente a quelli elencati nell’ art. 92, mostrano un ruolo del Presidenteche, secondo la personalita che ricopre la carica, puo determinare conno-tazioni presidenziali del sistema, che pure e dichiaratamente parlamentare.
Tale riflessione si ricollega, in particolare, alla connessione che viene sta-bilita tra l’elezione del Presidente della Repubblica e l’eventuale scioglimento
10
dell’ Assemblea che non riesca ad eleggerlo.I tre poteri tradizionali sono circondati da altri organi costituzionali come
la Commissione centrale delle elezioni (parte XII), la Corte dei conti (parteXIV), le Forze Armate con il Consiglio di Sicurezza Nazionale (art. 168). Taliorgani costituzionali completano il quadro di riparto dei poteri di vertice, purse non mancano aspetti di una subordinazione di essi (che contrastano conil profilo di livello costituzionale loro assegnato).
6 6. Magistrati e Pubblico Ministero
L’organizzazione costituzionale si eompleta con la disciplina della Magis-tratura e del Pubblico Ministero, che e contenuta nella parte IX e che at-tribuisce particolari garanzie ai componenti della Corte Suprema ed ai magis-trati in genere; la Costituzione distingue i magistrati del Pubblico Ministerodagli organi aventi potere giurisdizionale; non li inserisce tra i soggetti cheesercitano la funzione giurisdizionale, ma precisa chiaramente che trattasidi un organo avente solo la funzione di accusa (art. 148) e che viene orga-nizzato in maniera distinta dalla Magistratura; il Procuratore Generale e iprocuratori vengono nominati (art. 149) dal Presidente della Repubblica e daesso revocati, rispettivamente, su proposta dell’ Assemblea o del procuratoregenerale.
Vi e una forma di garanzia in tale disegno, atteso che i pubblici minis-teri costituiscono un organo centrale dello Stato che opera presso il sistemagiudiziario (art. 148); vi e tuttavia l’influenza (anche se indiretta) dell’ el-emento politico, stante il potere di dichiarare la decadenza del ProcuratoreGenerale su proposta dell’Assemblea ed anche dei singoli procuratori su pro-posta del Procuratore Generale (legato istituzionalmente al Presidente dellaRepubblica).
Il Presidente della Repubblica, con tali poteri, acquisisce un ruolo deci-sivo nel sistema costituzionale, specie se si ritiene che egli non sia obbligato adichiarare la decadenza a seguito delle proposte dell’ Assemblea o del Procu-ratore Generale.
Su tali profili sara la prassi costituzionale a chiarire il vero senso delladisciplina in esame.
7 7. Le autonomie locali
Il sistema di articolazione del potere politico sul piano territoriale viene ri-conosciuto nella parte concernente il governo locale (parte VI).
11
Si prevedono Comuni, Municipi e Circoscrizioni; queste ultime sono,praticamente, le Regioni (art. 108). Si stabiliscono gli organi rappresenta-tivi ed esecutivi di tali enti locali (art. 109), fissando competenze non moltoampie che caratterizzano una sfera di autogoverno attribuita in relazione allenecessita, agli interessi comuni ed economici nonche alla tradizione storica(art. 108, 2 comma); le funzioni di auto governo sono esercitate sia attraversoorgani rappresentativi che tramite il referendum (art. 108,4 comma).
Agli enti locali possono essere delegate competenze statali e sono attribuititributi in conformita alla legge, avendo un bilancio indipendente (artt. 111-112).
Il Governo ha il potere di nominare un Prefetto della circoscrizione edisciogliere gli organi elettivi (art. 114), con possibilita per questi di ricorsoalla Corte Costituzionale (art. 115).
L’autonomia locale e caratterizzata da democrazia rappresentativa e democraziadiretta; sotto questo profilo il disegno e coerente con quello dell’organizzazionecentrale che viene a risentire gli effetti della democrazia diretta, in quanto eprevisto sia il referendum abrogativo che quello consultivo e propositivo (art.150) con previsione costituzionale dei limiti di ammissibilita del referendumstesso (art. 151).
8 8. I diritti e le liberta fondamentali - l’avvocato
del popolo
In questo quadro di fonti normative, di organizzazione costituzionale, di au-tonomie locali e di democrazia diretta si collocano le liberta e i diritti fon-damentali dell’uomo disciplinati nella seconda parte e che costituiscono uninsieme di situazioni soggettive alle quali si affiancano altre pretese, non gius-tiziabili, connesse agli obiettivi sociali di cui al titolo V della parte seconda(art. 59).
Per questi ultimi si tratta dei diritti sociali con la precisazione che pero,in base all’art. 59, comma 2, il conseguimento degli obiettivi sociali non puoessere chiesto direttamente ai tribunali.
Tutta la sfera delle situazioni giuridiche soggettive viene affidata alladifesa o vigilanza dell’avvocato del popolo (una specie di ombudsman).
Trattasi di sistema di liberta che viene dichiarato strettamente connessoalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la quale costituisce il parametrominimo di tutela che non puo essere in alcun modo incrinato dai limiti che,per ogni diritto, potrebbe fissare la legge o la costituzione.
Tutti questi diritti vengono indirizzati da una serie di principi generali,
12
differenti dai principi fondamentali contenuti nella prima parte (concernentila sovranita, le norme di diritto internazionale, la forma di governo, i dirittidegli albanesi, i partiti politici, la neutralita religiosa della Repubblica, ilsistema economico, il principio dell’autonomia locale, la lingua ufficiale); iprincipi generali, infatti, stabiliscono i caratteri dei diritti e delle libertafondamentali, la loro appartenenza, la disciplina dei limiti, il principio dieguaglianza, la cittadinanza e la tutela delle minoranze.
Nel titolo secondo, la liberta e i diritti personali prendono le mosse daldiritto alla vita (art. 21); vengono garantiti la liberta di espressione (art.22), il diritto all’informazione (art. 23), la liberta di coscienza e di religione(art. 24); la garanzia si sofferma poi su una serie di articoli, dal 25 al 35,che concernono la liberta personale in senso stretto e tutti i profili delladetenzione, del processo, dei diritti dell’imputato; essi mostrano l’esigenzastorica di condannare gli abusi nella materia penale, con la storicizzazione diun fenomeno passato che, evidentemente, ha fatto largo ed ingiustificato usodei mezzi penali.
Al complesso di norme sulla liberta personale, la carcerazione, il processopenale, si aggiungono le norme sulla liberta e segretezza della corrispondenza,del domicilio e della residenza, del diritto di espatrio (artt. 36-40).
Nell’art. 41 viene disciplinata la proprieta, mentre negli artt. 42 e 43 vie la disciplina del diritto di difesa giudiziaria.
Il titolo In sulle liberta e i diritti politici si articola nel diritto di voto(art. 45), nel diritto di associazione e di riunione (art. 46), nella liberta deigruppi (art. 47) e nel diritto di petizione e di appello agli organi istituzionali(art. 48).
Le liberta e i diritti economici, sociali e culturali (del titolo IV) arti-colano un sistema che, prendendo le mosse dal diritto al lavoro (art. 49)e dall’acquisizione delle risorse necessarie al proprio sostentamento, tutelai sindacati (art. 50), lo sciopero (art. 51), prevedendo l’assicurazione el’assistenza sociale (art. 52). Particolare attenzione, nell’art.53, viene asseg-nata al matrimonio e alla famiglia che godono di un riguardo dallo Stato,anche se viene ammesso il divorzio.
La tutela dei minori (art. 54) e l’assistenza sanitaria (art. 55) completanoil quadro, unitamente al diritto all’informazione sulla tutela ambientale (art.56) ed al diritto all’istruzione (art. 57).
Particolare protezione viene assicurata ai minorenni, ai giovani ed allemadri giovani (art. 54) e l’assistenza sanitaria e sociale configurano un ri-conoscimento costituzionale mediato dalla riserva di legge.
Anche il diritto all’informazione riguardo all’ambiente ed alla sua pro-tezione rientra nel quadro di tutela economico e sociale.
Sotto il profilo che puo defmirsi come caratterizzante lo Stato di cultura,
13
l’art. 57 riconosce il diritto all’istruzione, l’obbligatorieta dell’istruzione sco-lastica ed infme l’autonomia delle istituzioni di alto livello che si pone unita-mente alla liberta di espressione artistica e di ricerca scientifica (art. 58).
I diritti sociali specificamente indicati nel titolo IV hanno carattere digiustiziabilita, se si interpreta sistematicamente il complesso di tali dispo-sizioni in relazione al 2 comma dell’art. 59 concernente gli obiettivi sociali,laddove si stabilisce che il conseguimento di tali obiettivi (i quali, in alcuniordinamenti, costituiscono oggetto dei diritti sociali) non puo essere chiestoai tribunali. In ogni caso lo Stato si pone obiettivi di miglioramento del liv-ello sociale del Paese (art. 59) prevedendo anche condizioni e misure, rinviatealle determinazioni di legge, per realizzare tali obiettivi.
La serie delle situazioni giuridiche soggettive costituzionali che configuradiritti, liberta ed interessi legittimi viene ad essere oggetto di difesa da partedi una specie di ombudsman e cioe l’avvocato del popolo disciplinato neltitolo VI.
Si tratta di organo indipendente con poteri di istruttoria, di informazionee sollecitazione dei provvedimenti dell’Amministrazione.
9 9. Le garanzie costituzionali - la Corte cos-
tituzionale
Il disegno costituzionale si articola in un sistema relativo agli organi ed aipoteri configurabile come Stato-apparato rispetto al quale lo Statocomunita(identificato in tutto il popolo con le sue articolazioni ed autonomie) si apresia sul piano territoriale attraverso municipi, comuni e circoscrizioni, sia sulpiano delle formazioni sociali attraverso partiti, sindacati, gruppi, associ-azioni e confessioni religiose, famiglia, sia attraverso il riconoscimento di sin-goli diritti di liberta civile, economica, sociale e politica.
Nell’equilibrio che si determina tra l’esercizio dei poteri pubblici e lagaranzia dei diritti costituzionali delle persone, si inserisce il profilo riguardantela garanzia costituzionale che si rinviene non solo nel carattere rigido dellaCostituzione riveniente dalla parte xvn che disciplina la revisione, ma anchein tutte le riserve di legge che hanno funzione garantistica e soprattutto nelruolo particolarmente significativo assegnato alla Corte costituzionale dotatadi ampie competenze che si estendono dai profili di illegittimita ed incosti-tuzionalita concernenti gli atti normativi (art. 131 lett. a, b, c) ai profiliriguardanti il ruolo e le funzioni dei soggetti costituzionali (art, 1311ett. d,e, f, g) con riguardo ai conflitti di attribuzione, alla costituzionalita dei par-titi, alla decadenza del Presidente della Repubblica, alla sua eleggibilita ed
14
incompatibilita. Ma la competenza della Corte si riferiscono anche al refer-endum ed alla sua ammissibilita (art. 131, letto h) ed infine vi e la possibilitadi ricorso diretto (tipico di alcuni ordinamenti latini) riconosciuto alle per-sone fisiche per violazione dei diritti costituzionali allorche siano stati esaurititutti i mezzi giudiziari approntati per la tutela di questi diritti.
La Corte costituzionale, peraltro, interviene sempre su richiesta di unsoggetto legittimato (come stabilisce l’art. 134).
Si tratta, quindi, di un organo che deve assicurare nella sua interpre-tazione, che viene considerata definitiva (art. 124, Io comma), la funzionalitaed efficienza del sistema costituzionale, eliminando con i suoi interventi le pa-tologie che creano squilibrio sia nel profilo della gerarchia delle fonti, sia nelladistribuzione dei poteri, sia nell’ effettivo spazio delle liberta delle persone edelle forze politiche, economiche e sociali, in un contesto di dichiarata tuteladei diritti e delle liberta fondamentali dell’uomo, rispetto ai quali la Con-venzione europea dei diritti dell’uomo rappresenta il parametro di garanziaminima che viene assicurata all’interno dell’ ordinamento albanese.
CAPITOLO SECONDO-LA NUOVA COSTI-
TUZIONE DELLA REPUBBLICA ALBANESE
10 1. I precedenti progetti di riforma nell’ultimo
decennio
L’attuale Costituzione della Repubblica albanese e il frutto di untravaglioiniziato subito dopo la caduta del regime comunista
Il progetto di una nuova costituzione, adeguata ai tempi odierni ed inlinea con quella delle grandi democrazie occidentali, parte dal 1990.
In quell’anno si inizio una prima stesura del progetto, interrotta per il rin-novo del Parlamento, e riproposta al nuovo Parlamento, uscito dalle elezionidel 1991, nel quale per la prima volta erano presenti i partjti politici.
Da quella data e fino al 1994 furono approvate varie leggi fondamentali diriordino dello Stato, sia riguardo al riconoscimento dei diritti e delle libertafondamentali dei cittadini, sia riguardo alla riorganizzazione della giustiziaed all’allineamento dell’Albania nel contesto internazionale.
In particolare nel febbraio del 1991 fu pubblicato un progetto di Costi-tuzione, approvato solo parzialmente nel successivo mese di aprile, per quelloche concerneva i principi generali, il Parlamento, il Presidente della repub-blica ed il Consiglio dei Ministri. Altri titoli si aggiunsero in un secondomomento.
15
Le dispute tra maggioranza ed opposizione che si incentrano soprattuttosulla individuazione dei poteri da concedere al Presidente della Repubblica,impedirono di arrivare ad un testo organico e completo, del quale, tuttavia,si avvertiva una stringata necessita.
In tale clima di aspettativa costituzionale si inquadra il tenativo operatonel 1994 dal Governo di far approvare la nuova costituzione da un’ Assem-blea non eletta dal popolo ma espresione della maggioranza parlamentare.Di fronte alla decisa opposizione sociale che si sollevo avverso una proce-dura che si avvertiva palesemnte contraria ai principi del costituzionalismodemocrativo, si ritenne di sottoporre il progetto di nuova costituzione ad unreferendum approvativo, il cui esito risulto negativo.
Ne seguı una situazione convulsa che vide il tentativo di un progettoalternativo, nel 1995, ad opera di quattro partiti dell’opposizione di allora.
Formatosi il nuovo Parlamento, nel 1997, si e dato vita ad un nuovo pro-getto di Costituzione, per il quale si e chiesta la collaborazione della ComunitaEuropea e, all’interno, si e tentato di coinvolgere tutte le forze politiche.
Licenziato da un’apposita commissione ed approvato dall’ Assemblea, iltesto della nuova Costituzione e stato sottoposto a referendum, nel novembredel 1998, che ha avuto esito favorevole.
11 2. Le aspirazioni di nuovo assetto costi-
tuzionale dagli inizi del secolo la Monar-
chia Zoghista
Dal novembre del 1998 l’Albania ha una Costituzione che la pone a pienodiritto tra i Paesi democratici ed accoglie le aspirazioni piu moderne delpopolo albanese.
Essa costituisce il punto di arrivo di una aspirazione che parte dal mo-mento dell’acquisizione dell’indipendenza da parte dello Stato Albanese. In-fatti subito dopo il riconoscimento della separazione dall ’Impero Ottomano,avvenuta nel 1912, si penso di dare un nuovo assetto costituzionale alloStato albanese. Da una commissione di controllo internazionale, formatadalle grandi potenze europee, fu predisposto uno Statuto organico dell’ Al-bania. Sotto la spinta dei movimenti costituzionali che avanzavano in tuttal’Europa, questo Statuto prefigurava l’Albania come Stato costituzionale, subase parlamentare; ma, a causa delle forti resistenze esercitate dai ”poteri”precostituiti, il Parlamento si vide privato, in concreto, della sua posizionecentrale nell’ assetto costituzionale, rimanendo attributario di un ruolo moltoridotto.
16
Le vicende della prima guerra mondiale, con l’invasione dell’Albania daparte degli eserciti stranieri, interruppero il processo che si era appena avvi-ato. Solo nel 1922 fu possibile rilanciare un nuovo progetto di costituzione,che prevedeva la nascita di una Monarchia parlamentare ispirata ai principidella divisione dei poteri. Questa nuova Costituzione ebbe breve durata,perche gia il2 marzo del 1925 venne sostituita dallo Statuto Fondamentaledella Repubblica di Albania, incentrato sui poteri del Capo dello Stato, capoanche del Governo e titolare dell’iniziativa legislativa. La forma prevista eraquella repubblicana. Poco dopo, nel settembre del 1928, Ahmet Zogu, cheguidava lo Stato dopo la vittoria interna (del 1924) contro le forze progressistedi Fan Noli, fece proclamare, da un’ Assemblea Costituzionale, la Monarchiae si fece eleggere Re degli Albanesi, come Zog I.
Da questo Statuto fondamentale e nata e si e sviluppa la costituzionedello Stato zoghista, che provvide all’approvazione di un nuovo Statuto fon-damentale del Regno albanese (entrato in vigore il 1 dicembre 1928).
I due Statuti, non molto lunghi, avevano preso a modello le costituzionidel tempo (belga, francese, svizzera, italiana, austriaca, bulgara). Lo Statutozoghista si era basato soprattutto sulla costituzione belga e solo in parte suquella italiana e bulgara. In esso, tuttavia, al Re venivano attribuiti poteridi gran lunga piti ampi di quelli riconosciuti ai Sovrani dalle costituzionieuropee del tempo. In particolare la concentrazione di poteri nelle mani delRe era vastissima, a spese del Parlamento e del Governo, fino al punto chel’iniziativa legislativa spettava al Re e non anche al Governo. Comunquesi distingueva tra Capo dello Stato (il Re) e Capo del Governo, un PrimoMinistro di nomina regale.
Nella costituzione zoghista non era lasciato nessuno spazio al plural-ismo politico: la formazione di partiti e di associazioni politiche era vi-etata, potendo costituire persino reato. Veniva riconosciuta formalmentel’indipendenza del potere giudiziario, che tuttavia era esercitato da giudicidi nomina regale.
La Monarchia si propose con carattere di laicita: percio, pur tutelandoed agevolando la famiglia, con successive leggi riconobbe il divorzio.
12 3. La Costituzione fascista e la successiva
Costituzione comunista
Durante la seconda guerra mondiale l’indipendenza dello Stato albanese fucompromessa dall’ occupazione straniera. L’annessione all’Italia comportol’applicazione della Costituzione fascista e, successivamente, dello stato di
17
occupazione da parte delle truppe naziste della Germania.La liberazione coincise con l’ affennazione del regime comunista. Il quale
provvide all’approvazione (marzo 1946) di una nuova Costituzione, totali-taria, statalista e monista.
In essa i poteri venivano accentrati nelle mani del Presidente, in cio, al dila della apparente rottura fonnale, non differenziandosi gran che da quantoprevisto dallo statuto zoghista, anch’esso, come si e detto, accentratore, perquello che concerneva i poteri del Capo dello Stato.
Questa Costituzione proclamava esplicitamente la necessita della dit-tatura del proletariato, la quale, nei fatti e di la dal riconoscimento mer-amente fonnale che pur conteneva, comportava una compressione dei dirittidi liberta. Lo Stato si professava ateo e, di conseguenza, vennero soppressetutte le fonne di culto e le istituzioni religiose furono abolite. Riconosciutoe proclamato il ruolo guida del partito comunista, erano vietati gli altri par-titi. Era abolita la proprieta privata e con essa le fonne di acquisizione etrasferimento, quali l’eredita e le donazioni, nonche parte delle obbligazioni.
La tutela dei lavoratori era demandata ad un sindacato unico. QuestaCostituzione aveva avuto come modelli di partenza le costituzioni iugoslavee sovietica, ma fu vissuta con maggiore rigidita di esse.
E da questa situazione che e partito il processo rifonnatore approdatoall’attuale Costituzione, la quale, pertanto, potra essere compresa nelle suevalenze storiche e nei suoi avanzamenti solo avendo presente il cammino fattoper pervenire al riconoscimento di principi e diritti soffocati per ben 45 anni.
13 4. Sovranita, eguaglianza, Stato di diritto,
diritti e liberta, l’avvocato del popolo, la
tutela dell’ ambiente
Possiamo ora, anche alla luce di queste osservazioni, mettere in evidenzaalcuni punti essenziali della nuova Costituzione.
Si riconosce che la sovranita appartiene al popolo che la esercita diret-tamente o tramite i proprio rappresentatnti, eletti a suffragio universale datutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta. La Repub-blica Albanese adotta il sistema parlamentare, ispirandosi al principio delladivisione dei poteri, proclamando esplicitamente il pluralismo, la convivenzareligiosa e la tutela delle minoranze. A fondamento del sistema giuridicosono posti i diritti e le liberta fondamentali dell’uomo, dei quali si dichiaraespressamente l’indivisibilita, l’inalienabilita e l’inviolabilita. Tali diritti sonoattribuiti anche agli apolidi ed agli stranieri.
18
In questo ambito viene recepito il principio dell’uguaglianza di fronte allalegge, senza alcuna discriminazione per sesso, razza, religione, etnia, lingua,opinioni politiche, religiose o filosofiche.
Significativa e la tutela del diritto alla vita e della vita della persona. Essasi salda con il riconoscimento delle liberta, ivi compresa quella di espressione,anche a mezzo stampa, radio e televisione. L’eventuale incriminazione deveavvenire in modo da garantire la difesa, nella forma pio completa, e comunquel’accusa deve basarsi sul rispetto del principio dell’irretroattivita della leggepenale.
Al cittadino e assicurata la segretezza della corrispondenza e l’inviolabilitadel domicilio, che puo essere stabilito liberamente nel luogo che si desideri.
Particolare attenzione viene posta al matrimonio ed alla famiglia; e co-munque ammesso il divorzio. Significativa e particolarmente avanzata e laparificazione dei figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati nel matrimonio.
Da sottolineare e il rilievo dato all’istruzione, per la quale a tutti si ri-conosce il diritto di accesso in base alle rispettive capacita. Tale norma ecertamente di tipo programmatico, ma ha notevoli risvolti precettivi, po-tendo condizionare la politica del Governo e delle Istituzioni formative.
Lo Stato viene chiaramente definito come uno Stato di diritto, nel qualeil diritto definisce e limita i compiti ed i poteri di tutti gli Organi operantiin Esso.
La Costituzione pone un’ attenzione particolare al perseguimento dell’identitae dell’unita del popolo albanese, sia dentro che fuori i confini nazionali.
I partiti politici sono liberi di organizzarsi, purche non istighino all’odioed alla violenza ed abbiano un sistema interno democratico: essi devonorendere pubblici i propri bilanci.
Riguardo alla religione la Repubblica si pone su un piano di laicita, chegarantisce la parita tra tutte le Comunita religiose, in una prospettiva diindipendenza e di collaborazione. Alle Cjmunita religiose viene riconosciutala personalita giuridica.
Viene sancito il diritto alla proprieta privata, con il conseguente riconosci-mento dell’eredita, delle obbligazioni e delle donazioni.
Per le forze armate, il cui ruolo fondamentale per l’indipendenza delPaese e posto in risalto, si sancisce l’assoluta neutralita rispetto alle questionipolitiche: per questo esse sono sottoposte all’autorita civile.
Il riconoscimento del diritto e della liberta di lavoro ed all’esercizio dellaprofessione e posto in grande rilievo ed accompagnato dal diritto all’organizzazionenei sindacati ed all’assistenza ed assicurazione sociale. E riconosciuto ildiritto di sciopero.
Innovazione importante e l’istituzione dell’avvocato del popolo che perseguela difesa del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Esso e
19
autonomo ed indipendente e viene eletto dall’ Assemblea legislativa, allaquale sottopone un rapporto annuale, riferisce se vi sia stata una richiestain tal senso da parte della stessa Assemblea o nei casi che ritenga parti-colarmente rilevanti, propone raccomandazioni o presenta provvedimenti atutela dei diritti e delle liberta violate dalla pubblica amministrazione. Quiva notato che il raccordo con gli interessi del popolo poteva, forse, esseremeglio assicurato dall’elezione diretta, perche non sempre i Deputati pos-sono interpretare gli interessi dei cittadini comuni, specie in una societa plu-ralista, qual e quella albanese, ed in una fase nella quale le trasformazionisocio-economiche possono essere influenzate da gruppi organizzati e capacidi influenzare lo stesso Parlamento.
Tra le innovazioni vi e anche l’attenzione alla tutela ambientale, fatta rien-trare tra i fini che lo Stato e tenuto a perseguire, insieme a quelli dell’occupazione,della salute e dell’istruzione. Sul punto il riconoscimento e piuttosto timidoed e limitante l’affidamento allo Stato della salvaguardia dell’ ambiente. Incompenso viene superata l’ottica di altre costituzioni che fanno rientrare laquestione dell’ambiente nell’ ambito della tutela della salute. Esplicitamentelo Stato e impegnato ad assicurare un ambiente salubre ed ecologicamenteadatto per la generazione di oggi e per la prossima e si fa riferimento allosfruttamento razionale dei boschi, delle acque, del verde e delle sorgenti nat-urali nell’ ambito dello sviluppo sostenibile, che concretizza uno dei concettipiu recenti in campo di tutela dell’ ambiente. Certo sarebbe stato auspica-bile una concezione meno amtropocentrica e piu biocentrica della questioneambientale, inserita tra i diritti fondamentali ed affidata, quanto ai mezzidi tutela, alla cura (anche) dell’avvocato del popolo e ad eventuali azionipopolari.
14 5. Potere legislativo ed esecutivo
Il potere legislativo si incentra sul Parlamento, monocamerale, eletto perquattro anni, cui spetta la funzione legislativa. Per la sua formazione vienericonosciuto il ruolo specifico dei partiti politici, in quanto solo ai partitipolitici spetta la designazione dei candidati da eleggere come deputati. Ilmandato non e vincolante. L’iniziativa legislativa spetta al Consiglio deiMinistri, a ciascun deputato e a ventimila elettori.
L’unita dello Stato e di indirizzo e assicurata dal Presidente della Re-pubblica, sui poteri del quale vi e stato un serrato dibattito. La disciplinaadottata sembra in parte mutuata dal sistema costituzionale italiano vigente,di cui condivide l’impostazione generale. La Costituzione albanse non con-figura quindi in modello presidenziale, al conrario pone al centro del sistema
20
il Parlamento, purtuttavia il Presidente della Repubblica ha molte possibilitadi incidere nella vita del Paese: spetta a lui la nomina del Primo Ministro,su indicazione del partito o della coalizione di partiti di maggioranza, chedeve riceve l’approvazione dell’ Assemblea. E lui a nominare, con il con-senso dell’ Assemblea legislativa, il Procuratore generale della Repubblica edi giudici della Corte costituzionale. L’effettiva incidenza del Presidente dellaRepubblica si vedra nel corso dell’ applicazione della Costituzione, nel qualeapparira chiaro quale peso Egli avra rispetto all’Assemblea e come il concorsodelle due volonta si andra ad articolare e combinare.
Spetta al Primo Ministro la formulazione del programma di Governo e laindicazione, al Presidente, dei Ministri, con i quali costituira il Consiglio deiMinistri, che stabilisce le difettive principali della politica generale statale.Il Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento. All’esigenza di garantirela governabilita anche quando dalle elezioni non vengono fuori maggioranzestabili, si e data una risposta peculiare: qualora l’ Assemblea non approvila nomina del Primo ministro il Presidente della Repubblica conferisce adaltri un nuovo indnico, se anche questi non dovesse raccogliere il consensoparlamentare, l’onere di designare il Primo ministro passa all’Assemblea;qualora non dovesse riuscire a farvi fronte essa verrebbe sciolta dal Presidentedella Repubblica. Si sono pertanto abbandonate altre strade, come quelladella sfiducia costruttiva, che pur erano state affacciate, perche si e preferitochiamare direttamente il popolo a pronunciarsi sulle prospettive di governodel Paese.
15 6. Potere giudiziario e Pubblico Ministero
Viene garantita l’indipendenza del potere giudiziario, organizzato autonoma-mente rispetto al potere esecutivo ed al Parlamento. L’indipendenza dellamagistratura e assicurata dall’esercizio della giurisdizione affidato’ alla CorteSuprema, alle Corti d’appello ed ai Tribunali di primo grado. La primaha giurisdizione propria (in unico grado) nonche in sede di impugnazione.Essa funge da Collegio giudicante per la messa in stato di accusa del Presi-dente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri o i singoliMinistri, dei deputati, dei giudici della Corte Suprema stessa e della CorteCostituzionale. A rafforzamento dell’indipendenza dei giudici viene istitu-ito il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente dellaRepubblica.
L’ufficio di pubblico ministero non rientra nella magistratura, poiche gliorgani preposti alla promozione dell’ azione penale sono organizzati a partenella Procuratoria. Essa esercita l’azione penale attraverso i pubblici min-
21
isteri e rappresenta in giudizio l’accusa, da parte dello Stato. Al verticevi e un Procuratore generale nominato dal Presidente della Repubblica conil consenso del Parlamento, che, a sua volta, nomina gli altri procuratori.La scelta merita riflessione particolare perche e frutto del desiderio di sot-trarre all’esecutivo, che prima aveva grandissima influenza sui pubblici min-isteri, l’esercizio dell’ azione penale. Tuttavia essa, attribuendo la nomina delprocuratore generale al Presidente della Repubblica ed al Parlamento, nonsembra sottrarla, come sarebbe invece auspicabile, alle influenze politiche.
Il controllo economico e finanziario e affidato alla Corte dei Conti.
16 7. La Corte costituzionale
In modo netto viene sancita la priorita della Costituzione la cui tutela eaffidata ad una Corte Costituzionale, autonoma ed indipendente, i cui com-ponenti sono designati dal Presidente e con il consenso dell’ Assemblea leg-islativa. Essa rappresenta una novita nel panorama costituzionale albanese,nel quale solo nel 1991 era stato previsto un Consiglio Costituzionale che,al di la del suo nome, era un vero organo di controllo costituzionale, cui eraattribuito il controllo della legittimita costituzionale delle leggi.
La Corte Costituzionale, in primo luogo, e impegnata a garantire l’osservanzadella Costituzione e della sua interpretazione definitiva. Le sue decisioni sonoinappellabili e la dichiarazione di incostituzionalita della legge e, pertanto,definitiva. Essa ha numerose competenze, che la propongono come arbitrosupremo della vita dello Stato di diritto: decide in tutti i casi di conflittotra i poteri dello Stato e riguardo alle incompatibilita del Presidente dellaRepubblica, si pronuncia sulla costituzionalitadei referendum e degli accordiinternazionali, non ancora ratificati. Quest’ultimo punto merita particolareattenzione, perche ribadisce la prioritadella Costituzione albanese rispettoalle norme internazionali.
Il mandato dei giudici dura nove anni: periodo sufficientemente lungoche consente loro di transitare almeno tra due legislature. Sull’esempio diquanto sta emergendo in Italia, per meglio garantire l’indipendenza dei giu-dici forse sarebbe stato opportuna una diversa durata e, comunque, il divietodi ricoprire cariche o incarichi per un congruo periodo dopo la cessazionedel mandato: cio per evitare che in vista di un successivo incarico il giudicepossa essere influenzato nella sua decisione
22
17 8. Autonomie locali, fonti normative
Molto spazio viene riservato alle autonomie locali: articolate in Comuni oMunicipi e Circoscrizioni, dotati della personalita giuridica; essi hanno com-petenze amministrative e tributarie nell’ambito delle rispettive giurisdizioni.In tal modo si e realizzato il riconoscimento delle specificita territoriali inun Paese che, pur nella sua limitata estensione, ha profonde diversita trale varie regioni che lo compongono. Pensando alla realta italiana, va quiprecisato che le Circosrcizioni ricoprono il ruolo che in Italia e affidato alleRegioni, pero con un’autonomia piu accentuata. Il Governo si raccorda conle Circoscrizioni attraverso un Prefetto.
Pur nel riconoscimento della priorita del Parlamento, il sistema delle fontidel diritto risulta articolato secondo una gerarchia che vede al primo postola Costituzione, seguita dagli accordi internazionali ratificati, dalle leggi edagli atti normativi del Consiglio dei Ministri. Il riconoscimento della nor-mativita degli accordi internazionali rappresenta una novita significativa; permaterie specifiche (come la pace, le alleanze, i diritti umani, l’adesione adorganismi internazionali, il cambiamento di leggi) e necessario che i trattatiinternazionali vengano successivamente ratificati con legge.
18 9. Il referendum
E previsto l’esercizio diretto della sovranita popolare tramite referendum.Di norma esso e abrogativo, ma per questioni di particolare importanza puoconcernere anche progetti di legge, finendo per diventare propositivo. Prob-abilmente l’accesso al referendum propositivo poteva essere perseguito inmaniera piu decisa qualora non lo si fosse sottoposto alla mediazione delParlamento che, ad una osservazione della realta materiale, risulta ancoraimpreparato a far fronte alle istanze della societa.
Qui mi consento un’osservazione. Mi pare che sarebbe stato auspicabileaccompagnare l’introduzione del referendum con altre forme di esercizio di-retto della sovranita popolare da parte dei cittadini. In particolare sarebbestata opportuna !’introduzione dell’ azione popolare a tutela degli interessidella comunita, che, specie in alcune materie (ad esempio quella ambientale),rischiano di restare disattesi, quando non calpestati.
19 10. Rilievi conclusivi
In conclusione la nuova Costituzione ha operato una sintesi tra le linee di-rettrici delle attuali costituzioni parlamentari e presenta innovazioni signi-
23
ficative, alcune delle quali dovranno penetrare ancora nella consapevolezzagiuridica del popolo albanese, sul quale preme la penetrante eredita dei kan-umi, ispirati da principi differenti. Spetta agli operatori sociali e, soprat-tutto, ai giuristi approfondire gli aspetti che la nuova Costituzione presentae annonizzarli nel vissuto del popolo albanese, in modo da transitarlo nellarealta dell’oggi, che non puo, tuttavia, dimenticare le proprie radici di popolomultietnico, multiculturale e multireligioso, ancorato al pensiero ed alle ideeoccidentali, ma non lontano da suggestioni e visioni di altre matrici (in par-ticolare musulmane ed ortodosse).
Con la nuova Costituzione l’Albania dimostra di volere crescere nell’ordinee nel rispetto del diritto; essa vuol essere un punto fermo del desiderio dellarivendicazione di un futuro nel consesso delle nazioni europee e della volontadi non perdere la propria identita, derivantegli anche dall’ essere stato edancora essere quasi la cerniera per il vicino Oriente.
In questo contesto spetta, dunque, agli interpreti ed agli operatori deldiritto far sı che questa nuova Costituzione albanese penetri nella consapev-olezza giuridica del popolo, in modo che diventi la prima democratica Costi-tuzione degli Albanesi.
A tal fine l’apporto dei Paesi vicini puo essere di grande aiuto. Essosi deve fondare su una conoscenza della realta albanese e della sua nuovaCostituzione. E per questo motivo e con questo spirito che ho atteso allasua traduzione nella lingua italiana, revisionata dal prof. Aldo Loiodice, chemi auguro diventi veicolo per la diffusione nell ’Europa, realta alla qualel’Albania di oggi guarda con grande fiducia e speranza.
LA COSTITUZIONE ALBANESE
L’ASSEMBLEA POPOLARE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICAALBANESE Noi, Popolo albanese, orgoglioso e consapevole della nostra sto-ria, con responsabilita per il futuro, con fiducia in Dio o negli altri valoriuniversali, con la decisione di costruire uno Stato di diritto, democratico esociale, per garantire le liberta e i diritti fondamentali dell ’uomo, con spiritodi tolleranza e convivenza religiosa, con impegno per la tutela della dignitae della personalita umana, oltre che per la prosperita della nazione, per lapace, il benessere, la cultura e la solidarieta sociale, con l’aspirazione secolareper la dignita e per l’unione nazionale, con il profondo convincimento che lagiustizia, la pace, l’armonia e la collaborazione tra le nazioni sono i valoripiualti dell ’umanita, DELIBERIAMO QUESTA COSTITUZIONE
24
20 PRIMA PARTE: I PRINCIPI FONDA-
MENTALI
Articolo 1
1. L’Albania e una Repubblica parlamentare.
2. La Repubblica albanese e uno Stato unitario.
3. Il Governo e fondato su di un sistema di elezioni libere, periodiche, asuffragio universale e con voto eguale per tutti i cittadini.
Articolo 2
1. La sovranita della Repubblica appartiene al popolo.
2. Il popolo esercita la sovranita direttamente o tramite i suoi rappresen-tanti.
3. Per proteggere la pace e l’interesse nazionale la Repubblica albanesepuo partecipare ad un sistema di garanzia collettiva sovranazionale, inbase ad una legge approvata con la maggioranza dei componenti dell’Assemblea
Articolo 3
1. La sovranita dello Stato e la sua integrita territoriale, la dignita dell’uomo, i diritti e le liberta, la giustizia sociale, il sistema costituzionale,il pluralismo, l’identita e l’eredita nazionale, la convivenza religiosa,nonche la comprensione degli Albanesi verso le minoranze sono il fon-damento dello Stato, che ha l’obbligo di rispettarli e tutelarli.
Articolo 4
1. Il diritto determina il fondamento e i limiti dell’azione dello Stato.
2. La Costituzione e la legge piu alta della Repubblica albanese.
3. Le disposizioni costituzionali si applicano immediatamente, salvo chesia diversamente disposto dalla stessa Costituzione.
Articolo 5
1. La Repubblica si conforma alle norme riconosciute del diritto inter-nazionale ed a quelle rese obbligatorie nell’ordinamento interno.
25
Articolo 6
1. L’organizzazione e il funzionamento degli organi, previsti nella Costi-tuzione, si conformano alle rispettive leggi, salvo che la Costituzionedisponga diversamente.
Articolo 7
1. La forma di Governo della Repubblica albanese si fonda sulla divisionee sul bilanciamento tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Articolo 8
1. La Repubblica albanese riconosce e garantisce i diritti nazionali deglialbanesi non cittadini, che vivono fuori dai suoi confini.
2. La Repubblica albanese riconosce e garantisce i diritti dei cittadini chevivono provvisoriamente o defrnitivamente fuori dai sui confini.
3. La Repubblica albanese garantisce e aiuta i cittadini albanesi che vivonoe lavorano in stato di emigrazione a conservare e sviluppare i rapporticoncernenti l’eredita culturale nazionale.
Articolo 9
1. I partiti politici si costituiscono liberamente. La loro organizzazione siadegua ai principi democratici.
2. I partiti politici e le altre organizzazioni, i programmi e l’attivita dellequali si fondano su metodi totalitari, che istigano e stimolano l’odiorazziale, religioso, regionale o etnico, che usano violenza per prendereil governo o per influire sulla politica statale, e quelli con carattereillegale, sono proibiti dalla legge.
3. I finanziamenti e le spese dei partiti sono sempre pubblici.
Articolo 10
1. La Repubblica albanese non stabilisce una religione ufficiale.
2. Lo Stato e neutrale sulle questioni religiose e di coscienza e garantiscea tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con laparola nella vita pubblica.
26
3. Lo Stato riconosce l’uguaglianza tra le Comunita religiose.
4. Lo Stato e le Comunita religiose rispettano reciprocamente la loro in-dipendenza e collaborano per il bene di ognuno e di tutti.
5. I rapporti tra lo Stato e le Comunita religiose si regolano secondo gliaccordi stipulati tra i loro rappresentanti e il Consiglio dei Ministri.Questi accordi vanno ratificati dall’Assemblea.
6. Le Comunita religiose sono persone giuridiche. Esse hanno autonomiadi gestione dei loro patrimoni secondo i principi, le regole e i canoni aloro propri, purche non violino gli interessi dei terzi.
Articolo 11
l. Il sistema economico della Repubblica albanese si fonda sulla proprietaprivata e pubblica, e sull’economia di mercato derivante dalla liberta nell’attivita economica.
1. Le proprieta privata e pubblica sono garantite dalla legge in modoeguale.
2. Le limitazioni della liberta nell’attivita economica si possono stabiliresolo per rilevanti motivi pubblici.
Articolo 12
1. Le forze armate garantiscono l’indipendenza del Paese, ne proteggonoanche l’integrita territoriale e l’assetto costituzionale.
2. Le forze armate sono neutrali rispetto alle questioni politiche e sonosoggette al controllo civile.
3. Nessuna forza militare straniera puo essere accettata nel territorio al-banese, salvo che per legge approvata dalla maggioranza dei componentidell’ Assemblea.
Articolo 13
1. Gli enti locali della Repubblica albanese sono istituiti in attuazione deldecentramento del potere e svolgono le loro funzioni secondo il principiodell’autonomia locale.
27
Articolo 14
1. La lingua ufficiale della Repubblica e l’albanese.
2. La bandiera della Repubblica e il bicolore: rosso e nero, con al centrouna aquila nera bicipite.
3. Lo Stemma della Repubblica albanese presenta uno scudo su sfondorosso e al centro un’aquila nera bicipite. Alla cima dello scudo doratosi evidenzia l’ elmo di Scanderbeg.
4. L’inno nazionale e ”Intorno alla nostra bandiera, uniti”
5. La festa nazionale della Repubblica albanese e il Giorno della Bandiera,il28 Novembre.
6. La capitale della Repubblica albanese e Tirana
21 SECONDA PARTE:I DIRITTI E LE LIB-
ERTA FONDAMENTALI DELL’UOMO
21.1 TITOLO I: I PRINCIPI GENERALI
Articolo 15
1. I diritti e le liberta fondamentali dell’uomo sono indivisibili, inalienabilie inviolabili e sono il fondamento di tutto il sistema giuridico.
2. Gli organi dei poteri pubblici, nell’esercizio delle loro funzioni, devonorispettare i diritti e le liberta fondamentali dell ’uomo, e contribuireanche alla loro realizzazione.
Articolo 16
1. I diritti e le liberta fondamentali nonche gli obblighi previsti dalla Cos-tituzione per i cittadini albanesi valgono ugualmente per gli stranieri eper gli apolidi nel territorio della Repubblica albanese, salvo i casi incui la Costituzione leghi in via esclusiva il godimento dei diritti e delleliberta alla cittadinanza o nazionalita albanese.
2. I diritti e le liberta fondamentali, come anche gli obblighi previsti nellaCostituzione si riferiscono anche alle persone giuridiche, in quanto com-patibili con gli scopi generali di esse e con il contenuto dei relativi diritti,liberta ed obblighi.
28
Articolo 17
1. Le limitazioni dei diritti e delle liberta garantiti dalla presente Costi-tuzione possono essere stabiliti solo con legge in relazione ad un inter-esse pubblico o alla tutela dei diritti di terzi. La limitazione deve essereproporzionata alla situazione che l ’ha causata.
2. Queste limitazioni non possono incrinare l’essenza dei diritti e delleliberta e in nessun caso possono eccedere i limiti previsti dalla Conven-zione Europea per i diritti dell ’uomo.
Articolo 18
1. Tutti sono eguali davanti alla legge.
2. Nessuno puo essere discriminato per sesso, razza, religione, etnia, lin-gua, opinioni politiche, religiose o filosofiche, condizioni economiche esociali, istruzione, oppure per la provenienza patema.
3. Nessuno puo essere discriminato per i motivi di cui al secondo commase non esiste un motivo obiettivo legalmente riconosciuto.
Articolo 19
1. Chiunque nasca da un genitore di cittadinanza albanese, acquista au-tomaticamente la cittadinanza albanese. La cittadinanza albanese siacquista anche negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il cittadino albanese non puo essere privato della cittadinanza, salvonei casi di rinuncia.
Articolo 20
1. Le persone che appartengono a minoranze nazionali godono piena eguaglianzadavanti alla legge per i loro diritti e liberta.
2. Essi hanno diritto di manifestare liberamente, senza esservi impediti oobbligati, la loro appartenenza etnica, culturale, religiosa e linguistica,di conservarla e svilupparla, di istruire e istruirsi nella propria linguamaterna, nonche di aderire alle associazioni organizzate per la tuteladei loro interessi e identita.
29
21.2 TITOLO II:LE LIBERTA E I DIRITTI PER-SONALI
Articolo 21
1. La vita della persona e tutelata dalla legge.
Articolo 22
1. La liberta d’espressione e garantita.
2. La liberta di stampa, radio e televisione e garantita.
3. La censura dei mezzi di comunicazione e vietata.
4. La legge puo prevedere la concessione o l’autorizzazione per l’eserciziodi stazioni radio e televisive.
Articolo 23
1. E garantito il diritto all’informazione.
2. Chiunque ha diritto, a norma di legge, all’informazione sull’attivitadegli organi statali, nonche sulle persone che esercitano funzioni statali.
3. A chiunque e data la facolta di seguire le riunioni degli organi collegialielettivi.
Articolo 24
1. E garantita la liberta di coscienza e di religione.
2. Ognuno e libero di scegliere o di cambiare la religione o le convinzioni,nonchedi professarle individualmente e collettivamente, in pubblico e nella vitaprivata, attraverso il culto, l’istruzione e le pratiche dei riti.
3. Nessuno puo essere obbligato o privato delle facolta di partecipazionead una comunita religiosa o alle sue pratiche, nonche di professare inpubblico le proprie convinzioni o la sua fede
Articolo 25
1. Nessuno puo essere sottoposto a tortura, condanna o trattamenti crudeli,disumanio infamanti.
30
Articolo 26
1. Nessuno puo essere obbligato ad un lavoro forzato, salvo i casi di ese-cuzione di una sentenza, di servizio militare, di servizio derivante dallostato di guerra, di emergenza, di calamita naturali che minacciano lavita o la salute dell’umanita.
Articolo 27
1. Nessuno puo essere privato della liberta, salvo nei casi e nei modi pre-visti dalla legge.
2. La liberta della persona non puo essere limitata, salvo i casi di:
a ) condanna al carcere da parte del tribunale competente;
b ) inosservanza degli ordini legittimi delle corti di giustizia o per in-adempimento degli obblighi indicati dalla legge;
c ) sospetti motivati di un atto criminoso o per l’esigenza di prevenirela consumazione di un reato, o per allontanare il reo dopo che loabbia commesso;
d ) sorveglianza del minorenne per fmi di educazione o per accompag-narlo presso gli organi competenti;
e ) quando una persona abbia una malattia infettiva, sia incapace men-tale e pericoloso per la societa;
f ) ingresso abusivo nel territorio albanese, nonche nei casi di espulsionee di estradizione;
3. Nessuno puo essere privato della liberta per motivi di inadempienzacontrattuale.
Articolo 28
1. Chiunque viene privato della liberta ha diritto di ricevere, immedi-atamente nella lingua da lui conosciuta, comunicazione dei motivi delprovvedimento, nonche in merito all’accusa che gli viene mossa.La per-sona privata della liberta deve essere informata che non ha nessun ob-bligo di fare dichiarazioni ed ha diritto di prendere contatti immediaticon un avvocato e, comunque,deve avere la possibilita di esercitare isuoi diritti.
31
2. La persona privata della liberta secondo l’articolo 27, comma 2, letterac,entro 48 ore deve essere presentata davanti al giudice, il quale con-valida l’arresto o concede la liberta non piu tardi di 48 ore da quandoestato investito della cognizione del caso.
3. Il detenuto ha diritto di proporre appello contro la decisione del giudice.Ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole o di esserelasciato libero dietro prestazione di garanzia patrimoniale secondo lemodalita previste dalla legge.
4. In tutti gli altri casi, la persona privata della liberta con procedurestragiudiziali puo presentarsi in qualsiasi momento davanti al giudice,che decide entro 48 ore sulla legittimita del provvedimento di privazionedella liberta.
5. Ogni persona privata della liberta ai sensi dell’art. 27 ha diritto ad untrattamento umano e al rispetto della propria dignita.
Articolo 29
1. Nessuno puo essere accusato o dichiarato colpevole per un fatto che,secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato,salvo i casi di azioni che, al momento in cui furono commesse, cos-tituivano reati di guerra o crimini contro l’umanita secondo il dirittointernazionale.
2. Non si puo infliggere una condanna superiore a quella prevista dallalegge al momento in cui il reato fu commesso.
3. La legge penale piu favorevole ha forza retroattiva.
Articolo 30
1. Ogni persona viene considerata innocente sino a che non sia stataprovata la sua colpevolezza mediante sentenza definitiva.
Articolo 31
1. Durante il processo penale, chiunque ha il diritto di:
a ) venire informato immediatamente e in dettaglio sul motivo dell’accusa,sui suoi diritti e sulla facolta di avvertire i familiari;
32
b ) avere tempo e le agevolazioni sufficienti per la preparazione dellasua difesa;
c ) disporre gratuitamente di un interprete, se non conosce e non parlala lingua albanese;
d ) predisporre l’autodifesa o avvalersi di un avvocato nominato dalui; di potere comunicare liberamente e in privato con lui, noncheottenere la difesa gratuita se non disponga di sufficienti mezzieconomici;
e ) porre domande ai testi presenti e chiedere la presentazione di tuttii testi, di esperti e delle altre persone che possono accertare i fatti.
Articolo 32
1. Nessuno e costretto a testimoniare contro se stesso o i suoi familiari oad ammettere la propria colpa.
2. Nessuno puo essere dichiarato colpevole in base a prove raccolte ille-galmente.
Articolo 33
1. Ognuno ha diritto di essere sentito prima della condanna.
2. Di questo diritto non puo usufruire la persona che si sottrae alla gius-tizia.
Articolo 34
Nessuno puo essere condannato o giudicato piu di una volta per lo stessoreato,esclusi i casi di rinvio della questione alla cognizione di una corte su-periore,secondo le procedure previste dalla legge.
Articolo 35
1. Nessuno puo essere obbligato a rendere noti i dati che lo riguardanopersonalmente, esclusi i casi previsti dalla legge.
2. La raccolta, l’uso e la diffusione dei dati concernenti la persona, puossere effettuata solo con il suo consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Ognuno ha diritto di avere conoscenza dei dati raccolti sulla sua per-sona, esclusi i casi previsti dalla legge.
33
4. Ognuno ha diritto di chiedere la correzione o la cancellazione dei datifalsi, non completi o raccolti in contrasto con la legge.
Articolo 36
1. Sono garantite la liberta e la segretezza della corrispondenza o di qual-siasi altro mezzo di comunicazione.
Articolo 37
1. E garantita l’inviolabilita del domicilio.
2. La perquisizione del domicilio e di altri ambienti che si collegano conesso, si effettua soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3. Nessuno puo essere perquisito personalmente al di fuori delle esigenzedel processo penale, salvo i casi di ingresso e uscita dal territorio delloStato o quando venga minacciata la sicurezza pubblica.
Articolo 38
1. Tutti hanno diritto di scegliere il luogo di residenza nonche di muoversiliberamente su ogni parte del territorio dello Stato.
2. A nessuno puo essere impedito di uscire liberamente dal territorio delloStato.
Articolo 39
1. Nessun cittadino albanese puo essere espulso dal territorio del Stato.
2. L’estradizione e ammessa soltanto quando e prevista dagli accordi in-ternazionali di cui la Repubblica albanese e parte, e solo con provved-imento giudiziario.
3. E vietata l’espulsione collettiva degli stranieri. L’espulsione degli stranierie concessa alle condizioni determinate dalla legge.
Articolo 40
1. Gli stranieri hanno diritto di asilo nella Repubblica albanese secondola legge.
34
Articolo 41
1. E garantito il diritto alla proprieta privata.
2. La proprieta si acquista con donazione, eredita, compravendita e inqualsiasi altro modo previsto dal codice civile.
3. La legge puo prevedere espropriazioni o limitazioni del diritto di pro-prieta soltanto per pubblica utilita.
4. Le espropriazioni o le limitazioni del diritto di proprieta assimilabiliall’espropriazione sono concesse solo previa adeguata indennita.
5. Per le controversie concernenti la misura dell’indennita si puo far ricorsoal tribunale.
Articolo 42
1. La liberta, la proprieta e i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dallalegge, non possono essere lesi al di fuori di un processo regolare.
2. Ognuno, per difendere i diritti, le liberta e i suoi interessi costituzionalie legali, o nei casi di accuse mosse contro di lui, ha diritto ad un giudiziogiusto e pubblico entro un termine ragionevole da parte di un tribunaleindipendente e neutro previsto dalla legge
Articolo 43
1. Chiunque ha diritto di proporre appello contro una sentenza pressouna corte di grado superiore, salvo i casi in cui la Costituzione prevedadiversamente.
Articolo 44
1. Chiunque ha diritto alla riabilitazione e/o al risarcimento in conformitaalla legge, se e stato leso da un atto, azione o omissione illegale degliorgani statali.
21.3 TITOLO III:LE LIBERTA E I DIRITTI POlITICI
Articolo 45
1 Ogni cittadino, che ha raggiunto l’eta di diciotto anni, anche nello stessogiorno della votazione, ha il diritto di elettorato attivo e passivo.
35
2 Sono esclusi dal diritto di voto i cittadini dichiarati incapaci mentalicon una sentenza defInitiva.
3 I condannati, che stanno scontando una pena che comporta privazionedella liberta personale, hanno solo l’elettorato attivo.
4 Il voto e personale, uguale, libero e segreto.
Articolo 46
1. Tutti hanno diritto di associarsi e riunirsi per qualsiasi finalita legal-mente ammissibile.
2. L’iscrizione al tribunale delle organizzazioni e associazioni si effettuasecondo le procedure previste dalla legge.
3. Le organizzazioni e le associazioni che perseguono fini anticostituzionalisono proibite dalla legge.
Articolo 47
1. E garantita la liberta dei gruppi pacifici e senza armi, nonche l’appartenenzaad essi.
2. Riunioni pacifiche nei luoghi aperti e pubblici si possono svolgere sec-ondo la procedura prevista dalla legge.
Articolo 48
1. Chiunque, da solo o insieme ad altri, puo rivolgere una richiesta, unappello o un’osservazione, agli organi pubblici, i quali sono obbligati arispondere entro i termini e le condizioni indicati dalla legge.
21.4 TITOLO IV:LE LIBERTA ED I DIRITTI ECO-NOMICI, SOCIALI E CULTURALI
Articolo 49
1. Chiunque ha diritto di acquisire le risorse per il suo sostentamentoattraverso un lavoro legittimo da lui scelto o accettato. Chiunque elibero di scegliere la professione, il posto di lavoro, nonche il sistemadella sua qualificazione professionale.
2. I lavoratori hanno diritto all’assistenza sociale sul lavoro.
36
Articolo 50
1. I lavoratori hanno diritto di associarsi liberamente nelle organizzazionisindacali per difendere i loro interessi.
Articolo 51
1. E garantito il diritto di sciopero concernente i rapporti di lavoro.
2. Limitazioni per particolari categorie, di lavoratori possono essere sta-bilite dalla legge per assicurare alla societa i servizi indispensabili.
Articolo 52
1. Chiunque ha diritto all’assicurazione sociale per vecchiaia o per in-abilita al lavoro, in conformita al sistema indicato dalla legge.
2. Chiunque, in caso di disoccupazione involontaria, sia sprovvisto di altrimezzi di sussistenza, ha diritto all’assistenza alle condizioni previstedalla legge.
Articolo 53
l. Chiunque ha diritto di contrarre matrimonio e di avere una famiglia.
1. Il matrimonio e la famiglia godono di un riguardo particolare dalloStato.
2. Il matrimonio e il divorzio sono disciplinati dalla legge.
Articolo 54
l. I minorenni, i giovani, le donne in stato interessante e le madri giovanigodono di una protezione particolare dalla legge.
1. I figli nati fuori del matrimonio godono degli stessi diritti dei figli natidal matrimonio.
2. Ogni minorenne ha diritto di essere tutelato dalla violenza,del maltrat-tamento, dello sfruttamento e dall’uso per lavoro, specialmente al disotto dell’eta minima prevista per il lavoro dei minorenni, che possanodanneggiare la salute fisica e morale e mettere a rischio la vita e il loronormale sviluppo.
37
Articolo 55
l. I cittadini godono di assistenza sociale in condizioni uguali,per previdenzasanitaria da parte dello Stato.
1. Chiunque ha diritto all’assistenza sanitaria secondo la procedura indi-cata dalla legge.
Articolo 56
1. Chiunque ha diritto di essere informato riguardo all’ambiente per lasua protezione.
Articolo 57
1. Tutti hanno diritto all’istruzione.
2. L’istruzione scolastica obbligatoria e stabilita dalla legge.
3. L’istruzione superiore generale pubblica e aperta a tutti.
4. L’istruzione superiore professionale nonche quella di alto livello vienecondizionata soltanto dal criterio della capacita.
5. L’istruzione obbligatoria e quella superiore nelle scuole pubbliche sonogratuite.
6. Gli alunni e gli studenti si possono istruire anche nelle scuole non pub-bliche di tutti i livelli, le quali vengono istituite e funzionano a normadi legge.
7 L’autonomia delle istituzioni di alto livello e la liberta accademica sonogarantite dalla legge.
Articolo 58
1. La liberta di espressione artistica e della ricerca scientifica, l’applicazionee l’utilizzo dei risultati ottenuti, nonche dei vantaggi da loro derivantisono garantiti a tutti.
2. Il diritto di autore e tutelato dalla legge.
38
21.5 TITOLO V: OBIETTIVI SOCIALI
Articolo 59
1. Lo Stato, entro le competenze costituzionali e con i mezzi di cui dispone,nonche nel rispetto dell’iniziativa e della responsabilita private, persegue:
a ) l’occupazione a condizioni idonee di tutte le persone abili al lavoro.
b ) la soddisfazione dei bisogni del cittadino per quanto concerne l’abitazione;
c ) lo standard sanitario, fisico e psichico piu alto possibile;
d ) l’istruzione e la qualificazione secondo le capacita dei bambini e deigiovani, oltre che delle persone disoccupate;
e ) un ambiente salubre ed ecologicamente adatto per l’attuale gener-azione e per le successive;
f ) lo sfruttamento razionale dei boschi, delle acque, dei pascoli, e di al-tre sorgenti naturali, fondandolo sul principio dello sviluppo com-patibile;
g ) la cura e l’assistenza di anziani, orfani e invalidi;
h ) lo sviluppo dello sport e delle attivita ricreative;
i ) la riabilitazione sanitaria, l’educazione specializzata e l’integrazionenella societa dei disabili ed il continuo miglioramento delle lorocondizioni di vita;
j ) la protezione dell’eredita culturale nazionale ed in particolare dellalingua albanese.
2. Il conseguimento degli obbiettivi sociali non puo essere chiesto diret-tamente ai tribunali. La legge determina le condizioni e la misura inbase alle quali si puo chiedere la realizzazione degli obbiettivi.
21.6 TITOLO VI: L’AVVOCATO DEL POPOLO
Articolo 60
1. L’avvocato del popolo difende i diritti, le liberta e gli interessi legit-timi dell’individuo dalle azioni ed omissioni illecite ed illegittime dellapubblica amministrazione.
2. L’avvocato del popolo e indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;
3. L’avvocato del popolo ha un bilancio separato, che gestisce autonoma-mente. Egli predispone il bilancio in conformita alla legge.
39
Articolo 61
1. L’avvocato del popolo viene eletto dai tre quinti dei membri dell’Assembleaper un periodo di cinque anni, con possibilita di rielezione.
2. Avvocato del popolo puo essere ogni cittadino albanese, in possessodella laurea in giurisprudenza, con conoscenze e attivita riconosciutenell’ambito dei diritti dell’uomo e della legge.
3. L’avvocato del popolo gode della stessa immunita accordata al giudicedella Corte Suprema.
4. L’avvocato del popolo non puo appartenere a partiti politici, non puoesercitare nessun’altra attivita politica, statale o professionale e neanchefar parte degli organismi difettivi delle organizzazioni sociali, economichee commerciali.
Articolo 62
1. L’avvocato del popolo puo essere rimosso su richiesta motivata da partedi un terzo dei deputati.
2. In questo caso l’Assemblea decide a maggioranza dei tre punti dei com-ponenti.
Articolo 63
1. L’avvocato del popolo sottopone al Parlamento un rapporto annuale.
2. L’avvocato del popolo riferisce dinanzi al Parlamento quando gli vengarichiesto o quando chieda all’Assemblea di essere sentito per casi cheritiene importanti.
3. L’avvocato del popolo ha diritto di presentare raccomandazioni e diproporre provvedimenti quando noti violazioni dei diritti e delle libertadell’uomo da parte della pubblica amministrazione.
4. Gli organi ed i funzionari pubblici sono obbligati a fornire all’avvocatodel popolo tutti i documenti e le informazioni da lui richiesti.
40
22 TERZA PARTE III: PARLAMENTO
22.1 TITOLO I: L’ELEZIONE E LA DURATA
Articolo 64
1. Il Parlamento si compone di centoquaranta deputati; cento deputatisono eletti direttamente in collegi uninominali ognuno un numero piuo meno simile di elettori, quaranta deputati sono scelti tramite listedi candidati dei partiti o coalizioni di partiti secondo l’ordine di listaproposto.
2. Il numero totale dei deputati di ogni partito o coalizione di partiti sistabilisce in rapporto, il piu vicino possibile, ai voti validi presi da loroin tutto il Paese nel primo turno di elezioni.
3. I partiti che ottengono meno del 2,5conseguano meno del 4nel primoturno delle elezioni non si possono avvalere delle rispettive liste di can-didati.
Articolo 65
1. Il Parlamento viene eletto per quattro anni.
2. Le elezioni del Parlamento hanno luogo da sessanta a trenta giorniprima del termine del suo mandato e non piu tardi di quarantacinquegiorni dopo il suo scioglimento. ,
3. Il mandato dell’ Assemblea prosegue sino alla prima riunione del nuovoParlamento. Nel periodo di prorogatio, il Parlamento non puo emanareleggi o prendere decisioni, esclusi i casi di emergenza.
Articolo 66
1. Il mandato del Parlamento viene prorogato solo nei casi di guerra efino a quando essa continua. Quando il Parlamento e sciolto vieneconvocato automaticamente.
Articolo 67
1. Il Parlamento appena eletto e convocato, per la prima riunione, dalPresidente della Repubblica, non piu di venti giorni dopo le elezioni.
41
2. Se il Presidente della Repubblica non provvede in tal senso, il Parla-mento si deve riunire automaticamente entro dieci giorni dalla scadenzadel termine previsto nel primo comma del presente articolo.
22.2 TITOLO II: I DEPUTATI
Articolo 68
1. I candidati a deputato possono essere indicati solo dai partiti politici,dallecoalizioni di partiti e dagli elettori.
2. Le regole per la designazione dei candidati a deputato, per l’ organiz-zazione e lo svolgimento delle elezioni, nonche la ripartizione dei seggielettorali e le condizioni di validita delle elezioni, sono stabilite dallalegge elettorale.
Articolo 69
1. Non si possono candidare ne essere eletti come deputati, prima delledimissioni:
a ) i giudici, i procuratori della Repubblica;
b ) i militari in servizio attivo;
c ) gli agenti della polizia e della sicurezza nazionale;
d ) i rappresentati diplomatici;
e ) i sindaci dei Municipi e dei Comuni ed i prefetti nelle zone doveesercitano la loro funzione;
f ) i capi e i componenti delle commissioni elettorali;
g ) il Presidente della Repubblica, gli alti funzionari dell’ amministrazione statale previsti dalla legge.
2. L’elezione conseguita in contrasto con il primo comma del presentearticolo e nulla.
Articolo 70
1. I deputati rappresentano il popolo e non sono vincolati a nessun mandatoobbligatorio.
2. I deputati non possono rivestire contemporaneamente altre cariche statali, ad eccezione di quella di membro del Consiglio dei Ministri. Altricasi di incompatibilita sono stabiliti dalla legge.
42
3. I deputati non possono svolgere nessuna attivita lucrosa che derivi dallerisorse statali o governative locali e non possono ottenere guadagni dall’utilizzo di tali risorse.
4. Per ogni violazione del terzo comma del presente articolo, su mozionedel Presidente dell’ Assemblea o di un decimo dei suoi membri, l’Assembleademanda la questione alla Corte costituzionale, la quale dichiara l’incompatibilita.
Articolo 71
1. Il mandato di deputato decorre dal giorno della proclamazione da partedella rispettiva commissione.
2. Il mandato del deputato cessa oppure non e valido, nei seguenti casi:
a ) quando l’eletto non presta giuramento;
b ) quando abbandona il mandato;
c ) quando si verifica uno dei casi di incompatibilita previsti negli ar-ticoli 69, 70, commi 2 e 3;
d ) quando termina il mandato dell’Assemblea;
e ) in caso di assenza per sei mesi consecutivi dall’Assemblea senza unvalido motivo;
f ) nel caso di condanna con sentenza definitiva per aver commesso uncrimine.
Articolo 72
1. Prima dello svolgimento del mandato i deputati prestano giuramentoall’Assemblea.
Articolo 73
1. Il deputato non e responsabile per i pareri espressi in Assemblea eper i voti da lui dati. Questa disposizione non si applica nel caso didichiarazione menzognera.
2. Il deputato non puo essere incriminato senza l’autorizzazione dell’ As-semblea. L’autorizzazione e necessaria anche per l’arresto.
3. Senza autorizzazione egli e soggetto a fermo giudiziario solo in caso diflagranza o quasi flagranza di reato. In questi casi il Procuratore Gen-erale informa immediatamente l’Assemblea la quale, quando verificache il fatto non sussiste, decide l’assoluzione.
43
4. Per i casi previsti nei commi 2 e 3 del presente articolo l’Assembleadecide con votazione segreta.
22.3 TITOLO III: L’ORGANIZZAZIONE E IL FUN-ZIONAMENTO
Articolo 74
1. Il Parlamento svolge i lavori annuali in due sessioni ordinarie. La primasessione comincia il terzo lunedı di gennaio e la seconda sessione il primolunedı di settembre.
2. Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria quando la convo-cazione e richiesta dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministroo da un quinto dei deputati.
3. Le sessioni straordinarie vengono convocate dal Presidente dell’ Assem-blea con l’ordine del giorno richiesto
Articolo 75
l. L’Assemblea elegge e revoca il suo Presidente.
1. L’Assemblea e organizzata e funziona in base al regolamento approvatodalla maggioranza dei componenti.
Articolo 76
1. Il Presidente presiede l’adunanza durante il dibattito, dirige i lavori,assicura il rispetto dei diritti dell’ Assemblea e dei suoi membri e rap-presenta l’Assemblea nei rapporti con i terzi.
2. Il funzionario civile di grado piu alto dell’ Assemblea e il Segretariogenerale.
3. Altri servizi necessari per il funzionamento dell’ Assemblea sono prestatidagli altri impiegati, secondo il regolamento interno.
Articolo 77
1. L’Assemblea sceglie nel suo seno le commissioni permanenti e puo for-mare commissioni speciali.
44
2. L’Assemblea ha diritto, e su richiesta di un quarto dei suoi membri eobbligata, ad istituire una commissione d’inchiesta per esaminare unaquestione particolare. Le loro conclusioni non sono vincolanti per itribunali, pero se ne puo dare notizia alla procuratoria, che le valutasecondo le procedure di legge.
3. Le commissioni d’inchiesta agiscono in conformita alle procedure pre-viste dalla legge.
Articolo 78
1. L’Assemblea decide a maggioranza dei voti e con la presenza dellamaggioranza dei suoi componenti, escluso i casi in cui la Costituzionepreveda una maggioranza qualificata.
2. Le riunioni dei deputati, convocate in difformita dal regolamento, nonhanno effetto giuridico.
Articolo 79
1. Le riunioni dell’ Assemblea si svolgono a porte aperte.
2. Su richiesta del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro o diun quinto dei deputati, le riunioni dell’ Assemblea possono essere svoltea porte chiuse, quando in tal senso si sia espressa la maggioranza deisuoi membri.
Articolo 80
1. Il Primo Ministro e qualsiasi altro membro del Consiglio dei Ministrisono obbligati a rispondere alle interpellanze dei deputati entro tresettimane dalla presentazione.
2. Ciascun componente del Consiglio dei Ministri ha diritto di parteciparealle riunioni dell’ Assemblea o delle sue commissioni; egli puo prenderela parola ogni volta che lo chieda.
3 I dirigenti delle istituzioni statali, su richiesta delle commissioni parla-mentari, forniscono chiarimenti e informazioni per questioni varie sulla loroattivita secondo quanto indicato dalla legge
45
22.4 TITOLO IV: IL PROCEDIMENTO LEGISLA-TIVO
Articolo 81
1. Il diritto di proporre leggi appartiene al Consiglio dei Ministri, al singolodeputato e a ventimila elettori.
2. Vengono approvate a maggioranza dei tre quinti dei membri dell’ As-semblea:
a ) le leggi per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzionipreviste dalla Costituzione;
b ) la legge sulle cittadinanza;
c ) la legge sulle elezioni generali e locali;
d ) la legge sui referendum;
e ) i codici;
f ) la legge sullo stato di emergenza;
g ) la legge sullo status dei funzionari pubblici;
h ) la legge d’amnistia;
i ) la legge di organizzazione amministrativa territoriale della Repub-blica.
Articolo 82
1. La proposta di legge, quando occorra, deve essere sempre accompagnatadalla indicazione della copertura fmanziaria delle spese derivanti dallasua applicazione.
2. Nessun progetto di legge non governativo, che comporti aumento dispese per il bilancio dello Stato, o che diminuisca le entrate, puo essereapprovato senza prendere in considerazione il parere del Consiglio deiMinistri, il quale si deve pronunziare entro trenta giorni dalla data dipresentazione del progetto di legge.
3. Se il Consiglio dei Ministri non si pronunzia entro questo termine, ilprogetto di legge e procedibile e viene esaminato secondo la proceduranormale.
46
Articolo 83
1. Il progetto di legge si vota tre volte: in linea di principio, articolo perarticolo ed in generale.
2. L’Assemblea, su richiesta del Consiglio dei Ministri o di un quinto deideputati, puo esaminare e approvare o solo approvare un progetto dilegge con una procedura accelerata, ma non prima di una settimanadall’inizio della relativa procedura.
3. La procedura accelerata non e permessa per quanto concerne l’esamedi progetti di legge contemplati nell’ articolo 81 comma 2, ad eccezionedi quelli di cui alla lettera ’r’.
Articolo 84
l. Il Presidente della Repubblica promulga la legge approvata dall’ Assembleaentro venti giorni dalla sua trasmissione.
1. La legge si considera promulgata quando il Presidente della Repubblicanon provvede ai sensi del primo comma del presente articolo e del primocomma dell’articolo 85.
2. La legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale.
3. Nei casi di misure d’emergenza, nonche nei casi necessari ed urgenti,quando lo decida la maggioranza dell’ Assemblea e con il consenso delPresidente della Repubblica, la legge entra in vigore immediatamente,subito dopo la pubblicazione. La legge deve essere pubblicata nel primonumero della Gazzetta immediato successivo alla data di sua promul-gazione.
Articolo 85
l. Il Presidente dalla Repubblica puo rinviare la legge all’Assemblea per ilriesame una volta sola.
1. Il decreto del Presidente che chiede il riesame di una legge non haeffetto se consegue il voto contrario della maggioranza dei componentidell’ Assemblea.
47
23 IV PARTE:IL PRESIDENTE DELLA RE-
PUBBLICA
Articolo 86
1. Il Presidente della Repubblica e il capo dello Stato e rappresenta l’unitanazionale.
2. Puo essere eletto Presidente soltanto chi sia cittadino albanese sin dallanascita, residente in Albania negli ultimi dieci anni ed abbia compiutoquarant’ anni.
Articolo 87
1. La candidatura a Presidente viene proposta all’Assemblea da un grupponon inferiore a venti deputati. Ogni deputato non puo partecipare apiu di uno di tali gruppi.
2. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio seg-reto,senza dibattito, a maggioranza dei tre quinti dell’ Assemblea.
3. Se nella prima votazione non si raggiunge la maggioranza richiesta,entrosette giorni si effettua una seconda votazione.
4. Ove, anche nella seconda votazione, non si raggiunga la maggioranzarichiesta, si procede ad una terza votazione entro sette giorni.
5. Quando i candidati sono piu di due e nessuno dei due ha conseguitola maggioranza richiesta, entro sette giorni, si effettua una quartavotazione tra i due candidati che hanno ottenuto il numero maggioredi voti.
6. Se alla quarta votazione nessuno dei due candidati ha conseguito lamaggioranza richiesta, si procede ad una quinta votazione.
7. Se anche dopo la quinta votazione nessuno dei due candidati raggiungela maggioranza richiesta, l’Assemblea si scioglie ed entro sessanta giornisi svolgono nuove elezioni generali.
8. La nuova Assemblea elegge il nuovo Presidente secondo la proceduraprevista dai precedenti commi del presente articolo. Qualora neanchela nuova l’Assemblea elegga il Presidente, essa si scioglie ed entro 60giorni si svolgono nuove elezioni generali.
48
9. L’Assemblea successiva elegge il nuovo Presidente della Repubblica amaggioranza dei suoi componenti.
Articolo 88
1. In ogni caso, il Presidente della Repubblica e eletto per cinque anni,con possibilita di essere rieletto una volta sola.
2. Il procedimento per l’elezione del Presidente inizia non oltre trentagiorni anteriori alla scadenza del mandato presidenziale precedente.
3. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, nonprima che sia scaduto il mandato del Presidente precedente, prestagiuramento di fedelta alla Repubblica, dinanzi al Parlamento. Il Pres-idente presta il seguente giuramento:”Giuro che saro ubbidiente allaCostituzione e alle leggi nazionali, rispettero i diritti e le liberta deicittadini, proteggero l’indipendenza della Repubblica albanese e saroal servizio dell’interesse comune e del progresso del Popolo albanese”.Il Presidente puo anche aggiungere: ”Che Dio mi aiuti!”.
4. Il Presidente, che rassegni le dimissioni prima della scadenza del suomandato, non puo candidarsi nell’ elezione presidenziale che si tienedopo le sue dimissioni.
Articolo 89
1. L’ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasialtra carica pubblica; egli non puo essere membro di partito e non puosvolgere attivita privata.
Articolo 90
l. Il Presidente della Repubblica non e responsabile degli atti compiuti du-rante l’esercizio delle sue funzioni.
1. Il Presidente della Repubblica puo essere rimosso per violazione gravedella Costituzione e per aver commesso un grave reato. La propostadi rimozione del Presidente in questi casi puo essere P!esentata da nonmeno di un quarto dei componenti del Parlamento e deve essere ap-provata da non meno di due terzi dei suoi membri.
2. La decisione del Parlamento deve essere inviata alla Corte costituzionale,la quale, quando verifica la colpevolezza del Presidente della Repub-blica, dichiara la sua rimozione dalla carica.
49
Articolo 91
1. Quando il Presidente della Repubblica non possa adempiere provvi-soriamente alle proprie funzioni o quando la sua carica resti vacante,le sue competenze sono temporaneamente svolte dal Presidente dell’Assemblea.
2. In caso di impedimento permanente del Presidente della Repubblicaper piu di sessanta giorni, l’Assemblea maggioranza dei due terzi deicomponenti, decide di sottoporre la questione alla Corte costituzionale,la quale attesta definitivamente il fatto dell’impedimento. In caso diconstatazione dell’impedimento, la carica di Presidente resta vacantee si fa luogo all’elezione del nuovo Presidente entro dieci giorni dall’accertamento dell’impedimento.
Articolo 92
1. Il Presidente inoltre:
a ) puo inviare messaggi all’Assemblea;
b ) esercita il diritto di parola in conformita alla legge;
c ) concede la cittadinanza albanese e acconsente alla sua rinuncia;
d ) concede le medaglie e i titoli d’onore secondo la legge;
e ) concede i piu alti gradi militari secondo la legge;
f ) su proposta del Primo Ministro, nomina ed accredita i plenipoten-ziari della Repubblica albanese negli altri Stati e nelle organiz-zazioni internazionali;
g ) riceve le lettere credenziali e il congedo dei rappresentanti diplo-matici degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali accred-itate nella Repubblica albanese;
h ) ratifica gli accordi internazionali secondo la legge;
i ) su proposta del Primo Ministro, nomina il direttore del servizioinformativo dello Stato;
j ) nomina il presidente dell’Accademia delle scienze ed i rettori delleuniversita in conformita alla legge;
k ) fissa la data dell’elezione dall’Assemblea e degli organi di governolocale e la data di svolgimento dei referendum;
l ) chiede pareri e dati in forma scritta ai dirigenti delle istituzionistatali per questioni che riguardano le loro funzioni.
50
Articolo 93
1. Il Presidente della Repubblica, nell’esercizio delle sue competenze, em-ana decreti
Articolo 94
1. Il Presidente della Repubblica non puo esercitare altre competenze oltrequelle riconosciute espressamente dalla Costituzione o previste in ap-posite leggi.
24 PARTE V:IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Articolo 95
1. Il Consiglio dei Ministri e composto dal Primo Ministro, dal vice PrimoMinistro e dai Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri esercita ogni funzione statale che non sia stataattribuita agli altri organi governativi statali o alle autorita locali.
Articolo 96
1. Il Presidente della Repubblica, all’inizio della legislatura ed in ognicaso in cui la caricia di Primo Ministro resti vacante, nomina il PrimoMinistro su indicazione del partito o della coalizione dei partiti chehanno la maggioranza in Parlamento.
2. In caso di mancata approvazione da parte dell’Assemblea della nominadel Primo Ministro designato, il Presidente nomina un nuovo PrimoMinistro entro dieci giorni.
3. In caso di mancata approvazione della nuova nomina di Primo Min-istro, entro dieci giorni l’Assemblea elegge un nuovo Primo Ministro.In questo caso il Presidente nomina Primo Ministro l’eletto.
4. In caso di impossibilita di eleggere il Primo Ministro, il Presidente dellaRepubblica scioglie l’Assemblea.
Articolo 97
1. Il Primo Ministro nominato secondo gli articoli 96,104 o 105, pre-senta entro dieci giorni all’Assemblea, per l’approvazione, il programmapolitico del Consiglio dei Ministri, ivi compresa la sua composizione.
51
Articolo 98
1. I Ministri sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica,entro sette giorni dalla relativa indicazione da parte del Primo ministro.
2. Il decreto di nomina e di revoca viene esaminato dall’Assemblea entrodieci giorni.
Articolo 99
1. Prima di assumere le funzioni, il Primo Ministro, il vice Primo Min-istro ed i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente dellaRepubblica
Articolo 100
1. Il Consiglio dei Ministri stabilisce le direttive principali della politicagenerale statale.
2. Il Consiglio dei Ministri decide sulle proposte del Primo Ministro o deiMinistri competenti.
3. Le riunioni del Consiglio dei Ministri si svolgono a porte chiuse.
4. Gli atti del Consiglio dei Ministri sono validi quando sono firmati dalPrimo Ministro o dal Ministro che li propone.
5. Il Consiglio dei Ministri emana decreti e regolamenti.
Articolo 101
1. Il Consiglio dei Ministri, nei casi di necessita e d’urgenza, adotta, sottola sua responsabilita, atti normativi aventi forza di legge, per assumerei necessari provvedimenti provvisori. Questi atti normativi vengonoinviati immediatamente per la conversione all’Assemblea, la quale siriunisce entro cinque giorni, se non e gia riunita. Questi atti normativiperdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti dall’Assembleaentro quarantacinque giorni.
Articolo 102
1. Il Primo Ministro:
a ) rappresenta il Consiglio dei Ministri e presiede le sue riunioni;
52
b ) formula e presenta le difettive principali della politica generale delloStato e ne e responsabile;
c ) assicura l’applicazione della legislazione e delle politiche approvatedal Consiglio dei Ministri;
d ) coordina e controlla l’attivita dei membri del Consiglio dei Ministrie delle altre istituzioni dell’ amministrazione centrale dello Stato;
e ) esercita le altre funzioni previste dalla Costituzione e dalle leggi.
2. Il Primo Ministro ricompone le divergenze tra i Ministri.
3. Il Primo Ministro nell’esercizio delle sue funzioni emana ordinanze.
4. Il Ministro, nell’ambito delle funzioni principali della politica generalestatale, dirige ed e responsabile dell’ attivita rientrante nelle sue compe-tenze. Il Ministro, nell’esercizio delle sue competenze, emana ordinanzee difettive.
Articolo 103
1. Puo essere Ministro chiunque abbia i requisiti per essere eletto dep-utato. 2. Il Ministro non puo esercitare nessuna attivita statale nedirigere o partecipare a organi di societa con fini di lucro.
2. I membri del Consiglio dei Ministri godono dell’immunita prevista peri deputati.
Articolo 104
1. Nel caso in cui la mozione di fiducia presentata dal Primo ministrovenga respinta, l’Assemblea entro quindici giorni elegge un altro Primoministro. In questo caso il Presidente nomina Primo Ministro l’eletto.
2. Quando l’Assemblea non provveda ad eleggere un nuovo Primo Min-istro, il Presidente della Repubblica ne decreta lo scioglimento.
3. La votazione della mozione di fiducia avviene dopo che siano trascorsitre giorni dalla sua presentazione.
Articolo 105
1. Nel caso in cui la mozione di sfiducia presentata da un quinto dei depu-tati venga approvata dalla maggioranza dei componenti dell’Assemblea,quest’ultima entro quindici giorni elegge un altro Primo Ministro. In
53
questo caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo primo Min-istro.
2. Quando l’Assemblea non provvede ad eleggere il Primo Ministro, ilPresidente della Repubblica ne decreta lo scioglimento.
3. La votazione sulla mozione di sfiducia avviene dopo tre giorni dalla suapresentazione.
Articolo 106
1. Il Primo Ministro ed i Ministri sono obbligati a rimanere in carica sinoalla formazione del Consiglio dei Ministri successivo.
Articolo 107
1. Gli impiegati pubblici applicano la legge e sono al servizio del popolo.
2. Gli impiegati nella pubblica amministrazione vengono selezionati perconcorso, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Le garanzie sulla nomina, le funzioni ed il trattamento giuridico degliimpiegati sono stabilite dalla legge.
25 PARTE VI:IL GOVERNO LOCALE
Articolo 108
1. Gli enti locali sono i Comuni, i Municipi e le Circoscrizioni. Altriorganismi di governo locale sono disciplinati dalla legge.
2. . Le divisioni amministrativo-territoriali degli organismi di governo lo-cale sono determinate dalla legge con riguardo alla necessita,’call’interesseeconomico comune ed alla tradizione storica. I loro confini non possonoessere variati senza il previo consenso della popolazione residente.
3. Il Comune e il Municipio sono organismi di base del governo locale.Essi esercitano tutte le funzioni di autogoverno, escluse quelle che perlegge sono attribuite ad altri organismi.
4. Le funzioni di autogoverno degli enti locali vengono esercitate attraversoi loro rappresentanti ed i referendum. I principi e le procedure perlo svolgimento del referendum locale sono previsti dalla legge ai sensidell’art. 151, secondo comma.
54
Articolo 109
1. Gli organi rappresentativi degli organismi di base del governo localesono i Consigli, che vengono eletti ogni tre anni a suffragio universalee diretto, con voto segreto.
2. L’organo esecutivo del Municipio o del Comune e il Sindaco, il qualeviene eletto direttamente dal popolo ai sensi del primo comma del pre-sente articolo.
3. I diritti elettorali riguardanti i Consigli ed il Sindaco competono soloai cittadini residenti stabilmente nel territorio del rispettivo organismolocale.
4. Gli organi regionali hanno diritto di formare unioni tra Comuni per larappresentanza dei loro interessi, di collaborare con altre regioni e diavere propri rappresentanti nelle organizzazioni internazionali.
Articolo 110
1. La Circoscrizione e composta da piu organismi di base del governolocale aventi collegamenti tradizionali, economici e sociali ed interessicomuni.
2. La Circoscrizione e l’ente nel quale si forma e si attua la politica re-gionale, armonizzandola con gli indirizzi politici statali.
3. L’organo rappresentativo della Circoscrizione e il Consiglio della Cir-coscrizione. I Municipi ed i Comuni designano i membri nel Consigliodella Circoscrizione in proporzione alla loro popolazione, con un minimodi un membro. I Sindaci sono membri permanenti del Consiglio dellaCircoscrizione. Gli altri membri sono eletti con criterio proporzionale,in base a liste di candidati, dalla giunta comunale o municipale.
4. Il Consiglio della Circoscrizione puo emanare ordinanze e decreti convalore vincolante generale per la Circoscrizione.
Articolo 111
1. Gli enti locali sono persone giuridiche.
2. Gli enti locali hanno un bilancio indipendente, predisposto in confor-mita alla legge.
55
Articolo 112
1. Agli enti locali possono essere delegate, in conformita alla legge, com-petenze dell’ amministrazione statale. Le spese conseguenti alla delegasono a carico dello Stato.
2. Agli organi delle autorita locali sono attribuiti tributi in conformita allalegge o secondo accordi. Le spese concernenti gli obblighi inderogabilidegli organi delle autorita locali sono a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 113
1. I Consigli comunali, municipali e della Circoscrizione:
a ) regolano e amministrano, con indipendenza, le questioni locali ri-entranti nella loro competenza.
b ) esercitano i diritti di proprieta, amministrano con indipendenza leentrate ed hanno diritto di esercitare le attivita economiche.
c ) raccolgono e spendono le risorse indispensabili ad esercitare le lorofunzioni.
d ) istituiscono, in conformita alla legge, le tasse locali.
e ) determinano le regole per la propria organizzazione ed il loro fun-zionamento in conformita alla legge.
f ) stabiliscono i simboli delle autorita locali ed i titoli locali onorari.
g ) intraprendono iniziative per questioni locali dinanzi agli organi pre-visti dalla legge.
2. Questi organi emanano ordinanze, ordini e decisioni.
3. I diritti di auto governo degli enti locali vengono tutelati dai tribunali.
Articolo 114
1. Il Consiglio dei Ministri nomina il Prefetto come suo rappresentantein ogni circoscrizione. Le competenze del Prefetto sono stabilite dallalegge.
Articolo 115
1. L’organo degli enti locali eletto direttamente puo essere sciolto o revo-cato dal Consiglio dei Ministri per gravi violazioni della Costituzione odelle leggi.
56
2. L’organo sciolto o revocato puo proporre ricorso alla Corte costituzionaleentro quindici giorni; in tal caso la decisione del Consiglio dei Ministrie sospesa.
3. In caso di mancato ricorso entro quindici giorni o quando la Corte costi-tuzionale confermi la decisione del Consiglio dei Ministri, il Presidentedella Repubblica stabilisce la data delle nuove elezioni dell’ organodell’ente locale.
26 PARTE VII:GLI ATTI NORMATIVI E
GLI ACCORDI INTERNAZIONALI
26.1 TITOLO I:GLI ATTI NORMATIVI
Articolo 116
1. Gli atti normativi che hanno vigenza su tutto il territorio della Repub-blica albanese sono:
a ) la Costituzione;
b ) gli accordi internazionali ratificati;
c ) le leggi;
d ) gli atti normativi del Consiglio dei Ministri.
2. Gli atti emanati dagli enti locali hanno forza di legge solo entro l’ambitoterritoriale dove i rispettivi organi esercitano le loro funzioni.
3. Gli atti normativi dei Ministri e degli organi dirigenti di altre istituzionicentrali hanno forza su tutto il territorio della Repubblica albaneseentro la sfera delle loro attribuzioni.
Articolo 117
l. Le leggi, gli atti normativi del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, dellealtre istituzioni centrali dello Stato, entrano in vigore solo dopo la pubbli-cazione sulla Gazzetta Ufficiale.
1. La promulgazione e la pubblicazione degli altri atti normativi avvienesecondo le forme previste dalla legge.
57
2. Gli accordi internazionali che si ratificano con legge, vengono promul-gati e pubblicati secondo le procedure previste dalle leggi. La promul-gazione e la pubblicazione degli altri accordi internazionali si effettuain conformita alla legge
Articolo 118
l. Gli atti subordinati alla legge sono emanati, secondo le leggi, dagli organiprevisti nella Costituzione.
1. La legge deve autorizzare l’emanazione degli atti ad essa subordinati,determinare l’organo competente, le materie che essi possono disci-plinare, nonche i principi in base ai quali devono essere adottati.
2. L’organo autorizzato ad emanare atti subordinati alla legge, ai sensi delsecondo comma, non puo delegare tale competenza ad altro organo.
Articolo 119
1. I regolamenti del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e di altre istituzionicentrali dello Stato, nonche i decreti del Primo Ministro, dei Ministrie dei dirigenti delle istituzioni centrali hanno carattere interno e sonoobbligatori solo per le amministrazioni da essi dipendenti.
2. Questi atti sono emanati in conformita alla legge e non possono servirecome base per prendere decisioni che riguardino il cittadino, le personegiuridiche e gli altri soggetti.
3. I regolamenti e le ordinanze si adottano e si applicano sulla base degliatti che hanno forza giuridica generale.
Articolo 120
1. I principi e le procedure riguardanti l’emanazione degli atti giuridiciregionali sono previsti dalla legge.
26.2 TITOLO II:GLI ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 121
1. La ratifica e la denunzia degli accordi internazionali della Repubblicaalbanese avvengono per legge nei casi che concernono:
a ) il territorio, la pace, le alleanze, questioni politiche e militari;
58
b ) i diritti e le liberta dell’uomo, nonche gli obblighi dei cittadini comeprevisti dalla Costituzione;
c ) l’appartenenza della Repubblica albanese alle organizzazioni inter-nazionali;
d ) la misura degli obblighi finanziari da parte della Repubblica al-banese;
e ) l’approvazione, il cambiamento, la defmizione o l’abolizione delleleggi.
2. L’Assemblea, a maggioranza assoluta, puo ratificare anche altri accordiinternazionali non previsti nel primo comma del presente articolo.
3. In caso di sottoscrizione da parte del Consiglio dei Ministri di un ac-cordo internazionale non ratificato con legge, il Primo Ministro provvedea dame comunicazione all’Assemblea.
4. I principi e le procedure per la ratifica e la denunzia degli accordi in-ternazionali sono previsti dalla legge
Articolo 122
1. Ogni accordo internazionale ratificato fa parte dell’ordinamento giuridicointerno, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica albanese. Esso si applica immediatamente, esclusi i casi in cuila sua applicazione richieda l’emanazione di una legge. La modifica,l’integrazione e l’abrogazione delle leggi approvate dalla maggioranzadei componenti dell’ Assemblea, per effetto della ratifica degli accordiinternazionali, vengono deliberate con la stessa maggioranza.
2. Un accordo internazionale ratificato con legge prevale sulla legge in casodi contrasto.
3. Le norme emanate da un’organizzazione internazionale prevalgono, incaso di contrasto, sul diritto interno, quando negli accordi ratificatidalla Repubblica albanese, riguardanti l’appartenenza a quell’ organiz-zazione, si preveda espressamente l’immediata applicazione delle normesuddette
Articolo 123
1. La Repubblica albanese, in base agli accordi internazionali, puo dele-gare alle organizzazioni internazionali competenze statali per questionideterminate.
59
2. La legge, con la quale si ratifica l’accordo internazionale, di cui al primocomma, viene approvata a maggioranza assoluta.
3. L’Assemblea puo disporre che tale accordo venga ratificato tramite ref-erendum.
27 PARTE VIII:LA CORTE COSTITUZIONALE
Articolo 124
1. La Corte costituzionale garantisce l’osservanza della Costituzione e pro-nuncia la sua interpretazione definitiva.
2. La Corte costituzionale e soggetta soltanto alla Costituzione.
Articolo 125
1. La Corte costituzionale e composta da nove membri, nominati dal Pres-idente della Repubblica con il consenso dell’Assemblea.
2. I Giudici sono nominati per nove anni, e non possono essere nuovamentenominati; essi sono scelti fra un elenco di giuristi di alta qualificazionee con esperienza professionale non inferiore a quindici anni.
3. Ogni tre anni e rinnovato un terzo dei componenti della Corte costi-tuzionale, secondo le procedure di legge.
4. Il Presidente della Corte costituzionale e scelto tra i suoi componentied e nominato dal Presidente della Repubblica con il consenso dell’Assemblea; rimane in carica per tre anni.
5. Il Giudice della Corte costituzionale rimane in carica sino alla nominadel suo successore.
Articolo 126
1. Il Presidente della Corte costituzionale non puo essere incriminatosenza il consenso della Corte costituzionale. Il Giudice della Corte cos-tituzionale e soggetto a fermo e ad arresto soltanto nei casi di flagranzao di quasi flagranza. L’organo competente informa immediatamente laCorte costituzionale. Quando la Corte costituzionale non confermi ilprovvedimento entro ventiquattro ore, l’organo competente e tenuto aliberarlo.
60
Articolo 127
1. Il mandato di giudice della Corte costituzionale cessa quando il com-ponente:
a ) venga condannato con sentenza definitiva per aver commesso uncrimine;
b ) si assenti ingiustificatamente dalla partecipazione all’esercizio dellefunzioni per piu di sei mesi;
c ) compia l’eta di settant’anni;
d ) rassegni le dimissioni;
e ) sia dichiarato incapace d’agire con sentenza definitiva.
2. La cessazione del mandato del Giudice viene dichiarata con decisionedella Corte costituzionale.
3. Quando la carica di Giudice rimane vacante il Presidente della Repub-blica, con il consenso del Parlamento, nomina un Giudice nuovo, il qualerimane in carica fino al termine del mandato del Giudice sostituito
Articolo 128
1. Il Giudice della Corte costituzionale viene revocato con il voto di dueterzi dell’ Assemblea, per violazione della Costituzione, per aver commessoun crimine, per incapacita mentale e fisica, per atti e comportamentiche discreditano gravemente l’immagine del Giudice. La decisione dell’Assemblea viene esaminata dalla Corte costituzionale, la quale se con-ferma l’esistenza di uno dei motivi sopra esposti, dichiara la decadenzadalla carica.
Articolo 129
1. I Giudici della Corte costituzionale prima di assumere le funzioni prestanogiuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Articolo 130
1. L’ufficio di Giudice della Corte costituzionale e incompatibile con ognialtra carica o funzione pubblica o privata.
61
Articolo 131
1. La Corte costituzionale decide sulle seguenti materie:
a ) incompatibilita della legge con la Costituzione o con gli accordiinternazionali, come previsto nell’articolo 122;
b ) incompatibilita tra gli accordi internazionali e la Costituzione,prima della ratifica;
c ) incompatibilita degli atti normativi degli organi generali e localicon la Costituzione e con gli accordi internazionali;
d ) conflitti di attribuzione tra gli organi statali, nonche tra il governocentrale e locale;
e ) costituzionalita dei partiti e delle altre organizzazioni politiche,nonche della loro attivita, conformemente all’ articolo 9 della Cos-tituzione;
f ) rimozione dalla carica del Presidente della Repubblica e confermadell’impossibilita di esercizio delle sue funzioni;
g ) questioni concernenti l’eleggibilita e l’incompatibilita nell’eserciziodelle funzioni di Presidente della Repubblica e di deputato, nonchela verifica della loro elezione;
h ) costituzionalita del referendum e proclamazione dei suoi risultati;
i ) giudizi defmitivi sui ricorsi delle persone fisiche per violazione didiritti costituzionali, verificatasi in un processo previsto dalla legge,allorche siano esauriti tutti i mezzi giudiziari stabiliti per la tuteladi questi diritti.
Articolo 132
1. Le decisioni della Corte costituzionale sono obbligatorie e definitive. LaCorte costituzionale ha solo il potere di annullare gli atti che esamina.
2. Le decisioni della Corte costituzionale entrano in vigore dal giorno dellapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Corte costituzionale puostabilire che la legge o l’atto normativo siano abrogati con una diversadecorrenza.
3. L’opinione della minoranza viene resa pubblica con la decisione.
62
Articolo 133
1. La decisione riguardante i ricorsi delle persone fisiche viene presa dalnumero di Giudici stabilito dalla legge.
2. La Corte costituzionale decide a maggioranza assoluta
Articolo 134
1. La Corte costituzionale esercita le sue competenze su richiesta:
a ) del Presidente della Repubblica;
b ) del Primo Ministro;
c ) di non meno di un quinto dei deputati;
d ) del presidente della Corte dei conti;
e ) di ogni Corte ai sensi dell’art. 145, comma 2, della Costituzione;
f ) dell’ avvocato del popolo;
g ) degli organi degli Enti locali;
h ) degli organi delle comunita religiose;
i ) dei partiti politici e delle altre organizzazioni;
j ) delle persone fisiche.
2. I soggetti previsti dalle lettere f, g, h, i, j del comma 1 di questo arti-colo,possono adire la Corte solo per le questioni che li concernono.
28 PARTE IX:LA MAGISTRATURA
Articolo 135
1. La funzione giurisdizionale e esercitata dalla Corte suprema, dalla Corted’appello e dal Tribunale di primo grado, i quali sono istituiti secondole norme di legge.
2. L’Assemblea puo istituire con legge Corti aventi competenze in materiespecifiche, ma in nessun caso Corti straordinarie.
63
Articolo 136
1. I componenti dalla Corte suprema sono nominati dal Presidente dellaRepubblica, con il consenso dell’Assemblea.
2. Il Presidente e nominato tra i suoi membri secondo la procedura pre-vista dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Presidente ed i giudici della Corte suprema sono nominati per noveanni e non possono essere nominati di nuovo.
4. Altri magistrati sono nominati dal Presidente della Repubblica su des-ignazione del Consiglio superiore della magistratura.
5. Possono essere Giudici solo i cittadini laureati in giurisprudenza. Lecondizioni e le procedure sono stabilite dalla legge.
Articolo 137
1. Il giudice della Corte suprema puo essere incriminato solo con il con-senso dell’Assemblea.
2. Il giudice della Corte suprema puo essere sottoposto a fermo giudiziariose colto in flagranza o quasi flagranza di reato. L’organo competentene da comunicazione immediata alla Corte costituzionale. Quando laCorte costituzionale non confermi entro ventiquattro ore il rinvio agiudizio del giudice arrestato, l’organo competente e tenuto a rilasciarlo.
3. Gli altri giudici sono incriminati solo con il consenso del Consiglio su-periore della Magistratura.
4. I giudici possono essere sottoposti a fermo giudiziario se colti in fla-granza di reato o quasi flagranza di reato. L’organo competente ne dacomunicazione immediata al Consiglio Superiore della Magistratura.Se il Consiglio Superiore della Magistratura non conferma il rinvio agiudizio entro ventiquattro ore, l’organo competente e tenuto a rilas-ciarlo.
Articolo 138
1. La carica di giudice e a tempo .indeterminato, la retribuzione e gli altriproventi non possono essere diminuiti.
64
Articolo 139
1. Il mandato di giudice della Corte suprema cessa quando il componente:
a ) e condannato con sentenza definitiva per aver commesso un reato;
b ) si assenta ingiustificatamente per piu di sei mesi;
c ) compie l’eta di sessantacinque anni;
d ) rassegna le dimissioni;
e ) e dichiarato incapace d’agire con sentenza definitiva.
2. La cessazione del mandato di giudice e dichiarata dalla Corte suprema.
Articolo 140
1. Il giudice della Corte suprema puo essere dichiarato decaduto dall’Assemblea con voto favorevole dei dei due terzi dei componenti, perviolazione della Costituzione, per aver commesso un reato, per inca-pacitafisica e mentale nonche per aver compiuto gesti e comportamentidisonorevoli per la posizione e l’immagine del giudice. La decisionedell’ Assemblea viene riesaminata dalla Corte costituzionale, la qualeverificando tale motivo, dichiara la decadenza dalla carica.
Articolo 141
1. La Corte suprema ha giurisdizione in unico grado ovvero in sede diimpugnazione. Ha giurisdizione in unico grado quando giudica sulleaccuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente ed i membridel Consiglio dei Ministri, i deputati, i giudici della Corte Suprema edi Giudici della Corte costituzionale.
2. Per l’uniformita o la modifica degli indirizzi giurisprudenziali, la Cortesuprema puo assegnare determinate cause per riesame alle Sezioni Unite.
Articolo 142
1. Le sentenze devono essere motivate.
2. La Corte suprema deve rendere pubbliche le sue decisioni unitamenteall’opinione della minoranza.
3. Gli organi dello Stato sono tenuti ad eseguire le sentenze.
65
Articolo 143
1. L’ufficio di magistrato e incompatibile con ogni carica ed ufficio pub-blico e privato.
Articolo 144
1. Le Corti hanno bilancio distinto, con amministrazione autonoma. Essepredispongono il loro bilancio secondo la legge.
Articolo 145
l. I giudici sono indipendenti e sono soggetti solo alla Costituzione e alle leggi.2. Quando i giudici reputano una legge in contrasto con la Costituzione,non laapplicano. In questo caso, sospendono il giudizio e rimettono la questione allaCorte costituzionale. Le sentenze della Corte costituzionale sono vincolantiper tutte le Corti.
1. Le interferenze nella funzione della Magistratura comportano le respon-sabilita stabilite dalla legge.
Articolo 146
1. Le Corti emanano le sentenze in nome della Repubblica.
2. Le sentenze sono sempre pronunciate pubblicamente.
Articolo 147
1. Il Consiglio superiore della Magistratura e composto dal Presidentedella Repubblica, dal Presidente della Corte suprema, dal Ministrodella giustizia, da tre membri eletti dall’Assemblea e da nove giudici ap-partenenti ai vari gradi, i quali sono eletti dalla Conferenza GiudiziariaNazionale. I membri elettivi durano in carica cinque anni e non sonoimmediatamente rieleggibili.
2. Il Presidente delle Repubblica presiede il Consiglio superiore della Mag-istratura.
3. Il Consiglio superiore della Magistratura, su proposta del Presidente,sceglie fra i suoi membri un vicepresidente. Il vicepresidente organizzal’attivita del Consiglio superiore della Magistratura e presiede le riu-nioni in assenza del Presidente della Repubblica.
66
4. Il Consiglio superiore della Magistratura decide il trasferimento di mag-istrati e i provvedimenti disciplinari in conformita alla legge.
5. I magistrati sono inamovibili, salvo il caso di necessita organizzativedell’ ordinamento giudiziario o per la volonta dei magistrati stessi.
6. Il giudice puo essere dichiarato decaduto dal Consiglio superiore dellaMagistratura per avere commesso un crimine, per incapacita mentaleo fisica, per atti e comportamenti che discreditano gravemente la po-sizione e l’immagine del giudice o per incapacita professionale. Controquesta decisione il giudice ha diritto di ricorrere alla Corte Suprema,la quale, in questo caso, decide a Sezioni unite.
29 PARTE X:IL PUBBLICO MINISTERO
Articolo 148
1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale e rappresenta in giudiziola parte che accusa in nome dello Stato.Il pubblico ministero esercitaanche altre funzioni stabilite dalla legge.
2. L’organizzazione e le funzioni dell’ufficio del pubblico ministero sonoquelle di un organo centrale presso il sistema giudiziario.
3. Nell’esercizio delle loro funzioni i pubblici ministeri sono soggetti allaCostituzione e alle leggi.
Articolo 149
1. Il procuratore generale e nominato dal Presidente della Repubblica conil consenso dell’Assemblea.
2. Il procuratore generale puo essere dichiarato decaduto dal Presidentedella Repubblica su proposta dell’ Assemblea, per violazione della Cos-tituzione o per grave violazione di legge durante l’esercizio delle suefunzioni, per incapacita fisiche o mentali, per gesti e comportamentidisonorevoli per l’immagine e la posizione del procuratore.
3. Gli altri procuratori sono nominati o revocati dal Presidente della Re-pubblica su proposta del procuratore generale.
4. Il procuratore generale informa costantemente l’Assemblea sulla situ-azione della criminalita.
67
30 PARTE XI:IL REFERENDUM
Articolo 150
1. Il popolo, su iniziativa di cinquantamila elettori, puo procedere al ref-erendum per l’abrogazione di Una legge, nonche puo chiedere al Presi-dente della Repubblica l’indizione del referendum per i casi di partico-lare importanza.
2. L’Assemblea, su proposta di non meno di un quinto dei deputati osu proposta del Consiglio dei Ministri, puo stabilire che una questioneo un progetto di legge di importanza particolare siano sottoposti alreferendum.
3. I principi e la procedura per lo svolgimento del referendum nonche leregole sulla sua validita sono previsti dalla legge.
Articolo 151
1. La legge approvata con referendum viene promulgata dal Presidentedella Repubblica.
2. Non e ammesso referendum per questioni concernenti l’integrita terri-toriale della Repubblica dell’Albania, la limitazione delle liberta e deidiritti fondamentali dell ’uomo, il bilancio e le questioni tributarie, ladichiarazione dello stato d’emergenza, la dichiarazione dello stato diguerra o di pace, l’amnistia e l’indulto.
3. Il referendum relativo alla stessa questione non puo essere ripetutoprima che siano trascorsi tre anni.
Articolo 152
1. La Corte costituzionale esamina preliminarmente la costituzionalitadelle questioni sottoposte al referendum, secondo l’art. 150 commi1 e 2, l’art. 151 commi 2 e 3 e secondo l’art. 177 commi 4 e 5, entrosessanta giorni.
2. L’importanza di questioni particolari, previste all’art. 150 commi 1 e2,non e sottoposta all’esame della Corte costituzionale.
3. La data del referendum e fissata dal Presidente della Repubblica en-tro quarantacinque giorni dalla adozione della decisione positiva dellaCorte costituzionale o dalla scadenza del termine entro il quale la Corte
68
costituzionale doveva pronunciarsi. Nel corso di ciascun anno tutti ireferendum si svolgono nel medesimo giorno.
31 PARTE XII:LA COMMISSIONE CEN-
TRALE DELLE ELEZIONI
Articolo 153
1. La Commissione centrale delle elezioni e l’organo permanente che prepara,sorveglia, dirige e verifica tutti gli aspetti concernenti le elezioni ed ireferendum e ne proclama i risultati.
Articolo 154
1. La Commissione e composta da sette membri, eletti per un mandato disette anni. Due componenti sono eletti dall’Assemblea, due dal Presi-dente della Repubblica, tre dal Consiglio superiore della Magistratura.
2. La composizione della Commissione centrale delle elezioni si rinnovaogni tre anni secondo le procedure stabilite dalla legge.
3. La carica di membro della Commissione e incompatibile con altre at-tivita statali o politiche.
4. I soggetti elettorali designano le loro rappresentanze, presso la Com-missione, prive del diritto di voto.
5. Il componente della Commissione gode dell’immunita dei membri dellaCorte suprema.
6. La Commissione ha autonomia di bilancio.
32 PARTE XIII:LE FINANZE PUBBLICHE
Articolo 155
1. Le tasse, le imposte regionali e nazionali, lo sgravio o l’esonero da esse dialcune categorie di contribuenti, nonche le modalita della loro esazionesono determinate dalla legge. In questi casi la legge non puo avereefficacia retroattiva.
69
Articolo 156
1. Lo Stato puo chiedere o garantire prestiti e crediti finanziari, nei casiprevisti dalla legge.
Articolo 157
1. Il sistema finanziario e composto dal bilancio dello Stato e dai bilanciregionali.
2. Il sistema finanziario e costituito dalle entrate relative alle tasse, alleimposte e agli altri obblighi finanziari, nonche dalle altre entrate le-gali.Esso inoltre include tutte le spese statali.
3. Gli enti locali stabiliscono e riscuotono le tasse e le altre imposte dovuteconformemente alla legge.
4. Gli organi statali e locali sono obbligati a rendere pubbliche le entratee le spese.
Articolo 158
1. Il Primo Ministro, a nome del Consiglio dei Ministri, presenta all’ As-semblea il progetto di legge di bilancio dello Stato durante la sessioneestiva, che non puo essere chiusa prima della sua approvazione.
2. Se il progetto di legge non viene approvato entro l’inizio del successivoanno finanziario, il Consiglio dei Ministri puo spendere ogni mese undodicesimo del bilancio dell’ anno precedente, fintanto che non vengaapprovato.
3. L’Assemblea approva il nuovo bilancio entro tre mesi dall’ultimo giornodell’ anno finanziario precedente, salvo il caso di misure straordinarie.
4. Il Consiglio dei Ministri e obbligato a presentare all’Assemblea il rap-porto concernente l’applicazione del bilancio e il debito statale dell’annoprecedente.
5. L’Assemblea decide definitivamente dopo la presentazione del rapportodella Corte dei conti.
Articolo 159
1. I principi e le procedure di formazione del progetto di bilancio, e diapplicazione del bilancio stesso sono determinati dalla legge.
70
Articolo 160
1. Durante l’anno finanziario, l’Assemblea puo apportare cambiamenti albilancio.
2. I cambiamenti al bilancio si operano secondo le procedure previste perla proposta e l’approvazione del bilancio stesso.
3. Le spese previste dalle altre leggi non possono essere diminuite fin tantoche queste leggi siano in vigore.
Articolo 161
1. La Banca centrale dello Stato e la Banca dell’ Albania. Essa ha ildiritto esclusivo di emissione e circolazione della moneta albanese, diapplicazione indipendente della politica monetaria e del possesso edell’amministrazione delle riserve valutarie della Repubblica albanese.
2. La Banca dell’Albania e diretta da un consiglio presieduto dal Gover-natore. li Governatore e eletto per sette anni dall’Assemblea su indi-cazione del Presidente della Repubblica e puo essere rieletto.
33 PARTE XIV:LA CORTE DEI CONTI
Articolo 162
1. La Corte dei conti e l’istituzione piu alta preposta al controllo eco-nomico e finanziario. Essa e soggetta solo alla Costituzione e alle leggi.
2. Il Presidente della Corte viene eletto e revocato dal Parlamento suproposta del Presidente della Repubblica; rimane in carica per setteanni ed e rieleggibile.
Articolo 163
1. La Corte dei conti controlla:
a ) l’attivita economica delle istituzioni statali e delle altre persone giuridiche statali;
b ) l’ agibilita e la salvaguardia dei fondi statali, degli organi statali,centralie locali;
71
c ) l’attivita economica delle persone giuridiche, nelle quali lo Stato hapiu di meta della partecipazione e delle azioni, o quando i debiti,i crediti e gli oneri siano garantiti dallo Stato.
Articolo 164
1. La Corte dei conti presenta all’Assemblea:
a ) la relazione per l’applicazione del bilancio dello Stato;
b ) il parere sul rapporto del Consiglio dei Ministri per le spese dell’anno finanziario precedente prima dell ’ approvazione da partedell’Assemblea;
c ) un’informativa sui risultati dei controlli, quando sia richiesta dell’Assemblea.
2. La Corte dei conti presenta all’Assemblea il rapporto annuale sullapropria attivita.
Articolo 165
1. Il Presidente della Corte dei conti puo essere invitato a parteciparecon diritto di parola alle riunioni del Consiglio dei Ministri, quando siesaminano questioni relative alle sue funzioni.
2. Il Presidente della Corte dei conti gode dell’immunita dei giudici dellaCorte suprema.
34 PARTE XV:LE FORZE ARMATE
Articolo 166
1. I cittadini albanesi hanno il dovere di partecipare alla difesa della Re-pubblica dell’Albania, secondo le modalita previste dalla legge.
2. Il cittadino che, per motivi di coscienza, non accetti il servizio militarenelle forze armate e obbligato a prestare un servizio alternativo, secondole modalita previste dalla legge.
Articolo 167
1. I militari in servizio attivo non possono avere altre cariche statali nepartecipare a partiti o ad attivita politiche.
72
2. Gli appartenenti alle forze armate o le persone che prestano servizialternativi godono di tutti i diritti e delle liberta costituzionali, esclusoi casi in cui la legge preveda diversamente.
Articolo 168
1. Le Forze Armate della Repubblica albanese sono composte dalle forzeterrestri, marittime ed aeronautiche.
2. Il Presidente della Repubblica e Comandante delle Forze Armate.
3. Il Consiglio di sicurezza nazionale e organo di consulenza del Presidentedella Repubblica.
Articolo 169
1. Il Presidente della Repubblica, durante lo stato di pace, dirige le ForzeArmate attraverso il Primo Ministro ed il Ministro della Difesa.
2. Il Presidente della Repubblica, in stato di guerra, nomina e revoca ilComandante delle Forze Armate su proposta del Primo Ministro.
3. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, nominae revoca il Capo di Stato maggiore, nonche su proposta del ministrodella Difesa, nomina e revoca i capi delle forze terrestri, marittime edaeronautiche.
35 PARTE XVI:I PROVVEDIMENTI D’EMERGENZA
Articolo 170
1. I provvedimenti d’emergenza si applicano nei casi di stato di guerra,di stato di emergenza o di calamita naturale e durano finche continuatale situazione.
2. I principi dell’attivita degli organi pubblici e la misura delle limitazionidei diritti e delle liberta dell’uomo durante lo stato d’emergenza, sonodeterminati dalla legge.
3. La legge deve indicare i principi, i settori e i modi di indennizzo delleperdite che derivino dalla limitazione dei diritti e delle liberta o sianocausate dai provvedimenti d’emergenza.
73
4. Gli atti adottati in esecuzione delle misure d’emergenza, devono essereproporzionati alla misura del pericolo e devono tendere a ripristinarenel piu breve tempo possibile le condizioni del normale funzionamentodello Stato.
5. Durante il periodo di applicazione delle misure d’emergenza, non deveessere modificato nessuno di questi atti: la Costituzione, le leggi per l’elezione dell’ Assemblea e per gli organi degli enti locali, le leggi per lemisure d’emergenza.
6. Durante il periodo d’applicazione delle misure straordinarie di emer-genza non si svolgono le elezioni locali, non si svolge il referendum enon puo essere eletto un nuovo Presidente. Le elezioni locali vengonosvolte laddove non vi sia applicazione delle misure d’emergenza.
Articolo 171
1. In caso di aggressione armata contro la Repubblica albanese, il Pres-idente dell’Albania, su richiesta del Consiglio dei Ministri, dichiara lostato di guerra.
2. In caso di minaccia dall’estero o quando l’obbligo della difesa deriva daun accordo internazionale, l’Assemblea, su proposta del Presidente dellaRepubblica, dichiara lo stato di guerra, indice lo stato di mobilitazioneo di smobilitazione generale o parziale.
Articolo 172
1. Nel caso dell’art. 171, comma 1, il Presidente della Repubblica presentaall’Assemblea il decreto sullo stato di guerra entro quarantotto ore dallasottoscrizione, specificando i diritti che vengono limitati.
2. L’Assemblea esamina immediatamente il decreto del Presidente dellaRepubblica e delibera su di esso a maggioranza assoluta.
Articolo 173
1. Nel caso di pericolo per il sistema costituzionale e per la sicurezzapubblica, su richiesta del Consiglio dei ministri, si puo applicare, suparte o su tutto il territorio dello Stato, lo stato di emergenza, il qualedura fino a quando continui il pericolo, ma comunque non oltre sessantagiorni.
74
2. Con l’applicazione dello stato di emergenza l’intervento delle Forze Ar-mate e consentito previa decisione dell’Assemblea e solo quando le forzedi polizia non siano in grado di ristabilire l’ordine.
3. La proroga dello stato di emergenza trova applicazione solo con il con-senso dell’Assemblea da rinnovare ogni trenta giorni, per un periodonon superiore a novanta giorni.
Articolo 174
1. Per prevenire o evitare le conseguenze di una calamita naturale o diun incidente tecnologico, il Consiglio dei Ministri puo decidere, per unperiodo non superiore a trenta giorni, lo stato di calamita naturale suuna parte o su tutto il territorio dello Stato.
2. La proroga dello stato della calamita naturale e ammessa solo previoconsenso dell’ Assemblea.
Articolo 175
1. Durante lo stato di guerra o d’emergenza non si limitano i diritti e leliberta previste dagli articoli: 15, 18, 19, 20,21,24,25,29, 30, 31, 32, 34,e 39 comma 1, 41 commi 1, 2, 3 e 5, 42, 43, 48, 54, 55.
2. Durante lo stato di calamita naturale si possono limitare i diritti e leliberta previste dagli articoli 37, 38, 41, comma 4, 49, 51.
3. Gli atti per la dichiarazione dello stato di guerra, lo stato di emergenzae di calamita naturale devono determinare i diritti e le liberta che silimitano ai sensi dei primi due commi del presente articolo.
Articolo 176
1. Quando l’Assemblea non puo essere riunita durante lo stato di guerra,il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri,puo adottare atti aventi forza di legge, i quali devono essere approvatidall’Assemblea nella sua prima riunione.
75
36 PARTE XVII:LA REVISIONE DELLA COS-
TITUZIONE
Articolo 177
1. L’iniziativa di revisione della Costituzione compete a non meno di unquinto dei componenti dell’Assemblea.
2. Nessuna revisione della Costituzione puo essere proposta durante lostato d’emergenza.
3. Il progetto di revisione deve essere approvato da non meno dei due terzidei componenti dell’Assemblea.
4. L’Assemblea puo stabilire, a maggioranza dei due terzi dei componenti,che i progetti di emendamento costituzionale vengano sottoposti a ref-erendum. Il progetto di legge per la revisione della costituzione entra invigore dopo la ratifica con referendum, che si effettua non oltre sessantagiorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea.
5. L’emendamento costituzionale gia approvato e soggetto a referendum,su richiesta di un quinto dei componenti dell’ Assemblea.
6. Il Presidente della Repubblica non ha puo rinviare per riesame unalegge di revisione della Costituzione gia approvata dall’Assemblea.
7. La legge approvata con referendum viene promulgata dal Presidentedella Repubblica ed entra in vigore nella data da essa prevista.
8. La revisione della Costituzione per la stessa questione non puo essereriproposta prima che sia trascorso un anno dal giorno della reiezionedel progetto di legge in Assemblea e non prima che siano trascorsi treanni dalla data di esito negativo del referendum.
37 PARTE XVIII:DISPOSIZIONI TRANSI-
TORIE E FINALI
Articolo 178
1. Le leggi e gli altri atti nonnativi approvati prima dell’entrata in vigoredalla Costituzione restano in vigore finche non sono abrogati.
76
2. Il Consiglio dei Ministri presenta all’Assemblea un progetto di legginecessarie per l’attuazione della presente Costituzione.
Articolo 179
1. Il mandato degli organi Costituzionali esistenti alla data di entrata invigore della Costituzione cessa secondo i tennini previsti dalla legge 29aprile 1991, n. 7491 ”Per le disposizioni principali costituzionali”, conle modifiche e le integrazioni successive.
2. I membri della Corte di cassazione continuano il loro esercizio comemembri della Corte suprema, secondo il mandato precedente.
3. I membri del Consiglio superiore della Magistratura eletti nell’ambitodei pubblici ministeri vengono sostituiti con i membri eletti dalla riu-nione generale dei giudici.
4. Gli enti locali svolgono le loro funzioni finche non cessa il loro mandato.
Articolo 180
1. Gli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica albanese primadell’entrata in vigore dalla Costituzione vigente, si considerano ratifi-cati in conformita alla Costituzione vigente.
2. Il Consiglio dei Ministri sottopone all’esame della Corte costituzionalegli accordi internazionali che contengano disposizioni in contrasto conla Costituzione.
Articolo 181
1. L’Assemblea, entro due/tre anni dall’entrata in vigore della presenteCostituzione, emana le leggi per la sistemazione delle varie questioniconcernenti le espropriazioni e le requisizioni effettuate prima dell’ ap-provazione della. Costituzione vigente, secondo la rafia espressa daicriteri dell’art.41.
2. Le leggi e gli altri atti normativi approvati prima dell’entrata in vigoredella Costituzione vigente concernenti le espropriazioni e le requisizioni,trovano applicazione allorquando non contrastino con essa.
77
Articolo 182
1. La legge 29 aprile 1991, n. 7491, ”Per le disposizioni principali costi-tuzionali”, e le altre leggi costituzionali sono abrogate con l’entrata invigore della presente Costituzione.
Articolo 183
1. La presente Costituzione entra in vigore con la promulgazione da partedel Presidente della Repubblica.
Appendice
38 1) Il processo di formazione
Il 21 ottobre 1998 il Parlamento defmı (approvandola) la Costituzione, laquale e stata sottoposta a referendum nazionale il 22 novembre 1998. Questoprogetto fmale era risultato da un processo intensivo annuale che lo definı,nonche da un vaglio nazionale (da parte della commissione della Venezia delConsiglio dell’Europa e di alcuni redattori di tutti e due le parti), e dalleampie consulte pubbliche. L’intenzione di queste consulte a livello nazionaleera la creazione di un processo di composizione aperto e trasparente, il qualepotesse dare la facolta di partecipare a tutte le parti interessate. La commis-sione Costituzionale per il Referendum, il Ministero del Riforma Legislativaed il centro amministrativo per il Coordinamento dell’Assistenza, la Parte-cipazione del Pubblico, sponsorizzato da OSBE, hanno lavorato insieme conaltre organizzate nazionali e internazionali per raggiungere questo obbiet-tivo. Il successo di questo tentativo fece sı che la Delegazione Parlamentarea tre, del KE, BE, ed OSBE nella Dichiarazione del giugno ’98 ritenne di”congratulare la Commissione per le sue consulte di grande ampiezza”.
Dal dicembre ’97 a settembre del ’98, la Commissione, il Ministero dellaRiforma Costituzionale e QAKAPP lavorarono con altre parti interessate perdare vita ad un piano a due fasi. Succintamente, la I fase del piano compresepiu di dieci forum. e simposium dove si discussero questioni costituzionali enei quali lo Star Tecnico evidenzio l’idea base sulle questioni che il pubblicoconsiderava importanti. Nel frattempo, mentre la I fase continuava, la Com-missione inizio la composizione del testo e nel giugno ’98 defrnı un progettoiniziale; il 5 agosto approvo un testo totalmente rivisto. Dopo di che cominciola II fase, la quale consiste in un esame ampio del testo del 5 agosto, da partedi singoli ed organizzazioni, dentro e fuori dell’Albania. Tutte due le fasi
78
sono state accompagnate da consultazioni di esperti costituzionali stranieri,i quali fecero un’analisi indipendente del contenuto tecnico del progetto. Nelpaese, la Commissione per la composizione della Costituzione, QAKAPP,e altre organizzazioni internazionali organizzarono una serie di sedute pub-bliche per raccogliere i commenti del pubblico sul progetto gia proposto, doveparteciparono centinaia di persone. Queste sedute sono state eseguite da unnumero elevato di esperti, cittadini, politici ed diverse OJQ albanesi, dove laQAKAPP ha raccolto tutti i suggerimenti e i commenti e li ha passati allaCommissione per un riesame.
La QAKAPP sistemo tutti i commenti per aiutare la Commissione edil suo Staff tecnico nel processo di riesame. Si esaminarono centinaia disuggerimenti di cambiamenti e si accettarono piu di 50 cambiamenti propostiriguardo a 45 articoli. In tutto la Commissione emando circa il 25pubblico.Il 30 settembre 1998 la Commissione termino questo processo approvando iltesto definitivo.
Durante il periodo 5-20 ottobre, l’Assemblea riesamino il testo propostodalla Commissione costituzionale, dove sono state incrociate in modo in-tensivo le discussioni nelle commissioni con il dibattito in sede plenaria. IlProgetto e stato esaminato dalle seguenti commissioni: dell ’Ordine Pub-blico e Servizio Informativo Nazionale, dei Lavori Pubblici e Commerciali,dell’Agricoltura ed Alimenti, del Lavoro, degli Esteri, della Sanita e dell’Ambiente,dell ’Economia, delle Finanze e Privatizzazione e quella dei Diritti dell’Uomoe delle Minoranze. Queste sezioni dibattimentali sono state aperte e se-guite liberamente dalla stampa, da esperti nazionali e dal rappresentantedella Commissione di Venezia. Alla chiusura della settimana di esame daparte delle commissioni, la rappresentante della Commissione di Veneziadichiaro senza nessuna esitazione: ”Il Progetto della Costituzione comba-cia pienamente con i modelli democratici Europei”. Per di piu, il progettodefrnitivo approvato il 21 ottobre 1998 contiene tutti i suggerimenti del pub-blico che sono stati accolti dalla Commissione Costituzionale nel suo testodel 30 settembre.
39 2) Quesiti elementari
Protegge la Costituzione la proprieta privata?La Costituzione sanziona che la proprieta privata, l’economia del merca
to e la liberta dell’ attivita economica sono i pilastri del nostro sistema eco-nomico. L’articolo 41 garantisce in concreto il diritto di ognuno a possedereed usare la proprieta privata e prevede che ogni espropriazione della pro-prieta privata da parte dello Stato si puo effettuare soltanto per via di legge
79
e solo per interessi pubblici. In questi casi, il proprietario viene ricompensatoattraverso un ”risarcimento giusto”.
Alla fine, nessun limite del diritto della proprieta puo toccare il suo sig-nificato e non puo andare al di la dei limiti previsti dalla Convenzione Eu-ropea per i Diritti dell’Uomo. Siffatte garanzie possono essere sospese per ladichiarazione dello stato di guerra, lo stato d’emergenza o di disgrazie natu-rali, ma il diritto ad un processo regolare legale ed il diritto che la percentualedel risarcimento per le espropriazioni sia deciso dai tribunali non puo esseresospeso.
La pena di morte: e vietata o e permessa dalla Costituzione?La Costituzione ne pennette ne vieta la pena di morte. L’articolo 21
affenna soltanto che ”la vita della persona e protetta dalla legge”. La Costi-tuzione lascia questa questione alla legislazione futura e alle decisioni giudiziarie
La Costituzione garantisce l’uguaglianza tra i gruppi etnici, religiosi o pernascita?
L’articolo 18 sanziona che tutti sono uguali davanti alla legge. Vieta anchela discriminazione per sesso, razza, fede, etnia, lingua, o in base alle opinionipolitiche, religiose o filosofiche o a causa dell ’istruzione, oppure dello statoeconomico sociale, cosı come per la discendenza patema. Pero questo articolonon ostacola la discriminazione positiva, pennettendo un trattamento o unsostegno particolare per detenninate categorie. Per esempio, la Costituzioneprevede incentivi particolari per l’istruzione di studenti di talento provenientida famiglie con reddito basso. Inoltre, l’articolo 20 prevede anche la pro-tezione delle minoranze. esso garantisce, testualmente, ”piena uguaglianzadavanti alla legge” per le minoranze e stabilisce che: ”esse hanno diritto diesprimere liberamente, senza freni o vincoli di sorta, la loro appartenenzaetnica, culturale, religiosa e linguistica”.
Garantisce la Costituzione la liberta religiosa?La liberta di coscienza e di religione e un diritto fondamentale person-
alissimo. L’articolo 24 garantisce diversi aspetti di questi diritti, compresoanche la scelta personale della religione e delle proprie convinzioni, nonche ilmodo di esprimere queste convinzioni. Tale liberta include il diritto di nonessere obbligato o ostacolato a partecipare ad una comunita religiosa, ne dalGoverno ne da qualche parte privata. Il singolo ha diritto inoltre di tenerele sue convinzioni per se, cioe di non essere obbligato a renderle di pubblicodominio. Le comunita religiose possono configurare la loro amministrazioneinterna come meglio credono.
La Costituzione protegge la liberta di movimento?La liberta di movimento e un diritto personalissimo fondamentale che e
stato limitato grandemente dal regime comunista. La nuova Costituzioneprevede che la limitazione di questo diritto puo avvenire solo in circostanze
80
straordinarie e soltanto per periodi limitati. Nonnalmente, ognuno ha dirittodi scegliere il luogo di residenza e di essere libero di muoversi sul territo-rio dello Stato. I cittadini albanesi non possono essere cacciati dal terri-torio albanese e possono subire l’estradizione solo in base ad una decisionegiudiziaria.
La Costituzione garantisce l’uguaglianza tra i gruppi etnici, religiosi o pernascita?
L’articolo 18 sanziona che tutti sono uguali davanti alla legge. Vieta anchela discriminazione per sesso, razza, fede, etnia, lingua, o in base alle opinionipolitiche, religiose o filosofiche o a causa dell ’istruzione, oppure dello statoeconomico sociale, cosı come per la discendenza patema. Pero questo articolonon ostacola la discriminazione positiva, pennettendo un trattamento o unsostegno particolare per detenninate categorie. Per esempio, la Costituzioneprevede incentivi particolari per l’istruzione di studenti di talento provenientida famiglie con reddito basso. Inoltre, l’articolo 20 prevede anche la pro-tezione delle minoranze. esso garantisce, testualmente, ”piena uguaglianzadavanti alla legge” per le minoranze e stabilisce che: ”esse hanno diritto diesprimere liberamente, senza freni o vincoli di sorta, la loro appartenenzaetnica, culturale, religiosa e linguistica”.
Garantisce la Costituzione la liberta religiosa?La liberta di coscienza e di religione e un diritto fondamentale person-
alissimo. L’articolo 24 garantisce diversi aspetti di questi diritti, compresoanche la scelta personale della religione e delle proprie convinzioni, nonche ilmodo di esprimere queste convinzioni. Tale liberta include il diritto di nonessere obbligato o ostacolato a partecipare ad una comunita religiosa, ne dalGoverno ne da qualche parte privata. Il singolo ha diritto inoltre di tenerele sue convinzioni per se, cioe di non essere obbligato a renderle di pubblicodominio. Le comunita religiose possono configurare la loro amministrazioneinterna come meglio credono.
La Costituzione protegge la liberta di movimento?La liberta di movimento e un diritto personalissimo fondamentale che e
stato limitato grandemente dal regime comunista. La nuova Costituzioneprevede che la limitazione di questo diritto puo avvenire solo in circostanzestraordinarie e soltanto per periodi limitati. Nonnalmente, ognuno ha dirittodi scegliere il luogo di residenza e di essere libero di muoversi sul territo-rio dello Stato. I cittadini albanesi non possono essere cacciati dal terri-torio albanese e possono subire l’estradizione solo in base ad una decisionegiudiziaria.
E garantita la protezione particolare per i diritti delle donne e di altrecategorie?
Regolannente, il trattamento di disuguaglianza da parte dello Stato su
81
basi ”sospettose”, come per esempio la razza o religione, viola il principio dinon discriminazione. Pero, la nuova Costituzione non vieta la discriminazionepositiva. Esplicitamente, prevede ”il diritto alla protezione particolare delloStato” sul matrimonio, sulla famiglia, sui bambini, sulla gioventu, sulle donneincinte e sulle madri giovani.
Qual e la posizione della Procura (o Pubblico Ministero)?La Costituzione dispone che il Procuratore Generale venga nominato dal
Presidente della Repubblica con il consenso dell’Assemblea e venga rimossosu proposta di quest’ultima. Cosi, questa istituzione e collegata con l’organopiu neutro e non partitico della struttura costituzionale, il Presidente dellaRepubblica. Pero, nello svolgimento delle sue funzioni la Procura e soggettasoltanto alla Costituzione e alle leggi e non risponde a nessun altro organo,compresa l’Assemblea ed il Presidente. La Costituzione non mette la Procurasotto le competenze esclusive del Governo.
La Costituzione e stata ispirata da qualche filosofia politica determinata?Assolutamente no. La Costituzione rispecchia due questioni principali:
essa propone modelli di democrazia ampiamente accettati (la liberta delleelezioni, il pluralismo politico, la liberta di parola, l’autonomia del governolocale), secondo lo Stato di diritto (l’ordine costituzionale, la protezionedei diritti dell’uomo, le limitazioni del potere statale, l’indipendenza delpotere giudiziario); inoltre, prevede la divisione ed il bilanciamento dei po-teri. In conclusione, appresta un meccanismo costituzionale che in praticaassicurera all’Albania i benefici della democrazia e dello Stato di diritto,nonche uno Stato flessibile che dirigera il Paese durante la transizione versouna democrazia solida e prospera (ricca). Questi sono i principi cardinali co-muni a tutti gli stati democratici e non sono legati esclusivamente a qualchefilosofia politica o ideologica determinata.
Prevede la Costituzione un Presidente forte o debole? Un Primo Ministroe un Consiglio dei Ministri forte o debole?
In questo contesto, i termini ”forte” e ” debole” sono quasi disorien-tanti. Ogni organo ha il suo influsso particolare sulla struttura generalecostituzionale. In questa Costituzione, solo l’Esecutivo e non anche il Presi-dente eincaricato di svolgere funzioni esecutive e politiche. Per questo motivoil Presidente della Repubblica non viene considerato come parte dell ’Esec-utivo. Pero questo non vuoI dire che il Presidente sia ”debole”. Con lesue ampie competenze riguardo alle nomine degli organi di controllo ed ilsuo ruolo come garante dell’ordine costituzionale, il Presidente e una delleistituzioni fondamentali della struttura costituzionale.
Prevede la Costituzione delle garanzie per i Partiti politici di opposizione?Si. Ogni legge che concerne gli Organi, cosı come l’elezione del Presi-
dente,richiedono la maggiranza dei 3/5 dell’Assamblea.La richiesta di questa
82
maggioranza qualificata da spazio al ruolo dei partitidell’opposizione,per laformazione delle leggi fondamentali e per l’elezione del Presidente, richiedonola maggioranza dei 3/5 dell’Assemblea. La richiesta di questa maggioranzaqualificata da spazio al ruolo dei partiti dell’opposizione, per la formazionedelle leggi fondamentali e per l’elezione del Presidente.
Prevede la Costituzione delle autonomie per i governi regionali?Si. L’articolo 13 della Costituzione prevede esplicitamente che lo Stato
albanese e fondato su principi di decentralizzazione e sulle autonomie region-ali. Inoltre, gli articoli 108-115 evidenziano chiaramente che a diversi organiregionali e garantito il diritto di stipulare contratti, di imporre tasse e diamministrare le entrate e le loro proprieta in maniera indipendente.
40 3) Sintesi dei contenuti costituzionali
Gli elementi base di uno stato democratico si possono formulare in vari modi.La parte prima della Costituzione sanziona i principi fondamentali in baseai quali si organizza il nuovo stato democratico. Questa sezione stabilisceche lo stato albanese sia una repubblica parlamentare basata sulla divisionee soll’equilibrio dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Il sistema eco-nomico della nuova Repubblica si basa sui principi del libero mercato. Leforze armate sono sottoposte al potere e al controllo dell’autorita civile.
I DIRITII E LE LIBERTA FONDAMENTALI DELL’UOMOUn elemento fondamentale della democrazia costituzionale e l’ appli-
cazione di limiti specifici alle competenze dello Stato nei confronti dell’individuo.Questa parte della Costituzione fissa i diritti e le garanzie di cui ogni indi-viduo, albanese o straniero, gode contro eventuali intromissioni dello Statonella sua sfera privata. Le limitazioni di questi diritti sono consentite soloquando si fondano su esigenze di interesse pubblico o di tutela dei diritti al-trui. Ogni limitazione deve essere proporzionale alle circostanze che la hannomotivata e non deve andare al di la dei limiti concordati nella ConvenzioneEuropea dei diritti dell’uomo.
ASSEMBLEANella democrazia costituzionale moderna il potere legislativo viene es-
ercitato da un corpo di rappresentati eletti dal popolo. Questo organo sicompone normalmente di uno o due camere. TI sistema con una camerasi denomina unicamerale, l’altro, con due camere, si denomina bicamerale.La nostra Costituzione prevede una sola camera, l’Assemblea, la quale ecomposta da 140 deputati. L’elezione dei deputati avviene in circoscrizionielettorali territoriali e a livello nazionale attraverso elenchi in cui i candidativengono eletti in proporzione al numero globale dei voti ottenuti dal partito
83
di appartenenza.L’iniziativa legislativa compete al Governo, ad ogni deputato o a 20.000
elettori. Le leggi vengono approvate con la maggioranza dei votanti. Alcuneleggi importanti, come la legge elettorale, richiedono una maggioranza dei3/5 di tutti deputati. Durante l’esame il progetto di legge viene esaminatotre volte. La legge entra in vigore dopo la sottoscrizione del Presidente dellaRepubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAUna caratteristica in comune alle democrazie parlamentari e che il Pres-
idente ha prerogative limitate. Nel sistema albanese al Presidente spettanole prerogative specifiche, normali in una democrazia parlamentare. Le dispo-sizioni attribuiscono al Presidente le funzioni basi del Capo dello Stato: la de-terminazione della data delle elezioni generali per il rinnovo del Parlamento,l’applicazione del diritto di parola, la nomina e la conferma dei magistrati,l’accettazione delle credenziali diplomatiche e l’emanazione della legge. Perquanto riguarda quest’ultima, il Presidente puo opporre il veto su una leggesolo una volta. Il Presidente viene eletto dal Parlamento con la maggioranzadei 3/5 dei deputati, per un mandato di 5 anni. Se non si raggiunge lamaggioranza prescritta, l’Assemblea si scioglie. L’Assemblea nuova elegge ilPresidente con la stessa maggioranza dei 3/5. Se neanche l’Assemblea nuovaraggiunge questa maggioranza, si scioglie ed il nuovo Presidente viene elettodall’ Assemblea successiva con la maggioranza semplice.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL PRIMO MINISTROIl Consiglio dei Ministri in una democrazia parlamentare e organo cen-
trale del potere esecutivo. Il Primo Ministro e Presidente del Consiglio deiMinistri. Se nei confornti del Primo Ministro viene presentata una mozionedi sfiducia, puo essere esonerato solo quando l’Assemblea e in grado di
eleggere un altro Primo Ministro con la maggioranza necessaria (dovuta).Altrimenti, l’Assemblea si scioglie e vengono fatte nuove elezioni. La ParteQuinta prevede un Consiglio dei Ministri forte, il quale determina le politichegenerali e il coordinamento degli altri organi ed istituzioni dell’amministrazionecentrale. Questa funzione di sorveglianza e coordinamento va distinta dallecompetenze, importanti e specifiche, dei singoli Ministri. Ad ogni Ministrovengono attribuite competenze indipendenti riguardo all’amministrazione edorganizzazione all’interno del suo ministero. Il Ministro non puo esercitarealtra funzione statale e non puo essere membro degli organi di societa con[mi di lucro.
MAGISTRATURAIl magistrato (il giudice) provvede alla risoluzione delle controversie con-
cernenti l’interpretazione e l’applicazione delle leggi. La Parte del Progettodella Costituzione sui tribunali prevede un sistema giudiziario di tre gradi:
84
tribunali circondariali, corti dell’appello, corte di Cassazione ed il suo Presi-dente. Tutte le sentenze devono motivare l’applicazione della legge fatta peri casi concreti che, nel caso di specie, sono sottoposti a giudizio. Le sentenzedel Cassazione sono pubblicate.
Inoltre e stato previsto anche il Consiglio Superiore della Giustizia. IlConsiglio Superiore della Giustizia, elegge con l’approvazione del Presidente,i giudici dei diversi gradi. Il Presidente, con il consenso dell’Assemblea,elegge anche i membri della Cassazione ed il suo Presidente. I giudici godonodi immunita, della quale possono essere privati solo dall’ organo che li hanominati.
LA CORTE COSTITUZIONALELa Corte costituzionale e incaricata di risolvere le controversie costituzion-
ali concernenti la divisione dei poteri, nonche di esaminare i ricorsi individ-uali quando riguardano violazione dei diritti costituzionali. La Costituzioneprevede una Corte costituzionale di 9 membri, che puo esaminare vari ap-pelli costituzionali, compreso le questioni attinenti alla divisione dei poteri edalle violazioni dei diritti individuali. Secondo la costituzione, la Corte Cos-tituzionale svolgera una giurisdizione meno ampia di quella esistente. Peresempio, non ha competenze di esaminare questioni per propria iniziativa.
IL GOVERNO LOCALELa parte della Costituzione che riguarda il governo locale disciplina le
attrlbuzioni del potere locale, compreso il potere di imporre tasse, l’ em-anazione degli atti aventi forza di legge e i rapporti contrattuali. La creazionedelle strutture autonome dei governi locali opera il decentramento del poterestatale e comporta un legame piu stretto tra i cittadini e le strutture politichegovernative. Tale concetto trova posto anche nella parte dei ”principi fonda-mentali” della Costituzione. Queste disposizioni sono in accordo anche conla promessa pubblica del governo albanese di aderire alla Carta Europea sull’autogoverno locale.
ALTRE PARTILa Costituzione contiene disposizioni non ascrivibili ad alcuna categoria
particolare. Queste disposizioni riguardano l’ Avvocato del Popolo (ombuds-man), il referendum, le fmanze pubbliche, le forze armate, il controllo superi-ore dello Stato, la commissione centrale delle elezioni e le misure d’emergenza.La maggior parte di queste disposizioni, come quelle relative all’avvocato delpopolo, costituiscono una novita assoluU!, per l’Albania, le altre hanno avutedisposizioni analoghe anche nelle legislazioni precedenti.
85