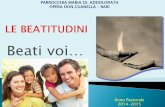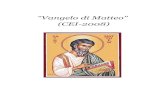"Il perché dei gelsomini"
-
Upload
antonello-mangano -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of "Il perché dei gelsomini"
2
Alberto Sciortino
Il perché dei gelsomini Tunisia. Le cause della rivoluzione che ha rovesciato Ben Alì
Sembrava monolitico. Godeva di grandi appoggi in Italia e Francia. Eppure il
potere del presidente-dittatore della Tunisia si è sgretolato in poco tempo. Perché?
La rivoluzione dei gelsomini è nata dalla rabbia del popolo affamato o dal desiderio
di libertà? Chi sono i giovani che hanno animato le rivolte? E quelli che fuggono
verso l’Italia? Da chi è formato il blocco sociale che ha creato una nuova prospettiva
nel Mediterraneo?
terrelibere.org
Edizione 1.0 [marzo 2011]
4
Alberto Sciortino (Palermo, 1960) è responsabile di progetti di
sviluppo economico in vari paesi africani, mediterranei e
latinoamericani per il CISS, “Cooperazione Internazionale Sud
Sud”, Ong con sede a Palermo. E' altresì autore di saggi e articoli
sui problemi economici dei paesi poveri. Per Baldini e Castoldi ha
pubblicato “L'Africa in guerra. I conflitti africani e la
globalizzazione” (2008).
Terrelibere.org produce e raccoglie dal 1999 inchieste e ricerche
sui rapporti tra Nord e Sud del Mondo, la mafia, le migrazioni,
l’economia e la disuguaglianza. Tutti i materiali sono diffusi
liberamente su licenza Creative Commons. Dal 2009 diventa casa
editrice.
7
Un potere monolitico?
Bisogna partire dagli avvenimenti, per ritrovarvi dei dettagli che ci pongono delle
questioni e ci obbligano a cercare delle risposte.
A seguito di settimane di forti proteste, a cui il regime aveva reagito con la
violenza, con un bilancio finale ufficiale di 234 morti, il presidente Zine el Abdine
Ben Alì è stato obbligato a lasciare il paese. In realtà, sembra che l’idea originaria di
Ben Alì e del suo entourage fosse di aspettare un rilassamento della situazione per
rientrare nel suo paese, ed è in questo senso che il governo – coordinato da diversi
anni da Mohammad Ghannouchi – e il partito al potere – il RCD – avevano deciso di
passare la presidenza temporanea della repubblica allo stesso Ghannouchi sulla base
dell’articolo della Costituzione applicabile ai casi assenza temporanea del presidente
della repubblica. Era il 14 gennaio 2011.
L’indomani – una volta partito il presidente – gli stessi soggetti politici decidono,
invece, di passare all’applicazione di un altro articolo della Costituzione (l’art. 57),
applicabile ai casi di assenza definitiva del capo dello stato. La presidenza era
dunque affidata al presidente della Camera dei Deputati, Fouad Mbazaa, mentre
Ghannouchi rientrava nel proprio ruolo di primo ministro e annunciava un nuovo
governo, detto «d’unità nazionale» post-Ben Alì.
Bisogna porsi la questione su che cosa sia realmente successo tra il 14 e il 15
gennaio. Che cosa ha potuto condurre i decisori politici tunisini a cambiare
radicalmente d’attitudine nelle 24 ore successive alla fuga del presidente? Cosa li ha
convinti a passare da un tentativo di “raffreddare” la situazione, per favorire il suo
rientro, alla dichiarazione d’apertura di una nuova fase, nella quale l’ex presidente,
diversi membri della sua famiglia e alcuni suoi collaboratori venivano ufficialmente
perseguiti dalla giustizia?
Certamente, si può pensare che la deposizione definitiva di Ben Alì fosse già nei
programmi di Ghannouchi e dei suoi collaboratori al momento in cui Ben Alì saliva
sull’aereo che l’avrebbe condotto in Arabia Saudita, ma questo non cambia molto i
termini della questione: come un potere che fino al giorno prima sembrava
8
totalmente monolitico intorno al suo presidente-dittatore ha potuto decidere di
sbarazzarsene in così poco tempo?
Ci sono due risposte possibili, e nessuna delle due basta da sola. La prima è –
certamente – la pressione della folla in strada. E' questa pressione che ha scatenato
tutte le dinamiche seguenti. Ma la seconda, senza la quale si può giurare che la
reazione alle proteste sarebbe stata una repressione ancora più violenta, fino al
rischio di un vero bagno di sangue e alla guerra civile, è che il potere tunisino non
era talmente monolitico come appariva.
9
La rivolta di chi?
Si è molto parlato in Tunisia, durante i giorni della rivolta, del ruolo dell’esercito.
In quest’elemento sta probabilmente una parte della verità. Per comprenderlo
bisogna aprire una piccola parentesi. Dal punto di vista militare, il potere tunisino in
questi ultimi anni si è basato meno sull’esercito che sulla polizia e su certi corpi
specializzati, compresa la guardia presidenziale, la sola a essere ben equipaggiata e
formata, e molto meglio pagata in rapporto all’esercito. Secondo i dati disponibili, la
polizia in Tunisia ha un numero d’effettivi che supera largamente quello
dell’esercito.
Durante le manifestazioni, tra dicembre 2010 e gennaio 2011, la polizia ha spesso
sparato sulla folla. I suoi dirigenti sono dunque responsabili della maggior parte
delle vittime di quei giorni. Di contro, l’esercito ha giocato in quei giorni un ruolo di
barriera tra la polizia e i manifestanti. Si è persino sentito parlare di episodi nei quali
l’esercito avrebbe disarmato la polizia per impedirle di sparare sulla folla.
Che ciò corrisponda o no alla realtà, certo è che i manifestanti hanno subito capito
la differenza d’attitudine tra i due corpi repressivi: li si è visti spesso nascondersi
dietro i carri militari e ancora molto giorni dopo la partenza di Ben Alì si potevano
vedere persone che si facevano fotografare accanto a questi carri coperti di fiori.
Va detto che le gerarchie militari hanno fatto prova di coraggio nella loro scelta di
campo, che – con un diverso sviluppo degli avvenimenti – sarebbe potuto costare
loro molto caro. Ma quest’atteggiamento dell’esercito non è di certo nato ieri, nei
giorni della rivolta. Ha invece delle radici nell’evoluzione della società e del potere
durante questi ultimi dieci anni, evoluzione che non riguarda solo l’esercito.
La scelta di campo di quest’ultima prova che una parte dell’establishment tunisino
non condivideva il sostegno senza condizioni al sistema di potere rappresentato da
Ben Alì. Si può star certi – e i giorni seguenti l’avrebbero provato ulteriormente –
che i militari non erano i soli in questa posizione.
Essi sapevano di poter contare su un consenso che hanno correttamente valutato
10
come maggioritario, senza il quale si sarebbero invece conformati all’ordine di
repressione. Capire chi, nelle differenti fasce sociali e nelle differenti istituzioni, ha
accolto favorevolmente la possibilità di sbarazzarsi di Ben Alì è oggi importante per
capire le prospettive della rivolta tunisina.
11
Povertà, privilegi e ricchezza
Si è molto discusso ultimamente se questa rivoluzione sia stata l’ennesimo (e il più
forte) dei “moti del pane” che il paese aveva già diverse volte conosciuto in passato, o
piuttosto una rivolta moderna, che non aveva nulla a che fare con la fame, ma era
l’espressione di genti che reclamavano le loro libertà e i loro diritti di cittadinanza.
A mio avviso non c’è alcun dubbio che la rivolta sia stata inizialmente lanciata dalle
fasce più sfavorite della parte più povera del paese. Il fatto stesso che le prime zone
interessate siano situate nelle regioni dell’interno colpite dalla disoccupazione e che
vivono su un’agricoltura quasi al limite della sussistenza lo prova (Sidi Bouzid,
Kasserine, Thala, …). Ma già qui bisogna sfumare il giudizio. Queste zone interne
hanno condizioni complesse, che non possono essere riassunte efficacemente con la
semplice parola “povertà”.
La povertà in Tunisia esiste, ma esiste (come – si potrebbe dire – ormai quasi
dappertutto nel mondo) sotto forme molto diversificate e con una localizzazione
molto irregolare. “Le povertà” – piuttosto che “la povertà” – si manifestano in quelle
zone interne per esempio con l’aspetto delle donne rimaste spesso sole a gestire
piccole imprese agricole familiari senza prospettiva e totalmente emarginate dalla
vita sociale; o con il viso delle ragazze avviate (anche dalle ONG!) a dei corsi di
formazione in ricamo, tappezzeria, taglio e cucito che nella migliore delle ipotesi
daranno loro solo la possibilità di essere sfruttate dagli intermediari che
acquisteranno i loro tappeti a prezzi derisori per venderli sui mercati turistici con
guadagni che loro non potranno neppure immaginare; o ancora nelle persone dei
giovani che hanno studiato – spesso fino al diploma, a volte fino alla laurea – e che
non sanno come utilizzare il loro titolo, ma che di contro – com’è stato evocato
spesso – sanno bene utilizzare Internet, persino in un paese in cui la censura
rendeva quest’operazione complicata, a volte pericolosa.
La povertà è quella delle famiglie intere che vivono ancora della raccolta di legna e
piante nel bosco, lontano, molto lontano dagli occhi dei turisti che acquistano a
buon prezzo il pacchetto tutto compreso della Tunisia delle spiagge e dei nuovi suq
12
“antichi” di Hammamet.
Per molti giovani di queste zone interne per molto tempo la possibilità di uscire
dalla loro situazione di disagio era affidata alla speranza di emigrare, ma con gli
accordi ogni giorno più restrittivi tra i paesi delle due rive del Mediterraneo per
impedire le migrazioni, questa possibilità ultimamente si è ridotta in modo radicale.
Ciò che resta è dunque la vita monotona in villaggi privi della minima occasione
culturale.
Fuori della capitale non ci sono né cinema né librerie, né possibilità di sport o di
svago; al di fuori degli hotel della costa non ci sono neppure discoteche; la
televisione, la radio, la stampa sono solo i portavoce del regime; i soli luoghi
d’incontro sono i caffé frequentati unicamente da uomini e dove le giovani
generazioni sono costantemente sottoposte al giudizio degli anziani; i soli negozi
sono quelli d’alimentari e attrezzi agricoli. L’ambiente in cui si trovano questi
villaggi è stato devastato dall’abbandono delle colture, dalla crescente
desertificazione, dalle costruzioni senza regole e dall’onnipresenza dei rifiuti e delle
discariche abusive. Tutto questo fa parte della “povertà” allo stesso titolo della
mancanza d’impiego e di reddito.
E ancora, se l’impiego c’è, rischia a volte di rappresentare un’altra forma di
povertà, quando si tratti di lavoro nelle fabbriche (spesso straniere, o nazionali ma
che lavorano su commissione straniera) che basano la propria esistenza sul basso
costo della manodopera e sull’assenza totale di diritti, fino al punto che i salari non
arrivano ad aiutare le famiglie d’origine degli operai e delle operaie ma, al contrario,
sono le famiglie che devono integrare i redditi con il lavoro domestico o l’impiego
nel settore informale – a volte anche dei minori. E nelle zone turistiche la situazione
dei dipendenti non è differente, e spesso le occasioni di lavoro sono veicolate
attraverso le agenzie d’impiego interinale che finiscono per intercettare una parte
importante del reddito.
Povertà è anche la vita delle persone anziane, spesso analfabete, lasciate a sé stesse
o alla sola solidarietà familiare, che fortunatamente non è ancora scomparsa nel
paese, ma che finisce per trasformarsi in carichi di lavoro supplementare per le
donne. Povertà è quella delle migliaia e migliaia di persone che negli