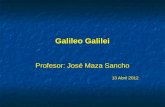Galileo Galilei
-
Upload
crocetti-simona -
Category
Documents
-
view
136 -
download
0
description
Transcript of Galileo Galilei

GALILEO GALILEIGalileo Galilei nacque a Pisa il 15 febbraio 1564 da genitori della media borghesia, a Firenze compì i primi studi di letteratura e logica, per volere del padre si iscrisse alla facoltà di medicina di Pisa, ma non era molto interessato e tornò a Firenze senza titoli accademici. Qui approfondì la matematica sotto un discepolo del celebre Tartaglia e cominciò a compiere osservazioni fisiche. Scoprì l’isocronismo delle oscillazioni pendolari e formulò alcuni teoremi di geometria e meccanica, dallo studi di Archimede scoprì la bilancetta per determinare il peso specifico dei corpi. Diede anche saggio della sua cultura letteraria con due lezioni all’accademia fiorentina: Circa la figura, sito e grandezza dell’Inferno di Dante e nelle Considerazioni sul Tasso . Nel 1589 ottenne la cattedra di matematica dell’università di Pisa dove rimase tre anni, poi passò a Padova, dove trascorse 18 anni. Con la costruzione del cannocchiale si aprì la serie delle grandi scoperte astronomiche che annunciò nel Sidereus nuncius (Ragguaglio astronomico) del 1610. Keplero riconobbe subito l’esattezza e l’importanza di tali scoperte. Proprio però le scoperte astronomiche e le idee copernicane lo misero in urto con gli aristotelici e le gerarchie ecclesiastiche. L’opera di Copernico venne messa all’indice, ma Galileo continuò i suoi studi e pubblicò Il saggiatore e continuò a lavorare al Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il tolemaico ed il copernicano, che stampò nel 1632 ma fu subito citato dal papa a comparire davanti al Tribunale del Sant’Uffizio a Roma. Il processo durò vari mesi e si concluse con l’abiura di Galilei . Il carcere a vita gli fu tramutato in confino prima a Siena e poi presso la sua villa di Arcetri dove fu assistito dalla figlia suor Maria Celeste. Qui scrisse il suo capolavoro scientifico: Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (teoria della resistenza dei materiali e la dinamica). L’8 gennaio 1642 Galileo muore ormai cieco.
LA BATTAGLIA PER L’AUTONOMIA DELLA SCIENZA E IL RIFIUTO DEL PRINCIPIO D’AUTORITA’Il primo risultato decisivo dell’opera di Galileo è la difesa dell’autonomia della scienza da ogni ingerenza esterna. Altri dotti avevano scelto di non sfidare le autorità costituite e tenevano celate le loro scoperte. Galileo invece intuisce che la battaglia per la libertà della scienza era una necessità storica di primaria importanza. La sua lotta riguardò due fronti: l’autorità religiosa e l’autorità culturale (aristotelici).Polemica contro la chiesa e contro i teologi. La controriforma aveva stabilito che ogni sapere doveva essere in armonia con le sacre scritture, come esse venivano interpretate dalla chiesa stessa. Applicato alla nuova scienza, questo decreto generava un problema: se il credente doveva attenersi solo al messaggio della Bibbia. Galileo invece pensa che una posizione del genere ostacolava il libero sviluppo del sapere e danneggiato la stessa religione. Di conseguenza nelle “Lettere Copernicane” Galileo affronta il problema dei rapporti tra scienza e fede, pervenendo al seguente schema di soluzione: la natura, oggetto della scienza, e la bibbia, base della religione, derivano entrambe da Dio, e come tali non possono contraddirsi tra loro. Eventuali contrasti sono quindi soltanto apparenti e vanno risolti rivedendo l’interpretazione della Bibbia, operazione tanto più legittima per Galilei se si pensa:- che le scritture hanno dovuto adeguarsi alle possibilità di comprensione di popoli rozzi ed usare quindi un linguaggio più semplice, mentre la natura e le sue leggi seguono un corso inesorabile ed immutabile.- la bibbia non contiene principi che riguardano leggi di natura ma verità che si riferiscono al destino ultimo dell’uomo. In conclusione, se la bibbia è arbitra nel campo etico e religioso, la scienza è arbitra nell’ambito delle verità naturali, non è la scienza che deve adattarsi alla bibbia ma il contrario. La posizione galileiana ha finito per imporsi non solo alla cultura laica ma anche alla chiesa, che con il tempo è pervenuta a riconoscere l’autonomia operativa della scienza nel campo delle conoscenze naturali.La polemica contro gli aristotelici. Indipendente dalla autorità della bibbia, la scienza lo deve essere altrettanto nei confronti di quella culturale di Aristotele e dei sapienti del passato. Galileo mostra grande stima per lo stagirita e per altri scienziati antichi. Il suo disprezzo colpisce i loro infedeli discepoli che invece di osservare direttamente la natura si limitano a consultare testi delle biblioteche. Ma se il filosofo greco tornasse al mondo riconoscerebbe lui come suo genuino discepolo e si mostrerebbe disposto a cambiare le proprie idee. Invece gli aristotelici continuano ad offrire triste spettacolo di un dogmatismo antiscientifico che ostacola l’avanzamento del sapere.
LE SCOPERTE FISICHE E ASTRONOMICHEA) Gli studi fisici. Per comprendere Galileo bisogna conoscere prima le scoperte scientifiche, fisiche ed astronomiche nelle quali si è incarnato. La demolizione della tradizionale visione del cosmo è strettamente connessa ai suoi studi fisici di meccanica e in particolare quella parte che riguarda il moto dei corpi (dinamica). Infatti il problema del moto occupò la mente di Galileo per tutta la vita.

Il principio d’inerzia. Per la fisica aristotelica la quiete era lo stato naturale dei corpi sublunari, essendo il moto qualcosa di temporaneo che viene meno non appena cessa l’applicazione della forza che lo produce. I moti erano di due tipi: naturali e violenti. Naturale è il moto di un corpo che si dirige verso il suo luogo naturale ( corpi pesanti basso, corpi leggeri alto), violento è il moto che conduce fuori dal suo luogo naturale. E per spiegare come i corpi di moto violento (freccia, proiettile) possono continuare a muoversi per un certo tempo in una direzione diversa, si ricorreva all’azione motrice dell’aria. Con l’intuizione teorica del principio di inerzia: un corpo tende a conservare indefinitamente il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme fino a che non intervengono forze esterne a modificarne lo stato, Galileo superava il doppio pregiudizio per cui la quiete è qualcosa di naturale. Galileo non diede mai un enunciazione generale precisa di tale principio, alcuni critici hanno negato che fosse giunto a concepirlo. Il principio di inerzia, utile anche in sede astronomica, spiegava perché il movimento dei pianeti e della terra potesse continuare indefinitamente . La delucidazione scientifica dei moti astrali richiedeva la doppia presenza di una forza centrifuga e una centripeta.Le leggi sulla caduta dei gravi. La fisica aristotelica pensava che la velocità di caduta dei corpi fosse direttamente proporzionale al peso e accelerata dalla spinta dell’aria. Galileo con un ragionamento teorico (esperimenti mentali) giunse a risultati opposti: se due corpi dello stesso peso cadono insieme, e durante la caduta si uniscono, formeranno un corpo unico che avrà un peso doppio, ma che si muoverà alla stessa velocità. Questo significa che tutti i corpi indipendentemente dal loro peso, cadono alla stesa velocità. Se l’esperienza immediata sembra confutare tale legge (es la pietra e la piuma) , questo è dovuto alla resistenza del mezzo, cioè dell’aria, nel vuoto la legge si realizza nella sua purezza. Dato che Galileo non disponeva ancora della pompa ad aria, inventata da Torricelli, dove si possono osservare i corpi cadere nel vuoto, la tradizione vuole che egli abbia eseguito alcuni esperimenti reali lasciando cadere, dall’alto della torre di Pisa, una sfera da una libbra ed una da 100 libbre, constatando che la seconda arrivasse a terra con brevissimo anticipo. Che questo esperimento sia stato eseguito o meno è la conferma delle tesi di Galileo e la smentita di quelle di Aristotele, per quest’ultimo infatti la prima sfera avrebbe dovuto compiere solo la centesima parte del percorso, essendo il peso nel rapporto 100 a 1. Il secondo principio della dinamica. In questo contesto di studi Galileo pervenne al principio per cui le forze applicate ai corpi non causano loro delle velocità, ma delle accelerazioni, proporzionali alle forze che le hanno prodotte. Questo gli permise di determinare il concetto di accelerazione come variazione di velocità e il concetto di massa di un corpo, come rapporto di proporzionalità tra le forze ad esso applicate e le accelerazioni prodotte da tali forze. I celebri esperimenti sul moto uniformemente accelerato sono un ulteriore coronamento a questi studi. Galileo ha spaziato, oltre che nella meccanica, anche nella fisica, dalla termica all’idrostatica, dall’ottica all’acustica, ma le scoperte che lo resero più celebre furono quelle astronomiche.
B) la distruzione della cosmologia aristotelica – tolemaica.La crisi della fisica aristotelica si accompagnano in Galileo alla demolizione del sistema tolemaico. La negazione della diversità di natura tra moti rettilinei (tipici del mondo sublunare), e moti circolari (tipici del mondo sopralunare) porta al rifiuto della diversità di struttura tra cielo e terra , fondata appunto sulla diversità dei rispettivi movimenti. Galileo aveva intuito la verità del copernicanesimo, grazie all’uso del telescopio, egli pervenne ad alcune scoperte comunicate nel Siderus nuncius. Le scoperte astronomiche. Tradizionalmente si riteneva che la Luna fosse rivestita di una superficie liscia e levigata. Le osservazioni telescopiche di Galileo mostrarono come molte delle macchie scure di essa, visibili ad occhio nudo, siano ombre proiettate dalle montagne lunari sotto l’effetto della luce del Sole. Aristotele credeva che soltanto la Terra, essendo immobile, fosse centro di moti astrali, Galileo scoprì i 4 satelliti di Giove, battezzati “pianeti medicei”, che compiono attorno ad esso movimenti analoghi a quelli che la Luna compie attorno alla Terra. Se Giove ruota con i propri satelliti, intorno al Sole, come suppone Copernico, secondo Galileo anche la Terra con il suo satellite, può ruotare intorno al Sole. La cosmologia tolemaica sosteneva che i corpi celesti essendo perfetti fossero incorruttibili e non soggetti al divenire. Questo pregiudizio era già stato messo in dubbio (Ockham) e negato esplicitamente da Cusano, Leonardo e Bruno, con Galileo ricevette il colpo di grazia. Grazie all’uso del telescopio, scoprì sulla superficie del Sole macchie oscure che si formavano e scomparivano, attestando l’esistenza di un processo di trasformazione in atto e dimostrando che anche i corpi celesti erano soggetti a fenomeni di alterazione e mutamento. I rappresentanti della cultura del tempo reagirono sdegnati, chi si rifiutò di guardare al telescopio, ritenendolo uno strumento diabolico o deformante delle immagini, chi non vedeva quello che vedeva Galileo, chi, come un gesuita, formulò ingegnose ipotesi secondo cui le macchie non erano nel Sole ma erano il passaggio di corpi celesti davanti ad esso. Galileo fece allora notare che erano intermittenti e difformi tra loro, e quindi non poteva trattarsi del passaggio di corpi astrali. Nel Medioevo si era sempre creduto che solo la Terra fosse un corpo opaco, illuminato dal Sole e privo di luce propria, la scoperta galileiana delle fasi di Venere, portava a pensare che ricevesse la luce del Sole girandovi attorno, e si poteva

quindi ritenere che la spiegazione fosse valida anche per gli altri pianeti illuminati dal Sole. Sempre grazie al telescopio scoprì che oltre le stelle fisse visibili ad occhio nudo, esistevano innumerevoli altre stelle che formavano galassie e nebulose. Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Durante il pontificato di Urbano VIII, che gli aveva sempre dimostrato benevolenza, Galileo pubblica il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, dietro il pretesto di voler presentare parzialmente i due maggiori modelli cosmologici, portava in realtà argomenti decisivi in favore del copernicanesimo. Per presentare la teoria geocentrica Galileo sceglie Simplicio, un pedante dalla mentalità conservatrice e tradizionalista, attaccato alle teorie aristoteliche. Per difendere la teoria copernicana sceglie Salviati, che incarna l’intelligenza chiara, rigorosa ed anticonformista. Nella parte di neutrale moderatore viene posto Sagredo, che rappresenta un tipo di personalità non oppressa dai pregiudizi. Il Dialogo è diviso in 4 giornate, nella prima Galileo pone sotto accusa la distinzione aristotelica tra il mondo celeste ed il mondo terrestre, con argomenti tratti dal Sidereus nuncius. La seconda giornata è dedicata alla confutazione degli argomenti contro il moto della Terra, c’è chi afferma che se questo fosse vero si solleverebbe un vento tale da trasportare gli oggetti; Galileo risponde che l’aria partecipa allo stesso movimento della terra, come un individuo su una nave in moto che comunque risulta fermo. Altri obiettano che se la Terra si muovesse da ovest ad est le nuvole sarebbero sempre in moto e il volo degli uccelli sarebbe ostacolato, Galileo risponde nuovamente che l’aria partecipa al moto della terra , che conduce con se nuvole, uccelli e ogni altra cosa. Al noto argomento secondo cui i gravi cadrebbero obliquamente risponde ugualmente che il grave si muove insieme alla Terra e cade perpendicolarmente, tanto è vero che un sasso, lasciato cadere dalla cime dell’albero di una nave in movimento, si ferma ai piedi dell’albero, proprio come se la nave stese ferma. Queste contro argomentazioni si ispirano alla “principio della relatività galileiana” secondo cui risulta impossibile decidere su esperienze meccaniche compiute all’interno di un sistema chiuso, se esso sia in quiete o in moto rettilineo uniforme. Nella terza giornata del dialogo viene dimostrato il moto di rotazione della terra ed esaltata la concezione copernicana. Nella quarta giornata Galileo espone la sua dottrina sulle maree.
c)La scoperta del cannocchiale e la difesa del suo valore scientifico. Gli strumenti di osservazione scientifica si rivelarono subito decisivi non solo per l’analisi ma anche per riprodurre il fenomeno nelle condizioni volute. Ciò comportò un esplicita attribuzione di valore conoscitivo. Ciò che ai nostri occhi può apparire ovvio non lo era affatto nell’epoca di Galileo. Nel Saggiatore Galileo scrive che è venuto a conoscenza del fatto che un olandese aveva presentato un occhiale attraverso il quale le cose lontane si vedevano perfettamente molto vicine; aveva proceduto a costruirne uno per proprio conto, all’inizio poco capace ma poi così potente da riuscire ad ottenere oltre 30 ingrandimenti lineari (1000 volte più grandi). La discussione sulla paternità del cannocchiale è tutt’ora aperta, ma la grandezza di Galileo non consiste nell’averlo costruito ma nell’averlo usato scientificamente, i nobili lo usavano come gioco di società. Molti teologi consideravano diabolico sostituire gli occhi naturali creati da Dio, da ciò il rifiuto di accostare i loro occhi al nuovo mezzo. Galileo ebbe la genialità ed il coraggio di puntare l’occhiale verso il cielo, trasformandolo in telescopio. Grazie a questo realizzò le sensazionali scoperte divulgate dal Sidereus nuncius. Il diritto di usare il cannocchiale come mezzo scientifico gli sarà duramente contestato e costituirà una delle ragioni di fondo dell’incomprensione tra lo scienziato e i teologi e aristotelici.
IL METODO DELLA SCIENZA Un altro risultato storicamente decisivo dell’opera di Galileo è l’individuazione del metodo della fisica, anche se non giunge a formulare una teoria organica del metodo poiché lo applica più che teorizzarlo filosoficamente. Nelle sue opere si trovano alcune preziose osservazioni metodologiche, nel Saggiatore, nel Dialogo e nei Discorsi Galileo articola il lavoro della scienza in due parti fondamentali: il momento risolutivo, o analitico, e quello compositivo o sintetico. Il primo consiste nel risolvere un fenomeno complesso nei suoi elementi semplici, quantitativi e misurabili, formulando un’ipotesi matematica. Il secondo risiede nella verifica e nell’esperimento attraverso cui si tenda di riprodurre il fenomeno in modo tale che, se l’ipotesi supera la prova, essa venga accettata e formulata in termini di legge, se non la supera risulta smentita.
Le “sensate esperienze” e le “necessarie dimostrazioni”. Con l’espressione “sensate esperienze” (esperienze dei sensi, soprattutto della vista), Galileo evidenzia il momento osservativo – induttivo della scienza, preponderante in alcune scoperte. Attraverso un’attenta ricognizione dei fatti e sulla base dell’osservazione induce una legge generale. Questo è il momento del metodo scientifico detto sperimentale. Le “necessarie dimostrazioni” o “matematiche dimostrazioni” sono i ragionamenti logici, condotti su base matematica, attraverso cui il ricercatore, partendo da un intuizione di base e procedendo per una “supposizione” formula in teoria le sue ipotesi, riservandosi di verificarle nella

pratica. Tipica è la via seguita da Galileo nell’intuizione teorica del principio di inerzia, riportata in un passo del dialogo : immaginiamo una superficie piana, pulitissima come uno specchio e di materia dura come l’acciaio, inclinata, e che sopra di essa voi ponete una palla perfettamente sferica e di materia durissima. Anche senza fare l’esperimento concreto sappiamo che si muoverà lungo la superficie e se ipotizziamo che sia tolta anche l’azione frenante dell’aria, ella continuerebbe a muoversi all’infinito se tanto durasse l’inclinazione del piano. Sostituendo poi la superficie inclinata con una orizzontale, la medesima palla se fosse spinta sul medesimo piano continuerebbe il suo moto, ammesso che lo spazio fosse interminato e che non intervenisse una forza esterna a variarne od arrestarne il moto.
Induzione e deduzione. Nella storiografia del passato lo scienziato pisano era stato presentato come un sostanziale “induttivista”, cioè un ricercatore che dall’osservazione dei fatti naturali perviene a scoprire le leggi che regolano i fenomeni; oppure, al contrario, come un convinto “deduttivista” più fiducioso nelle capacità della ragione che in quella dell’osservazione. In realtà Galileo è tutt’e due le cose insieme. Vi è nella prassi concreta una innegabile prevalenza del momento sperimentale teorico, ipotetico deduttivo ma la prevalenza dell’induzione sperimentale sulla deduzione teorica o viceversa non esclude la loro reciproca e indissolubile implicanza di fatto.-le “sensate esperienze” presuppongono sempre un riferimento alle “necessarie dimostrazioni”, in quanto, esse vengono assunte e rielaborate in un contesto matematico – razionale. Esse fin dall’inizio, sono “cariche di teoria” in quanto illuminate da un’ipotesi che le sceglie e le seleziona. E’ vero, ad esempio, che Galileo scoprì ignoti fenomeni astronomici basandosi sul senso della vista, ma la decisione stessa di studiare i cieli e di puntare il cannocchiale su determinati fenomeni e interpretarli in certi modi deriva dalla preliminare accettazione della teoria copernicana.- anche le “necessarie dimostrazioni” presuppongono sempre un loro implicito o esplicito richiamo alle “sensate esperienze” perché forniscono la base e lo spunto per le ipotesi poiché le stese intuizioni “geniali” non nascono nel vuoto ma a contatto con l’osservazione e lo studio dei fenomeni. In secondo luogo, intuizioni e ipotesi acquiscono validità solo per mezzo della conferma sperimentale. Non sempre è possibile una verifica diretta tuttavia risulta sempre possibile una verifica indiretta delle conseguenze che vengono “dedotte” dalla accettazione di tali principi. Per esempio, il principio di inerzia, anche se non constatabile empiricamente, spiega con esattezza i movimenti che si constatano in natura. Si aggiunga poi che tramite opportuni accorgimenti è possibile in laboratorio avvicinarsi alla sua verifica. Nelle necessarie dimostrazioni permette anche di afferrare meglio i rapporti e le differenze tra matematica pura e teoria fisica, mentre la logica tradizionale non serviva a intuire nulla di nuovo, la matematica si pone come uno strumento di scoperta scientifica poiché permette di avanzare nuove ipotesi sui fenomeni divenendo il linguaggio ed il metodo di lavoro della scienza. Tutto questo discorso sulle relazioni tra ragionamento ed attestazione dei sensi, teoria ed esperimento, matematica pura e fisica trova la sua più chiara e compiuta espressione nella lettera scritta a Pietro Carcavy che è forse il documento più prezioso che possediamo circa il metodo di Galileo.
Esperienza e verifica. In Galileo i concetti di esperienza e di verifica assumono un significato originale rispetto al passato, l’esperienza di cui parla non è l’esperienza immediata ma il frutto di una elaborazione teorico matematica dei dati. L’esperienza quotidiana può essere ingannevole , Galileo ha dovuto combattere tutta la vita contro le apparenze immediate dei fenomeni. Con lui comincia ad affermarsi il divario fra mondo della fisica e mondo comune, caratteristico della scienza moderna, in secondo luogo l’esperienza di per se non ha valore scientifico se non è legittimata dall’esperimento. La verifica non è quella immediata dei sensi, che può confermare teorie erronee, bensì la verifica intesa come procedura complessa intenzionalmente volta a creare le necessarie condizioni affinchè un certo evento possa prodursi. Essendo ogni fenomeno una realtà complessa ogni scienziato deve riprodurlo in modo semplificato astraendo circostanze disturbanti. Lo scienziato è dunque costretto a trovare condizioni che spesso non esistono nella realtà ma solo in laboratorio e talvolta solo in un laboratorio ideale, da ciò il ricorso ai celebri esperimenti mentali ; non avendo la possibilità di effettuare concretamente la verifica alle sue teorie, ricorre ad una sorta di fisica ideale: suppone l’assenza di forze, immagina piani perfettamente levigati.
METODO E FILOSOFIACon il suo metodo Galileo perviene a quella struttura concettuale che forma lo schema teorico della scienza moderna: la natura è un organo oggettivo e casualmente strutturato in relazioni governate da leggi e la scienza è un sapere sperimentale – matematico. Galileo afferma che le opere della natura non possono essere giudicate con un metro puramente umano, è arroganza dichiarare inutili quelle opere di cui non si comprenda l’utilità: non sappiano a cosa servano Giove o Saturno o alcuni dei nostri organi : non dobbiamo cercare perché la natura opera in un certo modo (causa finale), ma solo come opera (causa efficiente). Lo scienziato deve occuparsi esclusivamente delle leggi che regolano i fatti, Galileo non intende negare una finalità ma solo accantonarle, ritenendone metodologicamente nonscientifica la ricerca non essendo dato alla mente di conoscerle.

Presupposti e giustificazioni filosofiche del metodo. La struttura concettuale di Galileo è autonoma e indipendente da giustificazioni filosofiche anche se nella sua mente si accompagna a schemi di natura teorico – filosofica che fungono da ispirazione e giustificazione. In altre parole Galileo, pur non essendo un filosofo, si è ispirato ad alcune idee generali di tipo filosofico, attinte per lo più alla tradizione a lui contemporanea:
La fiducia galileiana nella matematica è convalidata dalla dottrina platonico – pitagorica della struttura matematica del cosmo quindi solo chi conosce il linguaggio matematico può decifrarla.
Il privilegiare gli aspetti quantitativi del reale la riduzione dell’oggetto scientifico a struttura matematica sono corroborati dall’antica distinzione atomistico – democritea tra proprietà oggettive e soggettive dei corpi. Le prime caratterizzano i corpi in quanto tali (quantità, grandezza, luogo), le seconde esistono in relazione ai nostri sensi (sapori, odori, colori).
La credenza nella validità del rapporto causale e delle leggi generali basate sul principio che a cause simili corrispondono effetti simili è suggerita e avvalorata dalla persuasione dell’uniformità dell’ordine naturale che risulta necessario e immutabile.
La fiducia nella verità assoluta della scienza conforta la teoria secondo cui la conoscenza umana, pur diversa da quella divina, è simile per il grado di certezza. Mentre dio conosce intuitivamente, cioè in modo immediato, la verità, l’uomo la conquista attraverso il ragionamento discorsivo, inoltre Dio conosce tutte le infinite verità, l’uomo solo alcune di esse.
Il “realismo” di Galileo. Tutte queste giustificazioni filosofiche poggiano su un’unica credenza di base: la corrispondenza tra pensiero ed essere, cioè la conformità tra ciò che la scienza sostiene e il mondo quale è veramente. Galileo interpreta il rapporto tra scienza e realtà in termini di riproduzione o rispecchiamento, in astronomia si è sempre rifiutato di essere considerato un semplice matematico ritenendosi uno studioso di fisica celeste “matematico e filosofo” al tempo stesso intendendo come filosofo indica la portata ontologica delle sue teorie. Ed è qui uni dei punti di scontro con la chiesa che lo voleva obbligare a parlare del copernicanesimo in termini puramente ipotetici. Questa persuasione realista non si lascia scalfire neanche dalle insidie logiche delle “argomentazioni di Urbano VIII” secondo cui lo studioso non conosce le infinite vie del creatore e non può essere mai sicuro che una sua teoria corrisponda veramente all’ordine seguito da Dio nell’ordine delle cose, deve quindi accontentarsi di parlare per ipotesi.
IL PROCESSONel XIX sec. la condanna di Galileo è stata avvolta da molte polemiche filo – clericali e anti – clericali, tesi i primi a comprendere il comportamento della Chiesa e minimizzare la vicenda, gli altri a denigrarla e usare il suo caso come atto di accusa nei confronti dell’oscurantismo religioso. Nel XX secolo le polemiche si sono sopite per una riabilitazione di galileo da parte della chiesa stessa. Anche se gli aristotelici pisani guardavano con irritazione il copernicanesimo di Galileo, le prime reazioni vennero dal clero, mentre i gesuiti mantenevano un atteggiamento prudente, i domenicani lo attaccarono apertamente e uno di essi accusò di eresia i copernicani citando lo scienziato presso il Sant’Uffizio. L’allargarsi della vicenda dal piano astronomico a quello fisico e religioso fece passare la vicenda ai teologi che dichiararono all’unanimità: assurda e falsa in filosofia e fortemente eretica la tesi eliocentrica, e la mobilità della Terra. I libri di Copernico vennero posti all’indice ma non si fece riferimento a Galileo che fu teoricamente convocato e formalmente ammonito, il verbale della seduta sarà di grande rilievo per il successivo processo, anche se questo risulta ancora oggi un giallo storico, per la mancanza delle firme tanto che molti sostengono sia stato scritto più tardi per avere prove scritte. Nel 2632 galileo, incoraggiato dall’elezione di papa Urbano VIII, pubblicò il dialogo, ricorrendo allo stratagemma di presentare in maniera obiettiva i due più grandi sistemi astronomici della storia. La rabbia del papa però, convinto di essere stato preso in giro nella figura di Simplicio dette ordine all’inquisitore di Firenze di sospendere immediatamente la diffusione dell’opera e a Galileo venne intimato di andare a Roma di fronte al Sant’Uffizio. Fu trasferito come prigioniero non nelle carceri dove erano stati Campanella e Bruno ma in stanze più confortevoli considerando la sua età ed i suoi malanni. L’accusa più grave era di aver trasgredito il precetto che gli impediva di insegnare o difendere la teoria Copernicana. Galileo affermò più volte di non aver ricevuto tale precetto, provò poi ad aggirare gli inquisitori sostenendo che nel Dialogo non aveva sostenuto le teorie copernicane ma aveva anzi mostrato la sua erroneità, ma i giudici dimostrarono facilmente il contrario e Galileo dovette ammettere di aver difeso tali teorie. Dopo un po’ di tempo venne la sentenza di condanna e nello stesso giorno Galileo, in ginocchio davanti ai cardinali della Congregazione pronunciò la sua abiura (rinnegare) al copernicanesimo.

IMPORTANZA DI GALILEO IN FILOSOFIA
Galileo è considerato il fondatore della scienza moderna e determina anche una svolta nel pensiero filosofico perché:
con lui entrano in crisi alcuni concetti millenari della metafisica come l’essenza e la causa finale che si rivelano inadatti e fuorvianti per un’esatta conoscenza della natura.
Rielabora in un modo del tutto nuovo i concetti di ragione, esperienza, induzione e deduzione abbattendo l’ideale aristotelico del sapere e facendo della verifica il contrassegno della nuova scienza.
Alla visione antropomorfica e metafisica della natura contrappone la concezione dell’universo come sistema di leggi e di relazioni.
Con il suo metodo lascia in eredità ai filosofi successivi una serie di problemi su cui si sarebbero affaticati grandi pensatori dal Seicento ai giorni nostri testimoniando l’incidenza della rivoluzione scientifica sul pensiero filosofico. Tantissimi movimenti filosofici successivi: il meccanicismo cartesiano, le dottrine di Locke e Hume, il positivismo ottocentesco, il marxismo, il pragmatismo e svariate altre teorie filosofiche moderna sono comprensibili solo in riferimento alla riflessione scientifica avviata da Galileo.