Fuoricollana - Aracne · 2017. 9. 20. · sca efficacia e bellezza si può attingere al Museo...
Transcript of Fuoricollana - Aracne · 2017. 9. 20. · sca efficacia e bellezza si può attingere al Museo...

Fuoricollana


Francesca Ferrari
Laboratori didatticidi astronomia
modelli cosmologici dalle origini al medioevo
implicazioni filosofiche, culturali e teologiche

Copyright © MMXIV
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
www.narrativaracne.it
via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065
Isbn 978-88-548-7480-0
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’editore.
I edizione: agosto 2014

5
introduzione
Propongo in questo saggio una serie di laboratori didattici multidisciplinari adatti alle classi III dei licei. Le materie coinvolte sono matematica, astrono-mia, storia, filosofia e informatica.Vogliamo affrontare l’origine della cosmologia tolemaica riflettendo sui punti nodali che hanno portato alla formulazione del complesso sistema accreditato fino al Medioevo.Nel Medioevo il modello si arricchì di numerosi significati che indagheremo grazie a opere letterarie e artistiche.


7
L’originedeLLa cosmoLogia scientiFica
Lo studio dei moti dei corpi celesti, anticamente, era necessario per scopi di applicazione pratica, quali le semine, l’orientamento, la misura dei terreni e riceveva perciò un considerevole tributo di interesse. Vediamo nei paragra-fi che seguono un possibile percorso che conduca gli studenti allo studio dell’origine dei modelli cosmologici che sono stati formulati nell’antichità sulla base di osservazioni astronomiche prima rudimentali, poi via via più accurate.
il moto del sole
Prima del II millennio a.C. i Sumeri e gli Egizi avevano costruito una semplice meridiana che consentisse loro di studiare sistematicamente il moto appa-rente che il Sole compie ogni giorno da est a ovest. Tale meridiana era un semplice gnomone che spuntava da una zona liscia del terreno e proiettava la propria ombra quando illuminata dal Sole.L’ombra dello gnomone varia in lunghezza e direzione durante l’arco del-la giornata, concordemente con il variare dell’altezza del Sole sull’orizzonte, consentendo una scansione del tempo e fornendo un metodo per l’orienta-mento. Nel momento in cui l’ombra dello gnomone è più corta, infatti, essa punta sempre nella mede-sima direzione: quella che chia-miamo nord. Ciò avviene perché il Sole culmina, ovvero raggiunge la massima altezza sull’orizzonte sempre in direzione sud.La lunghezza dell’ombra, inoltre, varia durante il corso dell’an-
Figura 1: moto giornaliero apparente del Sole al
variare della stagione.

8
no, al variare delle stagioni: durante l’inverno le ombre sono più lunghe, progressivamente si accorciano fino all’estate per poi riprendere ad al-lungarsi durante l’autunno. Il motivo è dovuto alla diversa altezza che il Sole raggiunge durante le stagioni. La figura 1 schematizza i diversi per-corsi apparenti del Sole e l’ombra che a mezzogiorno lo gnomone proietta. Queste osservazioni permettono una scansione del tempo durante l’anno e la definizione di quattro date significative: i solstizi e gli equinozi.Sempre facendo riferimento alla figura 1 possiamo illustrare agli studenti le date in questione.In corrispondenza del solstizio invernale il Sole culmina più in basso rispet-to a ogni altro giorno dell’anno, sorge e tramonta in punti dell’orizzonte spostati più a sud rispetto agli altri giorni dell’anno. Osservazioni accurate consentono di determinare una linea immaginaria detta eclittica sulla quale il Sole si sposta durante il corso dell’anno. L’eclittica è un circolo chiuso che attraversa le costellazioni dello zodiaco [1]. È importante sottolineare, discutendo con i ragazzi, che per quanto le os-servazioni con lo gnomone possano sembrarci “primitive” o rudimentali esse hanno permesso tutte le sopraccitate deduzioni.
Scheda didattica 1
Realizzazione e utilizzo della meridiana
Lunghezza e direzione deLL’ombra deLLo gnomone
MaterIale occorrente
• Gnomone• Foglio graduato• Metro• Goniometro
Figura 2: l’eclittica e l’equatore celeste.

9
no, al variare delle stagioni: durante l’inverno le ombre sono più lunghe, progressivamente si accorciano fino all’estate per poi riprendere ad al-lungarsi durante l’autunno. Il motivo è dovuto alla diversa altezza che il Sole raggiunge durante le stagioni. La figura 1 schematizza i diversi per-corsi apparenti del Sole e l’ombra che a mezzogiorno lo gnomone proietta. Queste osservazioni permettono una scansione del tempo durante l’anno e la definizione di quattro date significative: i solstizi e gli equinozi.Sempre facendo riferimento alla figura 1 possiamo illustrare agli studenti le date in questione.In corrispondenza del solstizio invernale il Sole culmina più in basso rispet-to a ogni altro giorno dell’anno, sorge e tramonta in punti dell’orizzonte spostati più a sud rispetto agli altri giorni dell’anno. Osservazioni accurate consentono di determinare una linea immaginaria detta eclittica sulla quale il Sole si sposta durante il corso dell’anno. L’eclittica è un circolo chiuso che attraversa le costellazioni dello zodiaco [1]. È importante sottolineare, discutendo con i ragazzi, che per quanto le os-servazioni con lo gnomone possano sembrarci “primitive” o rudimentali esse hanno permesso tutte le sopraccitate deduzioni.
Scheda didattica 1
Realizzazione e utilizzo della meridiana
Lunghezza e direzione deLL’ombra deLLo gnomone
MaterIale occorrente
• Gnomone• Foglio graduato• Metro• Goniometro
Figura 2: l’eclittica e l’equatore celeste.
attIVItà e MIsure
1. Posizioniamo il foglio graduato in una zona di terreno il più possi-bile liscia e orizzontale. Orientia-molo con l’aiuto di una bussola o di riferimenti noti.Nell’arco della medesima giornata possiamo fare diverse osserva-zioni della lunghezza e della po-sizione dell’ombra.2. Può essere ragionevole anno-tare una volta ogni ora la posizione dell’ombra tracciando un segno in corrispondenza della punta.3. Ripetendo le medesime operazioni nell’arco dell’anno possiamo vedere come variano la po-sizione e la lunghezza dell’ombra nel corso delle stagioni.4. Annotiamo durante tutte queste operazioni la lunghezza e l’angolo che l’ombra forma con la di-rezione nord.
accorgIMentI
Il foglio graduato deve essere ben fissato a terra in modo che non si sposti durante le osservazioni. Inol-tre è bene sia plastificato, in modo che si conservi durante le attività. Sostituire il foglio o comunque ri-posizionarlo può infatti introdurre errori e incertezze di misura dovute al non perfetto allineamento con le direzioni cardinali [3]. rIsultatI
Ogni giorno l’om-bra sembra dise-gnare una specie di ventaglio diver-so al variare delle stagioni in modo corrispondente alla traiettoria apparente del Sole, figura 5.
Figura 3: foglio graduato.
Figura 4: gno-
mone.
Figura 5: ombra dello gnomone durante l’anno. [1].

10
Il MezzogIorno solare Vero e l’ora conVenzIonale
Supponiamo come fecero gli antichi che il moto delle stelle sia regolare, cioè che le stelle impieghino sempre lo stesso tempo a compiere un giro. Proviamo ora a misurare l’intervallo di tempo tra un mezzogiorno e quello successivo, cioè tra una culminazione del Sole e quella successiva.Scopriamo che questo intervallo di tempo non è costante durante l’anno, essenzialmente per due ragioni:1. la velocità con la quale il Sole sembra muoversi attraverso le co-stellazioni dello zodiaco non è costante;2. l’angolo secondo il quale l’eclit-tica interseca l’equatore celeste ha un’influenza sulla variabilità del giorno solare: essendo l’eclittica inclinata, attraversa più linee me-ridiane ravvicinate in corrispon-denza dei solstizi e degli equinozi.Senza volere troppo complica-re l’attività possiamo introdurre ai ragazzi il modo in cui le civiltà moderne “correggono” queste ir-regolarità. Non potendo infatti utilizzare come mezzogiorno legale quello solare, diverso ogni giorno, si fa riferimento al tempo solare medio, cioè alla lunghezza media del giorno solare apparente. La fi-gura 6 mostra graficamente la discrepanza tra il mezzogiorno solare vero e quello medio convenzionale. La curva che ricorda un otto si chiama analemma e ci permette di individuare l’ora del mezzogiorno vero.
attIVItà e MIsure
In prossimità del mezzogiorno solare possiamo intensificare le misu-re con il nostro gnomone e verificare quando avviene la culminazio-ne del Sole: il momento cioè in cui l’ombra è più corta.Misuriamo l’angolo che l’ombra più corta fa con la direzione nord.
Figura 6: analemma.

11
rIsultatI
L’ombra è più corta in corrispondenza del mezzogiorno vero, dun-que, annotandone l’orario, possiamo ricostruire una tabella da con-frontare con i dati dell’analemma.Notiamo anche che l’angolo che l’ombra più corta forma con la di-rezione nord è prossimo allo zero, essendo la culminazione del Sole sempre a sud.
Pillole di Storia e Arte
la MerIdIana del Museo della specola dI bologna
Per capire bene il funzio-namento di una meridia-na cosa c’è di meglio che prenderne in esame una vera e vedere effettiva-mente come la si può uti-lizzare?Per sceglierne una che uni-sca efficacia e bellezza si può attingere al Museo del-la Specola a Bologna dove, in una delle sale espositive, si trova la meridiana in figura 7, decorata da Ercole Lelli [4].Dal foro gnomonico, così si chiama la piccola apertura in figura 8, entra la luce del Sole soltanto quando esso culmina, cioè al mezzo-giorno fisico, e illumina un punto della linea meridiana.La linea in origine era costituita soltanto da un filo tirato dalla parete
nord a quella sud della stanza. Ogni giorno il Sole illumina un punto diverso della linea, du-rante il trascorrere delle sta-gioni. In corrispondenza del solstizio d’estate il Sole illumina il punto più a sud della linea dato che la culminazione avviene nel punto più alto sopra
Figura 7: museo della Specola, sala meridiana.
Figura 8: foro gnomonico. Museo del-
la Specola, Sala meridiana.

12
l’orizzonte. Poi il luogo di il-luminazione si sposta pro-gressivamente verso nord fino al solstizio d’inverno, dopo il quale il moto s’in-verte.Nella figura 9 è tracciato uno schema che illustra gli spostamenti mensili del punto di illuminazione.Nel montaggio della figura 10 sono state affiancate le fotografie scattate ogni mese per monitorare lo spostamento della proiezione della luce solare.L’uomo che fu tanto paziente da osservare ogni giorno il Sole indi-viduandone la culminazione fu Eustachio Manfredi, che con una
semplice crocetta sul pavimento se-gnò il punto dove la luce del Sole si proiettava. Raccolti dati per un anno, tirò lo spago seguendo i segni ed ebbe così a disposizione una linea me-ridiana.Ercole Lelli sostituì poi lo spago con una linea di ottone e intarsiò i segni zo-diacali per indicare le stagioni [4].
il moto delle stelle
Agli occhi di un osservatore le distanze relative tra le stelle si mantengono costanti. Si mantiene inalterato, cioè, il disegno che esse tracciano nel cielo, disegno in cui le popolazioni antiche hanno immaginato figure mitologiche e divinità che hanno dato i nomi alle costellazioni.Alle medie latitudini le stelle sembrano eseguire, ogni notte, archi di circon-ferenza da est a ovest aventi come centro un punto che viene denominato polo celeste.Per quanto riguarda l’emisfero boreale questo punto è prossimo alla Stella Polare, che sembra mantenere la sua posizione pressoché inalterata durante
Figura 9: schema della proiezione del
Sole sulla linea meridiana.
Figura 10: sequenza di foto-
grafie scattate alla meridiana
della Specola.

13
Figura 11: moto delle stelle alle medie latitudini.
Fotografia scattata prolungando l’esposizione
per varie ore.
la notte e ha costituito perciò il punto di riferimento per l’orien-tamento degli antichi viaggiatori.Nell’emisfero australe è osserva-bile un analogo riferimento detto Croce del Sud, un gruppo cruci-forme di stelle, prossimo al polo sud celeste.All’equatore le stelle sembrano muoversi su linee rette parallele tra loro: i poli celesti non sono infatti visibili.L’osservazione dei moti apparenti alle medie latitudini ha condotto alla for-mulazione di un modello cosmologico nel quale le stelle sono trasportate da una sfera rotante, e questo appare giustificato osservando che le stelle sembrano effettivamente fissate a una semisfera in rotazione. Approfondi-remo questo nel prossimo paragrafo.Osservando il cielo notturno durante il susseguirsi delle stagioni, si nota che non tutte le stelle sono visibili per tutto l’anno. Vediamo di interpretare questo fenomeno.Le stelle impiegano un periodo di 23 ore e 56’ per compiere il moto ap-parente lungo un cerchio. Una stella che oggi alle ore 21:00 si trovi in un punto al di sotto del polo, domani si troverà nella medesima posizione alle ore 20:56 e dopodomani alle 20:52 ecc.Vi sono stelle che sono comunque sempre visibili durante l’anno e stelle che in alcuni periodi non si vedono perché nelle ore notturne sono al di sotto dell’orizzonte.Vediamo nella figura 11 che appunto alcune stelle compiono circonferenze attorno al polo completamente visibili. Dei percorsi di stelle più lontane dal polo, invece, vediamo solo un arco e queste stelle sembrano sorgere e tra-montare. Vengono chiamate stelle circumpolari quelle che non tramontano mai e che nella letteratura antica sono spesso citate assumendo peculiari significati. Vediamo, nella scheda, alcuni testi in cui si citano stelle e si at-tribuiscono loro significati pratici o mitologici [1].Proponiamo poi alcune attività che chiariscano ulteriormente il moto delle stelle.












![BIMESTRALE DI ASTRONOMIA Anno XXVI Marzo-Aprile 2000 147.pdf · Il contributo della Specola Solare Ticinese alla ras5e9na bellinzonese .. .. Mostra su GaiUeti :~/-A~:~7]5J A cura](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5c65b71f09d3f2ad6e8d18d7/bimestrale-di-astronomia-anno-xxvi-marzo-aprile-147pdf-il-contributo-della.jpg)

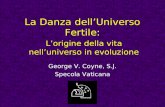


![Bibliografia - Springer978-88-470-2640-7/1.pdf · [16] Carlo Brioschi: Commentarj astronomici della Specola Reale di Napoli, voI. ... la Reale Accademia delle Scienze Fisiche e ...](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5c66e64c09d3f20f218cf031/bibliografia-springer-978-88-470-2640-71pdf-16-carlo-brioschi-commentarj.jpg)

