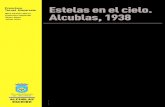Estelas (Italiano)
-
Upload
fabian-ruiz -
Category
Documents
-
view
55 -
download
3
Transcript of Estelas (Italiano)

22
A bel Carlevaro e Maurice Ohana si conob-bero a Parigi nella seconda metà del 1948,
in occasione della prima visita del chitarrista uru-guaiano in Europa. Attraverso la sua personaletestimonianza, la corrispondenza trentennale trai due e le notizie pubblicate e documentate sul-la stampa specializzata sappiamo che avevanocoltivato una intensa amicizia e una proficua col-laborazione artistica.
Non bisogna dimenticare che Ohana, in quelperiodo iniziale della sua carriera, frequentava imusicisti e gli altri artisti rioplatensi che abita-vano a Parigi o che erano di passaggio da quel-la città. Oltre a Carlevaro, chitarrista nel pienodi una carriera crescente e che pochi anni pri-ma era stato pubblicamente presentato da Segovia,ebbero contatti con Ohana, ricevendo il suo ap-poggio, almeno due compositori uruguaiani: HéctorTosar1 e, soprattutto, alcuni anni più tardi, LuisCampodónico.2 Però la personalità artistica piùlegata a Ohana tra coloro che arrivarono a Parigidalle terre del Plata crediamo sia stato il pitto-re e musicista argentino Sergio de Castro,3 chefu suo buon amico per tutta la vita. Un fatto digrande importanza in questo rapporto con Castro
(che era stato allievo di Manuel de Falla e cheaveva accompagnato il maestro spagnolo neisuoi ultimi anni a Córdoba in Argentina) è cheegli aveva fatto parte dell’Atelier (Taller), del pit -tore uruguaiano Joaquín Torres García.4 Per laprecisione, de Castro arrivò a Parigi nel 1949 do-po aver vissuto per lunghi periodi a Montevideostudiando architettura, lavorando nell’Atelier e fa-cendo parte della corrente che in seguito si sa-rebbe chiamata Scuola del Sud.
Abel Carlevaro arrivò a Parigi nel ’48 i m b e v u-to delle concezioni artistiche di To r res Garc í a :molto amico di alcuni degli artisti che facevanoparte integrante dell’Atelier (Augusto To r res, fi-glio del maestro, e i fratelli Alceu ed EdgardoR i b e i ro, tutti pittori) e già nutrito dell’ideadell”universalità costruttiva” propria di questa scuo-la, che avrebbe col tempo influenzato l’elabora-zione della sua teoria strumentale e che sicura-mente era già determinante per la sua concezio-ne come artista-interprete. Non sorprende il fat-to che Ohana fosse attratto da queste idee arti-stiche ed estetiche, visto che coincidevano con ilsuo spirito e con la ricerca che ha caratterizzatola sua opera: andare incontro alle grandi tradi-
CARLEVARO, OHANA: ESTELAS
UNA STORIA CHE SI CONOSCE APPENA
di Ruben Seroussi e Alfredo Escande
dal 1933 al 1942 dove studiò architettura e musica. Trail 1942 e il 1946 collaborò con Manuel de Falla inArgentina. Fu allievo di Torres García dal 1941 al 1949,anno in cui si stabilì a Parigi.
4. Joaquín Torres García (Montevideo, 1874-1949) ar-tista plastico, teorico dell’arte, docente, è il pittore uru-gayo più importante del secolo XX. Ideatore della cor-rente chiamata “Universalismo costruttivo”, visse in Spagnatra il 1891 e il 1934. Al suo ritorno in patria fondò aMontevideo il Taller che porta il suo nome.
1. Héctor Tosar, compositore, pianista, direttore d’or-chestra e didatta, nacque a Montevideo nel 1923 e morìnella stessa città nel 2002. È riconosciuto come perso-nalità preminente della musica uruguaya della secondametà del ventesimo secolo.
2. Luis Campodónico, compositore, pianista e scritto-re, nacque a Montevideo nel 1931 e morì a Parigi nel1973.
3. Sergio de Castro, artista plastico e musicista, nac-que a Buenos Aires nel 1922. È vissuto a Montevideo

23
zioni universali dell’uomo, libero dalla dipen-denza da una cultura europea decadente che perlui era simbolizzata, allora più che mai, dalla cru-ciale influenza che esercitò l’espressionismo te-desco tramite la scuola postweberniana e il suoseguito, ossia il serialismo totale. La ricerca di re-gole universali e dell’essenza archetipica degli og-getti (anche quando essi sono musicali), la ten-denza all’anonimato (non dimentichiamo la sua ul-tima opera per il nostro strumento che esprime laf o rma nella quale, secondo le sue parole, ha vo-luto rimanere nella storia: “Anonime du vingtièmes i è c l e ” per due chitarre) e molte altre idee che co-nosciamo tramite le sue opere e le sue paro l e ,t rovano eco e una risonanza molto marcata nelleidee di To r res García tanto apprezzate da Carle-v a ro. Non deve dunque sorpre n d e rci l’amicizia na-ta fra i due, né il fatto che nel 1950 Ohana ab-bia composto un concerto per chitarra e orc h e-stra, commissionato da Carlevaro e scritto in stre t-ta collaborazione con lui. Il concerto recava unap a r t i c o l a re dedica al chitarrista uruguaiano ( “ q u etié manos de faraón”) e il suo secondo movimentofu presentato in un concerto pubblico a Parigi dal-lo stesso compositore e dal chitarrista nella ver-sione per chitarra e pianoforte. L’opera fu term i-nata alla fine del 1950, con cadenze scritte daC a r l e v a ro che però si vide obbligato a far ritorn oa Montevideo lasciando il concerto ineseguito. Piùtardi, Ohana prese il primo e il terzo movimentoe ne fece la base del suo concerto Tres Gráficos,m e n t re il secondo movimento, opportunamente tra-scritto, divenne la sua S a r a b a n d a per pianofortee orc h e s t r a .5
Più di vent’anni dopo questi fatti, nel 1974,Carlevaro, ormai famoso come chitarrista e co-
me innovatore della tecnica strumentale fece ri-torno a Parigi e cercò di riprendere i contatticon il suo vecchio amico. Andò infatti a farglivisita nel suo appartamento parigino ed ecco co-me racconta questo episodio nell’intervista dataa Gonzalo Solari per “Guitart” (aprile 1999):6
Quando ritornai a Parigi nel 1974 mi incon-trai di nuovo con Mauricio Ohana. Portai conme la mia chitarra dato che egli diceva di es-sere molto deluso dalle possibilità dello stru-mento che – secondo lui – non poteva compe-tere con il pianoforte in quanto a produzionedel suono. Per dimostrarlo, formò una linea ret-ta con i due avambracci tenendo le mani unitee così potè premere tutti i tasti compresi tra ungomito e l’altro producendo una sonorità mol-to bella. Gli dissi: “Mauricio, questo è il pia-noforte. Ascolta adesso quello che ti può offri-re la chitarra: non sono solo le sue sei corde avuoto” […] Dopo aver ascoltato alcune delle mieimprovvisazioni Ohana mi disse: “Abel, questomi piace molto. Aspetta che porto un po’ di car-ta e componiamo qualcosa.” E così, frugandotra i suoni che avevo prodotto, iniziammo a la-vorare con un entusiasmo tale che passamo co-sì l’intera notte. L’indomani io dovevo viaggiaree così egli mi lasciò il foglio incaricandomi diriempire la parti per completare l’opera. Io pro-misi di farlo. Dopo un anno e passa finii il la-voro e presentai Estelas [questo era il titolo dat-to al pezzo, n.d. R.] nei concerti che tenevo inquell’epoca in cui facevo dei corsi organizzatida Radio France e Robert Vidal a Parigi.
Dieci anni prima, nel novembre del 1989,
“Mauricio, eso es el piano. Ahora escucha lo que la gui -tarra puede ofrecerte: no son sólo sus seis cuerdas alaire”. [...] Ohana me respondió, después de escuchar al -gunas de mis improvisaciones: “Abel, eso me gusta mu -cho. Espera que traigo un papel y vamos a componeralgo”. Y así, hurgando en los sonidos que yo había pro -ducido, empezamos a trabajar con tanto entusiasmo,que cuando quisimos acordar, había pasado toda lanoche. Yo debía viajar al día siguiente, así que él medio el papel, encargándome que rellenara las partes pa -ra completar la obra. Yo le prometí que así lo haría.Después de un año largo terminé el trabajo y estrenéE s t e l a s en los conciertos que di en la época en que da -ba cursos organizados por Radio France y Robert Vidalen Paris.«
5. Tutti i dettagli di questa storia si trovano docu-mentati nel libro (in preparazione) di Alfredo EscandeAbel Carlevaro e la chitarra del secolo XX.
6. L’originale in spagnolo di questa intervista si trovanell’archivio di Carlevaro e lo trascriviamo qui di se-guito:
»Cuando volví a Paris en 1974, me encontré nueva -mente con Mauricio Ohana. Llevé mi guitarra, ya queél manifestaba estar muy desilusionado con las posi -bilidades del instrumento porque – según me decía –no podía competir con el piano en la producción desonido. Para demostrarlo, colocó en línea recta ambosantebrazos, unidos por las manos, y presionó con ellostodas las teclas así abarcadas (de codo a codo) pro -duciendo una sonoridad muy hermosa. Yo le dije:

24
quando Ohana era ancora in vita, Carlevaro, pri-ma di suonare Estelas, si era così espresso nelcorso di un’intervista alla televisione spagnola(TVE2):7
Suonerò un’opera moderna di un grandecompositore spagnolo che vive a Parigi: si chia-ma Mauricio Ohana, da lungo tempo mio caroamico. Lo conobbi la prima volta che andai aParigi. Un pomeriggio nel suo appartamento pa-rigino lavorammo insieme: io dandogli le ideeda dentro lo strumento e lui completando tuttoil lavoro musicale. In questa maniera creammoun’opera che ho già presentato in varie occa-sioni e che si chiama Estelas.
Dobbiamo dire che Carlevaro eseguì in primaEstelas a New York, il 16 marzo 1977. Quellostesso anno eseguì il brano in Francia, durantei R e n c o n t re s o rganizzati a Castres da RobertVidal così come in altre città degli Stati Uniti, inColombia e a Montevideo. A quel punto scrissea Ohana informandolo della prima esecuzione edel successo dell’opera. Il 10 ottobre 1977 Ohanarisponde:
Caro amico Abel,Sono molto contento di ricevere tue notizie!
Proprio in questi giorni mi domandavo che fi-ne avessero fatto Estelas. Vedo che le hai por-tate al trionfo e così continueranno nelle tuemani.
Ti sarò molto grato se me ne mandi una co-pia perché neppure mi ricordo com’erano.
Per quanto riguarda quello che mi chiedi perl’editore Barry, non potrò dare alcuna autoriz-zazione prima di essermi consultato con il mioeditore Jobert, al quale sono legato da un con-tratto di esclusiva. Però una qualche soluzionesi potrà prendere in considerazione: sia dividendoi diritti con Barry oppure, per una condizione,
delimitando i territori. Mi consulterò con laDirettrice e ti saprò dire qualcosa.
Spero di vederti da queste parti. Quest’estateè avvenuta la prima esecuzione di una miaMessa ed è stato un grande momento per me.
Un cordiale e affettuoso abbraccio,M. Ohana10 X 77
Tenendo in conto che E s t e l a s sembrava con-t r a s s e g n a re il ritorno di Ohana alla composizioneper la chitarra a sei corde, risulta interessante chedurante la tournée negli Stati Uniti nel corso del-la quale presentò il lavoro per la prima volta,C a r l e v a ro dichiarasse in un’intervista a San Francisco:8
Ora sto lavorando a un’opera intitolata F a n t a s í apara la seis cuerdas 9 per continuare con le seicorde e non con le dieci.
Le esecuzioni pubbliche di E s t e l a s c o n t i n u a n oe Ohana insiste in varie lettere a chiedere una co-pia del pezzo. Così scrive il 21 novembre del 1978:
Amico Carlevaro,A suo tempo ricevetti i tuoi programmi degli
Stati Uniti e ti ringrazio per la premura. Mi fapiacere sapere che il pezzo è di tuo gradimen-to. D’accordo con l’editore Jobert, non ho po-tuto concedere a Barry i diritti che chiedevano.Con Jobert ho un contratto di esclusiva e nondesiderano fare eccezioni.
Ti sarei molto grato se tu mi inviassi al piùpresto una fotocopia del pezzo per pubblicarloqui e poi mettere a disposizione dell’’editoreBarry una certa quantità di copie.
Spero che i tuoi successi continuino e nelfrattempo di invio un saluto amichevole,
Maurice Ohana
E il 20marzo del 1980:
Amico Carlevaro, continuo a non avere notizie di Estelas per
chitarra il cui invio mi avevi preannunciato unanno e mezzo fa.
Visto che non ricevo niente, vorrei che tu nefacessi una fotocopia e che me la inviassi il piùpresto possibile poiché sta per essere pubblica-to il catalogo delle mie opere e a questo titolonon corrisponde alcuna musica.
7. Nell’archivio di Carlevaro esiste la registrazione vi-deo di quest’intervista e gli autori di quest’articolo nepossiedono copia.
8. L’intervista fu concessa a Spencer Burleson il 28marzo 1977 e pubblicata sulla rivista giapponeseGendai Guitar.
9. Carlevaro eseguì quest’opera, almeno sotto questotitolo, una sola volta: il 22 luglio di quello stesso anno(1977) a Castres. Era dedicata a Miguel Angel Girollet.

25
Finalmente il 30 giugno di quell’anno Carle-varo risponde:
Stimato amico Mauricio,sono contento di aver ricevuto tue notizie –
la tua lettera datata 20 marzo l’ho ricevuta so-lo in giugno! Per questa ragione e per quantomi racconti penso che la posta si stia compor-tando proprio male.
Ho suonato la tua opera Estelas in giro pergli Stati Uniti e in Canada ed è piaciuta moltis-simo arrivando a concentrare su di sé l’atten-zione del pubblico.
Il 4 luglio viaggerò in Francia ed eseguirò latua opera a Castres. Il 21 luglio sarò a Parigi emi piacerebbe poterti vedere là. Porterò la tuapartitura e te la consegnerò personalmente (senon sarai via per le vacanze).
Comunque sia quando arriverò a Parigi cer-cherò di parlarti per telefono. Non ti preoccu-pare che in una maniera o l’altra avrai Estelas.Mi congratulo con te. Ti invio un cordiale e af-fettuoso saluto.
Il tuo amico,Abel.
Sappiamo dalla testimonianza diretta di Carlevaro(ed è facile averne conferma osservando la do-cumentazione che riproduciamo qui di seguito)che egli fece un dettagliato lavoro di elabora-zione delle idee che Ohana aveva abbozzato suun foglio prendendo spunto dagli esempi che ilchitarrista proponeva col suo strumento. Malgradociò, ha sempre dichiarato pubblicamente che lapaternità dell’opera apparteneva esclusivamentea Mauricio Ohana (che ha sempre chiamato conil nome in spagnolo) e così lo indicò – comevedremo – nel manoscritto che consegnò al com-positore nel mese di luglio 1980.
Che fine ha fatto Estelas, visto che non è maistata pubblicata da Ohana né si trova nel cata-logo delle sue opere? Se ci atteniamo ai pro-grammi conservati nell’archivio personale diCarlevaro, egli ha eseguito questa composizionein quarantatré concerti pubblici tra il mese dimarzo 1977 e il settembre del 2000. Venti di que-sti concerti ebbero luogo prima della consegnadel manoscritto definitivo a Ohana, altri venti traquel momento e il decesso del compositore av-venuto nel 1992. Infine tre esecuzioni sono po-steriori a quest’ultima data. Estelas è stata ese-
guita in tredici Paesi diversi e ne esistono al-meno due registrazioni: una realizzata in occa-sione di un concerto a Porto Alegre il 7 luglio1979 e l’altra durante la già citata apparizionealla televisione spagnola nel novembre 1989.
L’ultimo giorno del 1980 Ohana invia a Carlevarouna cartolina dalla Svizzera:
Felice anno NuovoCon molti successi.Estelas stanno nel “maturatoio” aspettando qual-
che piccola modifica prima della pubblicazione.Un abbraccio affettuoso.M. Ohana.
Nell’archivio di Carlevaro non esiste altra let-tera di Ohana. Questa è l’ultima. Non sappiamon e p p u re se si siano incontrati nuovamente.Sappiamo invece (perché ce lo ha raccontatoVani de Carlevaro) che egli si chiedeva spessoche avesse mai fatto Ohana di quel manoscrit-to, visto che non aveva mai ricevuto notizie del-la sua pubblicazione. Vediamo cosa diceva nelfrattempo pubblicamente Ohana. Nel 1982, alladomanda perché non scrivesse più per chitarraa dieci corde, dichiarava a Pascal Bolbach su“Cahiers de la Guitare”:10
Molto presto mi sono sentito a disagio den-tro la gabbia limitata dalle sei corde della chi-tarra tradizionale.
E dopo aver raccontato l’esperienza di averideato insieme a Narciso Yepes una chitarra adieci corde dice:
Certamente la vecchia guardia copre di sde-gno questo tentativo di sconvolgere le sue abi-tudini e la sua pigrizia. Lasciamola fare.
Il repertorio è ancora limitato […] Ho appe-na scritto una nuova suite, Cadran lunaire chesarà pubblicata da Billaudot, commissionata daLuis Martin Diego. È la prima opera che scrivoper chitarra dopo quasi vent’anni.
La sottolineatura è nostra. Nella stessa pagina,dopo aver detto che ammirava anche alcuni chi-tarristi che non corrispondevano completamen-
10. “Les Cahiers de la Guitare”, n. 2, aprile 1982.

26
te, secondo lui, ai suoi criteri estetici (e tra que-sti cita Carlevaro) Ohana dice:
Li ammiro per altre qualità, anche se il lororepertorio resta conformista e non si avventuranella musica del nostro tempo, se non come inuna sorta di incursione in un paese nemico.
Ancora su “Les Cahiers de la Guitare”, ma qua-si due anni dopo, in un articolo dedicato all’ana-lisi della suite Cadran Lunaire, appare l’unicoriferimento che abbiamo potuto trovare fino aoggi relativo a un possibile collegamento di AbelCarlevaro con questa opera (non vi figura peròalcun riferimento a Estelas, la cui esistenza puòdarsi che l’articolista ignorasse). Il chitarrista fran-cese Arnaud Dumond dice in questo articolo:11
Suggerita tanti anni fa da Abel Carlevaro, laversione definitiva di Cadran Lunaire è stataportata a termine per il giovane chitarrista spa-gnolo Luis Martin Diego.
D’altra parte, nel mese di luglio 1986, in un’in-tervista di Leonardo Mascagna a Maurice Ohanapubblicata ne “il Fronimo” n. 56 leggiamo il se-guente dialogo:
L. M.: Anche la Sua ultima composizione C a d r a nL u n a i r e è destinata alla chitarra a dieci corde.Lei non tornerà più allo strumento tradizionale?
M.O.: Assolutamente no, in nessun modo.L: M.: Lo ritiene definitivamente sorpassato?M. O.: Lo ritengo uno strumento molto limi-
tato, come il violino, che implica un’armonia ri-petitiva e monotona, con delle possibilità mol-to ristrette. In definitiva uno strumento che nonconviene al mio orecchio molto esigente e de-sideroso di estensioni molto più ampie.
Fin qui le parole e le azioni dei pro t a g o n i s t i .Vediamo ora cosa ricaviamo dallo studio dei do-cumenti che possediamo. Per gentile conces-sione della signora Vani de Carlevaro disponia-mo oggi delle fotocopie dei due manoscritti in-dispensabili per questa nostra ricerca: a) quel-lo realizzato durante la giornata di lavoro a Parigi,
nel 1974, per la maggior parte di mano diOhana mentre Carlevaro suonava degli esempisulla sua chitarra; b) quello che Carlevaro con-segnò al compositore nel luglio 1980 contenentela sua versione finale di E s t e l a s. Per comoditàdel lettore chiameremo in seguito “Ms. Ohana”il primo e “Ms. Carlevaro” il secondo. Il “Ms.Ohana”, realizzato in collaborazione con Carlevarodurante l’incontro parigino, si presenta schema-tico ma con molti dati concretamente fissati. Unc o n f ronto con la versione successivamente ela-borata dal chitarrista e cioè con il “Ms.C a r l e v a ro” ci mostra che quest’ultimo rimane fe-delissimo al primo. Carlevaro seguì la trama pia-nificata per quanto concerne l’ordine degli even-ti e conservò molte delle idee melodiche e rit-miche. In certi casi però variò alcuni elementie vedremo in seguito come questi diventeran-no particolarmente importanti nel compiere una l t ro confronto: questa volta tra Estelas e il ci-clo Cadran Lunaire ( le cui parti si intitolano“ S a t u rnal”, “Jondo”, “Sylva” e “Candil”) scritto daOhana tra il dicembre 1981 e il gennaio 1982.Ciò che attira particolarmente l’attenzione, e chein realtà è il motivo principale della nascita diquesto articolo, è la costatazione che la quasitotalità di E s t e l a s, prendendo come base il “Ms.C a r l e v a ro”, è stata utilizzata da Ohana in ma-niera frammentata e si trova distribuita nelleq u a t t ro parti che formano l’opera composta po-co più di un anno dopo che Carlevaro avevaconsegnato al compositore il sopracitato mano-s c r i t t o .
Entrambi i manoscritti, quello dell’abbozzo ori-ginale di Estelas e quello dell’elaborazione fina-le compiuta da Carlevaro, vengono presentati in-tegralmente nelle pagine seguenti. Il lettore po-trà vedere da sé l’evoluzione e la cristallizza-zione dell’opera nella sua forma definitiva. Èchiaro che, se il manoscritto del 1974 raccogliele idee condivise dai due artisti senza possibi-lità di distinguere le une dalle altre, le differen-ze che si trovano nel manoscritto finale di Carlevaro(“Ms. Carlevaro”) rispetto al primo sono esclusi-vamente farina del sacco del chitarrista. Risultaallora ancora più interessante il fatto che duedei passaggi più significativamente cambiati daC a r l e v a ro troveranno posto quasi testualmentenell’ambito dei quattro pezzi che formano ilCadran Lunaire.11.“Les Cahiers de la Guitare”, n, 9, gennaio 1984.

27
Le quattro pagine del manoscritto Ohana del 1974

28
L’appunto su Carlos Gardel è un promemoriaperché Carlevaro non dimenticasse un incarico
riguardante alcune registrazioni del cantante ditango.
LE SEI PAGINE DEL “MANOSCRITTO CARLEVARO” CONSEGNATO A OHANA NEL LUGLIO 1980

29
Per quanto riguarda le corrispondenze tra lediverse sezioni (o “estelas”) come appaiono nell’ab-bozzo stilato da Ohana e quelle nella versionedefinitiva redatta da Carlevaro, eccone qui di se-guito lo schema:
MANOSCRITTO OHANa MANOSCRITTO CARLEVARO
Estela 1 Estela 1Estela 2 Estela 6Estela 3 Estela 2Estela 4 Estela 3Estela 5 Non appareEstela 6 Estela 4Estela 7 Estela 5Estela 8 Appare quasi come un refrain
in Estela 4 e 7 del ms. Carlevarocome espressamente indicatonel Ms. Ohana
Quando gli autori di questo articolo (compa-trioti ma residenti in poli opposti del globo) sis c a m b i a rono le idee circa la registrazione del pro-gramma televisivo spagnolo del 1989, emerse in-tuitivamente la prima impressione di somiglian-za tra Estelas e Cadran lunaire . In realtà Carlevaro ,durante il programma, stava annunciando e inseguito eseguendo un’opera che fino ad alloranon era stata inclusa da Maurice Ohana nel ca-talogo delle sue opere per chitarra. La curiositàci ha indotto a confro n t a re quella re g i s t r a z i o n edi Carlevaro con la partitura di Cadran lunaire.Le somiglianze e le identità sono presto risulta-te evidenti e così ci siamo dati da fare per po-ter studiare i manoscritti. Una volta in possessodi questi ultimi, il loro confronto con l’edizionea stampa di Cadran lunaire ci ha portato allastesura della seguente tavola comparativa:
Quadro 1
MS Carlevaro: p. 1, inizio del 1° rigoCadran Lunaire: p.1, fine del 1° rigo e inizio del 2°
© 1983 Gérard Billaudot Editeur S.A. Paris

Quadro 4
30
Quadro 2
MS Carlevaro: p. 1, fine 2° rigo
Saturnal: p. 3, fine del 3° rigo. Il La # si trasforma in Si b. Ilritmo ripetitivo nel MS Carlevaro appare abbozzato a ma-tita. © 1983 Gérard Billaudot Editeur S.A. Paris
Quadro 3
MS Carlevaro: p.5, 4° e 5° rigo
MS Carlevaro: p. 1, 3° rigoSaturnal: p. 5, 1° rigo.
Saturnal: p. 5, 2° rigo. Si ripete l’idea del tremolando nelbasso e il glissato di clusters sui bassi e con corde a vuo-to. © 1983 Gérard Billaudot Editeur S.A. Paris
MS Carlevaro: p. 1, 4° rigo
Jondo: p. 6, 4° rigo
Jondo: p. 10, 4° rigo. Identità ritmica e armonica e inseguito adozione del motivo ritmico © 1983 Gérard BillaudotEditeur S.A. Paris
Quadro 5
MS Carlevaro: p. 1, 5° rigo
Jondo: p. 8, 5° rigo. Identità della tessitura e del caratte-re ritmico e armonico (il pedale del basso cambia cor-da) © 1983 Gérard Billaudot Editeur S.A. Paris

31
Quadro 6
S y l v a: p. 12, 5° rigo e p. 12 1° rigo © 1983 Gérard BillaudotEditeur S.A. Paris
Testo identico. Merita qui dare rilievo all’evoluzione d e l l ’ e f-fetto che si presenta in questo quadro. Nel “MS O h a n a ” è in-dicato: – con grafia di Carlevaro: “con pulg. e índice casi
un chasquido” (e una freccia con direzione all’insu); – con grafia di Ohana: “pulgar e índice levantan la cuerda” e“golpeado”; – ancora con grafia di Ohana segnalata quella che potrebbe essere un’altra maniera per eseguirlo: “ g l i s s .r á p i d o ” e una freccia dalla nota superiore a quella inferiore.Nel “MS Carlevaro” l’indicazione è “toque doble” e cioè azione simultanea di p- i, p-m sulla stessa corda. Infine, in“Sylva” Ohana indica: “su due corde con valori irregolari” e sotto “metallico e mordente”
MS Carlevaro: p. 2, 1°, 2° e 3° rigo
Quadro 7
MS Carlevaro: p. 3, intera
Candil: fine di p. 14
Candil: fine di p. 15 © 1983 Gérard Billaudot Editeur S.A. Paris
Il testo è quasi identico. Il Fa# si trasforma in La b nell’ostinato riccorrente. Si amplia lo svolgimento melodico nelle due vo-ci esterne

32
Come dicevamo prima, tra i casi di utilizzo daparte di Ohana di materiali appartenenti a E s t e l a s,stimolano maggiormente il nostro interesse quel-li in cui Carlevaro ha scelto di modificare o svi-l u p p a re alcuni degli elementi originali. Questi so-no: l’esempio 6 (“Sylva”, p. 12) e l’esempio 7(“Candil” p. 14 e 15). Nel primo caso Ohanaadottò testualmente la realizzazione di Carlevaro ,che differisce, per quanto riguarda le altezze, dal-la versione originale (Ms. Ohana). Nel secondocaso il compositore adottò ugualmente la ver-sione di Carlevaro per la melodia sopra l’ostina-to. Ciò le conferisce un carattere modale total-
mente diverso rispetto a quello che si pre s e n t a-va nel Ms. Ohana (Fa, Mi, Do#, Si nel Ms.C a r l e v a ro ai quali, in “Candil”, Ohana agrega unSol acuto, mentre nel Ms. Ohana troviamo Fa,Mi b, Fa naturale, Fa #, Re, Fa naturale). Sicura-mente, dopo più di sei anni, Ohana non ricor-dava molto quell’abbozzo originale di E s t e l a s e dera naturale che si basasse sulla versione conse-gnatagli da Carlevaro per trarre gli elementi dar i e l a b o r a re in un secondo momento. Oltre que-sto dato ovvio però non possiamo dimenticare ,anzi sottolineiamo, il fatto che Ohana ha semprerispettato le doti creative di Carlevaro.12
Quadro 8
MS Carlevaro: p. 6 (appare anche a p. 4)Jo n d o : p. 8, 3° rigo e sgg. © 1983 Gérard Billaudot Editeur S.A. Paris
Quadro 9
MS Carlevaro: p. 5, primi tre righi
S y l v a: p. 12, 1° e 2° r i g o . © 1983 Gérard Billaudot Editeur S.A. ParisPossiamo aggiungere che, in generale, l’uso degli armo-nici era quasi inesistente nell’opera chitarristica diOhana; in questo caso quindi appare abbondante il con-tributo carlevariano.
la Faruca y Cadencias”). Probabilmente Ohana non hamai più avuto un rapporto di tale confidenza e stimacon gli altri chitarristi che hanno interpretato le sue ope-re (e l’elenco è più che rispettabile poiché annoveraNarciso Yepes, Alberto Ponce, Luis Martin Diego,Stephan Schmidt e altri).
12. Visto che il chitarrista uruguaiano è l’autore dellecadenze del Concierto originale risalente al 1950, nonpotremo mai sapere se parti considerevoli di questa ope-ra nella sua forma oggi nota con il titolo Tres Gráficosprovengano dalla penna di Carlevaro. (Non dimenti-chiamo che il primo movimento è intitolato “Gráfico de
Passaggio parallelo elaborato: melodia in movimento diatonico/modale nei limiti di un ambito ridotto. Si noti che l’ulti-mo rigo è simile a un altro passaggio di Estelas segnalato nel Quadro 5

33
Ciò significa che Ohana accettò come defini-tiva la versione di Estelas consegnatagli da Carlevaronel 1980, anche se rimangono valide le consi-derazioni che abbiamo appena esposto e cioèche Ohana non disponeva del primo manoscrit-to e che il musicista uruguaiano aveva eseguitoin pubblico la composizione senza prima con-sultarsi con il compositore (cosa che condizio-nava in qualche maniera il suo ulteriore com-portamento). L’atteggiamento di Ohana denotaa p p rezzamento per la qualità del lavoro cheCarlevaro aveva realizzato sulla sua opera, d’al-tro canto però ci pone degli interrogativi: per-ché Ohana non ha consegnato l’opera alla suacasa editrice13 per farla pubblicare, come dicevaa Carlevaro nelle sue ripetute richieste del ma-noscritto? E come si spiega il fatto che non l’ab-bia inclusa nel catalogo delle sue opere neppu-re come manoscritto inedito? Questi interrogati-vi acquistano maggiore risalto se teniamo contod e l l ’ i m p ressionante quantità di esecuzioni di E s t e l a sche Carlevaro fece per vent’anni. Raramente unacomposizione contemporanea viene eseguitatanto frequentemente.
Pensiamo che una probabile risposta si trovinell’ultima lettera di Ohana a Carlevaro: “Estelassi trova nel “Maturatoio” in attesa di qualche pic-cola modifica prima della pubblicazione”. Dopoil confronto dei manoscritti scopriamo però chele “piccole modifiche” si sono trasformate inrealtà in una nuova composizione che sfrutta imateriali di Estelas. Visto che tutto il materialesonoro di Estelas è incluso in Cadran lunaire,perché pubblicarla? Siamo perciò giunti alla con-clusione che in realtà Ohana ha trattato Estelascome una fonte di materiali e di idee timbriche,di tessitura, melodiche e ritmiche da sviluppareulteriormente: punto di patrenza per arrivare aCadran Lunaire, composizione di maggior re-spiro e inoltre elaborata per la chitarra a diecicorde per la quale Ohana non ha mai smessodi manifestare esplicitamente la sua preferenza.
Ci domandiamo inoltre perché Ohana non ab-bia comunicato a Carlevaro l’utilizzo di questomateriale che per molti versi apparteneva all’in-terprete-compositore Carlevaro non meno che
a Ohana. Questo interrogativo si accentua ancorpiù se teniamo in considerazione, così come ri-sulta dalle nostre ricerche, la grande importan-za che ha avuto in generale Carlevaro come sti-molatore della produzione chitarristica di Ohana.
Ohana iniziò il suo “idillio” creativo con lachitarra tramite Abel Carlevaro e le sue mani “defaraón” (come lui stesso le definiva nella dedi-ca del Concierto) dalla fine degli anni Quaranta.Abbiamo già accennato all’affinità spirituale tra idue basata su un’ideologia artistica ben deter-minata. Questa affinità stimolò quella prima ope-ra di Ohana; in seguito, dopo la loro separa-zione nel 1950, il compositore tornò a compor-re per il nostro strumento nel 1955 con Tiento– che in qualche maniera si potrebbe conside-rare in relazione con il mondo del Concierto, eprecisamente con il terzo movimento (che nellaversione finale si intitola “Grafique de la Buleriaet Tiento”) a causa dei motivi melodici e ritmi-ci propri di questo ritmo flamenco – e ancoranel 1957 con l’adattamento di quella sua primaincursione nel repertorio chitarristico che diven-ne Tres Gráficos. Dopo i nuovi stimoli (NarcisoYepes, la chitarra a dieci corde, Si le jour pa -raît, Alberto Ponce) Ohana si allontana di nuo-vo dalla chitarra. Solo il ritorno di Carlevaro aParigi e quella lunga notte del 1974, quando in-sieme crearono Estelas ci hanno restituito Ohanacompositore per chitarra. Questo “incanto carle-variano” funziona a tal punto che Ohana nontorna a scrivere per chitarra per sei anni, fino aquando cioè non riuscì a ottenere il manoscrit-to di Estelas. E abbiamo già visto quanto aves-se insistito per averlo.
Abbiamo constatato con sorpresa la spropor-zione che esiste tra la quantità di dati che te-stimoniano la singolare relazione tra Ohana eCarlevaro e il poco (o niente) che si sa di essanel mondo musicale. Molte volte capita che trai rapporti umani, quelli più importanti e profon-di rimangano nell’ambito del privato. Molto pro-babilmente questo è uno di quei casi.
Con questo articolo non pretendiamo di dareuna risposta a questo mistero del repertorio chi-tarristico del XX secolo. Saremmo però soddi-sfatti se la trama dei fatti che abbiamo raccon-tato in queste pagine sarà servita a dare un’im-magine fedele a fatti e personaggi che meritanodi avere un posto d’onore nella storia della chi-tarra. 13. L’editore era allora Jobert e in seguito Billaudot.

34
1948 Abel Carlevaro e Maurice Ohana si conosconoa Parigi
1950 Ohana compone un Concerto per chitarra e or-chestra dedicato al Carlevaro che scrive le ca-denze. Nel mese di aprile eseguono per la pri-ma volta il secondo movimento a Parigi.
1951 Esaurita la risorsa della sua borsa di studio,Carlevaro deve far ritorno in Uruguay. La pri-ma esecuzione del Concerto non può quindiaver luogo. Non esistono testimonianze di al-tri contatti tra i due musicisti fino al 1974, ec-cezion fatta per un scambio di cartoline po-stali avvenuto tra il dicembre 1968 e il gen-naio 1969.
1951 Ohana pubblica (con data 1950) la Sarabandaper pianoforte e orchestra, trascrizione del se-condo movimento del Concerto per chitarra eorchestra. La Sarabanda viene presentata inprima esecuzione.
1957 Ohana compone Tres Gráficos per chitarra eorchestra dedicato a Yepes. Utilizza il primo eil terzo movimento del vecchio Concerto.
1974 Carlevaro torna a Parigi e si incontra di nuo-vo con Ohana. Basandosi su idee ed esempistrumentali forniti dal chitarrista, abbozzanoEstelas, opera firmata da Ohana e dedicata aCarlevaro.
1977 Seguendo l’indicazione espressamente data dal
compositore, Carlevaro dà a Estelas la sua for-ma definitiva e la esegue per la prima volta aNew York come “opera di Ohana dedicata aCarlevaro”.
1977 10 ottobre – Prima lettera di Ohana a Carlevarocon richiesta di una copia di Estelas.
1978 21 novembre – Seconda lettera di Ohana conla stessa richiesta.
1980 20 marzo – Terza lettera di Ohana e ripetutarichiesta di copia di Estelas.
1980 30 giugno – Carlevaro scrive a Ohana annun-ciandogli che nel mese di luglio gli porteràpersonalmente a Parigi la copia di Estelas.
1980 luglio (probabilmente il giorno 22) – Carlevaroconsegna a Ohana, a Parigi, la sua versione fi-nale di Estelas.
1980 31 dicembre – Cartolina postale di Ohana cheannuncia che Estelas è in attesa di qualche mo-difica prima di essere data alle stampe.
1982 Ohana compone Cadrai lunaire, dedicato aLuis Martin Diego, utilizzando praticamente tut-to il materiale di Estelas che non sarà mai pub-blicata. Carlevaro continuerà a suonare que-st’opera, sempre con il nome di Ohana comeautore e il proprio come dedicatario, fina allasua morte.
1992 Muore Maurice Ohana2001 Muore Abel Carlevaro.
TAVOLA CRONOLOGICA