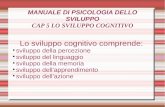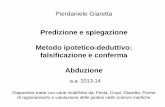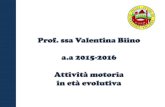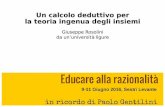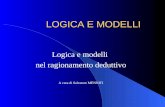Città di Torino Divisione Servizi Educativi-Settore ... · 2) Scoperta della funzione...
Transcript of Città di Torino Divisione Servizi Educativi-Settore ... · 2) Scoperta della funzione...

quello che potrebbe esserci scritto nel testo, legati alla più o meno alta conoscenza del suo contenuto e so-prattutto legati alla conoscenza sin-tattica della nostra lingua.
È necessario, a tal fine, tener pre-sente la relazione esistente tra lo scritto e il contesto, in caso contrario non potremmo sapere quale schema anticipatorio mettere in atto (Se si tratta di una ricetta di cucina o di un testo scientifico, ad esempio met-teremo in atto diversi schèmi antici-patori).
È necessario sottolineare l'impor-tanza degli schemi anticipatori in quanto ci permettono una lettura ve-loce facendo in modo che non si deb-ba decifrare tutta una parola oppure una frase, ma si possono fare pre-visioni in base al significato ed al contesto.
Tutto ciò ci permette di dare una spiegazione agli errori di lettura dei bambini quando, ad esempio, iniziano a leggere in modo esatto una parola finendo la poi in modo diverso da come è effettivamente scritta.
Essi non cercano di trovare una scappatoia all'impegno di una lettura attenta, si esercitano invece, se pure con risultati imperfetti, nell'utilizzo dei sistemi di anticipazione.
Il comportamento del bambino nei confronti della lettura è innanzi tutto condizionato dalla possibilità di sperimentare atti di lettura diversi, di costruirsi degli schemi logici di ri-ferimento. L'aver avuto modo di uti -
Quando lo stesso testo viene letto dapersone diverse, la comprensionedello scritto si modifica secondo icontributi personali che ogni lettore dàal significato del testo.
È innanzi tutto necessario tenerpresente che per poter leggere ade-guatamente un testo, il lettore devepoter conoscere le sue caratteristiche: forma grafica, dimensioni spaziali, forma grafica delle pagine,orientamento della scrittura, sistema ortografico.
Il testo fornisce indicazioni che nonrivestono tutte la medesima im-portanza e che devono essere consi-derate dal lettore soltanto se utili; incaso contrario il suo sistema percet-tivo sarà sovraccaricato da informa-zioni inutili e quindi creatrici di pos-sibili confusioni.
Nel processo di lettura oltre a mec-canismi di decifrazione, si mettono inatto processi di anticipazione di
Domandiamoci ora come avvienel'atto di lettura. La teoria condivisaancora da quasi tutto il mondo dellascuola sostiene che il lettore fa treoperazioni principali: a) decifra i se-gni, b) ne oralizza i suoni corrispon-denti in sequenza, c) ascolta i suoni ecapisce i significati (sia che ciò av-venga attraverso una lettura ad altavoce, sia che ciò avvenga attraversouna lettura silenziosa, in cui si sostiè-ne che l'oralizzazione è interna).
L'errore, secondo gli studi più re-centi, è stato, ed è ancora, quello di farcoincidere la capacità di leggere conla capacità di decifrare; ma come la scrittura non si apprende copiando, così non è imparando a decifrare che si impara a leggere.
Per intendere il processo di lettura dobbiamo innanzitutto comprendere in che modo il lettore, lo scrittore ed il testo contribuiscono a tale processo.
Città di TorinoDa "Bambini" n°4/1990
Divisione Servizi Educativi-Settore Servizi per l'InfanziaArchivio Bambini
1

lizzare e fare riflessioni su vari stru-menti di lettura: libri, giornali, lettere, barzellette, annunci pubblicitari, ognuno con caratteristiche proprie del linguaggio, permetterà al bambino dielaborare un sistema di conoscenzeutilizzando il quale sarà in grado diriconoscere ed anticipare il contenutodei diversi testi in base a delle caratteristiche conosciute inprecedenza.
Il ruolo delle immagini li bambino si comporta diversamente nei confronti della lettura a secondadella presenza o assenza di immagini afianco del testo. Nel caso di testo accompagnato dall'immagine si evidenzia il problema della relazione tra i due. Ad un livello iniziale si verifica l'indifferenziazione tra disegnoe scrittura, il lettore pensa che sipossano indifferentemente leggere testo e disegno. Ad un secondo livelloil testo può rappresentare solo l'etichetta dell'oggetto rappresentato.
Infatti il bambino alla domanda: "che cos'è questo?" (indicando il di-segno) risponde: "la mela", mentre alladomanda: "e qui che cosa ci sarà scritto ?" (indicando il testo che èscritto sotto) risponde: "mela", elimi-nando l'articolo ed il testo diventaun'etichetta sulla quale è scritto ilnome dell'oggetto (ipotesi del nome).
Quando si sottopone il bambino alla prova di invarianza, spostando uno stesso cartoncino con scritta la parola"mela" e ponendolo di volta in voltasotto disegni diversi, egli sostiene che il significato della scritta cambia inrelazione all'immagine sotto la qualeviene posta.
Ciò avviene perché all'inizio del processo di lettura il bambino pensa che gli indici che possono attribuire significati allo scritto siano il disegno e il contesto.
Man mano che il processo di acqui-sizione della lettura progredisce, le ca-ratteristiche quantitative del testo for-niscono indicazioni che permettono di
sostenere e perfezionare le previsioni re delle parole e il numero di seg-menti della frase.
La considerazione delle caratteri-stiche qualitative di un testo è carat-terizzata dalla conoscenza di modelli trasmessi socialmente, ad esempio il riconoscimento dell'iniziale del nome proprio o di altri conosciuti, e appare in un secondo momento in cui il bambino ha capito la natura del sistema. Nel processo di acquisizione della capacità di leggere il bambino utilizza due tipi di informazione: una di carattere visivo, fornita dalla posizione e dall'organizzazione delle lettere, che non dipende dal lettore; l'altra, non visiva, che è essenziale al processo di lettura: si tratta della competenza linguistica del lettore. Se il testo è infatti scritto in una lingua sconosciuta, chi legge potrà effettuare una esplorazione visiva delle pagine, ricercherà somiglianze e regolarità, ma non potrà effettuare un atto di lettura in senso stretto.
Un altro tipo di informazione non visiva è data da ciò che il lettore co-nosce del testo. Se noi prendiamo un libro di fiabe sappiamo già di che ge-nere sarà il contenuto e possiamo fare utili previsioni.
Ecco secondo la Ferreiro, l'impor-tanza di abituare il bambino ad operare con diversi testi per poterli analizzare, confrontarli con altri riconoscendone e valutandone le differenze.
li bambino avrà così modo di ac-quisire sempre più raffinate capacità di previsione intelligente.
Si può notare come l'autrice non dia importanza al processo di decifrazione dei segni grafici, anzi scoraggi l'utilizzo di tale metodo per l'insegnamento della lettura affer-mando che esso porta ad una verba - lizzazione dei segni grafici, senza cu-rare la comprensione di quanto viene letto.
Quando un bambino legge utiliz - zando unicamente le modalità della decifrazione, giunge alla fine della ri-ga di un testo e ne ha già dimenticato l'inizio, non a causa di un difetto di memoria, bensì dell'impossibilità di memorizzare una quantità di sillabe senza averne capito il significato.
Città di TorinoDa "Bambini" n°4/1990
Divisione Servizi Educativi-Settore Servizi per l'InfanziaArchivio Bambini
2

Il ruolo della scuola materna
Si può quindi impostare un lavoro specifico nella Scuola Materna perstimolare il bambino a porsi delle domande sul nostro sistema di scritturae per aiutarlo nel passaggio in questoprocesso evolutivo che, attraverso le tappe che abbiamo visto, lo porta ad essere pronto per l'apprendimentodella lettura-scrittura.
Un tale lavoro nella Scuola Materna sarà utile particolarmente per dare la possibilità di avvicinarsi alla linguascritta anche a quei bambini che a casa hanno scarse occasioni e scarsi modelli per poterlo fare; laScuola Materna può occuparsi cioèdelle idee che i bambini hanno su cosa è la scrittura e come funziona, di cuinessuno si occuperebbe fuori dal-l'istituzione scolastica.
Potremmo quindi sintetizzare gli obiettivi che la Scuola Materna puòporsi: 1) Familiarizzazione con lo scritto 2) Scoperta della funzione comunica-tiva dello scritto 3) Sviluppo della capacità di ragiona-mento deduttivo 4) Sviluppo dell'immaginazione come capacità di creare rappresentazioni mentali 5) Creare nel bambino il comporta-mento del "vero lettore"
Quali attività allora per raggiungere questi obiettivi?
Prima di tutto bisogna avere a di-sposizione materiale molto vario estimolante di lettura: libri di favole, libri di animali (anche quelli dei piùgrandi possono andar bene), giorna-lini, manifesti pubblicitari, posters,scatole varie che abbiano delle scritte, ecc., questo materiale deve essere sistemato in modo ben visibile daibambini; si può creare un angolo bi-blioteca, a turno i bambini esplete-ranno la funzione di bibliotecario edaranno in prestito i libri ai compagni.
L'angolo lettura dovrebbe essere unposto dove il bambino può sedersi o sdraiarsi, mettersi comodo insomma, un angolo tranquillo.
Avere materiale vario e ricco serve per stimolare nel bambino la curiosità
e la voglia di andare al di là di ciò che già sa.
Il bambino, come abbiamo visto, si pone naturalmente la domanda: "a cosa serve la scrittura ?" Sta a noi fornirgli materiale e momenti di discussione perché possa darsi delle risposte.
Lo scritto serve per ricordarsi, in-formarsi, comunicare: il bambino dovrà essere a contatto con scritti che esplicano queste tre funzioni.
Per ricordare può essere utile tra-scrivere la preparazione di una ricetta già sperimentata in classe; scrivere, accanto ai disegni, brevi brani che ricordino una storia inventata; fare un elenco delle cose da acquistare ecc. naturalmente scrive l'insegnante che è il modello, il bambino osserva e riflette.
Le illustrazioni servono per far ri-cordare al bambino "cosa c'era scritto".
Per ottenere informazioni si può si-stemare in classe un elenco illustrato dei compiti assegnati ai bambini, un tabellone cioè con nomi e simboli; un altro tabellone con scritte e di segni può essere quello del menù set-timanale; con l'aiuto dell'insegnante si possono ricavare dal giornale le in formazioni dei programmi TV; dalle scritte sulle scatole dei cibi si può sapere cosa c'è dentro e allora pos-siamo inventare in classe il gioco del mercatino con le bancarelle e relative insegne; anche i biglietti di annuncio di nascite o matrimoni ci danno delle informazioni; per costruire, per esempio, una bambola di lana, abbia-mo bisogno delle istruzioni illustrate, di un foglio esplicativo.
Parte di questo materiale può essere fotocopiato e incollato sul quaderno personale degli alunni, non importa se ancora non sanno leggere, le illustrazioni li aiutano a ricordare "cosa c'era scritto" e a sapere a "cosa serviva". In questo quaderno i bambini possono compiere i primi tentativi di scrittura, incoraggiati dalla maestra che non corregge gli sbagli ma gratifica e stimola i bam-bini: "bravo non è proprio come scri-vono i grandi, ma ci sei molto vicino!"
Spesso la scuola ha bisogno di co-municare alla famiglia avvisi vari; è
Città di TorinoDa "Bambini" n°4/1990
Divisione Servizi Educativi-Settore Servizi per l'InfanziaArchivio Bambini
3

il momento opportuno perché ilbambino sia partecipe di questi mes-saggi, ne possa discutere a scuola e acasa.
La comunicazione può avveniretramite avvisi illustrati; un tavolo condelle persone sedute attorno, indica una riunione; il disegno di un pulmanindica che nell'avviso si parla di una gita, ecc.
È importante che il bambino possa dettare all'adulto dei messaggi chevuole indirizzare ad altri, si puòpensare ad una cassetta per "imbu-care" i messaggi dei bambini, unavolta alla settimana i messaggi con-tenuti nella cassetta vengono lettidall'insegnante ai bambini.
Utile è senz'altro iniziare una pic-cola corrispondenza scolastica, inquesto caso i bambini sperimentano loscritto come vero strumento di co-municazione.
Quando ai bambini si presentanodei messaggi scritti e si domanda loro Il cosa ci sarà scritto ?" Ci si mettenella condizione di dover esercitarsi nel ragionamento deduttivo: prima ditutto essi devono raccogliere degli indizi che possono servire per arrivare alla comprensione (per esempio: si tratta di un biglietto, c'è la figura di un neonato, c'è una parola uguale al nomeSara, l 'ha portato Giorgio).
Poi bisogna mettere in relazione gliindizi: è un biglietto di annuncio di nascita, è nata una sorellina a Giorgio,si chiama Sara; a questo punto siformulano delle ipotesi su ciò che c'èscritto nel biglietto, tutte le ipotesisono accettate e discusse, solo allafine la maestra legge il biglietto e si possono così verificare le ipotesi.
Anche la lettura delle immagini diun libretto di favole serve per formu-lare delle ipotesi su ciò che c'è scritto nel libro, serve anche per sviluppare quella capacità di anticipazione sullo scritto che è tipica di ogni buonlettore.
Quando la maestra legge una favola e poi chiede ai bambini di descrivere ciò che ha letto, fa loro delle domande precise su personaggi, luoghi, azioni,ecc., facendo decidere i particolari,aiuta i bambini, cioè a sviluppare lacapacità di crearsi rappresentazioni
mentali, a trasformare delle frasi inimmagini mentali.
È questo un lavoro importante perla comprensione del testo, la semplice decifrazione non può essere con-siderata lettura, troppo spesso capita che bambini "alfabetizzati" non ri-cordino alla fine della lettura, sebbene di brevissimi testi, quello che hanno letto.
Questo ci porta al discorso delcreare nel bambino il comportamento del "vero lettore" che dovrebbe essere l'obiettivo terminale della scuola dell'obbligo che inizia appunto con laScuola Materna.
Per vero lettore si intende non ilsemplice alfabetizzato, ma colui chetrae piacere dalla lettura, sa scegliere le proprie letture in vista di scopi bendefiniti, sa fare delle previsioni e delle ipotesi su ciò che inizia a leggere e continua a leggere anche dopo la scuola.
Compito senz'altro arduo per lascuola, se si pensa quanto poco si èportati a leggere nella nostra società, dominata dal video, dalle immagini, dalle telecomunicazioni, ma proprio per questo ancora più importante: l'analfabetismo di ritorno è, secondoindagini, svolte in questi ultimi annisia in Europa che in USA, in continuaprogressione, e la scuola ha una parte di responsabilità se molti ragazzi,terminata la scuola dell'obbligo, non leggono più.
Fra le molte strategie che la scuola dell'obbligo dovrà mettere in atto peraffrontare il problema lettura c'èquello di cominciare a pensare chenon ci sia l'apprendere a leggere prima di leggere, come non c'è l'apprendere a parlare prima di parlare, l'apprendere a vivere in un gruppo prima di vivere in un gruppo, il conoscere lo spazio prima di vivere nello spazio, ma siapprende a parlare parlando, si conosce lo spazio vivendo nellospazio ecc. e così si apprende lo scritto vivendo lo scritto.
Questo vivere lo scritto, abbiamovisto, inizia molto presto a livello so-ciale, e spetta proprio alla scuola ma-terna creare le situazioni e gli stimoliperché questo "vivere lo scritto" sia labase di un apprendimento della lettura che non sia solo alfabetizzazione.
Città di TorinoDa "Bambini" n°4/1990
Divisione Servizi Educativi-Settore Servizi per l'InfanziaArchivio Bambini
4

Città di TorinoDa "Bambini" n°4/1990
Divisione Servizi Educativi-Settore Servizi per l'InfanziaArchivio Bambini
5

Città di TorinoDa "Bambini" n°4/1990
Divisione Servizi Educativi-Settore Servizi per l'InfanziaArchivio Bambini
6

Città di TorinoDa "Bambini" n°4/1990
Divisione Servizi Educativi-Settore Servizi per l'InfanziaArchivio Bambini
7

Ai genitori degli alunni di cinque anni della scuola materna statali Osio Sotto
Come già sapete, per i bambini di cinque anni, è stato programmato e già avviato un lavoro di particolar sensibilizzazione e avvicinamento alla lingua scritta.
Si pensa comunemente che compito della Scuola Materna sia quello di sviluppare le capacità motorie, sensoriali e percettive e il linguaggio verbale, che sono i prerequisiti all'apprendimento della lingua scritta.
Studi effettuati recentemente hanno scoperto l'esistenza di un processo evolutivo, che inizia molto precocemente (molto prima dei sei anni), durante il quale il bambino attraversa delle tappe fondamentali che portano ad avere un'idea esatta del nostro sistema di scrittura, cioè ad ogni segno corrisponde un suono e viceversa e che tutto ciò che si dice può essere scritto.
Ne consegue che la scuola materna ha il compito di facilitarenei bambini il passaggio attraverso queste tappe, mettendo loro a disposizione diverso e vario materiale scritto stimolando in loro la formulazione di ipotesi sulla scrittura e la lettura gratificandoli nei loro primi, seppur "sbagliati" secondo noi adulti, tentativi di scrittura, mettendoli cioè in una situazione in cui abbiano la possibilità di sperimentare, di far domande e cercare insieme agli altri, compagni e maestra, le risposte, confrontare le proprie opinioni, frutto di anni di osservazioni sullalingua scritta, con la quale sono a contatto quotidianamente (insegne, pubblicità, segnalazioni stradali, TV, sulle quali i bambini riflettono prima di entrare nella Scuola elementare). È molto importante che il lavoro si fa a scuola con i bambini sia capito e condiviso anche a casa, perciò vi sottoponiamo questo questionario che ha lo scopo di raccogliere le vostre opinioni e di avviare con voi un dialogo su questo argomento, che continuerà poi durante le riunioni nel corso dell’anno scolastico. L’insegnante La psicopedagogista
Città di TorinoDa "Bambini" n°4/1990
Divisione Servizi Educativi-Settore Servizi per l'InfanziaArchivio Bambini
8