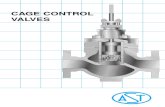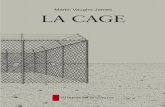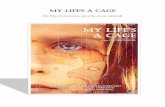Cage in Italia-libre
-
Upload
salvatore-melidoro -
Category
Documents
-
view
19 -
download
0
description
Transcript of Cage in Italia-libre
-
JOHN CAGE IN ITALIA: SENTIERI INTERROTTI.1
VENIERO RIZZARDI
Per molto tempo la ricezione dellesperienza di Cage come un insieme di dati di fatto, ossia di produzioni musicali, stato un tema minoritario o assente, soprattutto in Europa, dove sul finire degli anni Cinquanta, quando Cage innesc, oggettivamente, una reazione autocritica da parte delle avanguardie musicali, si fin presto per convenire sullirrilevanza e in definitiva sullinutilit di una disamina dei testi veri e propri dei singoli lavori, sem-brando sufficiente apprezzarne lartisticit, oltre agli aspetti provocatori, nel carattere di performance, nei riferimenti extramusicali, negli aspetti parateatrali, ecc. Era cos evitata una discussione, generalmente ritenuta imbarazzante, attorno ai contenuti propriamente musicali del suo lavoro.
Per comprendere la musica di Cage si dovuto attendere il formarsi di uno stile di analisi anche filologicamente attrezzato, che riconducesse la sua produzione alla sua oggettivit,2 quando in precedenza le dettagliate descrizioni delle procedure compositi-ve che lo stesso Cage aveva fornito, per illustrare al meglio le possibilit dellindetermi-nazione, sembravano dispensare da fatiche analitiche in cui nessuno daltronde riteneva utile avventurarsi, e lasciavano aperte le questioni poste dalle opere in quanto tali. La critica e la musicologia, specialmente in Europa, sono dunque a lungo rimaste sorde alla sollecitazione implicita a una delle fondamentali affermazioni di principio di Cage, il suo compito di compositore essere appunto quello di porre, ad ogni nuova opera, sempre nuove questioni. Soltanto poco prima della sua morte, verso la fine degli anni Ottanta, sono stati gradualmente rimossi i motivi sostanzialmente ideologici che avevano carat-terizzato la prima ricezione europea di Cage. Spentasi leco di uno scandalo iniziatosi ormai svariati decenni addietro, stato avviato un confronto finalmente disincantato con la specificit musicale della sua produzione, senza per questo neutralizzarne la radicalit degli assunti. Ed su tale orizzonte che occorre tracciare una considerazione retrospet-tiva della sua ricezione europea, che prende avvio nel 1949, quando Cage stabilisce un importante contatto con Pierre Boulez e lambiente musicale parigino, e che si sviluppa pienamente dopo il 1954, anno delle prime presentazioni pubbliche delle composizioni realizzate per mezzo di chance operations in una delle principali vetrine della nuova mu-sica europea, il festival di Donaueschingen, allorch suscita una reazione vivacissima da parte dellintera comunit internazionale dei compositori e musicologi. Tuttavia la storia della ricezione europea di Cage non si pu fare senza tener conto di significative varianti regionali: non dunque per convenzione, ma per ragioni oggettive che opportuno affrontare il tema Cage in Italia, ricco di dati di fatto e di motivi dinteresse, che spesso fuoriescono dallambito della cultura musicale. Il tema viene qui affrontato sommando alcuni frammenti di una storia ancora da scrivere; per il momento proponiamo un certo numero di dati e commenti a momenti significativi della sua fortuna italiana.
Cage pass gran parte del 1949 in Europa insieme a Merce Cunningham, soggiornando
1 Limpianto di questo articolo risale al 1993. Pubblicato sul n. 2 dei Quaderni Perugini di Musica Contemporanea in un numero interamente dedicato al compositore statunitense da poco scom-parso, cercava di proporre una prima retrospettiva sulle vicende della ricezione italiana di Cage. Lo ripubblico qui per quanto, dopo tanti anni, mi pare ancora utile attualizzando dove necessario; integrando, aggiornando dove opportuno, insomma tutto ci che era inevitabile fare, in alternativa a un nuovo articolo oppure alla pubblicazione di quello vecchio tal quale come documento storico.
2 Fondamentali sono stati in questo senso gli studi pubblicati da James Pritchett a partire dal 1979 e confluiti poi nel volume The Music of John Cage, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, che rimane tuttora il migliore contributo musicologico sullintera opera di Cage.
-
soprattutto a Parigi, dove strinse unimportante amicizia con Boulez, ebbe modo di pre-sentare in diverse sedi i suoi lavori per pianoforte preparato e in generale stabilire una connessione con gli ambienti della musica contemporanea europea, le cui conseguenze si sarebbero manifestate appieno qualche anno pi tardi. Questo potrebbe valere in misura ancora maggiore per il suo soggiorno italiano, di cui non si pu per dire se abbia dav-vero favorito un qualche reale contatto con lambiente musicale. Cage fu infatti presente al Festival della Societ Internazionale di Musica Contemporanea che quellanno si tenne in Sicilia, nelultima settimana di aprile. Assistette al Pierrot Lunaire di Schoenberg diretto da Pietro Scarpini, con Marya Freund, a Villa Igea di Palermo, recensendolo entusiasti-camente per Musical America.3 Dallo stesso articolo si apprende che Cage, terminato il festival, si spost a Milano per il primo Convegno Internazionale di Musica Dodecafonica. suggestivo pensare che in queste occasioni possa avere incontrato e scambiato idee con compositori italiani, in particolare Bruno Maderna, anchegli presente a Palermo e a Milano, ma di contatti del genere non si finora trovata traccia.
Per la sua prima apparizione pubblica si deve attendere il 1954. I cinque anni trascorsi nel frattempo sono carichi di sviluppi sia per Cage sia per la musica europea. In quellan-no Luciano Berio, che forse lo aveva incontrato in occasione di uno dei suoi numerosi concerti europei di qualche mese prima, sollecit Gino Negri, allora curatore della pro-grammazione musicale del Centro Culturale Pirelli di Milano, a organizzare in quella sede un concerto a due pianoforti con Cage e David Tudor. Il concerto milanese, tenutosi il 5 dicembre 1954, fu lultimo del loro tour autunnale, e con ogni probabilit comprendeva i nuovi pezzi per pianoforte preparato 3157.9864 for a Pianist e 3446.776 for a Pianist, a volte eseguiti simultaneamente. sicuro che si riprodusse anche a Milano lo scandalo gi suscitato a Donaueschingen e altrove. Si verific tra laltro un incidente grottesco: Riccardo Malipiero, che aveva introdotto il concerto, durante lintervallo prese di nuovo la parola per ritrattare tutto quanto di elogiativo aveva premesso, sulla fiducia, allesibizione dei due americani.4
Ma anche in Italia, come nel resto dEuropa, bisogna attendere qualche anno perch la presenza di Cage abbia modo di esercitare unazione sui giovani compositori, e preci-samente il 1958, quando Cage torna in Europa, presenta il Concert for piano and orche-stra5 e si presenta ai Corsi estivi di Darmstadt insieme a Tudor, con un seminario e una delle sue provocatorie conferenze-performance. In Italia Berio il primo a mostrare un interesse attivo nei suoi confronti: gi nel 1956 organizza al Conservatorio di Milano un concerto per la serie degli Incontri Musicali da lui diretta (replicato poi al Conservatorio di Venezia), in cui David Tudor presenta Music of Changes ;6 poi, sul finire del 1958, invita nuovamente Cage a Milano, dove soggiorna per quattro mesi fino al febbraio del 59; in questo periodo realizza tra laltro il nastro di Fontana Mix presso lo Studio di Fonologia della RAI, con lassistenza di Marino Zuccheri,7 e compone Aria per Cathy Berberian, che subito ne presenta la prima esecuzione.8 Ed sempre per interessamento di Berio, non-ch di Umberto Eco e Roberto Leydi, che Cage partecipa alle trasmissioni TV di Lascia o
3 John Cage, Contemporary Music Festivals Are Held in Italy, Musical America, giugno 1949, ora in John Cage: Writer. Selected Texts, a cura di R. Kostelanetz, New York, Cooper Square, 2000, p. 45.
4 Cos mi riferiva nel 2000 Roberto Leydi, che allepoca aveva fatto parte del gruppo promotore della serata Cage al Circolo Pirelli.
5 Kln, Westdeutsche Rundfunk (Musik der Zeit), 19 set. 1958. David Tudor, pf., John Cage, dir.
6 Milano, 6 dic.1956, Venezia 8 dic. 1956.
7 Cfr. la testimonianza di Marino Zuccheri Hur Fontana Mix kom till, in Nutida Musik, VI/6 (1962/63).
8 Roma, Accademia Filarmonica, 5 gen. 1959.
-
Raddoppia, nel gennaio 59, per le quali compone appositamente Water Walk e Sounds of Venice, due brevi composizioni che utilizzano nastri realizzati allo Studio di Fonolo-gia. Berio e Cage in questo periodo effettuano anche una breve tourne italiana con un programma di musica per due pianoforti (Winter Music, Music for Piano, Variations I), e la partecipazione occasionale di Cathy Berberian.9 Le cronache di quel periodo segnalano altre presentazioni della musica di Cage, come il concerto milanese del 21 gennaio alla Rotonda del Pellegrini, primo episodio pubblico dellassociazione di Cage con Juan Hi-dalgo e Walter Marchetti;10 e un significativo passaggio a Padova, favorito dalla presenza in citt di Sylvano Bussotti e Heinz-Klaus Metzger, che organizzano per conto dellallora vivacissimo circolo culturale Il pozzetto una performance pianistica di Cage, cui parte-cipano essi stessi insieme a Teresa Rampazzi. Il programma padovano comprendeva Win-ter Music, parti di Music for Piano, Variations I, Music Walk e unaudizione del nastro del Concert for Piano and Orchestra registrato a Colonia pochi mesi prima. La serata ebbe luogo il 7 febbraio, e fu preceduta da una conferenza di Metzger su Il progresso musicale da Schnberg a Cage.11 del resto significativo che la prima pubblicazione del saggio di Metzger John Cage o della liberazione, decisivo per la ricezione europea di Cage, appaia, quellanno, in italiano (tradotto da Sylvano Bussotti) su Incontri Musicali,12 la rivista di-retta da Berio e collegata allomonima serie di concerti organizzata congiuntamente con Luigi Nono a Venezia. Occorre poi ricordare il concerto, importante per lambiente romano, di David Tudor nel novembre 1959 allEliseo; poi i concerti veneziani di Musica doggi (giugno 1960) di Cage, Tudor, e Cornelius Cardew allAccademia di Belle Arti, con la prima italiana del Concert for Piano and Orchestra, e le Variations I , seguiti, di l a qualche mese, dallo spet-tacolo di danza di Merce Cunningham e Carolyn Brown, con Cage, Tudor ed Earle Brown, alla Biennale di Venezia. Le presenze di Cage in Italia si diradano a partire dal 1962, per riprendere sul finire del decennio si deve ricordare almeno il lavoro di Marcello Panni e della cerchia riunita attorno alle Settimane Musicali di Palermo13 in una situazione ormai mutata, che ha gi riassorbito limpatto, e gli entusiasmi di quelle prime presentazioni. Sono dunque gli anni tra il 1954 e il 1962 a delimitare la prima ricezione italiana di Cage, comprendendo, in un ruolo del tutto particolare, la posizione di Luigi Nono che, in una sede internazionale come i Corsi estivi di Darmstadt, nel settembre del 1959 prende net-tamente posizione contro la scuola informale nordamericana nella conferenza Presenza storica nella musica doggi, un testo che avr in breve unintensa circolazione.14 Tuttavia, prima di procedere a un commento di questi fatti, occorrer qualche considerazione pi generale sulla posizione di Cage rispetto alle avanguardie europee degli anni Cinquanta.
9 Milano, 20 dic. 1958, Roma, 5 gen. 1959, Firenze 8 gen. 1959.
10 La registrazione del concerto stata pubblicata nel 1999 a cura di Gabriele Bonomo nel CD La registrazione del concerto stata pubblicata nel 1999 a cura di Gabriele Bonomo nel CD Rumori alla Rotonda, Alga Marghen VA 11NMN.031. Il programma comprendeva musiche di Cage, Feldman, Marchetti, Hidalgo e Leopoldo La Rosa.
11 La documentazione si trova ora ne La documentazione si trova ora ne Il Pozzetto - un orizzonte aperto, a cura di F. Busetto e M. B. Ceolin, Padova, Editoriale Programma, 1991.
12 Oggi reperibile in Oggi reperibile in John Cage, a cura di G. Bonomo e G. Furghieri, Milano, Marcos y Marcos, 1999 (Riga, 15), p. 273.
13 Visione che si ebbe nel cielo di Palermo. Le Settimane Internazionali Nuova Musica 1960-1968, a cura di F. Tessitore, Roma, Cidim Rai-Eri, 2003. Al volume sono allegati due CD, uno dei quali comprende una storica registrazione di Winter Music, eseguita da A. Ballista, B. Canino, A. Neri, F. Rzewski, V. Voskobojnikov al Teatro Biondo di Palermo il 31 dicembre 1968.
14 Con il rifi uto dellesperienza di Cage, Nono si poneva contemporanemente in urto con la stessa Con il rifiuto dellesperienza di Cage, Nono si poneva contemporanemente in urto con la stessa cerchia di Darmstadt. Cfr. L. Nono, Presenza storica nella musica doggi, in La nostalgia del futuro. Scritti scelti 1948-1986, a cura di A.I. De Benedictis e V. Rizzardi, Milano, Il Saggiatore, 2007, pp. 147-154.
-
La compresenza-complementariet delle tecniche di organizzazione seriale della scrittu-ra e di quelle volte alla mobilit e apertura della forma un motivo forte della musica nuova, e lintenso scambio di esperienze tra Cage e Boulez sul finire degli anni Quaran-ta, quale viene documentato dalla corrispondenza,15 pu considerarsi un vero e proprio laboratorio didee nel quale il comune orientamento allautomatismo e allimpersonalit dei processi compositivi non si ancora fissato nel ricorso a principi casualit e serialit che, poco pi tardi, verranno ideologicamente contrapposti, con unartificiosit pole-mica che lascer tracce durature. Da questa angolatura il ruolo di Cage, comunemente designato come colui che fa precipitare la crisi della musica seriale, appare invece tutto interno alle vicende della nuova musica europea anzi, il fatto che Cage sia divenuto lemblema stesso di quella crisi si lascia interpretare proprio in ragione del suo contributo, decisivo, alla formazione di quello stesso pensiero seriale. In questo intreccio, dunque, se relativamente facile risalire a Cage dalle partiture pi scopertamente eversive, non cos semplice stabilire quanto lineare sia la sua influenza sulla quantit di opere aperte e mobili che si vengono producendo in quel periodo. Certo, le coincidenze temporali con quanto si produce in Italia sembrano parlare chiaro: con la Sequenza per flauto solo (1958) Berio introduce nel suo lavoro elementi di indeterminazione per quel che riguarda le durate; e Franco Evangelisti concepisce il quartetto Aleatorio nel 59, in tre brevi sezio-ni in successione libera, e altezze in qualche caso indeterminate.
La prima fase della ricezione italiana di Cage corrisponde dunque a contatti, incontri, concerti, frequentazioni che avvengono durante il suo intenso soggiorno milanese; e non una coincidenza il fatto che i musicisti a lui pi vicini in questa fase siano quelli che assumono pi pragmaticamente nel loro lavoro i risultati della destrutturazione cageana fino a farne elementi di stile: n i pittogrammi di Sylvano Bussotti, n le performances di Walter Marchetti hanno in comune gran che con le riflessioni in negativo, appena qual-che anno pi tardi, di un Donatoni. Quanto a Berio, noto quanto la sua scrittura vocale sia stata influenzata dalle caratteristiche vocali e interpretative di Cathy Berberian, ma anche vero che Aria di Cage contribu in modo decisivo ad affermare la personalit di Berberian come musa vocale della neovanguardia. Le tracce certe dellinfluenza di Cage sono comunque assolutamente eterogenee. Per esempio, interessante osservare come il testo capitale, il Concert for Piano and Orche-stra, agisca in direzioni tanto diverse: la sua notazione, in cui Cage aveva compendiato tutte le sue scritture sperimentali fino a quel momento, lantecedente immediato dei piano pieces for david tudor16 del 1959, metamorfosi musicale, suggerita da Metzger, di alcuni disegni che Bussotti aveva tracciato anni prima - dove entra in gioco, come mo-tivo originario, un gestualismo affine a quello riscontrabile nelle performances cagiane.17 Daltronde propriamente limmagine sonora, inaudita, del Concert il modello evidente di unopera come il Concerto per pianoforte (ancora 1959, dedicato a David Tudor), che Bruno Maderna realizz per mezzo delle elaborate tecniche seriali che impiegava in que-gli anni, una partitura convenzionalmente notata, ad eccezione della parte solistica, che invece abbonda in grafismi e notazione dazione.
15 Pierre Boulez/John Cage, Pierre Boulez/John Cage, Correspondance et documents, edits par Jean-Jacques Nattiez, nou-velle d. revue par R. Piencikowski, Mainz, Schott, 2002; tr. it. Corrispondenza e documenti, ed. it. a cura di W.E. Rosasco, Milano, Archinto, 2006.
16 Correttamente, Correttamente, five piano pieces for david tudor.
17 Occorre anche accennare, in questo contesto, a Giuseppe Chiari, inizialmente associato a Bussot- Occorre anche accennare, in questo contesto, a Giuseppe Chiari, inizialmente associato a Bussot-ti, e pi avanti direttamente coinvolto nel movimento fluxus.
-
La ricezione verbale di Cage esprime questa situazione in modo caratteristico: per esem-pio, Umberto Eco, fin dallora molto vicino a Berio, sceglie di iniziare la trattazione de la poetica dellopera aperta, in uno dei libri-chiave della neoavanguardia,18 con quattro esempi musicali (Stockhausen, Klavierstck XI; Berio, Sequenza per flauto solo; Pousseur, Scambi; Boulez, Troisime Sonate) cio tutti lavori in diverso modo debitori a Cage, e in qualche caso per ammissione degli stessi autori mentre il compositore americano figura, in quello stesso libro, soltanto in unappendice dedicata alla penetrazione delle dottrine Zen nella cultura occidentale. Questo esempio illustra bene come la rapida assi-milazione del pensiero di Cage allorizzonte problematico delle neoavanguardie coincida con lavvio della rimozione della sua esperienza musicale vera e propria, mentre la sua azione viene gi rubricata tra le attualit culturali. Questo effetto di rimozione il prodotto di due prese di posizione in apparenza contrap-poste, luna nettamente critica, laltra apologetica, che tuttavia, finiscono ambedue per travisare gli assunti originali di Cage. Da una parte, come si detto, la critica tutta poli-tica di Luigi Nono, che accusa Cage di unostentata indifferenza verso la storia e il neces-sario confronto che ogni artista deve istituire con essa; Nono inoltre nella sua requisitoria equivoca volontariamente il concetto di indeterminazione con quello di improvvisazione questultimo in realt osteggiato da Cage che favorirebbe irresponsabilit e dilettan-tismo da parte del compositore.19 Dallaltra parte vi lassolutizzazione del pensiero di Cage come critica dei fondamenti del comporre, in origine adornianamente proposta da Metzger,20 e destinata a divenire una formula teorica ambiguamente radicale di larga circolazione. passato qualche anno, e nel 1963, quello che sar il principale sostenitore italiano di Cage, Mario Bortolotto, interviene a commentare le urgenze mimetiche della nuova mu-sica, ossia lesplicitazione della sua condizione critica nel ritrovamento di metalinguaggi: soprattutto quello scenico, da cui nacque quello che fu denominato teatro strumenta-le. Bortolotto tracciava una linea diretta tra Cage e la nuova metamusica europea, so-stenendo non tanto che la critica dellamericano negasse semplicemente la capacit, dimostrata ad usura, di riuscire ancora a pensare la composizione, a far musica insomma; ma che ebbe tutto il suo valore quando propose una soluzione ancor pi strenua, che fu del dekomponieren prima; e oggi, con Kagel e Schnebel, laffacciarsi di una semplice pro-vocazione a mimare latto in cui la musica sorge, insieme creativo ed esecutivo, e cio ad agire come se la musica fosse ancora possibile.21 Tre anni pi tardi lazione della critica (non pi virgolettata!) di Cage verr considerata anche pi profonda, in un commento retrospettivo alla stagione della composizione cosiddetta aleatoria: La provocazione, lintellettuale morsa degli enunciati cagiani, scardinarono concetto, e prassi, aleatori, semplicemente indicandone la tenue provvisoriet. La multivalenza di quel comporre d in effetti per intangibile il momento compositivo in s: ne garantisce, giusto estendendo-ne il raggio, la natura carismatica.22
18 Umberto Eco, Umberto Eco, Lo Zen e lOccidente, in Opera aperta, Milano, Bompiani, 1962, pp. 212-215.
19 Cfr. sempre L. Nono, Cfr. sempre L. Nono, Presenza storica nella musica doggi, cit. La corrispondenza tra Nono e Cage rivela, daltra parte, un perdurante rapporto di amicizia tra i due che si rinsalda, poco prima della morte di Nono, in un incontro avvenuto a S. Pietroburgo (allora Leningrado) nel maggio 1988, durante il 3. Festival Musicale Internazionale dellURSS (comunicazione personale di J. Cage, maggio 1990).
20 Cfr. Cfr. John Cage o della liberazione, cit.
21 Mario Bortolotto, Mario Bortolotto, Comdie tiroir. Sulle urgenze mimetiche della nuova musica, ne Il Verri, n.14, 1964, p. 64.
22 Mario Bortolotto, Mario Bortolotto, un paradisus interruptus, in Avanguardia e Neoavanguardia, Milano, Sugar, 1966, p. 245.
-
A questa posizione corrispondeva pi di ogni altro latteggiamento del compositore ita-liano che defin allora un possibile post-cagismo in termini radicali e negativi, ossia Fran-co Donatoni, che tra il 1961 (Puppenspiel) e il 1962 (Per orchestra) aderiva ad un meto-do che consentisse di indagare la possibilit di indeterminazione globale della materia sonora; nel suo primo e pi importante compendio di poetica, Questo, Donatoni parte dallirreversibilit dellesperienza di Cage in quanto negazione del comporre (per essere cagiani non serve studiare lopera di Cage, bisogna soltanto esser compositori e morire cagianamente) respingendo per fermamente, nello stesso Cage, la possibilit, giudica-ta illusoria, di qualunque rigenerazione. Occorreva allora, secondo Donatoni, corregge-re lerrore fondamentale nato dallesperienza di Cage: latto di identificarsi al potere del suono appropriazione indebita di potere e reato di lesa materia.23
Anche Franco Evangelisti mostra di condividere la posizione di Bortolotto,24 pure nel suo lavoro lazione di Cage d luogo ad una diversa, feconda ambiguit: se la sua invocazione dellimminente fine della musica non una conclusione apocalittica, bens lavvento di un nuovo mondo sonoro a venire qualcosa che per Cage era invece praticabile da subito le invenzioni che precedono il silenzio di Evangelisti sono invece, nellapplicazione coe-rente dellindeterminazione dei parametri compositivi, tra le pi autenticamente cagiane delle musiche prodotte in Italia in quegli anni: Random or not Random, definita, pi che un partitura, una somma di appunti per orchestra (1957-62), esplicitamente dedicata alla squisita poetica del nulla di John Cage.
Una serie di testimonianze tardive, raccolte in un volumetto uscito nel 197825 a seguito di due importanti manifestazioni italiane dedicate a Cage (v.infra), consentono di com-prendere meglio, nel racconto retrospettivo dei protagonisti, i motivi fondamentali della prima ricezione italiana di Cage. significativo che a quel punto Bortolotto consideri la musica di Cage ferma allo stadio della stupefazione suscitata con il Concert for Piano and Orchestra, un giudizio che daltronde riprende, quasi alla lettera, quello gi espresso da Adorno nel 1964;26 e, nel dichiarare superato il suo stesso intransigente cagismo di un tempo, ricomprende lesperienza di Cage in unavanguardia ritenuta, in unacce-zione molto personale, fenomeno parassitario rispetto allautentica modernit musicale. Nelle parole di Paolo Castaldi, Cage sembra divenire lantecedente diretto del postmo-dernismo che si affaccia nella seconda met degli anni Settanta, avendo egli significato soprattutto la liberazione da tutte le grammatiche, da tutti i divieti, e lincoraggiamento verso il collage, limpiego di nessi banali, la riassunzione della materia consonante e lo sdoganamento del principio della ripetizione come elemento strutturale. Sempre nello stesso volumetto, Niccol Castiglioni, il cui lavoro peraltro non presenta riscontri diretti di una ricezione di Cage, rileva acutamente un motivo originario della poetica cagiana, ossia la proposizione di un diverso ordine dellascolto, possibile a partire dal sovvertimento del rituale concertistico. Sylvano Bussotti, il quale, nei primi anni 60, aveva introdotto una scrittura sperimentale derivata da quella di Cage, fino ad essere considerato alla stregua di suo allievo, , del tutto controcorrente, ancora il pi vicino, al-
23 Franco Donatoni, Franco Donatoni, Questo, Milano, Adelphi, 1970, p. 16.
24 Franco Evangelisti, Franco Evangelisti, Dal silenzio a un nuovo mondo sonoro, Roma, Semar, 1991. Cfr. lAppendice A. Degenerazione del significato della musica. Il libro fu terminato da Evangelisti nel 1979 e pubblicato per la prima volta in traduzione tedesca a cura di H.-K. Metzger e R. Riehn nella serie musik-konzepte, 43/44, Mnchen 1985.
25 John Cage. Dopo di me il silenzio (?), a cura di F. Mogni, Milano, emme edizioni ,1978.
26 Th.W.Adorno, Th.W.Adorno, Schwierigkeiten. I. Beim komponieren, tr.it. Difficolt.I.Nel comporre, in Impromptus, Milano, Feltrinelli 1973.
-
meno nella considerazione retrospettiva, alle scelte musicali di Cage, ed anzi il suo richia-mo, ancora, al Concert, in direzione contraria allesemplarit eversiva continuamente riproposta, e giunge fino a metterne in rilievo contrassegni stilistici.27
Si tratta di pensieri ormai postumi, che si compendiano bene nelle parole di Donatoni, allorch, in questa stessa occasione, ritorna sullesperienza di Cage qualificandola come malattia che contagi unintera generazione; e dei sintomi, ognuno di noi assolutizz quello a s somigliante: vi fu il caso e lindeterminazione, il grafismo e limprovvisazione, leccentricit narcisistica e lo pseudo-zen, lo happening e la indiscriminazione dellesito, il processo formalizzato e lequivalenza materiale/opera, e chi pi ne farnetica pi lo at-tribuisca a Cage.28 I temi negativi, dominanti nella ricezione europea di Cage, risultano infatti, nelle esperienze italiane, radicalizzati in una posizione nichilistica come quelle di Bortolotto e Donatoni, in apparenza simili, ma sostanzialmente lontane dai fondamenti dialettici del pensiero di Metzger posizione che, naturalmente, viene consumata molto presto. Dunque, con le parziali eccezioni rilevate in precedenza, non quasi per nulla riscontrabile alcuna pragmatica assunzione, o derivazione, dei principi impiegati da Cage nel pensare e strutturare gli avvenimenti sonori come avviene, ad es., nelle pi diverse musiche americane definibili post-cagiane, come le performances elettroacustiche di Al-vin Lucier, o dello stesso David Tudor, al primo minimalismo, ai sogni acustici di LaMonte Young, etc. esperienze accomunate nel fondamento essenzialmente sulle virtualit dei materiali e sul modello naturale di crescita dellavvenimento sonoro su se stesso, nonch dalla ridefinizione radicale del rapporto notazione/evento. Qualcosa di simile si pu forse riscontrare nelle pratiche sperimentali (soprattutto la costruzione di nuovi strumenti) di Mario Bertoncini, tra i primi a eseguire in Italia le opere per pianoforte di Cage e autore, nel 1965, di Cifre, una partitura largamente dominata dallindeterminazione e nel sor-gere di gruppi di improvvisazione, in particolare, nel 1965, quello di Nuova Consonanza, legato soprattutto alle figure di Franco Evangelisti e dello stesso Bertoncini.
Una cronologia delle presenze di Cage nellattivit concertistica italiana fino allinizio de-gli anni Settanta tenuto conto che pi spesso, fin dallinizio del decennio precedente, erano legate alle tourne della compagnia di danza di Merce Cunningham indurrebbe a vedere una continuit che in realt non corrisponde pi ad una qualche influenza sulla musica che si produce in Italia, tantomeno a una presenza nel dibattito critico. Ci che si dice e si scrive su Cage il residuo cristallizzato di una discussione di fatto gi conclusa, e la pubblicazione, nel 1971, di unantologia29 da Silence e A Year from Monday giunge come un frutto fuori stagione; si sarebbe anzi tentati di farne il termine a quo di una nuova fase della ricezione di Cage, che forse non riguarda pi, primariamente, la cultura musicale. Alle attivit di una cooperativa culturale di Milano, e alle iniziative di un collezionista dar-te, Gino Di Maggio, si deve un rinnovato interesse verso il lavoro del Cage multimediale degli anni Settanta. Unetichetta discografica indipendente, CRAMPS, curata tra gli altri da Walter Marchetti,30 che da tempo faceva riferimento al gruppo fluxus, e da un intel-lettuale di orientamento situazionista, Gianni-Emilio Simonetti, produce alcuni dischi di Cage, e, nel dicembre del 1977, si fa promotrice di quello che sar uno degli avvenimenti
27 Larticolo di Bussotti riproposto in questo programma. Larticolo di Bussotti riproposto in questo programma.
28 F. Donatoni, F. Donatoni, Comporre lesistenza/vivere lopera, in Dopo di me, cit., p. 95.
29 J. Cage, J. Cage, Silenzio. Antologia da Silence e A Year From Moday, a cura di R. Pedio, Milano, Feltrinelli 1971. Soltanto molti anni anni pi tardi compare la prima traduzione integrale italiana di un libro di Cage: Silenzio, Rimini, Skahe edizioni, 2009.
30 Marchetti anche il traduttore della prima edizione italiana del libro-intervista di Cage con Da- Marchetti anche il traduttore della prima edizione italiana del libro-intervista di Cage con Da-niel Charles, Per gli uccelli. Conversazioni con Daniel Charles, Milano, multhipla, 1977.
-
pi caratteristici di questa fase: la performance di alcune parti di Empty Words al Teatro Lirico di Milano, che, grazie alla pubblicit offerta dalla stazione radiofonica Canale 96, legata a una gruppo milanese della sinistra radicale, che contribu ad organizzare la se-rata, schier davanti a Cage un uditorio di circa duemila persone; si trattava del risultato di una vera e propria mobilitazione politica, il cui soggetto era il composito movimento autonomo che qualche mese prima si era espresso nei sette giorni del Convegno sulla repressione di Bologna. Era evidente che si sarebbe andati incontro a un equivoco, che si manifest dopo pochi minuti di quieta lettura del testo del Journal di Thoreau, com-pletamente desemantizzato nella manipolazione di Cage; in sala erano presenti gruppi organizzati di disturbatori, il che fa pensare che la figura di Cage fosse stata usata dagli organizzatori anche come veicolo pubblicitario, trasformandosi poi nello strumento, o nel bersaglio simbolico, di una festa caotica e distruttiva, o della messa in scena di un conflitto, che come tale ebbe per il lieto fine di un paradossale trionfo di Cage. Una pi pacifica e spettacolare festa collettiva sar invece quella dellestate successiva, ideata da Tito Gotti, sotto forma di una singolare ed elaborata performance ferroviaria su tre linee dellappennino bolognese, mediante un treno preparato: al suo interno erano installati altoparlanti che diffondevano suoni variamente prodotti dallo stesso treno, dai musicisti e dai passeggeri, mentre in ognuna delle stazioni era stato organizzato un diverso evento musicale.31 Laltro avvenimento di rilievo di quel decennio la realizzazione a cura di Josef Anton Riedl per la Biennale di Venezia del 1976 di HPSCHD allisola di S.Giorgio Maggiore, una complessa installazione comprendente 52 magnetofoni e 52 diaproiettori e la parte-cipazione di Cornelius Cardew, Lorenzo Ferrero, Stephen Montague e Frederic Rzewski. Si deve inoltre segnalare un progetto non realizzato del 1979, una grandiosa installazione volta a sonorizzare la collina di Montestella dIvrea, che Cage immagin su sollecitazione di alcune figure locali ancora legate alle idee illuminate di Adriano Olivetti.Nel corso degli anni Ottanta, la normalizzazione politica e la neutralizzazione delle ten-sioni che avevano animato il decennio precedente comporta anche un nuovo assetto delle politiche culturali, e viene cos meno anche laura eversiva dellopera di Cage, che dagli anni Cinquanta aveva potuto rigenerarsi e allargarsi fino a toccare una paradossale popolarit. Si comincia dunque ad assistere a isolate celebrazioni di una personalit or-mai venerabile, sulla quale sembra calato definitivamente il giudizio della storia. Giunge cos, tardivamente, il momento del Cage musicista, con una serie di occasioni create dalliniziativa di Mario Messinis, che programma la prima esecuzione italiana dei Thirty Pieces for Five Orchestras nella Chiesa di S. Stefano a Venezia per la Biennale Musica del 1982 Cage vi tiene anche la conferenza-performance Composition in Retrospect e una seconda esecuzione dello stesso lavoro nella Rassegna della RAI di Torino Il suono e lo spazio (1987). Tra i direttori delle cinque orchestre vi anche Luciano Berio, che in quella occasione tiene una conferenza pubblica insieme a Cage, moderata da Claudio Ambrosini, e rilascia unintervista in cui, mentre dichiara di avere per lui un enorme rispetto lo definisce persona molto attraente, un grande clown e uno che continua a disegnare i baffi alla Gioconda, aggiungendo che lunica cosa che li accomuna un dentista a New York.32 Sempre a Torino, aveva avuto luogo nel maggio 1984 un grande festival Cage durato due
31 Alla ricerca del silenzio perduto. 3 Excursions In a Prepared Train, Variations on a Theme by Tito Gotti per treni con microfoni, amplificatori, altoparlanti e nastri diffusi nelle stazioni. Cfr. Alla ricerca del silenzio perduto. Il treno di John Cage. 3 escursioni per treno preparato, 26 giugno 1978 Bolo-gna Porretta Bologna, 27 giugno 1978 Bologna Ravenna Bologna, 28 giugno 1978 Ravenna Rimini Ravenna, variazioni su un tema di Tito Gotti di John Cage con lassistenza di Juan Hidalgo e Walter Marchetti, Bologna, Baskerville, 2008.
32 Berio: I miei progetti con nuove tecnologie, a cura di A. Sinigaglia, La Stampa, 5 mag. 1987, p.27.
-
settimane, e la rassegna di Ferrara Aterforum programmer numerosi concerti nel 1991, tra cui la prima esecuzione italiana di Europera 5. A Padova, il Centro dArte presenter allinizio del 1992 un concerto dellEx Novo Ensemble diretto da Claudio Ambrosini con il Concert for Piano and Orchestra e la prima esecuzione italiana del terzo concerto per pianoforte e orchestra, Fourteen. Lultima rassegna organicamente dedicata alla musica di Cage, e aggiornata sulla sua produzione pi recente, sono le giornate organizzate a Perugia da Alfonso Fratteggiani Bianchi per i Quaderni Perugini di Musica Contempo-ranea, che coincidono con lultima apparizione pubblica in Europa di Cage, nel giugno del 1992, due mesi prima della morte. La prima esecuzione italiana di 103, per orchestra, simultaneamente alla proiezione del film One11 avviene a Venezia del 1993 e segna lavvio di una fortuna postuma niente affatto costante, che avr uno dei suoi momenti pi signi-ficativi nella rassegna di Milano Musica nel 2007.
Ventanni fa, alla scomparsa di Cage, questo tipo di ambigua fortuna era gi prevedibile: le uniche manifestazioni in memoriam di qualche prestigio furono organizzate nel 1993 dal settore Arti Visive della Biennale di Venezia, non da quello musicale. In area tedesca si manifestavano segni di un rinnovato interesse per Cage, in coincidenza con lultima fase della sua produzione, caratterizzata da quella che Cage stesso definisce la sua tardiva scoperta dellarmonia, e da un parallelo ritorno allimpiego di organici relativamente tradizionali. In Italia i motivi di una rinascente discussione filosofica sorta attorno alla poetica di Cage,33 pur se sospetta di un accademismo sconosciuto al dibattito di tren-ta o anche venti anni prima, sembravano corrispondere allesigenza, espressa anche in questarea da parte di molti giovani compositori, di spostare il senso ultimo del comporre dalla centralit del segno a quella del suono, cos come di porre al centro dellesperienza musicale la nozione di ascolto attivo, dunque anche un atteggiamento in generale meno ostile che in passato a soluzioni informali. Questo era tuttavia, se non altro, il segno di una ripresa dal fondamentale trauma storico delle avanguardie italiane degli anni Sessanta, che consumarono lesperienza di Cage al punto da non volerla, o poterla, comunicare alle generazioni successive.
33 Cfr. D.Charles, Cfr. D.Charles, Jo Kondo e John Cage, in Rivista italiana di Musicologia, XXVI (1991); id., Un soffio per nulla: osservazioni su Heidegger e Cage, in Filosofia 90, a cura di G.Vattimo, Bari, 1991; A. Raffi, Labbandono, il tempo, il silenzio: su alcuni luoghi del pensiero di John Cage, in Musica/Realt, 35/1991 .