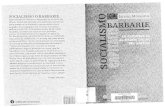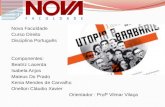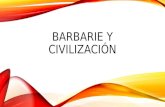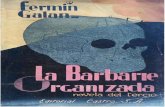Barbarie-l’Animale e l’Istituzione
-
Upload
carlosfgonzalez21 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Barbarie-l’Animale e l’Istituzione

85
FELICE CIMATTI
L’ANIMALE E L’ISTITUZIONE
Intervista Nei suoi ultimi lavori,1 si è concentrato sul problema dell’animali-
tà umana. Meglio, questa è la definizione, di un’«umanità non basa-
ta sul linguaggio». Ancora: un’animalità, quella umana, «non da ri-
trovare, bensì da costruire». Si tratta dunque di una sfida etica? E se
sì, in che senso?
L’animalità di cui parlo è un’etica, indubbiamente, ma un’etica non formulata (ammesso che un’etica si possa formulare). Di più, il proble-ma dell’animalità, per me, è il problema di una vita etica. E qui entra in gioco il paradosso: una vita etica è possibile a condizione che non ci sia più il Soggetto dell’etica. L’animalità non c’è già, ma va conquistata, oserei dire che va costruita. In questo senso, prendo una posizione radi-calmente critica nei confronti di tutte quelle idee pseudo-naturaliste che periodicamente tornano in voga, e che pensano l’animalità umana come qualcosa che abbiamo già conosciuto e si tratta di recuperare at-traverso l’insistenza sul corpo, sull’istintualità. Una posizione che spes-so diventa reazionaria, nel senso proprio del termine, che incarna cioè un modo di vita pericoloso; in secondo luogo scientificamente infonda-ta, perché questo tipo di animalità non è la nostra.
Il problema etico viene così posto: come è possibile immaginare una «forma di vita»? Penso a uno degli ultimi libri di Giorgio Agam-ben, Altissima povertà:2 vita e regola coincidono, meglio, la vita, il corpo, l’esperienza biologica, coincidono con ciò che ci caratterizza come viventi, il campo della regola e del linguaggio. Il linguaggio, in-fatti, è in primo luogo regola; non c’è linguaggio senza regola e, ro-vescerei, non c’è regola senza linguaggio, in particolare senza lingue. Cosa vuol dire una vita che coincide con la regola? Vuol dire una vita
1 F. Cimatti, Filosofia dell’animalità, Laterza, Bari 2013.2 G. Agamben, Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita, Neri
Pozza, Vicenza 2011.

86 Istituzione e differenza
– il libro di Agamben lo spiega bene – che non rinuncia all’aspetto co-munitario, perché regola significa sempre stare con gli altri e regolar-si, avere una forma di accordo. Si pone l’accento dunque su questo momento fondamentale dell’umano, il fatto cioè che è un animale so-ciale, nel senso più radicale del termine. Sociale non significa, sem-plicemente, che stiamo con gli altri; stanno con gli altri anche le for-miche, tutti gli animali hanno una vita sociale. Letteralmente, ci
costruiamo introiettando l’altro. Altrettanto, dire che l’animale uma-no è un animale politico vuol dire non solo che non può non avere rapporti politici, ma che, in un certo senso, la politica è nella sua car-ne e che quindi è un animale originariamente fatto di relazioni semi-
otiche e politiche con l’altro. E tuttavia – ecco perché il paradosso dell’animalità – questa stessa politicità originaria dell’umano produ-
ce una sorta di incapacità di stare al mondo.Il lavoro sull’animalità si ispira fortemente a Lacan, colui che più
di ogni altro, a mio avviso, ha pensato le conseguenze del fatto che parliamo. Parlare, dice Lacan, vuol dire che tu sei un corpo diviso in due, sei scisso, sei il soggetto che dice «io», e il corpo che subisce gli effetti di questo soggetto che dice «io» («io» è una abitudine, sostie-ne Deleuze). Si tratta di un dispositivo che produce separatezze, in-soddisfazione, incapacità di stare al mondo. Riprendendo la distinzio-ne di Heidegger tra mondo e ambiente: l’umano ha un mondo proprio perché parla. Questo vuol dire che ha un mondo a condizione di per-derlo: nel momento in cui lo pone, parlando, l’ha perso.
Non ho in mente solo l’interrogazione esistenziale, piuttosto insi-sto sulla deriva ecologica della specie umana. È abbastanza inevitabi-le che l’umano distrugga il mondo, non c’è niente da fare. Anche l’u-mano più mite, quello più buono o ecologicamente corretto, distrugge il mondo. Ma non lo distrugge come fa qualunque altro animale, lo fa secondo una scala spaventosamente maggiore. E questo perché l’u-mano traccia confini. È vero, in questo senso, come affermano le teo-rie giusnaturalistiche, che la proprietà privata è un diritto naturale. Un bambino dice di un giocattolo «è mio», subito se lo prende. È come se il giocattolo smettesse di essere qualcosa di comune. Perché succede tutto ciò? Io credo che nella nostra condizione ci sia – magari l’imma-gine è un po’ forte – un meccanismo patogeno. Volendo, visto che tanti pensatori degli ultimi anni (Agamben e Virno ad esempio) gio-cano con la mistica e con la teologia, c’è un peccato originale nell’u-mano, che è proprio il fatto che dice «io».

F. Cimatti – L’animale e l’istituzione 87
Il Soggetto dell’etica di cui occorre sbarazzarsi dunque è il sog-
getto dell’enunciazione: da «fenomeno originario» il linguaggio si
trasforma in malattia?
Si parte da una premessa antropologica: l’umano è quell’animale che diventa umano attraverso il lavoro di una vera e propria «macchi-na antropogenica»; quest’ultima coincide, essenzialmente, con l’esse-re inserito nella comunità parlante degli umani. La macchina antropo-genica produce «io», quindi immediatamente «tu», lo sappiamo da Benveniste, e poi produce un terzo, «egli», che non sappiamo cos’è, né «io» né «tu». Nella terza persona singolare, c’è tutta la politica: il clan-destino lo produce la lingua stessa, un non-io e non-tu che non sappia-mo mai bene dove mettere. E produce poi asservimento del corpo alla mente, origine di tutti gli asservimenti che impone una separatezza ra-dicale. In un certo senso, l’animale umano è l’animale della trascen-denza per definizione, il suo stesso corpo incarna questa distinzione, questa incapacità di abitare il tempo in cui sta, perché è un animale che sta qui e da un’altra parte, il corpo e un altro che lo osserva.
C’è una «figurina» che più volte riprende Freud quando cerca di spiegare che cos’è l’autocoscienza: un’immagine del cervello vista dall’alto (ricordiamo, Freud era un neurologo) e sul lato dell’emisfero sinistro, quello che nella maggior parte degli umani è l’emisfero lingui-stico, una specie di cappellino. Un cappellino, appunto, che sta fuori dalla testa: lì Freud colloca il super-Io, questo sguardo che da fuori guarda dentro. Indubbiamente, il super-Io ha connotazione moralisti-che, ma in primo luogo vuol dire qualcuno/qualcosa che non è il corpo, che è fuori dal corpo e lo controlla. Il super-Io è un poliziotto. Ognuno di noi ha in sé, bene o male che sia, anche in questa epoca che ci dico-no essere senza Padre, senza vergogna… ognuno di noi si porta dietro un poliziotto, il proprio personale poliziotto. Il poliziotto è la trascen-denza, questo non stare mai esattamente nel posto dove vuoi stare.
Animalità per me vuol dire: è possibile immaginare una vita in cui non c’è più quel poliziotto? Una vita senza trascendenza, appunto. La vera vita del materialista, a mio avviso, è questa, la vita dell’animali-tà. Evidentemente non è buona o cattiva, giusta o ingiusta, essendo queste ultime tutte distinzioni di lingua, quindi trascendenti. Un poli-ziotto buono non smette di essere un poliziotto. Un poliziotto com-prensivo, che ti dice «Fai così perché è la Natura a volerlo», rimane un poliziotto. Ancora, animalità vuol dire: una vita in cui il fatto che
sei umano, cioè animale della regola, non produce più trascendenza,

88 Istituzione e differenza
ma una vita tutta immanente. Parafrasando Agamben: la regola è di-ventata la tua carne. Non più, come dice Freud, quel cappellino che sta lì fuori e che ti dice «fai questo» o «fai quest’altro».
In questo senso, la psicoanalisi, in particolare quella lacaniana, è una straordinaria antropologia, perché mostra i dispositivi attraverso i quali si costruisce l’umano – proiezioni, identificazioni, fratture – e, allo stes-so tempo, si chiede: «è possibile uscire da questa condizione?» Lacan si pone il problema a partire dal nodo, sempre irrisolto, della fine dell’a-nalisi. Cosa ci dice di interessante? Che l’analisi è il tentativo di curare l’umano, cioè l’animale del linguaggio, attraverso la parola. Non è dun-que un tentativo reazionario o utopistico, perché piuttosto afferma: «sei fatto così, io ti curo omeopaticamente con ciò che ti ha ammalato». Ne-gli ultimi scritti, Lacan parlava addirittura del linguaggio come di un cancro, qualcosa che letteralmente corrode dall’interno l’umano.
Coincidenza di vita e regola vuol dire tentativo – è paradossale, è un ossimoro, e quindi è difficile da pensare, non dico di esserci riuscito – di immaginare una lingua che non produca più trascendenza. Altrettan-to, ci deve essere lingua, regola, altrimenti non saremmo più in presen-za di un corpo umano. Il corpo umano si inventa a partire dal linguaggio, c’è poco da discutere. Ogni forma di umano che presupponga la fine di ciò che lo rende umano non so cosa sia. Un umano ibridato con le mac-chine, un cyborg, è sempre umano, anche perché poi le macchine fun-zionano in base a meccanismi, algoritmi, che dipendono dal linguaggio.
Insistendo sull’immanenza, spesso prevalgono orientamenti teori-
ci che, assieme alla trascendenza, liquidano anche la nozione di isti-tuzione. L’animale che, con la parola, deve curarsi dai pronomi per-
sonali («io» e «tu») è ancora un animale istituzionale?
In qualche modo sì, certo, non si può non esserlo. Però, appunto, un’istituzione che rinuncia al suo carattere di trascendenza rispetto agli individui che la vivono. Esiste davvero qualcosa del genere? Può esistere?
Partiamo dall’istituzione per eccellenza, la lingua. La lingua esiste perché ci siamo noi che la parliamo. Tutte le volte che la lingua o i de-rivati della lingua presuppongono di vivere indipendentemente da noi, nascono problemi. Non sono certo un economista, ma penso che uno dei tratti più rilevanti della cosiddetta crisi finanziaria del capitalismo sia proprio l’affermazione di un dispositivo semiotico che va per conto suo. In questo senso, è difficile trovare una soluzione politica alla crisi,

F. Cimatti – L’animale e l’istituzione 89
perché il dispositivo denaro-segno ormai ha vita propria. Quando l’isti-tuzione vive di vita propria, arriva la trascendenza, arriva il poliziotto, arriva Dio, arriva quello che ci dice «fate i compiti a casa», «non avete ancora fatto abbastanza», e immediatamente entra in gioco il gergo pa-ra-religioso in voga tra gli economisti: «non avete fatto il vostro dove-re», «avete ecceduto», «avete consumato troppo», «avete goduto trop-po». Subito l’aspetto punitivo, moralistico. Non sarà casuale che il gergo usato dagli economisti è lo stesso che un tempo usavano i preti. Letteralmente le stesse parole, la stessa soluzione. Cosa si consiglia? «Consumate di meno», «sobrietà», «ascetismo», «povertà».
Allora possiamo dire che l’uomo, nella prospettiva dell’animalità, è ancora un animale istituzionale, proprio perché non si dà separazio-ne tra animale e istituzione. È questa la cosa complicata da inventare, un’istituzione incarnata. La domanda è obbligata: un’istituzione di questo tipo è ancora un’istituzione? Se vita e regola si combinano, l’umanità che ne esce fuori non è più quella che abbiamo conosciuto fin qui, altrettanto l’istituzione.
È difficile, però, non pensare l’istituzione come qualcosa che alla fine pretende di valere indipendentemente da colui che la incarna. E la lingua ha questa tendenza, fortissima. Per Lacan il nevrotico è esatta-mente colui che è parlato dall’istituzione (lingua). E tanto più si è pos-seduti, tanto più si difende l’istituzione che parla attraverso di noi. Se la malattia ha questa natura, Lacan propone: «passa attraverso l’esperien-za della lingua e della separatezza e prova ad arrivare al sinthomo» (è visibile la genialità di Lacan quando si sforza di inventare nuove paro-le). Il «sinthomo»3 è il momento in cui l’istituzione, la lingua, sei tu. E quindi, in un certo senso, diventi proprio questo corpo, assolutamente singolare. Temi non dissimili da quelli affrontati da Deleuze, nel suo ul-timo scritto, L’immanenza: una vita…,4 quando insiste sulla nozione di vita impersonale e singolare nello stesso tempo.
Un mondo del genere, quello in cui vale l’espressione lacaniana del «sinthomo», è il mondo dell’animalità che mi sta a cuore. Un mondo in cui non scompare tutto, e soprattutto non scompare il cor-
3 J. Lacan, Le séminaire. Livre XXIII. Le sinthome, Éditions du Seuil, Paris 2005, tr. it. di Antonio Di Ciaccia, Il seminario. Libro XIII. Il sinthomo, Casa Editrice Astrolabio, Roma 2006.
4 G. Deleuze, L’immanence: une vie…, in «Philosophie», n. 47, pp. 3-7, 1995, tr. it. di Fabio Polidori, L’immanenza: una vita…, in «aut aut», nn. 271-272, 1996, pp. 4-7.

90 Istituzione e differenza
po, anzi. Da materialisti diciamo che il corpo è l’inizio e la fine, e però un corpo che è proprio quel corpo lì. Per Lacan, in fondo, la cura analitica ha come obiettivo arrivare a quel corpo lì che tu non sei mai potuto essere. È un corpo da inventarsi, da costruirsi (Deleuze dice, in pagine che ricordano queste estreme riflessioni lacaniane, che il com-pito non è spiegare l’inconscio, piuttosto costruirlo).
Vale la pena fare una digressione sull’istituzione psicoanalitica laca-niana, perché può dirci qualcosa sul concetto di istituzione di cui siamo alla ricerca. Lacan non fa che rompere le istituzioni che fonda. Perché? È un matto? O forse di volta in volta capisce che l’istituzione diventa qualcosa di diverso, in grado di uccidere? Continuamente ne fonda di nuove e continuamente l’istituzione da lui fondata muta e comincia a incarnare principi che provano a sconfessarlo. Cosa cerca di fare, alla fine, Lacan? Alla fine non parla più, e mi sono chiesto: perché? Faceva i suoi schemi e i suoi grafi, però non voleva più parlare. Voleva inven-tarsi esattamente la sua cifra, assolutamente sua e solo sua. Un materia-lismo che pretende di essere all’altezza dei nostri corpi non può finge-re che il tema del rapporto fra corpo e istituzioni sia pacifico.
Naturalmente, questo corpo assolutamente singolare – l’animalità su cui insisto – è un corpo in un certo senso afasico, perché la lingua è co-munità. È una vita che un po’ se ne frega degli altri, ma non perché sia egoista, l’egoismo è ancora interno alla trascendenza. È un corpo che ha trovato la sua via, la segue. Per intenderci, l’esempio più facile da fare è quello dell’artista. Non il genio, sia chiaro, l’artista è chiunque ri-esca ad afferrare la vita impersonale e singolare nello stesso tempo. Farla finita con la soggettività, tutta roba che riguarda l’Altro, con il ri-conoscimento dell’Altro, significa farla finita con tutte le passioni tristi: l’invidia, la gelosia, l’ambizione di potere, la superbia, ecc.
La «fatica lacaniana» consiste nella domanda: ce la fai a liberarti dello sguardo dell’Altro? Tu, animale dell’istituzione, che ti costrui-sci a partire dallo sguardo dell’Altro, puoi arrivare un giorno a stare in piedi da solo? Questo è un compito fondamentale, per ciascuno di noi. E, soprattutto, sarebbe interessante immaginare/costruire istitu-zioni che favoriscono questa operazione.
Ci sono quattro (fondamentali) racconti – gli unici pubblicati in
vita (o quasi) e raccolti con il titolo Un artista del digiuno5 – nei qua-
5 F. Kafka, Un artista del digiuno, Quodlibet, Macerata 2013.

F. Cimatti – L’animale e l’istituzione 91
li Kafka ci presenta due temi tra loro strettamente connessi: la vita
dell’artista e quella dell’animale. Il protagonista del primo dei quat-
tro racconti è un trapezista, che vive sul trapezio come un ragno fa la
sua ragnatela; poi c’è Josephine, topolina e cantante nello stesso
tempo; infine il digiunatore. In tutti loro, il divenire-animale sembra
rendere impossibile la felicità. L’animale che Lei propone di conqui-
stare può ancora essere beato?
Fedeltà al corpo che sei. Poi c’è l’aspetto delle regole, parcheggia-re nei posti giusti, ecc. Ma l’etica che mi interessa è quella che insiste sulla fedeltà al corpo, al reale. Sicuramente Kafka ha provato, tra l’al-tro faticando tantissimo, a cercare un modo per stare al mondo meno doloroso di altri. Il racconto del topo, di Josephine la cantante, è in-dubbiamente straordinario. Ma c’è un altro racconto, bellissimo, un frammento di racconto, quello dell’indiano che va a cavallo e, a un certo punto, non si capisce più chi è che va su cosa, se è l’indiano che va a cavallo, o se è il cavallo che va sull’indiano. È un divenire-caval-lo dell’indiano, un divenire-indiano del cavallo.
Mi viene in mente un passo straordinario di Deleuze e Guattari sul divenire-erba. Ogni filo d’erba è proprio quella fogliolina lì, con la sua singolare punta cromatica. Le foglioline d’erba non pretendono di fare niente di straordinario, non c’è nessuna soggettività che dice «io», non c’è la super-erba che dice «io sono il capo», non c’è una regola trascen-dente. C’è una regola, altrimenti le foglie non crescerebbero in quel modo. È un modo di stare al mondo, anch’esso distruttivo, naturalmen-te, che mi pare più bello, più nobile, dello stare al mondo della sogget-tività, del tracciare confini («questa è casa mia, questa è la mia porta, questa è la mia macchina, la mia tomba, questi sono i miei figli, ecc.»).
Anche il tema kafkiano del digiuno è molto bello, e mi sembra as-sai simile a quello deleuziano del «divenire-impercettibile». Le tre virtù presentate in Millepiani:6 divenire-impersonale, divenire-imper-cettibile, divenire-indiscernibile. Non è casuale che gli animali prefe-riti di Kafka fossero i topi, gli animali più bistrattati, oppure gli inset-ti, tutti animali che non si vedono, che non riusciamo a distinguere. Uno scarafaggio, solitamente, lo confondiamo con qualunque altro scarafaggio, altrettanto un topo. Sono impercettibili, indiscernibili,
6 Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Minuit, Paris 1980, tr. it. di G. Passerone, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma 1996.

92 Istituzione e differenza
appunto. Il digiunatore è soltanto un corpo, un corpo che non vuole essere lì in primo piano. In fondo il problema di Kafka e del suo di-giuno richiama la figura del padre, violento, che mangiava tantissi-mo. E il padre cos’è? L’istituzione, è Dio, quello che tanto rimpiange certa psicoanalisi affascinata dal Padre, l’idea di un mondo in cui c’è la trascendenza. Cosa poteva fare quel piccolo Kafka per salvarsi? Diventare piccolo, topo, insetto, svanire, diventare impercettibile (come in uno straordinario romanzo di Matheson, Tre millimetri al
giorno). Un’immagine del genere forse non piace a chi pensa e sogna un’immagine più eroica della politica, ma è indubbiamente più adat-ta al mio modo di stare al mondo.
In più occasioni, Lei ha insistito sul rapporto tra Saussure e La-
can. Il primo ha chiarito che la lingua è un fatto e che il segno lingui-
stico è un’entità a due facce (significato e significante), dunque non
si dà pensiero che non sia intessuto di linguaggio. Il secondo è colui
che «ha tratto le conseguenze psicologiche» di tali acquisizioni teori-
che. Tornando a quanto si affermava in precedenza, sembra quasi che
Saussure abbia indicato la diagnosi e Lacan, nella ricerca del «rea-
le», abbia provato a tratteggiare la prognosi…
Partiamo da Saussure. Io non sono un linguista e, per quel poco che ho capito, il Saussure linguista ciò che doveva dare lo ha dato, men-tre pochi hanno propriamente pensato il Saussure filosofo. E credo che sia una grande occasione, quella che abbiamo oggi, di tornare su Saussure con questa nuova prospettiva. Non solo Saussure è un filo-sofo spaventosamente potente, è un filosofo che, anche con brevissi-mi cenni, ha colto alcune cose fondamentali del nostro tempo.
E poi dicevamo il «reale», il problema lacaniano. A un certo punto Lacan ha questa sorta di ubriacatura. Comincia con una grande tripar-tizione: l’immaginario, il simbolico, il reale. Da buon saussuriano dif-fida dell’immaginario. È un anti-psicologista, di più, considera lo psi-cologismo cosa molto pericolosa. È difficile dargli torto: l’immaginario è proprio il luogo in cui si depositano tutti i luoghi co-muni, il non pensato, ciò che ci arriva dalla tradizione. Tutti questi materiali, dice Lacan con piglio saussuriano, devono essere organiz-zati dal simbolico, la lingua. Ti costruisci rispetto all’Altro e lo fai nella lingua; emerge in primo piano la tesi fondamentale dell’incon-scio strutturato come un linguaggio. Molto presto, però, Lacan si ren-

F. Cimatti – L’animale e l’istituzione 93
de conto che tutto questo, la simbolizzazione, produce alienazione, nel senso più profondo, più radicale del termine.
È sempre stato curioso pensare l’immagine stranamente accomo-dante che l’ermeneutica ha dato dell’esperienza del linguaggio. Se il mondo è come dicono gli ermeneuti, è un incubo. Sei dentro una mac-china, un macinino, di chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere… È ciò che fa l’analista: ha a che fare con le chiacchiere, e si rende conto che le chiacchiere non possono essere la cura, che anzi c’è tutto un godi-mento invincibile nel sostare nelle chiacchiere. Tutti coloro che tutt’o-ra insistono sul dialogo, sull’importanza del confronto, ma di cosa stanno parlando? Sanno come funziona veramente il dialogo? Ne hanno esperienza? In questo senso, la psicoanalisi è un laboratorio di umanità. Secondo una scala minuscola, hai due umani che parlano, hai il succo dell’umano, ne vedi subito gli aspetti costitutivi ma anche tremendi: quella roba lì, il dialogo, va avanti tutta la vita.
Lacan dunque si chiede: «come se ne esce da questa cosa»? Quando parla di reale, Lacan parla esattamente di questo, e cioè di come trasfor-mare l’istituzione nel tuo corpo. Quanto più il corpo è il corpo che sei,
tanto meno è istituzionale. Con un ulteriore paradosso: tanto più il cor-po rimane corpo, quanto meno tu sai che quello è il tuo corpo, perché lo sei semplicemente. In fondo, noi possiamo sapere di essere un corpo perché siamo separati, divisi, siamo istituzione e corpo. Tanto più si ac-
corcia, si riduce l’intervallo tra istituzione e corpo, quanto meno c’è bi-
sogno di pensarsi come «io» e il corpo, «io» e il corpo che sono.
L’esperienza dell’istituzione è sempre esperienza collettiva, comu-nitaria, vale l’esempio agambeniano del cenobio e della regola fran-cescana. Il cenobio, però, è un’istituzione che non si mangia gli isti-tuiti. Ricordiamo la regola fondamentale dello strutturalismo: viene prima la relazione e poi i «funtivi», come dice Hjelmslev. L’alternati-va da pensare sarebbe: è possibile un mondo in cui il funtivo, il cor-po, non è schiacciato dall’istituzione, dalla funzione? In fondo, la grande critica che è stata mossa a Saussure è che lui si sbarazza della sostanza: la lingua è tutta forma, non c’è niente di sostanziale. Critica in parte sbagliata, perché Saussure è anche il pensatore della parole e la parole è il corpo che prende la voce. Ma rimane il fatto che ritorna-re a questa dimensione corporea implica allentare la presa dell’istitu-zione sul corpo.
L’altro filosofo decisivo per pensare quella particolare idea di ani-malità che mi sta a cuore è Wittgenstein. È proprio lui, infatti, che ha

94 Istituzione e differenza
pensato il paradosso del linguaggio privato: non esiste linguaggio, in-siste nelle Ricerche filosofiche, che non sia pubblico, perché «non si può seguire una regola ‘privatim’».7 Se fosse davvero così, saremmo spacciati, esisterebbe solo l’istituzione. Ma tanto nel Tractatus logi-
co-philosophicus8 quanto nella Conferenza sull’etica9 o nelle sue ulti-me considerazioni, sparpagliate qui e lì, emerge con forza la riflessio-ne sul mistico, sul limite del linguaggio, direi sul limite dell’istituzione. In qualche modo, riprendendo le parole di Paolo Vir-no, conquista la scena quella regolarità che precede le regole propria-mente intese, un corpo sub-normale (al di sotto della norma giuridica) che incarna l’istituzione senza subirne la trascendenza.
Per concludere. I pensatori che hanno pensato il problema dell’ani-malità e della vita immanente sono, nell’ordine: Wittgenstein, Lacan e Deleuze. Soprattutto i primi due, Wittgenstein e Lacan, sono quelli che, con più forza, hanno pensato le conseguenze del fatto che parliamo. Deleuze, invece, vuole da subito sbarazzarsi del linguaggio, meglio, di quel linguaggio dominato dalla soggettività. A partire da questa pre-messa, dove vuole arrivare? Una vita, l’«ecceità», l’impercettibile, la «piega», concetti sempre nuovi per pensare lo stesso problema. Un ma-terialista – e Deleuze lo era – deve avere come prima regola: tutto ciò che è trascendenza lo butto via. E se c’è un’entità trascendente per ec-cellenza, quella è il Soggetto. Una volta che ti sei sbarazzato del Sog-getto, provi a immaginare istituzioni che non lo presuppongono, e allo-ra si apre uno spazio di libertà totalmente impensato. Il Soggetto porta con sé il capitalismo, dove ognuno si sente in diritto di fare ciò che gli pare in nome, appunto, di questa super-soggettività. La vittoria del ca-pitalismo neoliberale che stiamo conoscendo è la vittoria di un super-Soggetto che nulla può limitare. Come lo smonti il dispositivo capitali-stico se non smonti la sua origine metafisica? Se tu dici «facciamo nuove regole», sei sempre lì, non te ne vai, non è che il capitalismo lo freghi con altre regole. La chance rivoluzionaria è in ogni momento, di-ceva Benjamin; non c’è nulla da attendere per poter incarnare nel pro-prio corpo l’istanza animalesca.
7 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., p. 109.8 Id., Tractatus logico-philosophicus (1922), Routhledge and Kegan Paul,
London 1961, tr. it. di A.G. Conte, Einaudi, Torino 1998.9 Id., Lecture on Ethics, in «The Philosophical Review», LXXV, 1965, tr. it. di
M. Ranchetti, Conferenza sull’etica, in L. Wittgenstein, Lezioni e conversa-zioni, a cura di M. Ranchetti, Adelphi, Milano 2005.