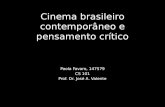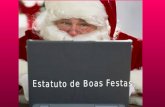Artigo
-
Upload
antonio-rebelo -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Artigo

Tale motivo dai forti contenuti elegiaá ha radiá piuttosto antiche: prima che
nella latinità cristiana, essa e già ampiamente attestata in quella dassica, sia in opere in
versi, sia all' interno di testi in prosa 107• ln tale am bito cultural e, pero, l' ubi sunt si
configura come un grido di rimpianto verso quel che l'azione del tempo strappa e
distrugge, in un ragionare che si esplica attraverso elenchi, spesso anche corposi, di
uomini valorosi e antiche áttà la cui gloria e ormai perduta per sempre. Estraneo ai
comune pensare delle opere della latinità dassica e, invece, quel moto di sofferta
riflessione sulla vanità e sulla morte che cosi cospicuo peso ricopre nella successiva
letteratura cristiana dei tardo-antico e del primo medioevo, nella quale l' ubi sunt diviene
il veicolo privilegiam per l'estemar.ione di quel disprezzo per le cose dei mondo cosi caro
all'escatologia di matrice cristiana. La diffusione e il progressivo vasto successo di questa
rematica in tale ambito conosce nelle opere di Efrem Siro101, prima, e di Isidoro di
Siviglia109, poi, due tappe fondamentali: il grande influsso di tali personaggi sulla
cristianità altomedievale, e in modo particolare sulla crescente realtà monastica, ha
infatti dato modo all' ubi sunt di divenire uno dei nudei argomentativi di maggior peso
all'intemo della letteratura cristiana di genere parenetico ed escatologico.
ln tale contesto, il successo di questo richiamo alia riflessione sulla caduátà delle
umane glorie e delle vanità terrene deve avere tratto linfa vitale anche in alcuni versetti
delle Scritture, sia vetero sia neotestamentari, che in maniera inequivocabile invitano
l'uomo a porre attenzione all'insignificanza delle cose rerrene:
"Ubi sunt príncipes gentium, et qui dominantur super bestias qUtE sunt super terramJ Qui in
avibus ctEli ludunt, qui argentum tbesaurizant, et aurum, in quo confidunt homines, et non
est finis acquisitionis eorum; qui argentum fobricant, et solliciti sunt, ner est inventio operum
illorum?' (Bar. III, 16-18)
"Homo, natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miseriis. Qui quasi fios
egreditur et conteritur, et fogit velut umbra, et nunquam in eodem statu permanet. [. .. ]
Homo vero cum mortuus foerit, et nudatus, atque consumptus, ubi, qU�ESo, est? Quomodo si
recedant aqUtE de mari, et jluvius vacuefoctus arescat; sic homo, cum dormierit, non resurget, donec atteratur ce/um, non evigilabit, nec consurget de somno suo" (job. XIv, 1-2 e 10-12)
"Scriptum est enim: 'Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
Ubi sapiens? Ubi scriba! Ubi conquisiror hrgus stEculi! Nonne stultam frcit Deus sapientiam
hujus mundi!' (I Cor. I, 19-2{})110
dei Synonima di Isidoro di Siviglia conrerruto nel ms. Cotton Tiberius A.iii, le omelie Blickling V, Blickling VIII, Blickling X, Assmann XW, lrvine VII e Vercrlli Jv. Soli due testi in versi, i poemetti
\Vamkrer e Seafarer, ci inflne testimorúano una rilenura in chiave poerica della tematica delTa
tkcatknza tklle cose terrene. Come avremo occasione di valutare nel corso dell'analisi dei passo
vercellese, alia base di gran parte delle formulaziorú anglosassoni dell'ubi sunt vi e una commistione
di varie rradizioni di ascendenza latina, riassumibili (seppure in maniera forse troppo rígida) nei
quatrro filorú remarici rappresentati da alrrettanti testi della cristiarúri latina: i Synonima di Isidoro
di Siviglia, lo pseudo-agostirúano Sermo ad Jratres in eremo 58, ii Sermo tk elemosinis di Cesario di
Arles e, infine, l'Admonitio ad ftlium spiritualem dello Fseudo-Basilio. Una schiacciante maggioranza
dei tredici testi anglosassorú ha fra le sue fonti, in maniera piu o meno esclusiva, !'opera dei Vescovo
di Siviglia: olrre all'omelista di Vercelli X e ovviamenre al rraduttore dell'escerro dei Synonima, da
tale testo latino prendono ispirazione anche gli aurori dell'Ome/ia di Maca rio, dei Sermo Augustini
(testo edito in Fadda 1977, pp. 144-157), della glossa al Liber Scintillarum (pubblicara in Rochais
1957, pp. 228-230) e !'anonimo poeta dei Seafam (edito in Muir 1994, I, pp. 232-236). Due delle
rimanenti omelie, Blicklin,t X (edita in Morris 1967, pp. 106-115) e lrvine VII (pubblicata in Irvine
1993, pp. 197-202), affondano !e !oro radiei nel sermone sull'elemosina di Cesario di Arles; le
omelie Blickling VIII e Assmann XIV (edi te rispettivamente in Morris 1967, pp. 97-105 e in
Assmann 1889, pp. 163-169), di contro, sembrano derivare da que! Sermo 58 per lungo tempo
erroneamente a ttribuito ad Agostino di Ippona. La sola omelia Blickling V (edita in Morris 1967,
pp. 54-65) appare rifarsi ai comenuri di un secondo resto dalla controversa attribuzione, l'Admonitio
ad ftlium spiritualem. Non e sraro a oggi possibile, inflne, individuare alcuna fonte certa per le
rimanenti due anestazioni anglosassoni dell�!bi sunt, quelle contenute nel \Vanderer (edito in Muir
1994, I, pp. 218-222) e in una seconda o me lia dei codice vercellese, Vercelli IV ( omelia edita in
Scragg 1992, pp. 9o-104). Per maggiori informaziorú bibliografiche in meriro a ciascuno dei resti
qui elencati si veda la ricca bibliografia forrúta in Di Sciacca 2003, pp. 23o-234 e note 22-34. Per
una analisi dei conrenuti della breve versione dell'ubi sunt contenura all'imerno della quarta omelia
vercellese si veda supra, cap. II, p. 125-126.
107 Per quanto concerne gli autori di testi in prosa latina che fanno uso di tale motivo, Liborio richiama
l'attenzione nello specifico su tre grandi personaggi quali Cicerone, Seneca e, in ultimo, Marco
Aurelio. Per quanro concerne il grande retore e avvocato, formulaziorú riconducibili all'ubi sunt sono
rilevabili nell'Ottava Filippica (M. Antonium Oratium Philippica, VIII, 8, 23) e nell'orazione in
difesa di Planeio (Oratio pro Cn. PTancio, XIII, 33), oltre che nella famosa epístola consolatoria
indi�ata a Cicerone e vergara da Servio Sulpicio in occasione della morre di Tullia (Epistulte ad
familiares, Iv, 5, 2-4): quesr'ultima, seppure non presenti la reiterazione anaforica delle proposiziorú
interroga tive introdotte da ubi suntlubi est, desta un ragionevole interesse in quanto rappresenta la
prima attestazione di quella variante de! motivo che, ai nomi dei grandi uomirú dei passato,
sosriruisce quelli delle gloriose cinà. Meno ricche sono !e testimorúanze di quesra remarica all'intemo delle opere di Seneca: esse si limitano a soli due passi, rispettivamente delle Lettere a
Lucílio (Epistufte ad Lucilium, CVII, 1) e della Consolatio ad Helviam matrem (XV, 1). Un discorso a
parte merirano, invece, i Ricordi di Marco Aurelio, nei quali ii motivo dell'ubi sunt sembra occupare
una posizione di rilievo all'interno dei pensieri redatti dall'imperatore-filosofo (V, 33; VII, 58; VIII, 25; XII, 21): un ruolo fondamentale in questo caso deve avere esercitato la profonda conoscenza
della cultura greca da parte di Marco Aurelio, una formazione di impianto sroico che deve avere
certamente influenzaro in modo cospicuo la sua visione spesso cupa della morte e delle vanità
umane. E opinione comune, perõ, che tale opera filosofica abbia avuro un impatto pressoché nullo
sulla genesi della formulazione cristiana dell'ubi sunt. Fra i poeti della latiniti pagana, invece, tale
tematica ha trovaro cospicua esplicazione nelle opere di personaggi quali Tibullo, Ovidio e Stazio.
Mentre per quanto concerne il primo e a noi giunta una singela attesrazione dei motivo in oggeno
(in Carmina, II, 3, 21), nei restanti due essa trova uno spazio certamente piu ampio: in Ovidio passi
riconducibili all'ubi sunt sono attestati in numerosi passi delle Metamorfosi (Metamorphoses, Iv, 592-593; VII, 499-5()(}; XI, 422; XIII, 92 e 340-341) e in un gruppo di versi degli Amores (IJJ, 9, 38-42}, nei quali, perõ, non compare il classico schema argomentativo basato sulla reirerazione delle
espressioni ubi estlubi sunt; nel corpo delle opere di Stazio, degni di attenzione sono l'Ecloga I dei
Libro II delle SiiVtE (in modo parricolare i vv. 41-55, seppure l'intero componimento desti
nell'insieme un certo interesse) e due passi della Tebaide (V, 613-616 e XII, 311-312}. Liborio
richiama, in ultimo, l'anenzione su ulteriori due aurori classici, uno di ambito latino e l'altro di
cultura greca: Orazio e Plurarco. Echi dei motivo qui discusso sono riscomrabili, infatti, sia nel
compianto per la morre di Archita (Carmina, I, .2$), dove perõ non compare in marúera esplicita la
formula retorica dell'ubi sunt, sia, per quanto concerne Plutarco, in Consolatio ad Apollonium XV, 110 D. Cfr. Liborio 1960, pp. 143-148.
1C8 Per un quadro imrodurtivo completo ed esaustivo sulla complessa figura di Efrem Siro (oltre che
sulla molto vasta produzione in língua siriaca, greca e latina a !ui piu o meno correttameme
atrribuita) si veda la voce a !ui dedicara nel N volume dei Dictionnaire de spiritualité ascétique et
mystique. Fra le piu antiche e influenti attestazioni dei tema dell'ubi sunt di ambito Cristiano vi e,
appunto, quella tramandaraci all'interno di una raccolta di inrú funebri attribuita a Efrem, i
Necrosima (in particolare si veda: Necrosima XLIII, Assemani 1742-1743, III, p. 308-311). Per
quanto concerne il controverso grado di diffusione e ii successo in ambito insulare delle opere
(originali e a !ui ascritte erroneamente) dei Padre della Cristiarúri orientale si vedano, fra gli altri:
Besrul 1981, pp. 1-24; Sims-Williams 1985, pp. 205-226; Srevenson 1998; Ganz 1999; Wright
2002, pp. 228-256 (contributo in merito alia probabile derivazione della sezione iniziale di Vercelli
IV e deli'Ome/ia di Maca rio da un sermone anribuibile a Efrem); Di Sciacca 2003, pp. 226-227; Di Sciacca 2006, pp. 381-387; Di Sciacca 20C8, pp. 107-1<:8.
109 Come detto, la versione isidoriana dell'ubi sunt e contenuta all'intemo di rre brevi capitoli dei
Secondo Libro dei Synonima, a oggi ritenura la fome d'ispirazione príncipe alia base della capillare diffusione della rematica in oggeno, cosi come sosterruro e argomentaro fra gli altri da Gilson,
prima, e successivamenre da Liborio e da Cross; cfr. Gilson 1932, pp. 14-15 e 33; Liborio1960, p.
155 e Cross 1956. ln merito alla diffusione di tale opera neli'Inghilterra anglosassone di vedano,
come deno, Di Sciacca 2001, pp. 235-257 e Di Sciacca 2006, pp. 383-387.
110 Passi di contenuto assimilabile a quello proposto sono inoltre risconrrabili, poi, in Psal. XXXVIII, 7
("Verumtamen in imagine pertransit homo; sed et frustra conturbatur: thesaurizat, et ignorat cui
congregabit ea."), Psal. LXXXIX, 6 e 9-10 ("Mane sicut herba transeat; mane floreat, et transeat;
vespere decidat, iduret, et aresCIJt. [..] Quoniam omnes dies nostri defocmmt; et in ira tua deftcimus.
Anni nostri sicut aranea meditabuntur; dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni. Si autem in
potentatibus octoginta anni, et amplius eorum labor et dolor, quoniam supervenit mansuetudo, et
corripiemur."), e in Is. XXXIII, 18 ("Cor tuum meditabitur timorem: ubi est literatus? Ubi legis verba
ponderans? Ubi doctor parvuforum!').
111 Tale forre componente bíblica e, infatti, facilmente riscontrabile non solo nella strurrura
argomentativa e contenutistica dei Synonima nella !oro interezza, ma anche nella densità di passi
Scritturali che caratte�a nello specifico i rre brevi capitoli dei Libro II che, come abbiamo visto,