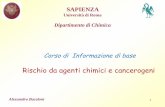“Alichino e Aredodesa” di Alessandro Wesselofsky
-
Upload
alberto-paganborn -
Category
Documents
-
view
26 -
download
8
description
Transcript of “Alichino e Aredodesa” di Alessandro Wesselofsky

ALICHINO E ABED0DE8A
L
Un'antica leggenda copta narra della figlia di Erode, la quale
avendo ballato dinanzi al padre ne richiese in premio, ad isti-
gazione della madre Erodiade, la testa di Giovanni Battista.
« Allora il re mandò un satellite nella prigione, che tagliò il
« capo al santo, lo pose sopra un bacile e lo diede alla giovane
« figlia. Essa lo prese e lo portò alla madre sua. Erodiade si
« rallegrò molto, poiché fu prevenuta nella sua domanda, e battè
« delle mani. Esse volevano contemplare l'atleta e la lingua par-
« laute la verità. Ma tosto gli occhi usciti dalle orbite le pen-
« dettero sulle guancie, la terra si aperse sotto ai piedi della
« perversa per inghiottirla. Un angelo del Signore discese dal
« cielo tenendo nelle mani una spada sguainata con cui colpì il
« collo della giovane figlia. Ed al luogo della testa santa si videro
« gli occhi col capo della giovane figlia pendenti sul collo e scen-
v< denti sulle mammelle » (1). La testa del santo era sparita, come
nel racconto del sinassario (2) copto essa s'invola dalle mani delle
donne perverse, continuando dall'alto a rimproverare ad Erode
il suo illecito connubio colla moglie del fratello.
(1) IVascrizione di tre manoscritti copti del museo egizio di Torino,
con traduzione italiana di Francesco Rossi, Torino, 1885, p. HO.
(2) Synaxarium, das ist Heiligenkalender der koptischen Christen, aus
dem Arabischen libersetzt von W. Wùstenpeld, Gotha, 1879, p. 7.
Giornale storico, XI, fase. 33. 21

326 A. WESSELOFSKT
Nello scritto sui settanta discepoli di Cristo, attribuito a Dositeo
di Tiro (1) il castigo della figlia di Erode è narrato alquanto di-
versamente: è-rcì óuareia^ TàX^ou koI ZuXXa, èirl toùtiu tiI» ùirdxtu òrto
KpOou^ naf{uQdar\<; Tf\c, Xijlivti^ TevriaapéT, l'i GuyàTiip rfjq 'Hpwòidòoc; Korà
répHiiv èirl toO uàTou^ ànépaivev. ToO òè Tzàyovc^ òiarpuPévroq, xò aù)|yia
aÙTfì^ Kareiróeri òrto toO- itàyouc; fiviuGev èinqpuévTo?. 'H bé 'Hptuòià? èiri
Tiliv Yovdxujv aùxfì? àiTO0€|uévr| t^v Ke(pa\-f]v tì]<; GuTaxpò(;, KXmouaa,
ójLioXóyci bla xoO atxriaaaGoi aùxr^v tì\v xeqpaXi'iv 'Imdvvou xoO BairriffroO
toOto ùiTé|Lieiv€v. Niceforo Callisto (2) aggiunge un nuovo tratto:
il capo dell'infelice ragazza, essendo separato dal busto, balla
sul ghiaccio, in memoria e in punizione di quell'altro ballo ne-
fasto, che ella esegui nel cospetto del padre, procacciando così
la morte del Battista; èiri xiva xóirov xaOxi] bef\aav &pq. X6i|Liilivo(;
TTopeùeaGai koI Troxajuòv bmPaiveiv, èTremep èKetvo^ KeKpuoxdXXtuxo koI
Tie.ttrYfòc, f\v, ùitèp vibxou aCixri ònfiei ireleùouaa. TTepi^^aTévxo^ 6è xoO
KpuardXXou, oùk dGeel bè udvxuj^ xò au|upàv t^v, xaxeppOri |uèv eòGùc; Kal
aÒTÌ\ fixpi briTTou Koì KeqpaXfìt;- koI ùuujpxeTxo aiiapfùjaa koì ùypilx; XiyuZo-
jiévr), oÙK èv Tf), dXX' èv tìbaxi. 'H bè Keqpa\i*| xCù KpOei Tzayelaa, eira xaì
bioGpauaGetffa, xal xoO XoiiroO biaipeGelaa aib|uaxoc, oò Siqpei, àXXò Kpu-
axdXXiu, óirèp xOtiv irdYUJv iJUpxelxo koI aòxr) xi^v èiriGavdxiov òpxtiaiv•
Kol ùit' 6v};iv ?Keixo udaiv l'i laiapà Keq)aXi?| eie; ùitó|uvr|Oiv «Dv ?bpaac
Toù? Geujiuévou^ dvdYouoa.
Una variante siriaca di questo racconto fu indicata da Pio
Zingerle (3); alla versione di Niceforo risalgono probabilmente
quelle forniteci dalle prediche medioevali e dalle leggende popo-
lari, che altri ebbe a notare (4). La tradizione catalana (5) segue
il racconto più semplice di Dositeo: un'altra, essa pure catalana,
dice Erode e sua figlia esser stati dannati « à rodar pel mon,
« sens consol ni conpanyia de ningù , fins à la fi del mon. Des
« de llavors fan per la terra seguida e penosa caminada, sempre
(1) Chronicon paschale, ed. Dindorf, II, pp. 13840.
(2) Hist. Ecclesiastica, lib. I, e. XX.
(3) Zeitschrift fùr deutsche Mythologie, I, 319.
(4) ScHWARTZ, Zur Herodias-Sage , in Ztsck. f.deutsches Alterthum
,
XXV, 170-73; Laistnbr, he. cit., 244-5; R. Kòhler, he. cit, XXVII, 96.
(5) PiTRÈ, Archivio, I, 136.

ALICHINO E AREDODESA 327
« de nits, sens guia y fugint de la llum del sol. De dias se estàn
« encauhats; à l'hora en que la fosquedat regna, deixan son
« redòs per altra volta caminar sens descans fins que '1 cant del
« gali los nuncia la aribada del jorn ».
È facile vedere che la pena scontata da Erodiade — che cosi
si chiamò nella leggenda posteriore l'infelice figlia di Erode,
assumendo il nome della madre — era originalmente conforme
al di lei peccato: un ballo in eterno. Niceforo Callisto fa ballare
la sua testa; un canto catalano cosi principia:
Las fillas del rey Herodes
Ballan que mes ballaràn (1).
Da questa immaginazione ne derivò un'altra: mentre in alcune
parti della Germania Erodiade-Herodina si trovò identificata
col turbine (2), altri parlarono di un continuo errare di notte-
tempo e senza tregua. Il Reinardus, I. 1139-1164, aggiunge altri
particolari (3): è la testa di S. Giovanni che soffiando sulla fan-
ciulla innamorata di lui fa si che ella si muova continuamente.
Si dice, che avendo risaputo dell'amore che sua figlia nutriva
per Giovanni, Erode lo fece decapitare. Quando lo riseppe Ero-
diade,
postulai afferri sibi tristis, et affert
regius in disco tempora trunca cliens,
mollibus allatum stringens caput illa lacertis
perfundit lacrimis, osculaque adderò avet ;
^oscula captantem caput aufugit atque resufflat,
illa per impluvium turbine flantis abit.
Ex ilio nimium memor ira Johannis eandem
per vacuum coeli flabilis urget iter:
(1) Mila y Fontanals, Observaciones sobre la poesia popular, p. 95, n. 6;
Zeitschrift f. deutsche Mytholoffie, IV, 191 (De la danza aerea à que estan
condenadas las Herodiades por la muerte del bautista).
(2) Ztsck.f.
deutsche Mythologie, I, 102 ; cfr. 1. Grimm, Deutsche Mythol.,
4e Ausg., 1, 256; Mannhardt, Gótterwelt, pp. 98-99; Schwartz, Der heu-
tige Volksglaube, pp. 24-25. Nella Piccola Russia si favoleggia che il tur-
bine è opera del diavolo.
(3) I. Grimm, D. Myth., 1. e, pp. 235-6.

328 A. WESSELOFSKY
mortuus infestai misera,m, nec vivus amarai,
non tamen haric penitus fata perisse sinunt.
Lenit honor luctum, minuit reverentia poenam,
pars hominum moestae tertia servii herae.
quercubus et corylis a noclis parte secunda
usque nigri ad galli carmina prima sedet.
Nunc ea nomen habel Pharaildis, Herodias ante
saltria, nec subiens nec subeunda pari.
L'amor di Erodiade per Giovanni è un tratto insolito, è, a
quanto pare, sconosciuto fuor del Reinardus; ma antico sarà il
« mortuus infestat miserara ». Nel Reinardus non v'è parola che
della testa; ma si può immaginare una forma di leggenda, ove
Giovanni decapitato perseguitava Erodiade che lo fuggiva. Cosi
si spiegherebbero alcuni particolari di una credenza, che non è
specialmente germanica, benché in Germania essa abbia avuto
il massimo sviluppo: intendo la cosi detta caccia demonica ossia
fantastica (1). Vi figura qualche volta un cacciatore senza testa (2),
il quale fra altri nomi porta anche quello di Hans lagenteufel (3)
e di Hans (4), cioè Giovanni, e si può ammettere che fra le
donne selvatiche (Holzweiblein), da lui perseguitate (5), si trovasse
anche Erodiade.
Ma lasciamo le supposizioni e veniamo ai fatti (6).
Un canone falsamente attribuito al sinodo di Ancira (a. 314),.
e probabilmente attinto da qualche capitolare franco del VH-VIII
secolo, venne inserito in un capitolare di Lodovico H imperatore
(1) Germanica sarà la cazza Beatric= Bertartch del Tirolo italiano e del
Veneto. Vedi Schneller, Mdrchen und Sagen aus Wdlschtirol, pp. 203 sgg.
e Angela Nardo Gibele, Zoologia veneta, p. 33.
(2) Grimm, toc. cit, II, 766, n. 8; 776, 779, n. 4; 787-788.
(3) Loc. cit., 776.
(4) WoLF, Beitrdge zur deutschen Mythologie, II, pp. 140-1 in n.
(5j Grimm, loc. cit. Indice a. v. Eolzweiblein; Simrock, Deutsche Mytho-
logie, 2 Ausg., pp. 223-4.
(6) Per le citazioni che seguono, ove non è altro richiamo , vedi Grimm,
loc. cit., I, pp. 34-5; II, 882 sgg. e Ducange-Favrb, Gloss. med. et inf. la-
tinitatis, a. v. Diana, Sera, Holda, Bensozia.

ALICHINO E AREDODESA 329
dell'anno 867 (1) e nel trattato di Reginone di Priim (f 915).
Diamo il testo di quest'ultimo (2): parlasi di certe donne scelle-
rate, le quali « retro post satanam conversae, daemonum illu-
« sionibus et phantasmatibus seductae, credunt se et profitentur
« nocturnis horis cum Diana paganorum dea et innumera multi*
« tudine mulierum equitare super quasdam bestias, et multa
-« terrarum spatia intempestae noctis silentio pertransire, ejusque
«jussionibus velut dominae obedire et certis noctibus ad ejus
« servitium evocari ». Gfr. Capitula Herardi episcopi Turonens.
e. 3, ed i Acta S. JacoM Mevan. tom. 4, Aug., pag. 730, col. I
(impugnavit errorem illarum mulierum quae vadunt ad cursum
cum Diana). Secondo le notazioni dei correttori al Corp. juris
canonici, fonte precipua del canone di Reginone sarebbe un passo
nel trattato De spiritu et anima, e. 28, indebitamente attribuito
nel VI secolo a S. Agostino (3); supposizione che viene infirmata
dal testo a stampa di questo trattato, che al nome di Diana ag-
giunge anche quelli di Erodiade e di Minerva (cum Diana Pa-
ganorum dea vel cum Herodiade et Minerva) (4). Se potessimo dar
fede alla vita manoscritta di papa Damaso I, delle ridde notturne
di Erodiade si sarebbe fatta parola, e negli stessi termini, già
nel sinodo romano del 367 (5). Nel IJber Decretorum (1. X, e. 1)
di Burcardo di Worms (1024) (6) essa riapparisce nel nostro testo
accanto a Diana (cum Diana paganorum dea vel cum Herodiade
et innumera multitudine mulierum), e cosi nella Concordia (fi-
nita 1151) di Graziano (cum Diana dea paganorum vel cum He-
(1) Baluze, Capitularia reg. Francorum, t. II, p. 365: e. XIII, De sor-
tilegiis et sortiariis.
(2) Reginonis Premiensis abbatis de eccles. disciplinis et religione Chri-
stiana libri duo, nel Migne, Patrol. lat., t. GXXXII, lib. II, e. GGGLXIV.
(3) Vedi SoLDAN , Geschichte der Hexenprozesse , neu bearbeitet von
H. Heppe, I, p. 131 in n. Gfr. Migne , Patrol. lat., t. 40 (testo). L' autore
supposto di questo scritto sarebbe Alchero, monaco di Glairvaux.
(4) Lo stesso dà Alberto Magno , Summa theoì. , 2 , 31. Vedi Grimm ,
l. ciL, II, p. 884, n. i.
(5) Soldan-Heppe, loc. cit., 1, 109.
(6) Migne, Patrol. lat., t. 140, pp. 831-2.

330 A. WESSELOFSKY
rodiade) (1) e negli scritti posteriori che attinsero all' uno o
all'altro (2). Se in un'altra parte del suo libro (3) (1. XIX, e. 5),
riassumendo il già detto sui pregiudizi intorno a Diana ed
Erodiade , Burcardo parla invece di Holda o di Unholda (4)
,
avrà avuto in vista sotto quel nome generico di genio, de-
monio buono (5) malo ,1' uno o 1' altro dei sovranorainati
esseri demonici. E lo stesso dicasi di Benzozia (Augerius II
episc. conseran. ann. 1280 in Statutis Mss. ; Goncil. Trever.
,
ann. 1310, ap. Marlene, Anecd., col. 257) o Bezezia (Stat. Syn.
S. Fiori , Mss. , f. 60) , nome dato in altre varianti del nostro
testo alla dea vagante, mentre Giovanni Saresberiense (Polv-
craticon, 1. 2, e. 12) non cita in simil occorrenza che il nome
di Erodiade (Nocticulam quamdam vel Herodiadem vel prae-
sidem noctis Dominam) , Gobelinus Persona (Gosmodr., act. 6
,
e. 38)— quello di Hera il cui corso notturno accadeva di solito
(1) Loc. cit. , t. 187: Gratiani Concordia discordantium canonum oc
primum de jure divinae et humanae constitutionis, Pars II, causa XXVI»quaest. V, e. XII.
(2) Veggasi , p. es. , uno scritto antico tedesco contro le superstizioni po-
polari (Grimm, l. cit.. Ili, 412: « mit der heiden gùttinen, dù da heisset Dyana
« oder mit Herodiade) » e Etienne de Bourbon: « Ad hanc ludificationem, que
« fit in sompniis, pertinet error illarum mulierum que dicunt se nocturnis
« horis cum Diana et Herodiade et aliis personis,
quas bonàs res vocant ^
« ambulare et super quasdam bestias equitare, et multa terrarum spacia per-
« transire et certis noctibus ad dearum servicium evocari ». Cfr. Anecdotes
historiques , lègendes et apologues tirés du recueil inédit d'Etienne de
Bourbon, pubi, par Lecoy de la Marche, Paris, 1877, pp. 3234.
(3) Chiamata anche Corrector.
(4) MiGNE , loc. cit., p. 362: « Gredidisti ut aliqua femina sit quae hoc
€ facere possit quod quaedam , a diabolo deceptae , se aflBrmant necessario
« et ex praecepto facere debere, id est cum daemonum turba in similitudi-
ne nem mulierum transformata, quam vulgaris stultitia Holdam (var. Unhol-
« dam) vocat, certis noctibus equitare debere super quasdam bestias et in
« eorum se consortio annumeratam esse ». Cfr. Soldan-Heppe, I, p. 109, n. 4.
(5) Cfr. le « bonae res » di Stefano da Borbone e di Vincenzio Bellova-
cense (Spec, mor.. Ili , 3 , 27) , e fra i molti nomi di esseri analoghi della
superstizione rumena, quelli di bunele, dultele, milostivele, frumoasele. Vedi
Jelele, Studiu de mitologia comparativa de Laznr Saineanu (BucurescY
,
1886), pp. 19, 26, 32.'

ALICHINO E AREDODESA 331
tra Natale e l'Epifania : « inter festum NativitatisJGhristi et festum
« Epiphaniae Domini Domina Hera volat per aera, quoniam Junoni
« apud gentiles aer deputabatur. Et quod Juno quandoque Hera
« appellatur et dipingebatur cum tintinnabulis et alis, dicebant
« vulgares praedicto tempore: Vrowe Here seu corrupto nomine:
« Vro Here de vlughet, et credebant illam sibi conferre rerum
•« temporalium abundantiam ».
Egli è difficile dire, quale dei due nomi, quello di Diana o
quello di Erodiade, sia più antico nella credenza surriferita.
Prescindendo dal sinodo romano del 367 e dal trattato I)e spiritu,
la menzione più antica di Diana nella leggenda da noi studiata
risalirebbe al IX-X secolo, quando il culto di Erodiade era già
conosciuto: lo dice Raterio di Verona (1), parlando di uomini,
i quali « Herodiam illam Baptistae interfectricem quasi reginam
« imo deam proponant, asserentes tertiam totius mundi partem illi
« traditam ». Questa « tertia pars mundi » sarà identica alla
« pars hominum tertia », che secondo il Reinardus è soggetta
ad Erodiade; il senso comune all'uno e all'altro passo me lo spiego
cosi : Erodiade si riposa nella seconda parte della notte e solo
nella terza essa esercita la sua influenza sul mondo. tratte-
rebbesi di un vero e proprio possesso della terza parte del ge-
nere umano , secondo che della dame Habonde si asserisce nel
Romanzo della Rosa?
18624 dont maintes gens par lor folie
cuident estre par nuit estries
errans avec dame Habonde,
et dient, (jue par tout le monde
li tiers enfant de nacion
sunt de ceste condicion.
18686 que li tiers du monde
aille ainsinc avec dame Habonde.
Dame Habonde è la Domina Abundia di Guglielmo d'Alvernia
(1) Grimm, loc. cit., 235.

382 A. WESSELOFSKY
(t 1248), cosi chiamata, da abundantia, come satia a satietate (1):
nomi entrambi dovuti all'etimologia popolare o scolastica, mentre
forse altro non sono che i riflessi di un altro più antico, attri-
buito a Diana-Erodiade.
Se fra questi due si decide per la maggior antichità del primo,
è facile vedere come all'immagine della dea vagante di notte sia
venuta ad aggiungersi quella di Erodiade, vagante ancor essa
in punizione del peccato commesso. È nota l'antica confusione
di Diana-A.rtemide con Ecate, dea degli incanti e dei sortilegi;
la danza lasciva delle donne in onore di Artemide Efesia; la
credenza greca che delle ridde notturne di Artemide-Ecate fanno
parte i fanciulli morti in tenera età e coloro che morirono senza
aver lasciato prole, né conosciuto l'amore, tutti ftypia aupiZovreq,
ètti appeal eujnòv èxovte? (2) : immagini queste che trovano ri-
scontro nelle rappresentazioni della caccia fantastica medioevale,
in cui Erodiade ebbe una parte, ora alquanto offuscata. — La
confusione di quella con Diana sarebbesi operata sulla base di
una certa conformità del concetto mitico, favorita dalla confor-
mità di nomi: fiera Diana — e Herodina (cfr. Zs. f. deuische
Myth., 1, 102) Herodiana, come ha nome Erodiade in qualche
testo slavo e nel trattato del Vintler, Die Pluemen der Tugent
(ed. I. Zingerle) v. 7737 sgg.:
• ^ So haben etlich geraein
mit der pòsen Erodiana (var. Herodiana).,
so glauben vii an Diana
die do ain valsche gottin ist.
Ma v'è anche luogo ad un altro costrutto : Herodiana sarà stata
capita come hera Diana; cfr. le parole di Burcardo: ejusque
(1) Grimm, loc. cit., I, pp. 237-239.
(2) Gfr. l'inno ad Ecate presso Miller, Mélanges de Uttérature grecque,
pp. 442, 399; Nauck, Mélanges gréco-romains. III, 183; Dilthey, Die Ar-
temis des Apelles und die wilde Jagd , nel Rhein. Mus. , N. F., B. XXV(1870), pp. 321 sgg.

ALIGHINO E AREDODESA 333
(se. Dianae) jussionibus velut domivae obedire; un sentimento
analogo l'ebbe l'autore del Bernardus traducendo Erodiade con
Pharaildis, cioè frau Hilde o Holda. Più tardi da Hera e Diana
si ebbero non più due nomi, ma due persone diverse: Diana e
Hera, la quale venne poi identificata con Giunone : domina Hera.
Se in quest'ultimo caso abbiamo da fare con un'intrusione eti-
mologica, il primo sarà prodotto dal ravvicinamento di due miti,
che per un certo tratto ebbero consimile sviluppo.
Mentre la tradizione catalana condannava Erodiade insieme
col padre ad una fuga senza fine, v'era chi se la raffigurava
come una caccia fantastica. Se nella provincia di Perigord e di
Franche-Comté, Jura e Ain essa porta il nome di « Ghasse Hérode »
che odesi nella vigilia dei Tre re (1), e Herodes, Herodis-Ròds
apparisce tra Natale e l'Epifania come cacciatore demonico nelle
leggende di Hannover e di Westfàlia (2), v'è luogo a dimandarsi,
s'egli era stato raffigurato da principio come perseguitato o come
persecutore, o se si trattava sempre di una fuga, di un dime-
narsi continuo per l'aria in punizione della tirannia. Perchè
Erode era il tyrannus, herus malus =r antico altotedesco wótan;
'med. altoted. wùetunge= furia, megera, sania; il Wùetunges her,
come ebbe nome in Germania la caccia fantastica, sarebbe, dunque:
l'esercito, la compagnia del tiranno, di Erode; le anime dei bam-
bini, che ne fanno parte — i fanciulli trucidati dal goiewuoio,
cioè Erode il Grande {Otfr-id , I, 19, 18) , che io suppongo con-
fuso nella tradizione popolare coli' uccisore del Battista. Se
dunque noi vediamo apparire qualche volta in capo alla caccia
fantastica in vece di Wod, Wut, Wode una frau Wode, Gode,
Gauden, non si tratta già di una sostituzione femminile del
Wótan =^ Erode, ma bensì di una tiranna = Erodiade (3).
(1) Woi.F, loc. cit., II, 163; Sébillot, Traditions et superstitions d^ la
Haute-Bretagne, I, 220; De Ghesnel, Dictionnaire des superstitions, a. v.
Chasses des esprits.
(2) Ztsch. f.deutsche Mythologie , I, 100-1(fò; Kuhn, Sagen, Gebraùche
und Mdrchen aus Westfalen, I, 1.
(3) Vedi Grimm, loc. cit., I, p. 110 (cfr. Ili, nota a p. 49); lì, pp 765 sgg.;
SiMROCK, loc. cit., p. 210; Lexer, Mittelhochd. Wb., a. v. wùetunge.

334 A. WESSELOFSKY
Per parte mia tradurrei con « esercito di Erode »— la « militia
« Hellequini », « Karlequini », « mesnie Hierlekin, Hellequin •»,
Helchien (Normandia) ecc. (1): nome che si dà alla caccia fan-
tastica accanto ad altri biblici: le chariot de David (Piccola Bret-
tagna), la chasse d'Oliferne (Franche-Gomté, Jura), la chasse
Gain (Normandia), chasse Machabée (Blois)(2). Già il Diez intrav-
vide 'nel Hellequin e le sue varianti un aspetto fiammingo, nie-
derlàndischen Klang. Herodes avrà dato nei dialetti della bassa
Germania il diminutivo Herdekìn (3); indi Herlekìn, Hellekìn.
Ciò che di Hellequin si narra nel romanzo antico francese di
Richard conferma in parte il noto racconto del Reinardus intorno
ad Erodiade, e si spiega a vicenda: il duca incontra nelle sue
foreste Hellequin che cacciava con sua gente ; egli si riposa sopra
una spina, come Erodiade nel Reinardus « quercubus et corylis »;
poi scende a terra sopra un pezzo di tela, che un suo siniscalco
stese sovra il suolo. Alla dimanda del duca, chi gli abbia dato
il permesso di caccia, risponde: essergli imposto da Dio di cosi
fare, correndo nella selva tutta la notte, ed ora si riposa (cfr. nel
Reinardus: usque nigri ad galli carmina prima sedet):
Tant avons chéminé estant esmerveillés
'que trestous hous en sommes honny et travaillez...
Si souffrons nous chascuns tant d'angoisse et de peine
que pas ne le pourroit-on dire en la semaine.
Da Herlekìn, forma che io suppongo seconda dopo il* Herdekin,
venne facilmente Hellekìn sotto l' influsso etimologico di hel-
(1) Vedi Grimm, loc. cit., II, 785-6; Wolf, loc. cit., II, 162; Libbrecht,
Gerv. von Tilbury, pp. 198-99, e Zur Volkskunde, pp. 27 sgg.; Diez, Wb.,
a. V. Arlecchino; Gachet, Glossaire, a. v. halegrin\ Littrè, Dici., a. v.
ariequin', Godefroy, Dici, de Vancienne langue fran^aise, a. v. hellequin.
Cfr. PiTRÈ, Archivio, III, 104-5.
(2) SÉBiLLOT, loc. cit., I, 220, 221; Wolf, loc. cit., II, 162; Simrock, loc.
cit., 219; Db Ghesnel, loc. cit.
(3) Cfr. nel Dizionario medio-basso tedesco di Schiller e Lùbben: ffer-
deke, Herthe, dimin. da Herdradis.

ALICHINO E AREDODESA 335
ligen = stancare qualcheduno perseguendolo, tormentarlo; o piut-
tosto di Helle: inferno. Hellekìn diventò un cacciatore infernale:
Helljàger, i suoi seguaci — tanti Hellekìni, che procedono con-
torcendosi, facendo gran chiasso, incutendo paura e maraviglia,
maliziosi ed astuti come i dimoni del medio evo. Questo tipo si
mantenne dipoi oscillando tra il malizioso-demonico ed il demo-
nico-giullaresco. Demonio è Dant Hellequin nel fabliau che conta
delle sue nozze con Luque la mandile (1) ; di giullaresco sa la
menzione di sonagli, come p. e. in Adam de la Halle (ed. Gous-
semaker 39):
J'oi la maisnie Hielekin
Mien ensiant qui vient devant
Et mainte cloquete sonnant,
nella descrizione della cavalcata trionfale di Orgoglio nel
Renard le Nouvel:
532 à sa siele et à ses lorains
Ot une cent cloketes aux mains
Ki demenoient tei tintin
Con li maisnie Hierlekin,
ciò che ci fa pensare alla Hera della tradizione sovracitata, cum
tintinnabuUs et alis. — Mentre Huon de Mery {Tornoiement
Antechrisi) non dà nessuna nuova particolare della « maisnie
« Helequin », il romanzo di Fauvel (146, Fonds Frangais, XIV s.)
la dice rabbiosa:
Je cuids que c'estoit Hellequin
Et tuit li autre sa maisnie
Qui le suivent toutc enragie.
Avec eux avoient hellequines
Qui avoient cointises fines.
E lo stesso si legge nel Mariage des fìlles au diable:
Il s'entrepoilent com mastin,
G'est la mesnie Hellequin.
(1) Vedi Romania, n' 46-7, pp. 224 sgg.

336 A. WESSELOFSKY
In Normandia, ove s'è mantenuta l'antica credenza della Ghassie
Annequin, Hennequin, ecc., il nome di hannequin che si dà ad
un ragazzo spiacevole vale demonio, folletto.
L'Alichino di Dante (Inf., XXI, 118; XXII, 112) non è altro
che Hellequin, diventato adirittura demonio (1), e a lui ben si at-
tagliano le parole che dì sé dice il suo compagno Gagnazzo:
Malizioso son' io troppo,
Quand io procuro a' miei maggior tristizia.
(Inf., XXII, 110-11).
E lo stesso dovrà ammettersi per l'Hellequin del mistero francese:
la trappola, che dalla scena conduceva all'inferno « teatrale »,
era chiusa da un sipario, rappresentante una testa di brutto e
spaventevole aspetto; questo sipario ebbe il nome di: chappe
d'Hellequin, forse perchè era là appunto la buca, donde scappa-
vano sulla scena i demoni, quando ne occorreva bisogno. Più
tardi ed oggi ancora quella specie di cortina, che va intorno
alla scena, si chiamò « manteau d'Arlequin » (2), nome che si
dà ancora in alcuni paesi di Francia alla « mesnie Hellequin » (3)
e che sopravvive in Arlecchino: perchè quella nota maschera
della Gommedia dell'Arte e del teatro dei burattini subentrò al
vecchio Hellequin, rivestendo il classico centunculo del mimo
antico e col volto ricoperto di nera fuliggine: usanza dei mimi
anche questa, ma che alla mente dello spettatore divolo e pauroso
simboleggiava la fuliggine d'inferno.
(1) Gfr. Graf, Demonologia di Dante, in questo Giorn., IX, 48 n.
(2) Petit de Julleville, Les mystères, 1, 322, n. 1.
(3) Gfr. P. Paris , Manuscrits franQais , 1 , 321 sgg. : « Dans mon pays
« (l'ancien Rémois) les petits enfants s'efifraient mutuellement à l'approche
« de la nuit en criant à tue-téte : « Arlequin sur nos talons ! », comme si la
« Mesnie Hellequin les poursuivait encore. On y donne aussi le nom d'Ar-
« lequins aux feux-follets enfantés par les exhalaisons de la terre dans les
« derniers jours d'automne. Ges Arlequins, disent les raères avec afFectation,
« s'attachent aux pas des enfants ; ils offrent une lumière trorapeuse en sau-
« tillant devant eux à quelque distance ,jusqu'h ce qu'ils aient conduit la
« pauvre victime dans un marais ou un précipice ».

ALICHINO E AREDODESA 337
u.
La caccia fantastica è riferita dalla credenza popolare germa-
nica al periodo di dodici giorni, dal 25 dicembre al 6 di gennaio,
l'Epifania, mentre il V era consecrato alla memoria di Giovanni
Battista, il cui nome doveva suggerire la leggenda di Erode e
di sua figlia. Questa pare aver dovuto cedere col tempo gran
parte della sua celebrità ad una personificazione sincrona: la
Befana italiana = Epiphania, la Berhta tedesca, la lucente, come
importa il suo nome, tolto dall' i^uépa tùiv àfiujv qpOjxuiv. Se ora
Berhta apparisce alcuna volta come spauracchio , Befana come
figlia di Erodiade (1), sarà sotto l'influsso d'Erodiade leggendaria.
In un racconto del Mòltthal (2), che riassume 1 già noti di Do-
siteo e di Niceforo, la figlia di Erode è una danzatrice sma-
niosa, che, dopo aver ballato dinanzi al padre, s'insuperbisce di
modo, che si mette a ballare mentre traversa un lago, coperto
di ghiaccio. Sprofonda nell' acqua e deve andare, così ballando,
all' inferno, onde scappa ogni notte del 5 gennaio per far, bal-
lando, il giro del mondo. Si chiama — Perhi o Perchtra.
Un influsso in senso inverso, cioè della Berhta-Befana sul tipo
di Erodiade dovrà ammettersi in parte pell'Aredodesa, Bedodese,
Redosa, Redosola, ecc. dell'alta Italia che non sarà altro che
Erodiade. Se nel veneto essa apparisce come una vecchietta
vispa e compiacente, che nella notte della Epifania appresta a
tutti i bimbi una calza piena di frutta e dolciumi (3) — è un
concetto del suo carattere che sa di nuovo, mentre altri racconti
di lei serbarono il suo tipo originale: come quando essa incute
paura alle donne che filano o lavorano la vigilia della festa (4),
(1) Grimm, loc. cit., I, 234.
(2) Ztsch. f. deutsches Althertum, XX VII, p. 96.
(3) Vedi Angela Nardo Gibele, Superstizioni Bellunesi e Cadorine, in
Arch. per lo studio delle trad. pop., IV, 588; V, 39-
(4) Loc. cit, IV, 590.

338 A. WESSELOFSKY
fa delle sue alle « tose che le andava a slittarsi co i so morosi »,
annegandole in un torrente. « Venia fora de lo inferno » stre-
pitando con catene (1), e i ragazzi intendono di cacciarla, bat-
tendo e scuotendo catene, treppiedi, zampogne, mentre vanno a
frotte per le strade (2). Scappa al primo canto del gallo (3). In
Cadore si racconta che alla vigilia dell'Epifania la Redodesa « si
« presenta alla chiesa di S. Giovanni al tocco della mezzanotte
« per esser battezzata. S. Giovanni la manda alla fontana con una
« cesta bucata per prender l'acqua necessaria alla cerimonia. Essa
« va ad attinger l'acqua e ritorna, naturalmente, dal santo con la
«cesta vuota. Allora segue fra loro questo dialogo:
Duan, Duan, batezime sto an,
Madona, un altro an!
« E la Redodesa mortificata se ne va. Ciò che è scritto, deve
« seguire sino alla fine del mondo » (4). S. Giovanni, mentovato in
quella tradizione, ci riconduce ad Erodiade ; ciò che della Redo-
desa si narra a Gron (5) — al racconto di Dositeo e di Niceforo
del passaggio di Erodiade sul lago o fiume gelato. « Sul punto
« della mezzanotte se ferma le acque del Gordevole e del Mis
« (due torrenti) e se forma na strada sul medo. Alora passa la
« Redodesa coi soi dodese Redodesegot, e se andesse per assidente
« qualchedun a tor acqua in quel momento, la li ingiotisse tuti
« 'n t' un fiat. Co vien la matina, i va a imprimar l'acqua coi
« anemai, e el primo che andeva 'na olta, trovea su le grave
« un maz de fior magnifizi, che parea impossibel se li podese
« trovar nel mese di genaro ». I dodici « Redodesegot » concor-
dano con ciò che si disse delle figlie di Erode nella tradizione
catalana, e dodese avrà influito sulla forma del nome Aredodese
= Erodiade.
(1) Loc. cit., V, 33, n. 1 e p. 34.
(2) Loc. cit., V, 33.
(3) Loc. cit., V, 32.
(4) Loc. cit., V, 32-33.
(5) Loc. cit., IV, 590.

ALICHINO E AREDODESA 339
Già lo dissi: la rappresentazione di un giro senza tregua, di
una caccia sempiterna si sviluppò da quella più antica del ballo :
nel racconto di Niceforo è la testa di Erodiade che si mette a
ballare. Allusioni a questo motivo io le trovo, in parte almeno,
nelle feste popolari di S. Giovanni d'estate (24 giugno). Anche
la caccia fantastica viene qualche volta riferita a questo ter-
mine (i); nel napoletano, nella notte che precede il 24 di giugno,
i contadini mettono fuori una secchia ripiena d' acqua, per ve-
dervi Erodiade colla madre che passano, rimproverandosi a vi-
cenda la morte del Battista (2). In alcune parti di Bulgaria c'è
l'usanza che tre giorni prima del 24 giugno sei ragazze mettonsi
insieme e travestite vanno per le case a ballare: l'una di esse,
che ha a nome Dragaica, rappresenta Erodiade, con un cappello
d'uomo in testa e un coltello in mano, che ella brandisce in
segno dell'uccisione del Battista (3). Nel giuoco della Dragaica
(1) SiMROCK, toc. cit., 216; cfr. Grimm, loc. cit., II, 767.
(2) PiTRÈ, Archivio, I, 327.
(3) ^oAaKoe^, E'bAiapcKviu napodem cdopHum, p. 56. Usanza diSvisciovo;
il giuoco si dice eseguito da fanciulle rumene (zingare?), benché il nome
di dragaica accenni ad una origine slava (o greca ?). Gihag , Dictionnaire
d'ètymologie daco^omane , Èlèments slaves ecc. , a v. drag — nota sol-
tanto : « dragaica= nom donne à la plus belle fiUe choisie à une cer-
« taine féte champétre et nom d'une danse que ces fiUes dansent ». Nei
drammi dell'Alessandri, citati dal Gihac, non si trova, rispetto a quest'uso,
che la frase: « giìica dragaYca pin curte (Opere complete, II, 938), gioaca
« dragaica ca o nebuna » (ib., III, 997). 11 Gantemir, Operele principelui
Dimitriu Cantemirtt, t. I, Bucuresci, 1872, p. 141, dà interessanti particolari
intorno a Dragaica, identificandola con Gerere, ma la spiegazione dell'uso è
tutt'altra che quella data da Giolakov: « Etenim eo anni tempore, 'quando
« segetes maturescere incipiunt, congregahtur, quot quot fuerint, vicinorum
« pagorum puellae ac inter se venustiorem et forma praestantiorem sub
« Dragaicae nomine eligunt. Hanc in agrum magno comitatu deductam, co-
* rona ex aristis plexa pluribusque strophiolis phrygio opere pictis exomant
« ac claves horreorum manibus eius suspendunt. Sic ornata Dragaica, ex-
« tensis manibus et strophiolis vento expositis, ita ut volantis speciem prae
« se ferat, ex agro domum redit et omnes quot quot in eam societatem
« iverant pagos cantando et saltando peragrat, stipata cunctis reliquis soda-
le libus quae cum canticis sat concinne compositis sororem et dominam« quam saepissime vocitant. Huius honoris villicae Moldavorum puellae ple-
« rumque sunt avidissimae, licet perpetua consuetudine cantavit, ne ea, qaae
< Dragaicae personam gesserit, intra triennium marito elocetur ».

340 A. WESSELOFSKY
abbiamo cosi un brano di dramma popolare parallelo a quello
già nsitatissimo fra i Rumeni nel periodo tra il 25 dicembre e
il 7 gennaio: una specie di Offlcium stellae, che in Transilvania
ed in Moldavia ebbe nome dal suo protagonista: Irodì= gli Erodi
(cfr. les Hallequins).
Sono conosciuti i rimproveri che sin dal principio del secolo XVI
la Chiesa moveva contro il ballo frenetico, a cui davansi le donne
e le fanciulle russe nella notte del 24 giugno. Ciò che se ne dice
rammenta la manìa della danza di S. Giovanni (St. Johannis
chorea, danse de St. Jean, Sanct Johans Dantz), che nel 1374
colse le popolazioni delle rive del Reno e della Mosella e dei
Paesi Bassi (1). Uomini e donne, vecchi e giovani, ragazze, scap-
pate dalla casa paterna, si assembravano su per le vie e nelle
chiese e si abbandonavano ad una danza appassionata, finché
cadevano tramortiti. Tutti avevano corone in testa e si fascia-
vano la vita di corde o fazzoletti — per non iscoppiare, e allo
stesso scopo si facevano battere e calpestare nel caso che cades-
sero dalla troppa stanchezza. L' interessante si è, eh' essi pro-
vavano un'invincibile avversione contro il color rosso e che
figurandosi talvolta esser entrati in un fiume di sangue, si
mettevano a saltare. — Il ballo sarà una reminiscenza di quello
di Erodiade, il sangue — di quello del Battista, il cui nome si
ripeteva nel breve canto, che accompagnava la danza:
Herre sankt Johann, so, so,
Frisch und froh,
Herre sankt Johann!
Il cronista Veit Weinberg (f 1580), rammentando il movimento
religioso del 1374, chiama questa danza Firlefantz; il sig. Freybe(2),
dimentico dell'allusione al 1374, crede che si tratti di spiriti
maligni, erranti nella notte di S. Giovanni, e della ricerca di
tesori nascosti. Noto di passaggio che collo stesso nome di Fìr-
(1) Cfr. Uhland, Schriften, III, 399401, e le note
(2) Germania, XXIV, p. 384.

ALICHINO E AREDODESA 341
lefantz si chiama nel Voigtland un giuoco che si fa nel giorno di
S. Giovanni, nel quale un certo Giovanni viene buttato nell'acqua.
Il ballo essendo generalmente condannato dalla Chiesa del
medio evo come opera del demonio, Erodiade si presentava come
la ballerina per eccellenza. L'autore dell' omelia irepì n^Tavoiac,
attribuita a S. Giovanni Crisostomo, ne parla a proposito di or-
chesti e di giuochi profani (1); nelle miniature si vede Erodiade
davanti ad Erode che si dimena a guisa di giullare (2) ; Eusebio
di Emesa la dice istrumento del diavolo , di cui egli si servi
per la morte del profeta: con la testa troncata essa giocò alla
palla (3). Un testo omiletico antico russo , attinto a fonte bi-
santina, rigetta ogni danza come nefanda: tutte quelle che si
danno al ballo, lo fanno in vitupero di S. Giovanni e saranno pu-
nite, con Erodiade nel fuoco che non si spenge, dal verme che non
dorme mai. In un testo greco medioevale dell'Apocalissi di Maria
r arcangelo Michele le addita Ywvatxa KpeiuaiaévTiv éirò rf\c, yMaar]c,
aÙTfj^ , Kol eì<; tòv rpdxriXov aùtrìc, f\v òpàKiuv èvTuXia|Liévo(; Kal IxpoYev
Tò axóMa aùrf\<; (4). È Erodiade. Punita , essa stessa diventa un
mezzo di punizione ad altri : una febbre maligna, che fa tremare
e contorcere i membri era assomigliata alla danza frenetica e
smaniosa di Erodiade; è Erodiade che cosi fa ballare l'infermo.
Un' antica formola superstiziosa russa,
propagatasi dalla Bul-
garia, fa delle febbri tante figlie di Erode, come la canzone ca-
talana parla di più figlie di lui, che ballano « que mes ballaran ».
Questa formola rimonta ad una più antica bizantina, conosciu-
tissima fra gli slavi fin del mezzogiorno, popolare anche fra i
rumeni (5). In essa San Sisinnio, o solo o col fratello Sinodoro,
(1) Gfr. anche l'omelia, parimente attribuita a S. Giovanni, nell'ed. Mignb,
t. LIX, 485-90.
(2) Th. Wright , The History of domestic manners and sentiments in
England, pp. 167, 168.
(3) MiGNE, Patrol. gr., t. LXXXVI, 1, p. 517.
(4) Annuaire de l'association pour Vencoiiragement des études grecques,
en France, 5® année (1871); Gidel, Étude sur une Apocalypse de la Yierge
Marie, p. 113.
(5) Vedi i miei PastACKama, VI, 40 sgg. ; 427 sgg. ; SaMtbrriKU no Aume-
GiornaU storico, XI, fase. 33. 22

342 A. WESSELOFSKY
danno la caccia alla demonica TiWib, avente dodici nomi. Nelle
varianti posteriori di questa mezzo-leggenda, mezzo-filatterio, i
nomi dei santi cangiano, quelli di riXXii» diventano tanti esseri
diversi, e subentrando la leggenda di Erodiade o di più figlie di
Erode cacciate e vaganti, se ne ebbe la formola russa (=: bulgara):
delle febbri, figlie di Erode, perseguitate da un santo. In questa
formola i vecchi nomi di riWdj cederono in gran parte ad altri
vennero storpiati. Ho specialmente in vista il nome di BuroO
'ApuZoO: il demonio 'OpiZooe del Testamentum Salomonis; loan-
nides nel glossario del dialetto di Trebisonda fa venire 'ApuloO
da à^vaaoc; e spiega: xaTaxeóviov irveOiua, [là-fwaa. Ad 'A^uZoO BuZoO
del testo bizantino corrispondono nelle versioni slave e rumene:
Avizoia, Aveziha, Avezuha ; nelle formole russe : Bèsiza o Besciha,
che è figlia di Erode, cioè Erodiade. Herodias vel Be{n)zozia di
Augerio, Herodias vel Bezezia degli statuti sinodali S. Fiori
avranno possibilmente conservato uno degli antichi nomi leggen-
dari di Erodiade , fatta demonio : 'OPi^oOe, 'ApuZoO, BuZoO, 'ApiZioO,
'ApiòaZioO = Bezozia , Bezezia, satia , onde più tardi Abundia —dame Habonde.
A conferma di ciò che s' è detto valgano ancora le seguenti
osservazioni. L' 'opi^ooe del Testamentum Solomonis, la TiXXib del
filatterio di Sisinnio uccide, rapisce, divora i bambini di tenera
età ; lo stesso si dice, a proposito di Erodiade , nel passo sovra-
citato di Q-iovanni Saresberiense (v. p. 330) : « Nocticulam quan-
« dam vel Herodiadem vel praesidem noctis dominam Consilia
« et conventus de nocte asserunt convocare, varia celebrari con-
« vivia praeterea infantes exponi lanrdis, et nunc frustatim
« discerptos edoud ingluvie in ventrem trajectos congeri, nunc
« praestdentis miseratione rejectos in cunas exponi » (1). Al
Q-rimm (2) gli ultimi particolari di questo racconto parvero in-
pamyprb u uapoduou cjioeecuocmu , I, 87 sgg. : SaMtbmKU no ucmopiu ano-
Kpu^oe-6, pp. 288 sgg.
(1) Grimm, B. Myth., II, 884.
(2) Loc. cit., II, 886.

ALIGHINO E AREDODEbA 343
novazione di una favola più antica e di tutt' altro carattere: si
trattava in principio di viaggi notturni di fate benefiche, por-
tanti nelle case, cui visitavano, la felicità e l'abbondanza (= A-
bundia), benedicenti ai bambini; il motivo del ratto venne intro-
dotto più tardi sotto l'influenza di racconti favolosi intorno agli
Elfen; nel testo di Giovanni l'antica correzione avrebbe lasciato
un vestigio nel carattere di Erodiade , che sola si mostra com-
passionevole , dando ordine che i fanciulli rapiti siano rimessi
nelle loro culle. Ma il fatto sta che si parla di ben altro che di
ratto, perchè i fanciulli vengono inghiottiti e poi di nuovo ridati
alla vita — come nella leggenda di Sisinnio la riXXù) inghiottisce
il bambino di Meletina e poi lo rigetta dietro le minacce del
santo. Appunto questa particolarità sarà la più antica, Erodiade
benevola un' intrusione recente. L'Erodiade delle credenze popo-
lari europee è dunque la TiXXùj del fìlatterio di Sisinnio , l' Ero-
diade delle ubbie bulgare e russe. Hasdeù riconobbe la greca
TiXXub, reXXd) nelle Jelele (Dìnsele, Frumoasele ecc.) rumene: fan-
ciulle demoniche, che vanno per l'aria, cagionando agli uomini
varie infermità, succhiando il loro sangue, riducendo a paralisi
i giovani infelici, pei quali sentono amore. Ebbene, fra le Jelele
appariscono anche le Jerodiecele , Iroditele : sono le nove figlie
di Efode imperatore e di Irodasa imperatrice, che viene anche
chiamata Irodia , Irodita la grande (1). È la Redodesa coi suoi
Rododesegot della leggenda di Gron.
Alessandro Wesselofsky.
(1) Saineanu, loc. cit., pp. 10, 11, 14, 15, 18, 53 n. 7.