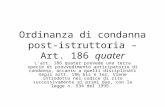Aggregazioni fra imprese: contratti di rete & altro · →il co. 4-quater dispone che «il...
Transcript of Aggregazioni fra imprese: contratti di rete & altro · →il co. 4-quater dispone che «il...
Pao
lo M
enti
©20
11
2
� nozione del contratto di rete
� contenuto e disciplina del contratto
� qualche confronto
Pao
lo M
enti
©20
11
3
L. 9 aprile 2009, n. 33, modificata dal d.l.. 31 maggio 2010, n. 78
Art. 3“Distretti produttivi e reti di imprese”
comma 4-ter (1°e 2°periodo) = nozione del contratto di rete (CR)
� Con il contratto di rete più imprenditori
� perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato
� e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete,
� a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese
� ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
� ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
� Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune
� e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso
Pao
lo M
enti
©20
11
4
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > nozione del contratto
parti del CR sono esclusivamente IMPRENDITORI ISCRITTI nel Registro delle Imprese (→); i contraenti – in numero di due o più – possono rivestire forma individuale o associata (società di persone, di capitali, cooperative e consortili; g.e.i.e.; consorzi con attività esterna; imprese sociali)
→ il co. 4-quater dispone che «il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contrat-to inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a cari-co di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari»: non può perciò contrarre re-te, con gli effetti della presente normativa, chi eserciti l’impresa in via di mero fatto
→ il contratto non pubblicizzato (ad es. perché non stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come richiesto dal co. 4-ter ) è valido ed efficace secondo le norme generali del c.c. (cfr. art. 1322) ma non anche agli effetti della presente normativa
non sono imprenditori gli enti pubblici non economici, i professionisti o altri sog-getti che non presentano i requisiti dell’art. 2082 c.c.: costoro non possono perciòcontrarre rete agli effetti della presente normativa (salvo stipulare contratti asso-ciativi innominati o joint ventures che si propongano scopi similari e che si posso-no collegare a CR)
Con il contratto di rete più imprenditori� � �
Pao
lo M
enti
©20
11
5
scopo (ovvero funzione o causa) del CR è migliorare la capacità innovativa e la competitività di ciascun singolo imprenditore contraente e di tutta la rete nel suo complesso
il CR non può pertanto determinare condizioni di dipendenza economica fra i contraenti o di vantaggio esclusivo di alcuni; ma si ammette che il CR sia stipu-lato fra le parti ad es. di un rapporto di subfornitura allo scopo di migliorare e uniformare i processi produttivi
scopo del CR non è di per sé produrre utili, ma favorire risultati positivi da parte di ciascun contraente grazie al miglioramento tecnologico e concorrenziale della propria impresa
lo scopo del CR esige che il vincolo sia durevole: la durata del vincolo associa-tivo deve essere indicata nel contratto (lett. d ); in caso di mancata indicazione si applica per analogia la disciplina del consorzio (art. 2604 c.c.) e non quella dei limiti contrattuali alla concorrenza (art. 2596) poiché il CR non è riducibile a questi ultimi: dunque 10 anni (e non i cinque dei meri patti anti-concorrenziali)
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > nozione del contratto
� � �perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato� � �
Pao
lo M
enti
©20
11
6
il PROGRAMMA DI RETE, elemento essenziale del CR, deve contenere (lett. c ):
• la enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante (→)• le modalità di realizzazione dello scopo comune (sulla misurazione v. pag. 14)• se è prevista la istituzione di un fondo patrimoniale comune (→), la misura e i
criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi succes-sivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; il PROGRAMMA può consentire che la dotazione ini-ziale al fondo avvenga – per il contraente s.p.a. – anche mediante costituzione di un pa-trimonio destinato a specifico affare (art. 2447-bis, co. 1°, lett. a, c.c.)
→ gli obblighi dei contraenti, sia positivi sia negativi, devono essere determinati o almeno determinabili potendosi ricorrere anche all’art. 1349 c.c. (arbitratore) onde adeguare gli impegni al mutamento delle situazioni economiche
→ il fondo, costituito dai conferimenti e contributi dei contraenti e dai beni acquistati con tali risorse, gode di autonomia patrimoniale rispetto ai creditori particolari, non può es-sere diviso per la durata del contratto (cfr. art. 2614 c.c.), risponde delle obbligazioni assunte in nome e per conto della rete e inoltre (non però se istituito ex art. 2447-bis) risponde in solido col singolo contraente per conto del quale siano state assunte obbli-gazioni dalla rete (cfr. art. 2615) ■ v. anche pag. 10
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > nozione del contratto
� � �e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete,
� � �
Pao
lo M
enti
©20
11
7
assieme all’obbligo di “scambiarsi informazioni o prestazioni” (./.) l’obbligo di col-laborazione è tra le novità del d.l. 78/’10 e lascia indipendenti al massimo livello compatibile con la rete le imprese dei contraenti salvo realizzare un coordina-mento più o meno esteso fra le stesse
le prestazioni a cui si obbligano i contraenti vanno determinate identificando am-biti e modalità (forme) di collaborazione, in vista ad es. della creazione di un mar-chio comune o dello sviluppo di una attività di ricerca anche appaltata ad altri o della elaborazione di disciplinari tecnici di produzione o di commercializzazione (specie se il CR interessa una filiera)
la utilità di questo livello minimale di integrazione sta nell’attribuire rilevanza con-trattuale a prestazioni e responsabilità altrimenti confinate nel pre-contrattuale, col conseguente rafforzamento di tutela (inversione dell’onere della prova ex art. 1218 c.c. e risarcibilità dell’interesse contrattuale positivo di contro al limite di cui all’art. 1337) e così di persuasione all’adempimento
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > nozione del contratto
� � �a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle
proprie imprese� � �
Pao
lo M
enti
©20
11
8
lo scambio di informazioni o di altre prestazioni realizza un vincolo più intenso della mera collaborazione e può anche rappresentare una fase evolutiva di que-sta ultima (ad es. quando ci si obblighi a mettere in rete informazioni attinenti allo sviluppo di una programma di ricerca, autogestito o appaltato); se si tratta di pre-stazioni industriali o commerciali, il CR può regolare lo scambio di prodotti fra segmenti di una filiera ovvero può integrare (ad es. nel comparto edile) le attivitàdi soggetti diversi prevenendo le conflittualità o aggiornare protocolli operativi con parti terze (ad es. consentendo di individuare e fidelizzare fornitori di rete)
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > nozione del contratto
� � �ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commer-
ciale, tecnica o tecnologica� � �
Pao
lo M
enti
©20
11
9
è la obbligazione prevista fin dall’origine della disciplina legale del CR, che lo av-vicina al consorzio con attività esterna realizzando il maggior grado di integrazio-ne fra i contraenti
rispetto al consorzio (art. 2602 ss. c.c.) sussistono varie differenze, la più impor-tante delle quali è che il CR non dà necessariamente luogo ad una organizzazio-ne (patrimonio, organo direttivo) distinta dalle imprese contraenti (./.); ne segue che (almeno) in caso di mancata organizzazione la rete rimane estranea – diver-samente dal consorzio: cfr. art. 2500 septies e octies c.c. - ad operazioni quali la trasformazione eterogenea da e in società
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > nozione del contratto
� � �ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto
della propria impresa.
Pao
lo M
enti
©20
11
10
col d.l. 78/’10 la costituzione del fondo comune è stata resa facoltativa (CR “leg-gero”) ma senza il fondo non si può ottenere la detassazione degli utili prevista fi-no al 2012 dall’art. 42, co. 2-quater, del d.l. cit. (e concessa a una quota degli utili dell’esercizio, non superiore a 1 milione di euri, destinati dai contraenti il CR al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete)
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali (in denaro o no) e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga ad apportare al fondo nonché le regole di gestione di esso sono elementi da stabilire nel pro-gramma di rete; se il CR prevede i contributi ma non li regola, si applica la disci-plina generale (societaria e consortile: art. 2253 c.c.) circa la pari entità per tutti i contraenti; la concreta misura può essere stabilita, come per i consorzi, in quanto necessario a coprire le spese annuali
non ci sono regole legali di rendicontazione; è raccomandabile l’adozione con-venzionale dei criteri di valutazione e di rappresentazione stabiliti per il bilancio d’esercizio delle s.p.a. (cfr. per i consorzi l’art. 2615-bis c.c.)
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > nozione del contratto
Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune � � �
Pao
lo M
enti
©20
11
11
dopo il d.l. 78/’10 diviene facoltativa anche la istituzione dell’organo comune per la esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso (OC)
se istituito l’OC agisce “come mandatario comune” (lett. e) munito di rappresen-tanza (“...in nome e per conto...”); nel silenzio del contratto l’OC rappresenta i contraenti del CR (i) nelle procedure di programmazione negoziata con le p.a., (ii) nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'ac-cesso al credito e (iii.a) in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di interna-zionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché (iii.b) all'utilizza-zione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza
il CR deve prevedere le regole per la sostituzione dell’OC; in mancanza si appli-cano le norme sul mandato e in specie, quanto alla revoca, l’art. 1726 c.c. sul mandato collettivo (l’OC è revocabile solo col consenso unanime salvo che ricor-ra una giusta causa)
l’OC può essere pluripersonale (poteri disgiunti salvo diversa previsione del CR)
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > nozione del contratto
[Il contratto può anche prevedere] � � �
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso
Pao
lo M
enti
©20
11
12
L. 9 aprile 2009, n. 33, modificata dal d.l.. 31 maggio 2010, n. 78
Art. 3“Distretti produttivi e reti di imprese”
comma 4-ter (3°periodo) = contenuto del contratto di rete (CR)
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redat-to per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità com-petitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, ecc.d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma re-stando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione so-ciale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune ecc.
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di inte-resse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di ge-stione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioran-za del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo
Pao
lo M
enti
©20
11
13
il CR è “contratto plurilaterale con comunione di scopo” (lett. d) con struttura (po-tenzialmente) aperta
le modalità di adesione sono indicate nel contratto; in mancanza si applica l’art. 1332 c.c.: “se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato co-stituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali”
è anche lecito vietare ogni adesione successiva (ma il consenso unanime dei contraenti può in ogni tempo disporre in contrario)
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > contenuto del contratto
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva
Pao
lo M
enti
©20
11
14
nuova dopo il d.l. 78/’10 è la prescrizione delle modalità per misurare l’avanza-mento verso gli obiettivi strategici, potendo l’autonomia negoziale ricorrere a varie tecniche (misurazione dell’aumento di fatturato, della riduzione dei costi ecc.) pur-ché dai risultati quantitativamente apprezzabili (senza di che non c’è misura)
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > contenuto del contratto
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della ca-pacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi
Pao
lo M
enti
©20
11
15
il recesso spetta comunque per giusta causa (ad es. la modifica a maggioranza del CR o del programma di rete: v. pag. 18); tra le cause contrattuali è ammissibi-le anche il recesso volontario, oltre agli eventi sopravvenuti che rendano privo di utilità per il contraente il CR (liquidazione coattiva o volontaria dell’impresa, modi-fica sostanziale dell’attività) o altre ipotesi (ad es. aumento dei contributi deciso dal l’organo comune)
mancando previsioni circa l’esercizio del diritto si ritiene applicabile la disciplina della cooperativa (art. 2532 c.c.: procedura di verifica e contestazione da parte dell’eventuale organo comune; effetto immediato sul rapporto di rete e differito sulle prestazioni dovute)
è legittimo negare al recedente liquidazione o rimborsi (cfr. art. 2609 c.c.)
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > contenuto del contratto
c) la definizione di un programma di rete, ecc. [v. pag. 6]d) la durata del contratto [v. pag. 5], le modalità di adesione di altri imprenditori [v.
pag. 13] e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ...
Pao
lo M
enti
©20
11
16
dette regole generali sono contenute negli articoli 1420 c.c. (nullità del singolo vincolo contrattuale), 1446 (annullabilità del medesimo), 1459 (risoluzione per inadempimento), 1466 (impossibilità sopravvenuta della prestazione) e sono tutte ispirate al principio che l’evento che colpisce il singolo rapporto di un contratto con più di due parti non incide sul rapporto nel suo complesso salvo che la parte-cipazione della parte interessata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale
nel CR le circostanze, specie riguardo alla risoluzione per inadempimento e per impossibilità sopravvenuta, possono anche consistere nella volontà degli altri contraenti di risolvere il contratto limitatamente al soggetto interessato qualora l’evento che integra l’inadempimento o la impossibilità sia dedotto come causa facoltativa di esclusione (come avviene nelle società personali e nelle cooperati-ve: rispettivamente art. 2286 c.c. e art. 2533)
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > contenuto del contratto
d) ... ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo
Pao
lo M
enti
©20
11
17
il riferimento a “la ragione o la denominazione sociale” dimostra che l’organo co-mune può anche essere rappresentato da un ente diverso dalla persona fisica
l’OC può constare anche di più organismi, ad es. di un organo direttivo e di una assemblea dei contraenti come avviene per i consorzi; si può prevedere anche un organo di composizione delle controversie (probiviri)
l’OC può prevedere la partecipazione di soli contraenti (tutti o no) o anche di terzi
la legge tace sulla responsabilità dell’OC verso i contraenti, in particolare per con-flitto di interessi; viene così applicabile la regola circa i consorzi (art. 2608 c.c.) ossia che la responsabilità dei preposti è disciplinata dalle norme sul mandato, col plausibile corollario che il grado di diligenza richiesto sia quello più grave di cui all’art. 1176, co. 2°, c.c. (non cioè del buon p adre di famiglia, ma di chi eserciti professionalmente la attività di preposto all’OC di rete)
[sull’OC v. anche pag. 11]
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > contenuto del contratto
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denomi-nazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune ecc.
Pao
lo M
enti
©20
11
18
trattandosi di contratto, regola generale è la unanimità (art. 1372 c.c.); tuttavia il CR può introdurre la regola maggioritaria per le modificazioni del programma di rete (col correttivo del diritto di recesso per giusta causa a favore dei dissenzienti: v. pag. 15)
non è richiesto il metodo assembleare ossia la collegialità piena delle decisioni, ma è opportuno – secondo taluno è anzi necessario – che tutti gli aventi diritto siano informati del procedimento decisionale in corso così da poter decidere di prendervi parte oppure no (metodo referendario o di collegialità attenuata)
L. 9 aprile 2009, n. 33 (mod. dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78)Art. 3 - “Distretti produttivi e reti di imprese” - comma 4-ter > contenuto del contratto
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole rela-tive alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma me-desimo
Pao
lo M
enti
©20
11
19
il CR assomma la FLESSIBILITÀ delle relazioni contrattuali con le particolari esigenze di STABILITÀ che accompagnano la istituzione di un coordinamento fra imprese volto a promuoverne lo sviluppo quali-quantitativo (innovazione e competizione)
...
qualche confronto con altri strumenti di integrazione fra imprese
Pao
lo M
enti
©20
11
19 bis
il CR assomma la FLESSIBILITÀ delle relazioni contrattuali con le particolari esigenze di STABILITÀ che accompagnano la istituzione di un coordinamento fra impresevolto a promuoverne lo sviluppo quali-quantitativo (innovazione e competizione)
la NATURA CONTRATTUALE differenzia il CR dalle più costose aggregazioni di tipo or-ganizzativo (consorzi, gruppi di società, g.e.i.e.) senza però impedire ai contraenti di adottare, anche in tempi successivi, uno o più elementi organizzativi se ritenuti utili (fondo comune, organo comune)
...
qualche confronto con altri strumenti di integrazione fra imprese
Pao
lo M
enti
©20
11
19 ter
il CR assomma la FLESSIBILITÀ delle relazioni contrattuali con le particolari esigenze di STABILITÀ che accompagnano la istituzione di un coordinamento fra impresevolto a promuoverne lo sviluppo quali-quantitativo (innovazione e competizione)
la NATURA CONTRATTUALE differenzia il CR dalle più costose aggregazioni di tipo or-ganizzativo (consorzi, gruppi di società, g.e.i.e.) senza però impedire ai contraenti di adottare, anche in tempi successivi, uno o più elementi organizzativi se ritenuti utili (fondo comune, organo comune)
la possibilità di DOTARSI DI ELEMENTI ORGANIZZATIVI distingue il CR dagli strumenti contrattuali di integrazione che tanto non prevedono (subforniture, franchising, a.t.i.); nello stesso tempo consente ai contraenti di decidere e modificare il grado di interdipendenza fra le rispettive imprese (dalla massima indipendenza caratteri-stica ad es. di una associazione temporanea al coordinamento più stringente)
...
qualche confronto con altri strumenti di integrazione fra imprese
Pao
lo M
enti
©20
11
19 quater
il CR assomma la FLESSIBILITÀ delle relazioni contrattuali con le particolari esigenze di STABILITÀ che accompagnano la istituzione di un coordinamento fra impresevolto a promuoverne lo sviluppo quali-quantitativo (innovazione e competizione)
la NATURA CONTRATTUALE differenzia il CR dalle più costose aggregazioni di tipo or-ganizzativo (consorzi, gruppi di società, g.e.i.e.) senza però impedire ai contraenti di adottare, anche in tempi successivi, uno o più elementi organizzativi se ritenuti utili (fondo comune, organo comune)
la possibilità di DOTARSI DI ELEMENTI ORGANIZZATIVI distingue il CR dagli strumenti contrattuali di integrazione che tanto non prevedono (subforniture, franchising, a.t.i.); nello stesso tempo consente ai contraenti di decidere e modificare il gradodi interdipendenza fra le rispettive imprese (dalla massima indipendenza caratteri-stica ad es. di una associazione temporanea al coordinamento più stringente)
la necessaria DEFINIZIONE DI OBIETTIVI STRATEGICI E INNOVATIVI perseguibili nel medio-lungo periodo differenzia il CR sia dalle forme contrattuali di integrazione occasio-nale (a.t.i.) perché postula e genera stabilità di rapporti, sia dalle altre figure inte-grative (subforniture, franchising) che cristallizzano il rapporto anziché farlo evolve-re in uno col progresso economico di tutti i partecipanti
...
qualche confronto con altri strumenti di integrazione fra imprese
Pao
lo M
enti
©20
11
19 quinquies
il CR assomma la FLESSIBILITÀ delle relazioni contrattuali con le particolari esigenze di STABILITÀ che accompagnano la istituzione di un coordinamento fra impresevolto a promuoverne lo sviluppo quali-quantitativo (innovazione e competizione)
la NATURA CONTRATTUALE differenzia il CR dalle più costose aggregazioni di tipo or-ganizzativo (consorzi, gruppi di società, g.e.i.e.) senza però impedire ai contraenti di adottare, anche in tempi successivi, uno o più elementi organizzativi se ritenuti utili (fondo comune, organo comune)
la possibilità di DOTARSI DI ELEMENTI ORGANIZZATIVI distingue il CR dagli strumenti contrattuali di integrazione che tanto non prevedono (subforniture, franchising, a.t.i.); nello stesso tempo consente ai contraenti di decidere e modificare il grado di interdipendenza fra le rispettive imprese (dalla massima indipendenza caratteri-stica ad es. di una associazione temporanea al coordinamento più stringente)
la necessaria DEFINIZIONE DI OBIETTIVI STRATEGICI E INNOVATIVI perseguibili nel medio-lungo periodo differenzia il CR sia dalle forme contrattuali di integrazione occasio-nale (a.t.i.) perché postula e genera stabilità di rapporti, sia dalle altre figure inte-grative (subforniture, franchising) che cristallizzano il rapporto anziché farlo evolve-re in uno col progresso economico di tutti i partecipanti
insomma un CR ben costruito può essere utile anche a prescindere dalle agevola-zioni fiscali che vi siano collegate
qualche confronto con altri strumenti di integrazione fra imprese