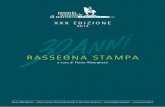73 STAMPA
-
Upload
pierluigi-de-rose -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of 73 STAMPA

Stampa e televisione
© Laurus Robuffo
1.
L. 2 febbraio 1939, n. 374. Norme per la con-segna obbligatoria di esemplari degli stam-pati e delle pubblicazioni (G.U. 6 marzo1939, n. 54) (Stralcio).
Art. 1. Ogni stampatore ha l’obbligo di conse-gnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazio-ne, quattro esemplari alla prefettura della provincianella quale ha sede l’officina grafica ed un esempla-re alla locale procura della Repubblica (1).
L’obbligo comprende anche ogni successiva edi-zione o ristampa con qualsiasi modificazione nelcontenuto o nella forma. Per ogni ristampa identicaalla pubblicazione precedente basta la consegna diun esemplare alla prefettura (1).
La consegna deve essere fatta prima che stampatie pubblicazioni siano posti in commercio o in diffu-sione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessaal committente o ad altra persona.
Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono,per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevo-lazioni previste dal R.D. 18 aprile 1940, n. 689 (artt.268, 269 e 270) e dal D.M. 23 novembre 1957.–––––––––
(1) Comma sostituito dall’art. 1, D.Lgs. Lgt. 31agosto 1945, n. 660.
Art. 2. Per le cartoline illustrate, le immagini re-ligiose e le fotografie devono essere consegnatiquattro esemplari alla prefettura ed un esemplare al-la procura della Repubblica (1).
L’obbligo comprende anche ogni riproduzione conqualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica al-la pubblicazione precedente basta la consegna di unesemplare alla prefettura.
Riguardo alle fotografie l’obbligo non sorge per ilsolo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fi-ne di sollecitare richieste di altre positive da stam-parsi.
Qualora le cartoline illustrate riproducano fotogra-ficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi,vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici ita-liani, oltre quelli indicati nel primo comma del pre-sente articolo, dovranno essere consegnati altre treesemplari per la presidenza del consiglio.–––––––––
(1) Comma sostituito dall’art. 2, D.Lgs. Lgt. 31agosto 1945, n. 660.
Art. 3. Quando trattasi di stampati e di pubblicazio-ni fatte per conto di Amministrazioni governative, lostampatore è tenuto a consegnare anche cinque copie,salva sempre l’applicazione dell’ultimo comma del-l’articolo precedente. L’obbligo comprende ancheogni riproduzione con qualsivoglia variante.
Per ogni riproduzione identica alla pubblicazioneprecedente, basta la consegna di un esemplare allaprefettura.
Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni in-terne o di carattere riservato che le Amministrazionifacciano stampare nelle proprie officine (1).–––––––––
(1) Articolo sostituito dall’art. 3, D.Lgs. Lgt. 31agosto 1945, n. 660.
Art. 4. Quando di una stessa pubblicazione ven-gano eseguite contemporaneamente più tirature, di-verse per il tipo della carta, il formato, le rilegatureod altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devo-no corrispondere alla tiratura di maggior pregio, re-stando escluse solo quelle speciali di gran lusso, ese-guite eccezionalmente in ristrettissimo numero dicopie non destinate al commercio.
In ogni caso l’obbligo della consegna si consideranon adempiuto quando siano stati consegnati esem-plari comunque imperfetti (1).–––––––––
(1) Articolo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. Lgt. 31agosto 1945, n. 660.
Art. 5. Ogni esemplare delle pubblicazioni e de-gli stampati soggetti all’obbligo della consegna de-ve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di que-sto, sull’ultima pagina del testo, l’esatta e ben visi-bile indicazione:
1) del nome e del domicilio legale dello stampa-tore, ovvero, nei casi previsti dal secondo commadell’art. 9, dall’editore;
2) dell’anno di effettiva pubblicazione.Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni
esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazio-ne del genere della ristampa, se identica o con mo-dificazioni, e dell’anno della precedente pubblica-zione. L’adempimento di tale obbligo, nei casi pre-visti dal secondo comma dell’art. 9, fa carico all’e-ditore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasistampatore.
Sugli esemplari da depositarsi deve essere appostala dicitura «Esemplare fuori commercio per la di-stribuzione agli effetti di legge».

© Laurus Robuffo
Art. 6. Per le cartoline illustrate, le immagini reli-giose e le fotografie, ciascuno degli esemplari da con-segnare deve portare, stampate o manoscritte, le indi-cazioni richieste dal 1° comma dell’articolo preceden-te. Sugli altri esemplari basta l’indicazione del nome edel domicilio legale dello stampatore o dell’editore.
Art. 7. Sono esenti dall’obbligo della consegna ifogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità delcommercio e dell’industria, i registri e moduli di uffi-cio e di commercio, le mappe catastali, le carte valo-ri, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buo-ni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografiedi carattere strettamente privato, le partecipazioni dinascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita,la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e fa-scette, le carte da involgere, comunque impresse e daparati ed altri simili stampati.
Inoltre i Ministeri dell’interno, di grazia e giustiziae la presidenza del consiglio potranno per quanto dirispettiva competenza, con decreti da pubblicarsinella G.U., concedere temporaneamente altre esen-zioni od agevolazioni e revocare le concessioni me-desime per particolari categorie di stampati o dipubblicazioni, come quelle di costo elevato o relati-ve a scienze esatte e materie strettamente tecniche,nonché le cartoline illustrate, le immagini religiose ele fotografie.
Art. 8. Per ogni violazione delle norme della pre-sente legge e del regolamento previsto dall’art. 14, lostampatore o editore è punito sempreché il fatto noncostituisca un più grave reato, con la sanzione am-ministrativa da lire 40.000 (euro 20) a 400.000 (euro206) (1). All’ammenda può’ essere aggiunta la so-spensione dall’esercizio della professione o dell’arteper un tempo non superiore a tre mesi, e, se concor-rano circostanze di particolare gravità anche la pub-blicazione della sentenza di condanna (2).
L’applicazione di dette sanzioni e degli eventualiprovvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamentidi pubblica sicurezza non esonera dall’obbligo diadempiere a quanto è prescritto dalla presente leggee dal relativo regolamento. In caso di mancata o co-munque imperfetta consegna degli esemplari dovuti,può, in ogni tempo, procedersi a esecuzione di uffi-cio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, iltrasgressore è tenuto altresì a risarcire i danni subitidall’Amministrazione dello Stato.–––––––––
(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata,da ultimo, sostituita con la sanzione amministrativadall’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Comma modificato dall’art. 5, D.lgs.Lgt. 31agosto 1945, n. 660.
Art. 9. Agli effetti della presente legge, s’intendeper stampatore ogni persona o ente che riproduca, ascopo di diffusione o di semplice distribuzione, unoscritto od una figura per mezzo della tipografia, lito-
grafia, fotografia, incisione o qualsivoglia altro pro-cedimento.
Negli obblighi dello stampatore subentra l’editorequando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comun-que concorso officine diverse o che, edite nello Sta-to siano state, in tutto o in parte, stampate all’estero.Si considera editore l’autore che curi direttamente lapubblicazione dell’opera.
Art. 10. Dei quattro esemplari ricevuti, la Prefet-tura trattiene uno per l’adempimento delle funzionidi sua competenza, e trasmette gli altri tre, rispetti-vamente, uno alla Presidenza del Consiglio dei mi-nistri (Ufficio stampa), uno alla Biblioteca naziona-le centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazio-nale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma.
La Prefettura, adempiuti gli obblighi di sua com-petenza, trasmette l’esemplare ricevuto alla bibliote-ca pubblica del capoluogo della Provincia, o di altracittà della Regione designata con decreto del Mini-stro per la pubblica istruzione. La Presidenza delConsiglio dei ministri (Ufficio stampa) trasmettel’esemplare ricevuto, dopo averne presa visione peril servizio di informazioni bibliografiche, al Mini-stero dell’interno (Direzione generale di P.S.) che,dopo l’uso d’ufficio, lo invia alla Biblioteca nazio-nale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma.
La Procura della Repubblica, adempiute le funzio-ni di sua competenza, trasmette l’esemplare d’obbli-go al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattie-ne gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusi-vo giudizio, possano servire ai bisogni della sua bi-blioteca, e rimette il resto ad altri istituti, presceltid’intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
L’esemplare di ogni ristampa identica alla pubbli-cazione precedente, richiesto dal co. 2 modificatodall’art. 1, è destinato alla Prefettura che, dopo l’u-so di ufficio lo trasmette alla biblioteca pubblica delcapoluogo della Provincia o di altra città della Re-gione designata con decreto del Ministero della pub-blica istruzione (1).–––––––––
(1) Articolo sostituito dall’art. 6, D.Lgs.Lgt. 31agosto 1945, n. 660.
Art. 11. Fermi gli obblighi di cui agli artt. 1, 2, 3e 9 della presente legge i Ministeri, gli uffici ed isti-tuti da essi dipendenti, e tutti gli altri istituti od entiche godono di assegni sul bilancio dello Stato, o checomunque siano enti di diritto pubblico, devono in-viare alle biblioteche del Senato e della Camera deideputati una copia di tutte le loro pubblicazioni,comprese le cartografiche e le fotografiche, degliestratti di essi e di ogni ristampa.
Tale obbligo permane a carico degli uffici e istitu-ti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazionisiano, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori oeditori privati.
Artt. 12-15. Omissis.

2.
R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052. Regolamen-to per l’attuazione della L. 2 febbraio 1939,n. 374 (G.U. 6 maggio 1941, n. 107) (Stralcio).
Art. 3. Per le materie contemplate dalla legge edal presente regolamento, sono competenti, nei rap-porti con lo stampatore, gli uffici nella cui giurisdi-zione ha sede l’officina grafica; nei rapporti con l’e-ditore gli uffici nella cui circoscrizione l’editore hail proprio domicilio legale.
Art. 5. Ogni stampatore è obbligato a tenere un re-gistro rilegato, con pagine numerate con inchiostroindelebile, nel quale deve iscrivere, prima della con-segna, cronologicamente e con numero progressivo,in unica serie, gli stampati che escono, anche incom-pleti, dalla sua officina, esclusi i giornali.
Uguale registro deve tenere ciascun editore pertutte le opere di sua edizione.
Tali registri debbono essere conformi ai moduli al-legati al presente regolamento e vidimati dall’auto-rità locale di pubblica sicurezza.
I registri devono essere presentati, ad ogni richiesta,alla Prefettura o all’ufficio da questa delegato e devo-no essere tenuti a disposizione delle autorità interessa-te all’applicazione della legge per i relativi accerta-menti.
Se l’editore pubblica cataloghi, deve indicarvi, perogni pubblicazione: la ditta dello stampatore, la sededell’officina grafica, l’anno di effettiva pubblicazione.Per la ristampa di pubblicazioni già da lui edite a mez-zo di qualsiasi stampatore deve inoltre indicare: il ge-nere della ristampa (se identica o con modificazioni);l’anno della precedente pubblicazione; la ditta e la se-de dell’officina grafica del precedente stampatore.
Art. 6. Agli effetti dell’art. 7 comma primo dellalegge, si considerano di carattere strettamente privatole fotografie che, per l’oggetto riprodotto, appaiono diinteresse circoscritto a singoli individui o famiglie.
Art. 7. I decreti dei Ministeri dell’interno, di graziae giustizia e della presidenza del consiglio, relativi al-la concessione temporanea ai sensi del secondo com-ma dell’art. 7 della legge, di esenzioni od agevolazio-ni nella consegna obbligatoria di esemplari degli stam-pati e delle pubblicazioni ed alla revoca delle conces-sioni medesime, devono essere emanati di ufficio o arichiesta degli interessati con domanda diretta alla pre-sidenza del consiglio, sentito il parere della Commis-sione di cui all’art. 12 della legge stessa.
Art. 8. La dicitura «Esemplare fuori commercioper la distribuzione agli effetti di legge», prescrittadall’art. 5 ultimo comma della legge, deve apporsi,per gli stampati di più pagine, sul frontespizio e suuna delle ultime pagine del testo e deve essere ap-plicata con inchiostro indelebile.
Art. 9. La consegna degli esemplari deve esserefatta in pacchi confezionati con involucro resistentee chiusi con sigillo metallico, recanti all’esterno, ol-tre l’indirizzo, la dicitura «Esemplari d’obbligo» e ilnome dello stampatore o editore.
Art. 10. Quando la consegna concerne esclusiva-mente opuscoli, periodici, riviste, pubblicazioni afascicoli, estratti da qualsiasi pubblicazione, foglivolanti, avvisi, manifesti e simili, è in facoltà dellostampatore o editore di eseguire la consegna stessamediante pieghi raccomandati, osservando la pre-scrizione dell’articolo precedente, salvo per quantoconcerne la chiusura con sigillo metallico.
Art. 11. Lo stampatore o editore ha l’obbligo diaccompagnare la consegna di ciascun pacco o piegocon elenco in due esemplari degli stampati e dellepubblicazioni.
Gli elenchi devono riportare per ciascuna pubbli-cazione i dati iscritti nel registro dello stampatore oeditore di cui all’art. 5 del presente regolamento.
Art. 12. Ai fini del terzo comma dell’art. 1 dellalegge, la consegna fatta a mezzo della posta o dellaferrovia si intende eseguita quando il pacco o il piegoè stato rimesso all’ufficio postale o ferroviario.
Art. 15. L’esemplare degli stampati e delle pub-blicazioni consegnato alla prefettura per la presiden-za del consiglio, ad eccezione dell’esemplare deiquotidiani e dei periodici, è dalla prefettura stessainoltrato immediatamente alla biblioteca nazionalecentrale «Vittorio Emanuele Il» in Roma, per lacompilazione della bibliografia generale. La prefet-tura da avviso al Ministero predetto dell’ avvenutoinoltro mediante elenco descrittivo quindicinale.
Art. 16. I tre esemplari delle cartoline illustrate ri-producenti paesaggi, vedute panoramiche, monu-menti, costumi tipici italiani, di cui all’ultimo com-ma dell’art. 2 della legge, sono assegnati dalle Dire-zioni generali della stampa italiana, della propagan-da e del turismo, per gli usi di diffusione, di propa-ganda e turistici, con assoluta esclusione di qualsia-si diritto, da parte del Ministero, di riproduzione de-gli esemplari stessi.
Art. 17. In caso di mancata, incompleta o comun-que imperfetta consegna degli esemplari dovuti, lapresidenza del consiglio, la prefettura e il provvedi-torato agli studi ne fanno denuncia alla pretura, perl’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8 del-la legge.
La presidenza del consiglio e il provveditorato aglistudi informano della denuncia la prefettura, cheviene del pari informata dalla procura della Repub-blica quando questa promuove di sua iniziativa ilprocedimento penale per le infrazioni di cui al com-ma precedente.
In ogni caso la pretura deve dare notizia alla pre-
© Laurus Robuffo

© Laurus Robuffo
fettura e all’autorità denunciante dell’esito del pro-cedimento, entro quindici giorni.
La prefettura è tenuta a dare notizia alla presidenzadel consiglio delle inadempienze nella consegna diesemplari dovuti, per le quali viene promosso proce-dimento penale, e dell’esito del procedimento.
Art. 18. Nel caso previsto dall’articolo preceden-te, l’autorità cui è dovuta la consegna degli esem-plari, indipendentemente dalla denuncia di cui al-l’articolo medesimo, ingiunge allo stampatore o edi-tore di eseguire o completare o perfezionare la con-segna, prefiggendogli il termine strettamente neces-sario, con diffida della esecuzione di ufficio alloscadere del termine.
Art. 19. L’esecuzione di ufficio della consegna diesemplari degli stampati e delle pubblicazioni è fat-ta a mezzo di ufficiale di pubblica sicurezza ed aspese dello stampatore o editore inadempiente.
Essa può consistere, a seconda dei casi, nell’ac-quisto dal commercio degli esemplari od anche nel-la riproduzione coi mezzi tecnici già predisposti dal-lo stesso obbligato (composizione tipografica, nega-tiva di fotografie e simili).
La nota delle spese relative è resa esecutiva dalprefetto ed è rimessa all’esattore comunale, che nefa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscalistabiliti dalla legge per la riscossione delle impostedirette.
Art. 20. Per assicurare la piena attuazione dellalegge, i soprintendenti bibliografici o loro delegatiprocedono ad ispezioni presso gli stampatori e glieditori, con facoltà di compiere ogni opportuno ac-certamento.
Se nelle ispezioni sono accertate infrazioni, vieneredatto processo verbale, da inviare alla pretura, aglieffetti dell’art. 8 della legge, ed alla prefettura.
I soprintendenti bibliografici devono inviare, allafine di ogni anno, una relazione circa le ispezioni al-la presidenza del consiglio, ai Ministeri dell’interno,di grazia e di giustizia, della P.I. e dell’industria ecommercio.
ALLEGATO.Moduli dei registri degli stampatori e degli editori.(Omissis)..
3.
R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561. Norme sulsequestro dei giornali e delle altre pubblica-zioni.
Art. 1. Non si può procedere al sequestro dellaedizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblica-zione o stampato, contemplati nell’Editto sulla
stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtù di unasentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria.
È tuttavia consentito all’autorità giudiziaria di di-sporre il sequestro di non oltre tre esemplari deigiornali o delle pubblicazioni o stampati, che impor-tino una violazione della legge penale.
Art. 2. In deroga a quanto è stabilito nell’articoloprecedente, si può far luogo al sequestro dei giorna-li o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sen-si della legge penale, sono da ritenere osceni o of-fensivi della pubblica decenza ovvero che divulganomezzi rivolti a impedire la procreazione o a procu-rare l’aborto o illustrano l’impiego di essi o dannoindicazione sul modo di procurarseli o contengonoinserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predet-ti (1).
Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nelcomma precedente, contro il colpevole si deve pro-cedere per giudizio direttissimo anche se non ricor-rono le condizioni prevedute nell’art. 502 del codicedi procedura penale, e la competenza è in ogni casodel tribunale.–––––––––––
(1) Con sentenza 16 marzo 1971, n. 49, la Cortecostituzionale ha sancito l’illegittimità del presentecomma limitatamente alle parole «a impedire laprocreazione».
Art. 3. Nulla è innovato alle disposizioni dell’art.4, commi primo e secondo, del R.D. 15 luglio 1923,o. 3288, convertito nella L. 31 dicembre 1925 n.2309; dell’art. 2, comma secondo, della L. 31 di-cembre 1925, n. 2307; dell’art. 5 del R.D.L. 14 gen-naio 1944, n. 13, in relazione all’art. 1 del D.L.Lt.12 aprile 1946, n. 165; dell’art. 28, comma secondo,della L. 22 febbraio 1934, n. 370.
Nulla è parimenti innovato alle norme dell’art. 8,comma secondo, della L. 2 febbraio 1939, n. 374, edell’art. 19 del relativo regolamento, approvato conR.D. 12 dicembre 1940, n. 2052, nonché alle normesulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tute-la del diritto d’autore dalla L. 22 aprile 1941, n. 633.
Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a ter-mini del comma primo, il pubblico ufficiale che vi haproceduto deve informare, non oltre le ventiquattroore, l’autorità giudiziaria con rapporto scritto.
Art. 4. Con l’entrata in vigore del presente decre-to, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica, cessano di avere efficacia per quanto ri-guarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati ingenerale:
gli articoli 112, comma terzo, e 114, comma quar-to, del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D.18 giugno 1931, n. 773;
l’articolo 200 del regolamento per l’esecuzione delpredetto T.U., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;

l’articolo 3, comma primo, del R.D.L. 10 luglio1924, n. 1081, convertito nella L. 31 dicembre 1925,n. 2308;
ed ogni altra disposizione contraria a quelle delpresente decreto.
4.
L. 8 febbraio 1948, n. 47. Disposizioni sullastampa.
Art. 1. Definizione di stampa o stampato. So-no considerate stampe o stampati, ai fini di questalegge, tutte le riproduzioni tipografiche o comun-que ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici,in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Art. 2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati.Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno dellapubblicazione, nonché il nome e il domicilio dellostampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, lepubblicazioni delle agenzie di informazioni e i pe-riodici di qualsiasi altro genere devono recare la in-dicazione:
del luogo e della data della pubblicazione:del nome e del domicilio dello stampatore;del nome del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile.All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non ob-
bligatorie, che contrassegno gli stampati, deve corri-spondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.
Art. 3. Direttore responsabile. Ogni giornale o al-tro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino ita-liano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizionenelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l’italianonon appartenente alla Repubblica, se possiede gli al-tri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali po-litiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parla-mentare, deve essere nominato un vice direttore, cheassume le qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti ildirettore responsabile, si applicano alla persona cheassume la responsabilità ai sensi del comma prece-dente (1).–––––––––
(1) Il comma 1, dell’art. 9, della L. 6 febbraio1996, n. 52, dispone che: «Agli effetti degli articoli3 e 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardan-ti rispettivamente il direttore responsabile ed il pro-prietario di giornali o altri periodici, i cittadini de-gli Stati membri della Comunità europea sono equi-parati ai cittadini italiani».
Art. 4. Proprietario. Per potere pubblicare ungiornale o altro periodico, il proprietario, se cittadi-
no italiano residente in Italia, deve possedere gli al-tri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali poli-tiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente al-l’estero, deve possedere gli altri requisiti per l’iscri-zione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i re-quisiti indicati nei commi precedenti devono essereposseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti an-che dalla persona che esercita l’impresa giornalisti-ca, se essa è diversa dal proprietario (1).–––––––––
(1) Il comma 1, dell’art. 9, della L. 6 febbraio1996, n. 52, dispone che: «Agli effetti degli articoli3 e 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardan-ti rispettivamente il direttore responsabile ed il pro-prietario di giornali o altri periodici, i cittadini de-gli Stati membri della Comunità europea sono equi-parati ai cittadini italiani».
Art. 5. Registrazione. Nessun giornale o perio-dico può essere pubblicato se non sia stato registra-to presso la cancelleria del tribunale, nella cui circo-scrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositatinella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate delproprietario e del direttore o vicedirettore responsa-bile, dalla quale risultino il nome e il domicilio diessi e della persona che esercita l’impresa giornali-stica, se questa è diversa dal proprietario, nonché iltitolo o la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requi-siti indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento di cui risulti la iscrizione nell’al-bo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiestadalle leggi sull’ordinamento professionale;
4) copia dell’atto di Costituzione o dello statuto, seproprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui dele-gato, verificata la regolarità dei documenti presenta-ti, ordina entro quindici giorni l’iscrizione del gior-nale o periodico in apposito registro tenuto dallacancelleria.
Il registro è pubblico.
Art. 6. Dichiarazione dei mutamenti. Ogni mu-tamento che intervenga in uno degli elementi enun-ciati nella dichiarazione prescritta dall’articolo 5,deve formare oggetto di nuova dichiarazione da de-positarsi, nelle forme ivi previste, entro quindicigiorni dall’avvenuto mutamento insieme con glieventuali documenti.
L’annotazione del mutamento è eseguita nei modiindicati nel terzo comma dell’articolo 5.
L’obbligo previsto nel presente articolo incombesul proprietario o sulla persona che esercita l’impre-sa giornalistica, se diversa dal proprietario.
© Laurus Robuffo

Art. 7. Decadenza della registrazione. L’effica-cia della registrazione cessa qualora, entro sei mesidalla data di essa, il periodico non sia stato pubbli-cato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione unainterruzione di oltre un anno.
Art. 8. Risposte e rettifiche. (1) Il direttore o, co-munque, il responsabile è tenuto a far inserire gratui-tamente nel quotidiano o nel periodico, o nell’agenziadi stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggettidi cui siano state pubblicate immagini od ai quali sia-no stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essiritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità,purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbianocontenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche dicui al comma precedente sono pubblicate non oltredue giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, intesta di pagina e collocate nella stessa pagina delgiornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni e le rettifiche sonopubblicate, non oltre il secondo numero successivo al-la settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stes-sa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferi-mento allo scritto che le ha determinate e devono es-sere pubblicate nella loro interezza, purché contenu-te entro il limite di trenta righe con le medesime ca-ratteristiche tipografiche, per la parte che si riferiscedirettamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e ter-zo comma, la rettifica o dichiarazione non sia statapubblicata o lo sia stata in violazione di quanto dispo-sto dal secondo, terzo e quarto comma, l’autore dellarichiesta di rettifica, se non intende procedere a normadel decimo comma dell’ articolo 21, può chiedere alpretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di proce-dura civile, che sia ordinata la pubblicazione (2).
La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligodi cui al presente articolo è punita con la sanzioneamministrativa da lire 15.000.000 (euro 7.746) a li-re 25.000.000 (euro 12.911) (3).
La sentenza di condanna deve essere pubblicataper estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’a-genzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pub-blicazione omessa sia effettuata (4).–––––––––––
(1) Articolo così sostituito dall’art. 42 della L. 5agosto 1981, n. 416, contenente norme sulla disci-plina delle imprese editrici e provvidenze per l’edi-toria.
(2) L’ufficio del pretore è stato soppresso dall’art.1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 recante: «Normein materia di istituzione del giudice unico di primogrado» e le relative competenze sono ora attribuiteal tribunale.
(3) La fattispecie è stata depenalizzata dall’art.32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(4) Per le ragioni esposte nella precedente nota, ledisposizioni debbono considerarsi non più operanti.
Art. 9. Pubblicazione obbligatoria di sentenze.Nel pronunciare condanna per reato commesso me-diante pubblicazione in un periodico, il giudice or-dina in ogni caso la pubblicazione della sentenza,integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Ildirettore responsabile è tenuto a eseguire gratuita-mente la pubblicazione a norma dell’articolo 615,primo comma del codice di procedura penale (1).–––––––––––
(1) Ora articolo 694 c.p.p.
Art. 10. Giornali murali. Il giornale murale, cheabbia un titolo e una normale periodicità di pubbli-cazione, anche se in parte manoscritto, è regolatodalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale o copia unica, è suffi-ciente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n.374 (1), che sia dato avviso della affissione all’auto-rità di pubblica sicurezza.
L’inosservanza di questa norma è punita ai sensidell’articolo 650 del codice penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fi-scale.–––––––––––
(1) La L. 2 febbraio 1939, n. 374 riguarda normeper la consegna obbligatoria degli stampati e dellepubblicazioni.
Art. 11. Responsabilità civile. Per i reati com-messi col mezzo della stampa sono civilmente re-sponsabili, in solido con gli autori del reato e fra diloro, il proprietario della pubblicazione e l’editore.
Art. 12. Riparazione pecuniaria. Nel caso didiffamazione commessa col mezzo della stampa, lapersona offesa può richiedere, oltre il risarcimentodei danni ai sensi dell’articolo 185 del codice pena-le, una somma a titolo di riparazione. La somma èdeterminata in relazione alla gravità dell’offesa edalla diffusione dello stampato.
Art. 13. Pene per la diffamazione. Nel caso didiffamazione commessa col mezzo della stampa,consistente nell’attribuzione di un fatto determinato,si applica la pena della reclusione da uno a sei annie quella della multa non inferiore a lire cinquecen-tomila (euro 258) (1).–––––––––
(1) La misura della multa è stata così elevata dal-l’art. 113, co. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14. Pubblicazione destinate all’infanzia oall’adolescenza. Le disposizioni dell’articolo 528del codice penale si applicano anche alle pubblica-zioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti,quando, per la sensibilità e impressionabilità ad es-si proprie, siano comunque idonee a offendere illoro sentimento morale od a costituire per essi in-
© Laurus Robuffo

citamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei gior-nali e periodici destinati all’infanzia, nei quali la de-scrizione o l’illustrazione di vicende poliziesche e diavventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamen-te in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di vio-lenza e di indisciplina sociale.
Art. 15. Pubblicazioni a contenuto impressio-nante o raccapricciante. Le disposizioni dell’arti-colo 528 del codice penale si applicano anche nelcaso di stampati i quali descrivano o illustrino, conparticolari impressionanti o raccapriccianti, avveni-menti realmente verificatisi o anche soltanto imma-ginari, in modo da poter turbare il comune senti-mento della morale o l’ordine familiare o da poterprovocare il diffondersi di suicidi o delitti.
Art. 16. Stampa clandestina. Chiunque intra-prende la pubblicazione di un giornale o altro perio-dico senza che sia stata eseguita la registrazione pre-scritta dall’articolo 5, è punito con la reclusione finoa due anni o con la multa fino a lire cinquecentomi-la (euro 258) (1).
La pena si applica a chiunque pubblica uno stam-pato non periodico, dal quale non risulti il nomedell’editore né quello dello stampatore o nel qualequesti siano indicati in modo non conforme al vero.–––––––––––
(1) La misura della multa è stata così elevata dal-l’art. 113, co. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 17. Omissione delle indicazioni obbligatoriesugli stampati. Salvo quanto è disposto dall’articoloprecedente, qualunque altra omissione o inesattezzanelle indicazioni prescritte dall’articolo 2 o la viola-zione dell’ultimo comma dello stesso articolo è puni-ta con l’ammenda sino a lire centomila (euro 51) (1).–––––––––––
(1) La sanzione originaria dell’ammenda è statasostituita da ultimo, con la sanzione amministrativadall’art. 32 L. 689/89.
Art. 18. Violazione degli obblighi stabiliti dal-l’articolo 6. Chi non effettua la dichiarazione dimutamento nel termine indicato nell’articolo 6, ocontinua la pubblicazione di un giornale o altro pe-riodico dopo che sia stata rifiutata l’annotazione delmutamento è punito con l’ammenda fino a lire due-centocinquantamila (euro 129) (1).–––––––––––
(1) La sanzione originaria dell’ammenda è statasostituita da ultimo, con la sanzione amministrativadall’art. 32 L. 689/89.
Art. 19. False dichiarazioni nella registrazionedi periodici. Chi nelle dichiarazioni prescritte dagliarticoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è pu-nito a norma del primo comma dell’articolo 483 delcodice penale.
Art. 20. Asportazione, distruzione, o deteriora-mento di stampati. Chiunque asporta, distrugge odeteriora stampati per i quali siano state osservate leprescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la ven-dita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fattonon costituisce reato più grave, con la reclusione dasei mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenzao minaccia impedisce la stampa, pubblicazione odiffusione dei periodici, per i quali siano state osser-vate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da piùpersone riunite o in luogo pubblico, ovvero pressotipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati apubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Art. 21. Competenza e forme del giudizio. Lacognizione dei reati commessi col mezzo dellastampa appartiene al tribunale, salvo che non siacompetente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimentoal pretore (1).
Al giudizio si procede col rito direttissimo (2).È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la
sentenza nel termine massimo di un mese dalla data dipresentazione della querela o della denuncia (3).
La competenza per i giudizi conseguenti alle viola-zioni delle norme in tema di rettifica, di cui all’artico-lo 8 della presente legge, appartiene al pretore (4).
Al giudizio si procede con il rito direttissimo (5).È fatto obbligo (6):
a) al pretore di depositare in ogni caso la senten-za entro sessanta giorni dalla presentazione della de-nuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenzaentro quarantacinque giorni dalla scadenza del ter-mine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sen-tenza entro sessanta giorni dalla scadenza del ter-mine per la presentazione dei motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattatianche nel periodo feriale previsto dall’articolo 91dell’ordinamento giudiziario approvato con regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell’obbligo previstonel settimo comma costituisce infrazione discipli-nare (7).
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivol-gersi al pretore affinché, in via d’urgenza, anche aisensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedu-ra penale, ordini al direttore la immediata pubblica-zione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o di-chiarazioni (8).–––––––––––
Articolo così modificato dall’art. 2 della L. 5 ago-sto 1981, n. 416, contenente la disciplina delle im-prese editrici e provvidenze per l’editoria.
(1) La Corte Cost. con sentenza 7 luglio 1962, n. 88
© Laurus Robuffo

ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.30, commi 2 e 3, c.p.p. del 1930, che prevedevano larimessione al pretore di procedimenti di competenzadel tribunale. Il comma 2 dell’art. 21 deve dunque ri-tenersi non più operante anche perché con l’istitu-zione del giudice unico è stato soppresso il pretore(art. 1 D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).
(2) La Corte Cost. con sentenza 8 febbraio 1991,n. 68, ha dichiarato la illegittimità costituzionaledell’art. 233 co. 2 disp. coord. c.p.p. che prevedevala possibilità di procedere a giudizio direttissimoper i reati commessi con il mezzo della stampa.
(3) La declaratoria di illegittimità costituzionalericordata nella nota che precede fa ritenere inappli-cabile la disposizione contenuta nel comma 4.
(4) La fattispecie prevista dall’art. 8, co. 6 dellalegge è stata depenalizzata e la disposizione conte-nuta nel comma 5 non è dunque più applicabile.
(5) Anche questa disposizione è superata a segui-to dell’intervenuta depenalizzazione della fattispe-cie prevista dall’art. 8 co. 6 della legge.
(6) Anche le disposizioni contenute in questo com-ma debbono ritenersi non più operanti per le ragio-ni esposte nella nota al comma 5.
(7) Valgono anche qui le considerazioni svolte nel-la nota al comma 5.
(8) Anche questa disposizione deve ritenersi supe-rata dall’avvenuta depenalizzazione del reato origi-nariamente previsto dall’art. 8 comma 6 della legge,poi depenalizzato.
Art. 22. Periodici già autorizzati. Per i giornalie gli altri periodici ai sensi delle leggi precedenti, laregistrazione prescritta dall’articolo 5 deve essereeffettuata nel termine di quattro mesi dall’entrata invigore della presente legge.
Art. 23. Abrogazioni. Sono abrogati il R.D.L. 14gennaio 1944, n. 13 e ogni altra disposizioni contra-ria o incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 24. Norme di attuazione. Il Governo ema-nerà le norme per l’attuazione della presente legge.
Art. 25. Entrata in vigore della legge. La presen-te legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
5.
L. 17 luglio 1975, n. 355. Esclusione dei ri-venditori professionali della stampa perio-dica e dei librai dalla responsabilità deri-vante dagli artt. 528 e 725 del codice penalee dagli artt. 14 e 15 della legge 8 febbraio1948, n. 47.
Articolo unico. Non sono punibili per i reati pre-visti dagli artt. 528 e 725 del codice penale e dagliartt. 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i ti-
tolari e gli addetti a rivendita di giornali e di rivisteper il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre,nell’esercizio normale della loro attività, pubblica-zioni ricevute dagli editori e distributori autorizzatiai sensi delle vigenti disposizioni.
La stessa disposizione si applica ai titolari ed agliaddetti a negozi di vendita di libri e pubblicazioninon periodiche, salvo il caso che essi operino di con-certo con gli editori ovvero con i distributori alfinespecifico di diffondere stampa oscena.
Le disposizioni di esonero di responsabilità di cuiai commi precedenti non si applicano quando sianoesposte, in modo da renderle immediatamente visi-bili al pubblico, parti palesemente oscene dellepubblicazioni o quando dette pubblicazioni sianovendute ai minori di anni sedici. In tale caso la pe-na è della reclusione sino ad un anno.
Nei casi in cui il reato previsto dall’art. 528 del co-dice penale sia commesso da un editore di libri ostampa periodica si applica la pena della reclusioneda uno a tre anni e della multa non inferiore a lire800.000 (euro 413) (1) (2).–––––––––––
(1) La sentenza della Corte costituzionale n. 1063del 24 novembre 1988, dep. 6 dicembre 1988, nel giu-dizio di legittimità promosso dal Pretore di Trieste hadichiarato non fondata la questione di legittimità co-stituzionale dell’art. 528 c.p. e dell’articolo unito L.17 luglio 1975, n. 355 (Esclusione dei rivenditori pro-fessionali della stampa periodica e dei librai dalla re-sponsabilità derivante dagli artt. 528 e 725 c.p. e da-gli artt. 14 e 15 L. 8 febbraio 1948, n. 47).
(2) La misura della multa è stata così elevata dal-l’art. 113 co. 4 L. 24 novembre 1981, n. 689.
6.
L. 6 agosto 1990, n. 223. Disciplina del siste-ma radiotelevisivo pubblico e privato.(Stralcio).
Artt.1-29. Omissis.
TITOLO IV
SANZIONI
Art. 30. Disposizioni penali. 1. Nel caso di tra-smissioni radiofoniche o televisive che abbianocarattere di oscenità il concessionario privato o laconcessionaria pubblica ovvero la persona da lorodelegata al controllo della trasmissione è punitocon le pene previste dal primo comma dell’artico-lo 528 del codice penale.
2. Si applicano alle trasmissioni le disposizionidi cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio1948, n. 47.
© Laurus Robuffo

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 efuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma1 che per colpa omettano di esercitare sul contenutodelle trasmissioni il controllo necessario ad impedi-re la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 so-no puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è com-messo un reato, con la pena stabilita per tale reatodiminuita in misura non eccedente un terzo.
4. Nel caso di reati di diffamazione commessi at-traverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione diun fatto determinato, si applicano ai soggetti di cuial comma 1 le sanzioni previste dall’articolo 13 del-la legge 8 febbraio 1948, n. 47.
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presentearticolo si applicano le disposizioni di cui all’artico-lo 21 della legge 8 febbraio 1948, numero 47. Per ireati di cui al comma 4 il foro competente è deter-minato dal luogo di residenza della persona offesa.
6. Sono puniti con le pene stabilite dall’articolo 5bis (1) del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolaredi concessione di cui all'articolo 16 o di concessio-ne per servizio pubblico ovvero la persona daglistessi delegata che violi le disposizioni di cui agli ar-ticoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell’artico-lo 37 della presente legge. Le stesse pene si applica-no agli amministratori della società titolare di con-cessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessioneper servizio pubblico o che comunque la controlla-no direttamente o indirettamente, che non trasmetta-no al Garante l'elenco dei propri soci.
7. Omissis.–––––––––––
(1) L’art. 5 bis D.L. 8 aprile 1974, n.95 è statoabrogato dall’art. 214 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 con le modalità, i limiti e la decorrenza previstidal medesimo art. 214.
7.
L. 30 marzo 2001, n. 125. Legge-quadro inmateria di alcol e di problemi alcolcorrelati.(In G.U. 18 aprile 2001, n. 90). (Stralcio).
Artt.1-12. Omissis.
Art. 13. Disposizioni in materia di pubblicità.1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, le emittenti radiotelevisivepubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, uni-tariamente ai rappresentanti della produzione, te-nuto conto anche dell’esigenza di valorizzare leproduzioni tipiche ed a denominazione di originecontrollata, adottano un codice di autoregolamen-tazione sulle modalità e sui contenuti dei messag-gi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e su-peralcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche esuperalcoliche che:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivol-ti ai minori e nei quindici minuti precedenti e suc-cessivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeuti-che che non siano espressamente riconosciute dalMinistero della Sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di al-col ovvero rappresenti in modo positivo l’assun-zione di bevande alcoliche e superalcoliche;
3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta dellebevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi fre-quentati prevalentemente dai minori di 18 anni dietà.
4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di be-vande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubbli-cità di bevande superalcoliche:
a) sulla stampa giornalieria e periodica desti-nata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasionedella proiezione di film destinati prevalentementealla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai com-mi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrati-va consistente nel pagamento di una somma da li-re 5 milioni (euro 2.582) a lire 20 milioni(10.329). La sanzione è raddoppiata per ogni ulte-riore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica al-tresì alle industrie produttrici ed ai responsabilidelle emittenti radiotelevisive e degli organi distampa nonché ai proprietari delle sale cinemato-grafiche.
Artt.14-16. Omissis.
8.
D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Testo unicodella radiotelevisione (S.O. alla G.U. 7 set-tembre 2005, n. 208). (Stralcio).
TITOLO I
PRINCIPI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Oggetto. 1. Il testo unico della radiotele-visione, di seguito denominato: “testo unico”, con-tiene:
a) i principi generali che informano l’assetto delsistema radiotelevisivo nazionale, regionale e loca-
© Laurus Robuffo

le, e lo adeguano all’introduzione della tecnologiadigitale ed al processo di convergenza tra la radiote-levisione ed altri settori delle comunicazioni inter-personali e di massa, quali le comunicazioni elettro-niche, l’editoria, anche elettronica ed Internet in tut-te le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materiaradiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni eabrogazioni necessarie al loro coordinamento o perassicurarne la migliore attuazione, nel rispetto dellaCostituzione, delle norme di diritto internazionalevigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi de-rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione euro-pea ed alle Comunità europee.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizio-ni in materia di trasmissione di programmi televisi-vi, di programmi radiofonici e di programmi-dati,anche ad accesso condizionato, nonché la fornituradi servizi interattivi associati e di servizi di accessocondizionato su frequenze terrestri, via cavo e viasatellite.
Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente testounico si intende per:
a) “programmi televisivi” e “programmi radiofo-nici” l’insieme, predisposto da un fornitore, dei con-tenuti unificati da un medesimo marchio editoriale edestinati alla fruizione del pubblico, rispettivamen-te, mediante la trasmissione televisiva o radiofonicacon ogni mezzo; l’espressione "programmi", ripor-tata senza specificazioni, si intende riferita a pro-grammi sia televisivi che radiofonici. Non si consi-derano programmi televisivi le trasmissioni mera-mente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
b) “programmi-dati” i servizi di informazionecostituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessida reti radiotelevisive e diversi dai programmi ra-diotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,incluse le pagine informative teletext e le pagine didati;
c) “operatore di rete” il soggetto titolare del di-ritto di installazione, esercizio e fornitura di una re-te di comunicazione elettronica su frequenze terre-stri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e diimpianti di messa in onda, multiplazione, distribu-zione e diffusione delle risorse frequenziali che con-sentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) “fornitore di contenuti” il soggetto che ha laresponsabilità editoriale nella predisposizione deiprogrammi televisivi o radiofonici e dei relativi pro-grammi-dati destinati alla diffusione anche ad ac-cesso condizionato su frequenze terrestri in tecnicadigitale, via cavo o via satellite o con ogni altromezzo di comunicazione elettronica e che è legitti-mato a svolgere le attività commerciali ed editorialiconnesse alla diffusione delle immagini o dei suonie dei relativi dati;
e) “fornitore di contenuti a carattere comunita-rio” il soggetto che ha la responsabilità editoriale
nella predisposizione dei programmi destinati allaradiodiffusione televisiva in ambito locale che si im-pegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pub-blicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere pro-grammi originali autoprodotti per almeno il 50 percento dell’orario di programmazione giornalierocompreso dalle 7 alle 21;
f) “programmi originali autoprodotti” i program-mi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti odalla sua controllante o da sue controllate, ovvero inco-produzione con altro fornitore di contenuti;
g) “produttori indipendenti” gli operatori di co-municazione europei che svolgono attività di produ-zioni audiovisive e che non sono controllati da ocollegati a soggetti destinatari di concessione, di li-cenza o di autorizzazione per la diffusione radiotele-visiva o che per un periodo di tre anni non destininoalmeno il 90 per cento della propria produzione aduna sola emittente;
h) “fornitore di servizi interattivi associati o diservizi di accesso condizionato” il soggetto chefornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi alpubblico di accesso condizionato, compresa la payper view, mediante distribuzione agli utenti dichiavi numeriche per l’abilitazione alla visione deiprogrammi, alla fatturazione dei servizi ed even-tualmente alla fornitura di apparati, ovvero che for-nisce servizi della società dell’informazione ai sen-si dall’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronicaai programmi;
i) “accesso condizionato” ogni misura e sistematecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligi-bile al servizio protetto sia subordinato a preventivae individuale autorizzazione da parte del fornitoredel servizio di accesso condizionato;
l) “sistema integrato delle comunicazioni” il set-tore economico che comprende le seguenti attività:stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristicaed elettronica anche per il tramite di Internet; radioe televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziativedi comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizza-zioni;
m) “servizio pubblico generale radiotelevisivo”il pubblico servizio esercitato su concessione nelsettore radiotelevisivo mediante la complessiva pro-grammazione, anche non informativa, della societàconcessionaria, secondo le modalità e nei limiti in-dicati dal presente testo unico e dalle altre norme diriferimento;
n) “ambito nazionale” l’esercizio dell’attività diradiodiffusione televisiva o sonora non limitata al-l’ambito locale;
o) “ambito locale radiofonico” l’esercizio del-l’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazionedel segnale fino a una copertura massima di quindi-ci milioni di abitanti;
© Laurus Robuffo

p) “ambito locale televisivo” l’esercizio dell’at-tività di radiodiffusione televisiva in uno o più ba-cini, comunque non superiori a sei, anche non li-mitrofi, purché con copertura inferiore al 50 percento della popolazione nazionale; l’ambito è de-nominato "regionale" o "provinciale" quando il ba-cino di esercizio dell’attività di radiodiffusione te-levisiva è unico e ricade nel territorio di una solaregione o di una sola provincia, e l’emittente nontrasmette in altri bacini; l’espressione "ambito lo-cale televisivo" riportata senza specificazioni si in-tende riferita anche alle trasmissioni in ambito re-gionale o provinciale;
q) “emittente televisiva” il titolare di concessio-ne o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnicaanalogica, che ha la responsabilità editoriale dei pa-linsesti dei programmi televisivi e li trasmette se-condo le seguenti tipologie:
1) “emittente televisiva a carattere informati-vo”l’emittente per la radiodiffusione televisiva sufrequenze terrestri in ambito locale, che trasmettequotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e leore 23 per non meno di due ore, programmi infor-mativi, di cui almeno il cinquanta per cento auto-prodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economi-ci, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, peralmeno la metà del tempo, devono riguardare temi eargomenti di interesse locale e devono comprenderetelegiornali diffusi per non meno di cinque giorni al-la settimana o, in alternativa, per centoventi giorni asemestre;
2) “emittente televisiva a carattere commerciale”l’emittente per la radiodiffusione televisiva su fre-quenze terrestri in ambito locale, senza specifici ob-blighi di informazione;
3) “emittente televisiva a carattere comunitario”l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambi-to locale costituita da associazione riconosciuta onon riconosciuta, fondazione o cooperativa priva discopo di lucro, che trasmette programmi originaliautoprodotti a carattere culturale, etnico, politico ereligioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; atrasmettere i predetti programmi per almeno il 50per cento dell’orario di trasmissione giornalierocompreso tra le ore 7 e le ore 21;
4) “emittente televisiva monotematica a caratte-re sociale” l’emittente per la radiodiffusione televi-siva in ambito locale che dedica almeno il 70 percento della programmazione monotematica quoti-diana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sa-nità e servizi sociali, classificabile come vera e pro-pria emittente di servizio;
5) “emittente televisiva commerciale nazionale”l’emittente che trasmette in chiaro prevalentementeprogrammi di tipo generalista con obbligo d’infor-mazione;
6) “emittente di televendite” l’emittente che tra-smette prevalentemente offerte dirette al pubblicoallo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o ser-vizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbliga-zioni;
r) “emittente radiofonica” il titolare di conces-sione o autorizzazione su frequenze terrestri in tec-nica analogica, che ha la responsabilità dei palinse-sti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti ti-pologie:
1) “emittente radiofonica a carattere comunita-rio”, nazionale o locale, l’emittente caratterizzatadall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette pro-grammi originali autoprodotti per almeno il 30 percento dell’orario di trasmissione giornaliero com-preso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi disponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 percento di pubblicità per ogni ora di diffusione; nonsono considerati programmi originali autoprodotti letrasmissioni di brani musicali intervallate da mes-saggi pubblicitari o da brevi commenti del condut-tore della stessa trasmissione;
2) “emittente radiofonica a carattere commer-ciale locale” l’emittente senza specifici obblighi dipalinsesto, che comunque destina almeno il 20 percento della programmazione settimanale all’infor-mazione, di cui almeno il 50 per cento all’informa-zione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale li-mite si calcola su non meno di sessantaquattro oresettimanali;
3) “emittente radiofonica nazionale” l’emittentesenza particolari obblighi, salvo la trasmissionequotidiana di giornali radio;
s) “opere europee” le opere originarie:1) di Stati membri dell’Unione europea;2) di Stati terzi europei che siano parti della
Convenzione europea sulla televisione transfronta-liera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratifi-cata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché leopere siano realizzate da uno o più produttori stabi-liti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la su-pervisione e il controllo effettivo di uno o più pro-duttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il con-tributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalentenel costo totale della co-produzione e questa non siacontrollata da uno o più produttori stabiliti al di fuo-ri di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in viaesclusiva, o in co-produzione con produttori stabili-ti in uno o più Stati membri dell’Unione europea, daproduttori stabiliti in uno o più Stati terzi europeicon i quali la Comunità europea abbia concluso ac-cordi nel settore dell’audiovisivo, qualora questeopere siano realizzate principalmente con il contri-buto di autori o lavoratori residenti in uno o più Sta-ti europei;
t) “sponsorizzazione” ogni contributo di un’im-presa pubblica o privata, non impegnata in attività
© Laurus Robuffo

televisive o radiofoniche o di produzione di opereaudiovisive o radiofoniche, al finanziamento diprogrammi, allo scopo di promuovere il suo nome,il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o isuoi prodotti, purché non facciano riferimenti spe-cifici di carattere promozionale a tali attività o pro-dotti;
u) “pubblicità” ogni forma di messaggio televisi-vo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro al-tro compenso da un’impresa pubblica o privata nel-l’ambito di un’attività commerciale, industriale, ar-tigianale o di una libera professione, allo scopo dipromuovere la fornitura, dietro compenso, di beni oservizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbli-gazioni;
v) “spot pubblicitari” ogni forma di pubblicità dicontenuto predeterminato, trasmessa dalle emittentiradiofoniche e televisive;
z) “televendita” ogni offerta diretta trasmessa alpubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofoni-co allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni oservizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbli-gazioni;
aa) “telepromozione” ogni forma di pubblicitàconsistente nell’esibizione di prodotti, presentazio-ne verbale e visiva di beni o servizi di un produtto-re di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’e-mittente televisiva o radiofonica nell’ambito di unprogramma, al fine di promuovere la fornitura, die-tro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esi-biti;
bb) “autopromozione” gli annunci dell’emittenterelativi ai propri programmi e ai prodotti collateralida questi direttamente derivati;
cc) “Autorita” l’Autorità per le garanzie nelle co-municazioni;
dd) “Ministero” il Ministero delle comunicazioni.
Art. 3. Principi fondamentali. 1. Sono principifondamentali del sistema radiotelevisivo la garan-zia della libertà e del pluralismo dei mezzi di co-municazione radiotelevisiva, la tutela della libertàdi espressione di ogni individuo, inclusa la libertàdi opinione e quella di ricevere o di comunicareinformazioni o idee senza limiti di frontiere, l’o-biettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialitàdell’informazione, l’apertura alle diverse opinionie tendenze politiche, sociali, culturali e religiose ela salvaguardia delle diversità etniche e del patri-monio culturale, artistico e ambientale, a livellonazionale e locale, nel rispetto delle libertà e deidiritti, in particolare della dignità della persona,della promozione e tutela del benessere, della sa-lute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico emorale del minore, garantiti dalla Costituzione,dal diritto comunitario, dalle norme internazionalivigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi sta-tali e regionali.
TITOLO II
SOGGETTI
CAPO I
FUNZIONI DEL MINISTERO
Art. 9. Ministero delle comunicazioni. 1. Il Mi-nistero esercita le competenze stabilite nel presentetesto unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni enei compiti di spettanza statale indicati dall’articolo32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,come da ultimo sostituito dall’articolo 2 del decretolegislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comu-nicazioni per il settore radiotelevisivo:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;b) la Commissione per l’assetto del sistema tele-
visivo, di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. Presso il Ministero operano, nel settore radiote-levisivo, il Comitato di controllo in materia di tele-vendite e spot di televendita di beni e servizi diastrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizirelativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto,enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip,lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di ap-plicazione del Codice di autoregolamentazione TV eminori.
CAPO II
FUNZIONI DELL’AUTORITÀ
Art. 10. Competenze in materia radiotelevisivadell’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-ni. 1. L’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essaaffidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fon-damentali della persona nel settore delle comunica-zioni, anche radiotelevisive.
2. L’Autorità, in materia di radiotelevisione, eser-cita le competenze richiamate dalle norme del pre-sente testo unico, nonché quelle rientranti nellefunzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigen-ti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in par-ticolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio1997, n. 249.
CAPO III
ALTRE COMPETENZE
Art. 11. Altre competenze. 1. Restano ferme lecompetenze in materia radiotelevisiva attribuite dal-le vigenti norme alla Presidenza del Consiglio deiMinistri, alla Commissione parlamentare per l’indi-
© Laurus Robuffo

rizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi-vi, al Garante per la protezione dei dati personali eall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
CAPO IV
REGIONI
Art. 12. Competenze delle regioni. 1. Le regioniesercitano la potestà legislativa concorrente in mate-ria di emittenza radiotelevisiva in ambito regionaleo provinciale, nel rispetto dei principi fondamentalicontenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulte-riori principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di programmiper la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale inambito regionale o provinciale avvenga nelle bandedi frequenza previste per detti servizi dal vigente re-golamento delle radiocomunicazioni dell’Unione in-ternazionale delle telecomunicazioni, nel rispettodegli accordi internazionali, della normativa dell’U-nione europea e di quella nazionale, nonché dei pia-ni nazionali di ripartizione e di assegnazione delleradiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli en-ti locali delle competenze in ordine al rilascio deiprovvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessorinecessari per l’accesso ai siti previsti dal piano na-zionale di assegnazione delle frequenze, in base allevigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’in-stallazione di reti e di impianti, nel rispetto dei prin-cipi di non discriminazione, proporzionalità e obiet-tività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigentiin materia di tutela della salute, di tutela del territo-rio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezzenaturali;
c) attribuzione a organi della regione o della pro-vincia delle competenze in ordine al rilascio delleautorizzazioni per fornitore di contenuti o per forni-tore di servizi interattivi associati o di servizi di ac-cesso condizionato destinati alla diffusione in ambi-to, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi dicui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi,tenendo conto della potenzialità economica del sog-getto richiedente, della qualità della programmazio-ne prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici,della pregressa presenza sul mercato, delle ore ditrasmissione effettuate, della qualità dei programmi,delle quote percentuali di spettacoli e di serviziinformativi autoprodotti, del personale dipendente,con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all’Al-bo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; iltitolare della licenza di operatore di rete televisiva intecnica digitale in ambito locale, qualora abbia ri-chiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimentodell’attività di fornitura di cui alla lettera b), ha di-ritto a ottenere almeno un’autorizzazione che con-
senta di irradiare nel blocco di programmi televisivinumerici di cui alla licenza rilasciata.
Art. 13. Funzionamento dei Comitati regionaliper le comunicazioni (Corecom). 1. Le funzioni dicui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 sono svolte an-che attraverso i Comitati regionali per le comunica-zioni (Corecom), organi funzionali dell’Autorità, aisensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 lu-glio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzionii Comitati regionali per le comunicazioni si avval-gono degli ispettorati territoriali del Ministero.
Art. 14. Disposizioni particolari per la regioneautonoma Valle d’Aosta e per le province auto-nome di Trento e di Bolzano. 1. Fermo restando ilrispetto dei principi fondamentali previsti dal pre-sente testo unico, la regione autonoma Valle d’Aostae le province autonome di Trento e di Bolzano prov-vedono alle finalità di cui al medesimo testo uniconell’ambito delle specifiche competenze ad essespettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle rela-tive norme di attuazione, anche con riferimento alledisposizioni del titolo V della parte seconda dellaCostituzione, per le parti in cui prevedono forme diautonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
TITOLO IV
NORME A TUTELA DELL’UTENTE
CAPO I
DIRITTO DI RETTIFICA
Art. 32. Telegiornali e giornali radio. Rettifica.1.Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le nor-me sulla registrazione dei giornali e periodici, con-tenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttoridei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fi-ne, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi mo-rali o materiali da trasmissioni contrarie a verità hadiritto di chiedere all’emittente, al fornitore di con-tenuti privato o alla concessionaria del servizio pub-blico generale radiotelevisivo ovvero alle personeda loro delegate al controllo della trasmissione chesia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultimanon abbia contenuto che possa dar luogo a respon-sabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto oredalla data di ricezione della relativa richiesta, in fa-scia oraria e con il rilievo corrispondenti a quellidella trasmissione che ha dato origine alla lesionedegli interessi. Trascorso detto termine senza che larettifica sia stata effettuata, l’interessato può tra-smettere la richiesta all’Autorità, che provvede aisensi del comma 4.
© Laurus Robuffo

4. Fatta salva la competenza dell’autorità giudi-ziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel ca-so in cui l’emittente, il fornitore di contenuti o laconcessionaria del servizio pubblico generale radio-televisivo ritengano che non ricorrono le condizioniper la trasmissione della rettifica, sottopongono en-tro il giorno successivo alla richiesta la questione al-l’Autorità, che si pronuncia nel termine di cinquegiorni. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta direttifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazionedella pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere tra-smessa entro le ventiquattro ore successive alla pro-nuncia medesima.
Art. 33. Comunicati di organi pubblici. 1. Il Go-verno, le amministrazioni dello Stato, le regioni e glienti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed ec-cezionali esigenze di pubblica necessità, nell’ambi-to interessato da dette esigenze, possono chiedere al-le emittenti, ai fornitori di contenuti o alla conces-sionaria del servizio pubblico generale radiotelevisi-vo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Det-ti comunicati devono essere trasmessi immediata-mente.
2. La società concessionaria del servizio pubblicogenerale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i co-municati e le dichiarazioni ufficiali del Presidentedella Repubblica, dei Presidenti del Senato della Re-pubblica e della Camera dei deputati, del Presidentedel Consiglio dei Ministri e del Presidente dellaCorte Costituzionale, su richiesta degli organi me-desimi, facendo precedere e seguire alle trasmissio-ni l’esplicita menzione della provenienza dei comu-nicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la ri-chiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri haeffetto immediato. In questo caso egli è tenuto adarne contemporanea comunicazione alla Commis-sione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-lanza dei servizi radiotelevisivi.
CAPO II
TUTELA DEI MINORI NELLAPROGRAMMAZIONE TELEVISIVA
Art. 34. Disposizioni a tutela dei minori. 1. Fer-mo il rispetto delle norme comunitarie a tutela deiminori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, com-ma 1, lettere b) e c), è vietata la trasmissione di filmai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezio-ne o la rappresentazione in pubblico oppure sianostati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici nonpossono essere trasmessi, nè integralmente, nè par-zialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenu-ti, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1,lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a
tutela dei minori previste dal Codice di autoregola-mentazione TV e minori approvato il 29 novembre2002, e successive modificazioni. Le eventuali mo-dificazioni del Codice o l’adozione di nuovi atti diautoregolamentazione sono recepiti con decreto delMinistro delle comunicazioni, adottato ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, previo parere della Commissione parlamen-tare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenutia garantire, anche secondo quanto stabilito nel Co-dice di cui al medesimo comma 3, l’applicazione dispecifiche misure a tutela dei minori nella fasciaoraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 eall’interno dei programmi direttamente rivolti ai mi-nori, con particolare riguardo ai messaggi pubblici-tari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comu-nicazione commerciale e pubblicitaria. Specifichemisure devono essere osservate nelle trasmissioni dicommento degli avvenimenti sportivi, in particolarecalcistici, anche al fine di contribuire alla diffusionetra i giovani dei valori di una competizione sportivaleale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fe-nomeni di violenza legati allo svolgimento di mani-festazioni sportive.
5. L’impiego di minori di anni quattordici in pro-grammi radiotelevisivi, oltre che essere vietato permessaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con re-golamento del Ministro delle comunicazioni, di con-certo con il Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali e con il Ministro per le pari opportunità.
6. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con ilMinistro dell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, dispone la realizzazione di campagne scola-stiche per un uso corretto e consapevole del mezzotelevisivo, nonché di trasmissioni con le stesse fina-lità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anchela diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi inorari di buon ascolto, con particolare riferimento al-le trasmissioni effettuate dalla concessionaria delservizio pubblico radiotelevisivo.
7. Le quote di riserva per la trasmissione di opereeuropee, previste dall’articolo 6 devono comprende-re anche opere cinematografiche o per la televisio-ne, comprese quelle di animazione, specificamenterivolte ai minori, nonché produzioni e programmiadatti ai minori ovvero idonei alla visione da partedei minori e degli adulti. Il tempo minimo di tra-smissione riservato a tali opere e programmi è de-terminato dall’Autorità.
Art. 35. Vigilanza e sanzioni. 1. Alla verifica del-l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 34provvede la Commissione per i servizi ed i prodottidell’Autorità, in collaborazione con il Comitato diapplicazione del Codice di autoregolamentazioneTV e minori, anche sulla base delle segnalazioni ef-fettuate dal medesimo Comitato. All’attività del Co-mitato il Ministero fornisce supporto organizzativo
© Laurus Robuffo

e logistico mediante le proprie risorse strumentali edi personale, senza ulteriori oneri a carico del bilan-cio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui al-l’articolo 34, nonché all’articolo 4, comma 1, lette-re b) e c), limitatamente alla violazione di norme inmateria di tutela dei minori, la Commissione per iservizi e i prodotti dell’Autorità, previa contesta-zione della violazione agli interessati ed assegna-zione di un termine non superiore a quindici giorniper le giustificazioni, delibera l’irrogazione dellasanzione amministrativa del pagamento di unasomma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casipiù gravi, la sospensione dell’efficacia della con-cessione o dell’autorizzazione per un periodo dauno a dieci giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al com-ma 1 dell’articolo 34 si applicano le sanzioni previ-ste dall’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n.161, intendendosi per chiusura del locale la disatti-vazione dell’impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costi-tuisce reato e indipendentemente dall’azione penale.Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per quel-le previste dal Codice di autoregolamentazione TV eminori, dal Comitato di applicazione del medesimoCodice viene data adeguata pubblicità anche me-diante comunicazione da parte dell’emittente san-zionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o dibuon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II delCapo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’Autorità presenta al Parlamento, entro il 31marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei di-ritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sullesanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità invia al-la Commissione parlamentare per l’infanzia di cuialla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazioneinformativa sullo svolgimento delle attività di suacompetenza in materia di tutela dei diritti dei mino-ri, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimen-ti o osservazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ
Art. 37. Interruzioni pubblicitarie. 1. Fermi re-stando i principi di cui all’articolo 4, comma 1, let-tere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla di-rettiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre1989, e successive modificazioni, gli spot pubblici-tari e di televendita isolati devono costituire ecce-zioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo delcomma 3 dell’articolo 26, la pubblicità e gli spot ditelevendita devono essere inseriti tra i programmi.Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono es-sere inseriti anche nel corso di un programma in
modo tale che non ne siano pregiudicati l’integritàed il valore, tenuto conto degli intervalli naturalidello stesso nonché della sua durata e natura, nonchéi diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome onei programmi sportivi, nelle cronache e negli spet-tacoli di analoga struttura comprendenti degli inter-valli, la pubblicità e gli spot di televendita possonoessere inseriti soltanto tra le parti autonome o negliintervalli.
3. L’inserimento di messaggi pubblicitari durantela trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali èconsentito negli intervalli abitualmente effettuatinelle sale teatrali. Per le opere di durata superiore aquarantacinque minuti è consentita una interruzioneper ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore in-terruzione se la durata programmata dell’opera su-pera di almeno venti minuti due o più atti o tempi diquarantacinque minuti ciascuno.
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi com-presi i lungometraggi cinematografici ed i film pro-dotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, iromanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i docu-mentari, di durata programmata superiore a quaran-tacinque minuti, può essere interrotta soltanto unavolta per ogni periodo di quarantacinque minuti. Èautorizzata un’altra interruzione se la durata pro-grammata delle predette opere supera di almenoventi minuti due o più periodi completi di quaranta-cinque minuti.
5. Quando programmi diversi da quelli di cui alcomma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot ditelevendita, in genere devono trascorrere almenoventi minuti tra ogni successiva interruzione all’in-terno del programma.
6. La pubblicità e la televendita non possono es-sere inserite durante la trasmissione di funzioni reli-giose. I notiziari e le rubriche di attualità, i docu-mentari, i programmi religiosi e quelli per bambini,di durata programmata inferiore a trenta minuti, nonpossono essere interrotti dalla pubblicità o televen-dita. Se la loro durata programmata è di almenotrenta minuti, si applicano le disposizioni di cui alpresente articolo.
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cuitrasmissioni siano destinate unicamente al territorionazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuatein interconnessione, in deroga alle disposizioni dicui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modifi-cazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante latrasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liri-che e musicali, sono consentite, oltre a quelle inseri-te nelle pause naturali delle opere medesime, due in-terruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indi-pendentemente dalla durata delle opere stesse; per leopere di durata programmata compresa tra novantae centonove minuti sono consentite analogamentedue interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo;
© Laurus Robuffo

per le opere di durata programmata uguale o supe-riore a centodieci minuti sono consentite tre interru-zioni pubblicitarie più una interruzione supplemen-tare ogni quarantacinque minuti di durata program-mata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai finidel presente articolo per durata programmata si in-tende il tempo di trasmissione compreso tra l’iniziodella sigla di apertura e la fine della sigla di chiusu-ra del programma al lordo della pubblicità inserita,come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. L’Autorità, sentita un’apposita commissione,composta da non oltre cinque membri e nominatadall’Autorità medesima tra personalità di ricono-sciuta competenza, determina le opere di valore ar-tistico, nonché le trasmissioni a carattere educativoe religioso che non possono subire interruzioni pub-blicitarie.
9. È vietata la pubblicità radiofonica e televisivadei medicinali e delle cure mediche disponibili uni-camente con ricetta medica. La pubblicità radiofoni-ca e televisiva di strutture sanitarie è regolata dallaapposita disciplina in materia di pubblicità sanitariadi cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come mo-dificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dallalegge 14 ottobre 1999, n. 362, nonché dall’articolo7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, esuccessive modificazioni.
10. La pubblicità televisiva delle bevande alcoli-che e la televendita devono conformarsi ai seguenticriteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, nè, inparticolare, presentare minori intenti a consumaretali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con pre-stazioni fisiche di particolare rilievo o con la guidadi automobili;
c) non creare l’impressione che il consumo di al-colici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcolichepossiedano qualità terapeutiche stimolanti o calman-ti o che contribuiscano a risolvere situazioni di con-flitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrol-lato di bevande alcoliche o presentare in una lucenegativa l’astinenza o la sobrietà;
f) non usare l’indicazione del rilevante grado al-colico come qualità positiva delle bevande.
11. È vietata la pubblicità televisiva delle sigaret-te o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La pub-blicità è vietata anche se effettuata in forma indiret-ta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli odi altri elementi caratteristici di prodotti del tabaccoo di aziende la cui attività principale consiste nellaproduzione o nella vendita di tali prodotti, quandoper forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in ba-se a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizza-zione sia idonea a perseguire una finalità pubblicita-ria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale
sia l’attività principale dell’azienda deve farsi riferi-mento all’incidenza del fatturato delle singole atti-vità di modo che quella principale sia comunqueprevalente rispetto a ciascuna delle altre attività diimpresa nell’ambito del territorio nazionale.
12. La trasmissione di dati e di informazioni al-l’utenza di cui all’articolo 26, comma 3, può com-prendere anche la diffusione di inserzioni pubblici-tarie.
Art. 40. Disposizioni sulle televendite. 1. È vie-tata la televendita che vilipenda la dignità umana,comporti discriminazioni di razza, sesso o naziona-lità, offenda convinzioni religiose e politiche, indu-ca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o lasicurezza o la protezione dell’ambiente. È vietata latelevendita di sigarette o di altri prodotti a base di ta-bacco.
2. La televendita non deve esortare i minori a sti-pulare contratti di compravendita o di locazione diprodotti e di servizi. La televendita non deve arreca-re pregiudizio morale o fisico ai minori e deve ri-spettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acqui-stare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’ine-sperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minori a persuade-re genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servi-zi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i mino-ri ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situa-zioni pericolose.
TITOLO VI
NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZAE DEL MERCATO
Art. 43. Posizioni dominanti nel sistema inte-grato delle comunicazioni. 1. I soggetti che opera-no nel sistema integrato delle comunicazioni sonotenuti a notificare all’Autorità le intese e le opera-zioni di concentrazione, al fine di consentire, secon-do le procedure previste in apposito regolamentoadottato dall’Autorità medesima, la verifica del ri-spetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10,11 e 12.
2. L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia inte-resse o, periodicamente, d’ufficio, individuato ilmercato rilevante conformemente ai principi di cuiagli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002, verifica che non si costituiscano, nel sistemaintegrato delle comunicazioni e nei mercati che locompongono, posizioni dominanti e che siano ri-spettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12,tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del li-
© Laurus Robuffo

vello di concorrenza all’interno del sistema, dellebarriere all’ingresso nello stesso, delle dimensionidi efficienza economica dell’impresa nonché degliindici quantitativi di diffusione dei programmi ra-diotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere ci-nematografiche o fonografiche.
3. L’Autorità, qualora accerti che un’impresa o ungruppo di imprese operanti nel sistema integratodelle comunicazioni si trovi nella condizione di po-tere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai com-mi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico ri-chiamo, segnalando la situazione di rischio e indi-cando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolomercato interessato. In caso di accertata violazionedei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi delcomma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazio-ne e le intese che contrastano con i divieti di cui alpresente articolo sono nulli.
5. L’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratte-ristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cuial comma 4, adotta i provvedimenti necessari pereliminare o impedire il formarsi delle posizioni dicui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesi-ve del pluralismo. Qualora ne riscontri l’esistenza,apre un’istruttoria nel rispetto del principio del con-traddittorio, al termine della quale interviene affin-ché esse vengano sollecitamente rimosse; qualoraaccerti il compimento di atti o di operazioni idoneea determinare una situazione vietata ai sensi deicommi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecu-zione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l’Au-torità ritenga di dover disporre misure che incidanosulla struttura dell’impresa, imponendo dismissionidi aziende o di rami di azienda, è tenuta a determi-nare nel provvedimento stesso un congruo termineentro il quale provvedere alla dismissione; tale ter-mine non può essere comunque superiore a dodicimesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti diconcentrazione di cui al presente articolo si applica-no in sede di rilascio ovvero di proroga delle con-cessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.
6. L’Autorità, con proprio regolamento adottatonel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparen-za di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e succes-sive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cuial comma 5, i relativi procedimenti e le modalità dicomunicazione. In particolare debbono essere assi-curati la notifica dell’apertura dell’istruttoria ai sog-getti interessati, la possibilità di questi di presentareproprie deduzioni in ogni stadio dell’istruttoria, ilpotere dell’Autorità di richiedere ai soggetti interes-sati e a terzi che ne siano in possesso di fornireinformazioni e di esibire documenti utili all’istrutto-ria stessa. L’Autorità è tenuta a rispettare gli obbli-ghi di riservatezza inerenti alla tutela delle personeo delle imprese su notizie, informazioni e dati inconformità alla normativa in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento didati personali.
7. All’atto della completa attuazione del piano na-zionale di assegnazione delle frequenze radiofoni-che e televisive in tecnica digitale, uno stesso forni-tore di contenuti, anche attraverso società qualifica-bili come controllate o collegate ai sensi dei commi13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazio-ni che consentano di diffondere più del 20 per centodel totale dei programmi televisivi o più del 20 percento dei programmi radiofonici irradiabili su fre-quenze terrestri in ambito nazionale mediante le re-ti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazio-nale di assegnazione delle frequenze televisive intecnica digitale, il limite al numero complessivo diprogrammi per ogni soggetto è del 20 per cento ed ècalcolato sul numero complessivo dei programmi te-levisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’arti-colo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, inambito nazionale su frequenze terrestri indifferente-mente in tecnica analogica o in tecnica digitale. Iprogrammi televisivi irradiati in tecnica digitalepossono concorrere a formare la base di calcolo overaggiungano una copertura pari al 50 per cento del-la popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20per cento non sono computati i programmi che co-stituiscono la replica simultanea di programmi irra-diati in tecnica analogica. Il presente criterio di cal-colo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono intecnica digitale programmi che raggiungono una co-pertura pari al 50 per cento della popolazione nazio-nale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di po-sizioni dominanti nei singoli mercati che compon-gono il sistema integrato delle comunicazioni, i sog-getti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatoridi comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1,comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio1997, n. 249, non possono né direttamente, né attra-verso soggetti controllati o collegati ai sensi deicommi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 percento dei ricavi complessivi del sistema integratodelle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivan-ti dal finanziamento del servizio pubblico radiotele-visivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicitànazionale e locale anche in forma diretta, da tele-vendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusio-ne del prodotto realizzata al punto vendita conesclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni consoggetti pubblici a carattere continuativo e da prov-videnze pubbliche erogate direttamente ai soggettiesercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1,lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli ab-bonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodiciinclusi i prodotti librari e fonografici commercializ-zati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a ca-
© Laurus Robuffo

rattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuari-stica anche per il tramite di internet e dalla utilizza-zione delle opere cinematografiche nelle diverseforme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso società controlla-te o collegate, i cui ricavi nel settore delle comuni-cazioni elettroniche, come definito ai sensi dell’arti-colo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi com-plessivi di quel settore, non possono conseguire nelsistema integrato delle comunicazioni ricavi supe-riori al 10 per cento del sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano l’attività televisiva inambito nazionale attraverso più di una rete non pos-sono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire parte-cipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani opartecipare alla costituzione di nuove imprese edi-trici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anchealle imprese controllate, controllanti o collegate aisensi dell’articolo 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni do-minanti vietate dal presente testo unico nel sistemaintegrato delle comunicazioni, si considerano anchele partecipazioni al capitale acquisite o comunquepossedute per il tramite di società anche indiretta-mente controllate, di società fiduciarie o per inter-posta persona. Si considerano acquisite le partecipa-zioni che vengono ad appartenere ad un soggetto di-verso da quello cui appartenevano precedentementeanche in conseguenza o in connessione ad operazio-ni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d’a-zienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchétra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi formaconclusi, in ordine all’esercizio concertato del voto,o comunque alla gestione della società, diversi dallamera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è con-siderato come titolare della somma di azioni o quo-te detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo sus-siste, anche con riferimento a soggetti diversi dallesocietà, nei casi previsti dall’articolo 2359, commiprimo e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella formadell’influenza dominante, salvo prova contraria, al-lorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in basealla concertazione con altri soci, abbia la possibilitàdi esercitare la maggioranza dei voti dell’assembleaordinaria o di nominare o revocare la maggioranzadegli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di ca-rattere finanziario o organizzativo o economico ido-nei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;2) il coordinamento della gestione dell’impresa
con quella di altre imprese ai fini del perseguimentodi uno scopo comune;
3) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto aquelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli le-gittimati in base all’assetto proprietario di poterinella scelta degli amministratori e dei dirigenti delleimprese;
c) l’assoggettamento a direzione comune, chepuò risultare anche in base alle caratteristiche dellacomposizione degli organi amministrativi o per altrisignificativi e qualificati elementi.
16. L’Autorità vigila sull’andamento e sull’evolu-zione dei mercati relativi al sistema integrato dellecomunicazioni, rendendo pubblici con apposite rela-zioni annuali al Parlamento i risultati delle analisieffettuate, nonché pronunciandosi espressamentesulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente ar-ticolo.
TITOLO X
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
CAPO I
SANZIONI
Art. 51. Sanzioni di competenza dell’Autorità.1. L’Autorità applica, secondo le procedure stabilitecon proprio regolamento, le sanzioni per la violazio-ne degli obblighi in materia di programmazione,pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in partico-lare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle conces-sioni per la radiodiffusione televisiva privata su fre-quenze terrestri adottate dall’Autorità con proprioregolamento, ivi inclusi gli impegni relativi allaprogrammazione assunti con la domanda di conces-sione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusioneterrestre in tecnica digitale, approvato con deliberadell’Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai for-nitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsoriz-zazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1,lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Mini-stro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicem-bre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell’Autorità;
d) dall’articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti del-l’Autorità, relativamente alla registrazione dei pro-grammi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempi-mento all’obbligo di trasmissione dei messaggi dicomunicazione pubblica, di cui all’articolo 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di ser-vizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall’arti-colo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n.650;
© Laurus Robuffo

g) in materia di tutela della produzione audiovi-siva europea ed indipendente, dall’articolo 44 e dairegolamenti dell’Autorità;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi dimancata, incompleta o tardiva osservanza del relati-vo obbligo di cui all’articolo 32;
i) in materia dei divieti di cui all’articolo 4, com-ma 1, lettera b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del me-desimo programma su tutto il territorio per il qualeè rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all’articolo 29;n) in materia di obbligo di informativa all’Au-
torità riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed extracontabili, dall’articolo 1, comma 28, della legge 23dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell’Au-torità;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicità diamministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo41.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b),c), d) ed e), l’Autorità dispone i necessari accerta-menti e contesta gli addebiti agli interessati, asse-gnando un termine non superiore a quindici giorniper le giustificazioni. Trascorso tale termine o quan-do le giustificazioni risultino inadeguate l’Autoritàdiffida gli interessati a cessare dal comportamentoillegittimo entro un termine non superiore a quindi-ci giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamen-to illegittimo persista oltre il termine sopraindicato,l’Autorità delibera l’irrogazione della sanzione am-ministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inos-servanza delle disposizioni di cui al comma 1, lette-re a) e b);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inos-servanza delle disposizioni di cui al comma 1, lette-re c) e d);
c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inos-servanza delle disposizioni di cui al comma 1, lette-ra e).
3. L’Autorità, applicando le norme contenute nelCapo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,n. 689, delibera l’irrogazione della sanzione ammi-nistrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di vio-lazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di vio-lazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di viola-zione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l),m) e n);
d) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di viola-zione delle norme di cui al comma 1, lettera o).
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lette-re h), i) e l) del comma 1, l’Autorità dispone altresì,nei confronti dell’emittente o del fornitore di conte-
nuti, la sospensione dell’attività per un periodo dauno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o più rego-lamenti nei confronti degli esercenti della radiodif-fusione sonora e televisiva in ambito locale, le san-zioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ri-dotte ad un decimo e quelle previste dall’articolo 35,comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. L’Autorità applica le sanzioni per le violazionidi norme previste dal presente testo unico in materiadi minori, ai sensi dell’articolo 35.
7. L’Autorità è altresì competente ad applicare lesanzioni in materia di posizioni dominanti di cui al-l’articolo 43, nonché quelle di cui all’articolo 1,commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n.249.
8. L’Autorità verifica l’adempimento dei compitiassegnati alla concessionaria del servizio pubblicogenerale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni,applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall’ar-ticolo 48.
9. Se la violazione è di particolare gravità o reite-rata, l’Autorità può disporre nei confronti dell’emit-tente o del fornitore di contenuti la sospensione del-l’attività per un periodo non superiore a sei mesi,ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanzaagli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la re-voca della concessione o dell’autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni ammini-strative per le violazioni previste dal presente arti-colo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 52. Sanzioni di competenza del Ministero.1. Restano ferme e si applicano agli impianti di ra-diodiffusione sonora e televisiva le disposizioni san-zionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003,n. 259.
2. Il Ministero, con le modalità e secondo le pro-cedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, di-spone la revoca della concessione o dell’autorizza-zione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio del-le concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli23, comma 1, e 24, commi 1 e 2;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione adaltra procedura concorsuale, non seguita da autoriz-zazione alla prosecuzione in via provvisoria all’e-sercizio dell’impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei principi di cuiall’articolo 42, comma 1, o comunque in caso dimancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, ilMinistero dispone la revoca ovvero la riduzionedell’assegnazione. Tali misure sono adottate qualo-ra il soggetto interessato, avvisato dell’inizio delprocedimento ed invitato a regolarizzare la propriaattività di trasmissione non vi provvede nel termi-ne di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiun-zione.
© Laurus Robuffo

4. Il Ministero dispone la sospensione dell’eserci-zio nei casi e con le modalità di cui all’articolo 24,comma 3.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni ammini-strative per le violazioni previste dal presente arti-colo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53. Principio di specialità. 1. In considera-zione degli obiettivi di tutela del pluralismo e deglialtri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenen-do conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficacee la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adot-tare misure proporzionate agli obiettivi, di incorag-giare investimenti efficienti in materia di infrastrut-ture, promovendo innovazione, e di adottare misurerispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo deimercati emergenti, le disposizioni del presente testounico in materia di reti utilizzate per la diffusionecircolare dei programmi di cui all’articolo 1, comma2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono,ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legi-slativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate inmateria dal medesimo.
Art. 54. Abrogazioni. 1. Sono o restano abrogatele seguenti disposizioni:
a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli1, 2, 3, 4, 5 e 6;
b) del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo1999, n. 78:
1) all’articolo 2, il comma 2;2) all’articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5,
5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies;c) della legge 30 aprile 1998, n. 122:
1) all’articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10e 11;
2) gli articoli 3 e 3-bis;d) della legge 31 luglio 1997, n. 249:
1) all’articolo 1, il comma 24;2) l’articolo 2, ad eccezione del comma 6;3) all’articolo 3, i commi 1, 8, 11, limitatamen-
te ai primi cinque periodi, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e23;
4) l’articolo 3-bis;e) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre1996, n. 650, l’articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11, 12,13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24;
f) del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre1993, n. 422:
1) all’articolo 5, i commi 1 e 1-bis;
2) all’articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5;3) gli articoli 6-bis, 8 e 9;
g) del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-bre 1992, n. 482, l’articolo 1, commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies;
h) il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre1992, n. 483;
i) della legge 6 agosto 1990, n. 223:1) gli articoli 2,3 e 6 ad eccezione del comma
11, limitatamente al secondo periodo;2) all’articolo 7, i commi 2 e 5;3) l’articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18;4) gli articoli 10, 12, 13, 15;5) all’articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18,
19, 20 e 23;6) l’articolo 17;7) l’articolo 18, ad eccezione del comma 4;8) l’articolo 19;9) all’articolo 20, il comma 4;10) l’articolo 21;11) l’articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7;12) all’articolo 24, il comma 3;13) gli articoli 28, 29, 31 e 37;
l) della legge 14 aprile 1975, n. 103:1) l’articolo 22;2) all’articolo 38, il terzo e quarto comma;3) all’articolo 41, il primo e secondo comma;4) l’articolo 43-bis e 44.
Art. 55. Disposizioni finali e finanziarie. 1. Ledisposizioni normative statali vigenti alla data dientrata in vigore del presente testo unico nelle ma-terie appartenenti alla legislazione regionale conti-nuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alladata di entrata in vigore delle disposizioni regiona-li in materia.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposi-zioni contenute nel presente testo unico non posso-no essere abrogate, derogate, sospese o comunquemodificate, se non in modo esplicito mediante l’in-dicazione specifica delle fonti da abrogare, deroga-re, sospendere o modificare.
3. Le disposizioni contenute in regolamenti del-l’Autorità richiamate nel presente testo unico posso-no essere modificate con deliberazione dell’Auto-rità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da intendersicome formale e non recettizio.
4. Dall’attuazione del presente decreto non devo-no derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.
Art. 56. Entrata in vigore. 1. Il presente testo uni-co entra in vigore il giorno successivo a quello del-la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.
© Laurus Robuffo