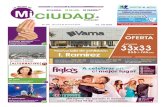5. 16012015 le chiesette di brenzone
-
Upload
luigi-perotti -
Category
Education
-
view
99 -
download
1
Transcript of 5. 16012015 le chiesette di brenzone
1
CONOSCERE IL BALDO – GARDA
I° CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI TURISTICI AMBIENTALI
5° INCONTRO: VENERDI’ 16 GENNAIO 2015
LE CHIESETTE DI BRENZONE
RELATORE: PROF. GIULIANO SALA
E’ un po’ restrittivo parlare semplicemente di “chiesette” perché stiamo parlando di
quattro chiese medioevali fra le quali abbiamo dei piccoli tesori sia dal punto di vista
architettonico e dal punto di vista pittorico, quindi sono una ricchezza del nostro
territorio, o sono stato qualche anno fa, invitato all’Ateneo di Salò a presentare un
libro di studi Gardesani del Garda Occidentale e ho preso tutta una serie di immagini
legate al culto dei Santi sul nostro territorio e sono rimasti stupiti i partecipanti della
parte Bresciana, della ricchezza che abbiamo ma soprattutto Brenzone, la pittura del
‘300 a Brenzone ha delle scansioni eccezionali. Noi partiamo dagli affreschi di San
Nicola ad Assenza, dall’Ultima Cena che è dalla fine del 1200 agli nizi del 1300,
abbiamo gli affreschi datati 1322, da lì passiamo poi al 1349 datati nella chiesa di
Sant’Antonio di Biasa al 1358 datati nella chiesa di San Pietro a Campo. Quindi
abbiamo una scansione anche cronologica eccezionale, perché non è che ci sono
molte date di riferimento su cui noi possiamo contare, quindi ritengo che
“chiesette” va a diminuire l’importanza del tema. Si tratta senz’altro di
un’espressione storica ed artistica del territorio molto importante. Ovviamente,
quando noi parliamo di queste chiese, parliamo di architettura, parliamo di pittura,
di date quindi di storia, perché non possiamo non inserire qualsiasi edificio nel suo
contesto storico, soprattutto se parliamo di chiese che hanno avuto una funzione
molto importante in quello che era il tessuto urbano del nostro territorio a partire
dall’Alto Medioevo.
Quindi io farei una piccola premessa di carattere storico a linee molto generali,
soprattutto per capirci un po’ con la terminologia, perché si parla di chiesa, si parla
di pieve, di cappella, oratorio, a volte vengono usati come sinonimi ma avrebbero un
loro significato ben preciso.
Per quanto riguarda la diffusione del Cristianesimo c’è una tradizione abbastanza
leggendaria che vuole che questo sia avvenuto intorno al IV° secolo in concomitanza
col vescovado di San Zeno a Verona che viene ricordato nel “Ritmo Pipiniano” (Vedi
2
allegato 1 e 2) come colui che convertì la città “qui reduxit Verona ad baptismum” e
San Vigilio per quanto riguarda la parte alta del Lago perché era Vescovo di Trento.
Ovviamente diciamo che la diffusione del Cristianesimo non fu un fatto immediato
né legato all’azione meritevole dei due santi Vescovi ma fu un fenomeno lungo
soprattutto nel territorio extra-urbano nel contado, nei “Pagus”, il termine
Paganesimo deriva proprio da Pagus che significa abitanti del villaggio, nel senso che
gli abitanti del villaggio furono gli ultimi a convertirsi al Cristianesimo, e anche
quando il Cristianesimo si diffuse nel nostro territorio grazie alla presenza di
mercanti, di ufficiali, di persone cristianizzate, grazie agli eremiti che cominciavano
ad abitare le alture del Baldo, famosi i Santi Benigno e Caro che avevano l’eremo
sopra Cassone, grazie agli altri monaci soprattutto quelli dei grandi Monasteri del
nostro territorio per esempio quello di San Zeno di Verona, quelli del Monastero di
San Colombano e di Bobbio che aveva una dipendenza a Bardolino, il Monastero di
Santa Cecilia di Brescia per quanto riguarda la parte bassa del lago. Quindi diciamo
che fu un fenomeno abbastanza lento nel tempo e chiaramente ci fu una serie di
contaminazioni di quelli che erano i riti e le credenze passate e la nuova religione. I
recenti studi sulla chiesa di San Zeno di Castelletto hanno rilevato che questa chiesa
esisteva già nell’Alto Medioevo e non è l’unica, ma lì c’è stata una campagna
archeologica che ha trovato dei dati certi sui quali poter ragionare. Penso poi alla
Chiesa di San Severo di Bardolino, quella è documentata nell’893, la Chiesa di san
Zeno non è documentata prima del XII secolo però la sua struttura ci fa capire che è
una Chiesa Alto Medioevale che nasce nei pressi di un’antica villa romana, lo stesso
di Bardolino e di San Zeno, una Chiesa che ha funzioni cimiteriali, ad uso della gente
che va ad insediarsi intorno a quello che erano i ruderi dell’antica villa romana e che
quindi con lo sviluppo dell’insediamento acquisisce anche una dignità di Chiesa con
“cure d’anime” dove viene mandato un sacerdote a celebrare la messa ed occuparsi
dei fedeli e questo coinciderà poi con lo sviluppo della chiesa e del suo incremento
che vedremo meglio quando parleremo nello specifico.
Quindi in questo periodo abbiamo già le nostre prime chiese nei nostri insediamenti,
cioè intorno all’VIII, IX secolo, forse anche prima e in questo periodo è anche ovvio
pensare ad una organizzazione del territorio della Diocesi di Verona da parte dei
vari Vescovi i quali dividono quello che è il territorio extra-urbano in circoscrizioni
chiamate Pievi.
3
Queste circoscrizioni possono essere più o meno ampie, facevano capo ad una
Chiesa Matrice, ad una chiesa importante la quale aveva un Arciprete, aveva dei
sacerdoti che vivevano in comunità e che erano alle dipendenze di questo arciprete,
la Chiesa Pievana o Pieve aveva all’interno un Fonte Battesimale, si amministravano
i Sacramenti, praticamente riproponeva nel territorio extra-urbano tutti i requisiti e
le competenze della cattedrale cittadina. Per quanto riguarda la situazione delle
Pievi nel territorio della sponda Orientale del Lago di Garda, abbiamo un documento
importante dell’anno 1145 che è una Bolla Pontificia di Papa Eugenio III, il quale si
rivolge al Vescovo Tebaldo di Verona e dice quale è la giurisdizione del Vescovo di
Verona. Per quanto riguarda il nostro territorio si fa menzione della Pieve di
Peschiera, quindi risalendo il Lago della Pieve di Lazise, quindi Cisano, poi Garda e
infine Malcesine. Si nota che quando si arriva sull’alto lago c’è una grossa dilatazione
per quanto riguarda la vicinanza di queste chiese plebane. Il territorio di Brenzone
era quindi soggetto alla Pieve di Malcesine, la Pieve di Garda arrivava grossomodo
fino a Pai e Albisano, da Castelletto in su si era già dipendenti della Pieve di
Malcesine. Ovviamente la Pieve di Malcesine di Santo Stefano era la Chiesa
principale e da lì partivano i vari sacerdoti a celebrare le messe nelle varie Cappelle,
ecco perché il termine Cappella, perché se pensate da Garda a Malcesine c’è un
ampio territorio e quindi non c’era una chiesa a Garda e una a Malcesine, ce n’erano
diverse, molte anche nel territorio di Brenzone, queste chiese sono chiamate
appunto Cappelle e in queste si andava solamente ad assistere alla celebrazione
della messa, non ci si accostava ai sacramenti, non c’era la Fonte Battesimale, per i
Sacramenti, per il Battesimo bisognava andare alla Chiesa Matrice, alla Pieve, però
comunque era garantita la celebrazione della messa; un po’ alla volta i vari
Cappellani, su richiesta delle popolazioni locali, finirono per stabilirsi presso questi
insediamenti e col tempo si arriva all’evolversi di Parrocchie autonome cioè da
Cappella dipendente dalla Pieve cominciano ad esserci le prime Chiese Parrocchiali.
La prima è la chiesa di San Giovanni Battista di Brenzone che è già parrocchiale nel
1460. Tornando al nostro territorio quindi la Pieve di riferimento è Malcesine e
abbiamo diverse cappelle sparse nel territorio soggette alla Pieve di Malcesine. C’è
un documento molto importante riportato anche dal Borsatti nel suo datato
“Malcesine” del 1929. Si parla di un documento nel quale il Pontefice Adriano IV
indirizza un documento all’arciprete pievano di Malcesine Manfredo nel quale
elenca diritti della sua Pieve. Vengono nominate delle Chiese: San Zeno che è
riconoscibile nella Chiesa di San Zeno di Castelletto, la Chiesa di San Nicola
riconoscibile con la Chiesa di Assenza, poi c’è una Chiesa di Sant’Angelo che non si è
4
mai riusciti finora ad identificare e poi c’è una formulazione che è stata spesso
equivocata che dice “Cappella Sancti Simeonis et Juda et Jovanni Evangelistae”,
secondo me è un’unica Chiesa. Nelle pubblicazioni passate spesso si è detto che le
Chiese erano 4 e si è identificato San Giovanni con la chiesa di Magugnano ma
questa è San Giovanni Battista e non San Giovanni Evangelista, ma la dicitura è
Cappella di Sant’Angelo, Cappella di San Zeno, Cappella di San Nicola e Cappella di
San Simone e Giuda e Giovanni Evangelista, per cui secondo me è una sola Chiesa
ma non so quale fosse. Se fosse da identificare nella Chiesa che si evolverà
Parrocchiale e che lo è nel 1460 dovremmo pensare a un mutamento di titolo
perché la Parrocchiale di Magugnano è intitolata a San Giovanni Battista, quindi
niente a che vedere con San Giovanni Evangelista.
Questo documento ci dà un’idea precisa della dislocazione delle chiese sul nostro
territorio.
Noi possiamo documentare l’esistenza di queste Chiese, anche attraverso i
documenti, come fatto di recente con un articolo sul “Gremal” dove ho potuto
dimostrare che anche a Campo esisteva una Chiesa fin dal XII secolo che
probabilmente è la chiesa che vediamo oggi ma completamente rifatta,
completamente ristrutturata nel 1300 quando ci fu anche l’intervento pittorico e
soprattutto nel 1700 quando venne rifatta completamente la facciata, però in un
documento si parla di un terreno e il riferimento è all’incrocio davanti alla Chiesa,
non c’è il titolo di questa Chiesa però, se noi guardiamo anche la posizione della
Chiesa di Campo adesso vediamo che c’è un incrocio davanti alla Chiesa, è un
quadrivio, infatti il termine che si legge sul documento “ad crucem” che io avevo
trascritto con la “C” grande intendendo come “alla Croce” come toponimo, poi,
parlando con il professor Vanarini dell’Università di Verona mi aveva detto che
secondo lui sarebbe stato meglio scriverlo con la “c” minuscola perché forse con
“croce” si intende il quadrivio quindi un nome comune e non tanto riferimento alla
presenza per esempio di una croce che dà poi il nome al toponimo.
Quindi abbiamo una presenza ricca, documentata sia dagli aspetti architettonici sia
dalle fonti storiche cartacee, pergamene e nei vari affreschi ecc.
Diciamo che nel XV Secolo, nel 1400, la prima ad evolversi a Parrocchiale sappiamo
che è la Chiesa di San Giovanni Battista e poi seguono via via tutte le altre fino a
raggiungere una situazione parrocchiale che è praticamente quella cha abbiamo
adesso. Naturalmente questa evoluzione nasce dall’esigenza della gente del posto
5
che voleva avere più garanzie nella cura d’anime, nella richiesta da parte di alcuni
parrocchiani che volevano avere una parrocchia ad esempio per i battesimi, nasceva
un bambino e magari non era in ottima salute, era scomodo dover fare riferimento
sempre alla chiesa pievale e quindi sono proprio le varie comunità che spesso e
volentieri richiedono la presenza di un cappellano fisso che viene chiamato rettore
e si impegnano anche a mantenerlo. Queste parrocchie vengono dette di “jus
patronatus”, nelle quali o la comunità locale o qualche benestante locale si impegna
a dotare il futuro parroco di un beneficio stabile, fisso, non in denaro ma in terreni,
questi terreni costituiscono un beneficio, poi i terreni vengono locati e garantiscono
ogni anno una rendita che serve a mantenere il sacerdote e in parte anche la chiesa
anche se il sacerdote riceverà sempre un contributo dalla vecchia pieve. Queste
sono parrocchie di “jus patronatus” perché chi mantiene il sacerdote ha il diritto di
proporlo nella nomina, nel senso che se la comunità ha il patronato è vacante la
parrocchia, si rivolge al Vescovo indicando dei nomi e il Vescovo di solito
acconsentiva. La nomina “collazione” naturalmente è vescovile, non è la comunità
che nomina il parroco, questo lo fa il Vescovo accogliendo però i suggerimenti della
gente del posto. Esistono anche parrocchie di “libera collazione” queste si formano
dalla frantumazione dell’antica pieve senza che nessuno intervenga
economicamente per creare un beneficio parrocchiale e in questo caso è il Vescovo
che nomina direttamente il sacerdote senza ascoltare nessuno.
Detto questo, comincerei a parlare delle chiese partendo appunto da San Zeno, in
ordine cronologico.
6
CHIESA DI SAN ZENO DE L’OSELET
FIG. 1 FIG. 2
FIG. 3
Che sia la più antica questo non lo si può dire, sappiamo però che è una chiesa
molto antica, lo sappiamo non tanto dai documenti che ce lo testimoniano
solamente a partire dal 1158 – 1159 ma dalla campagna di scavi che è stata fatta
FIG. 4
Questo disegno (Fig. 4) è stato ripreso da una pubblicazione della dottoressa
Brunella Bruno che ha condotto gli scavi sia presso la Villa Romana che presso la
Chiesa di San Zeno e ha messo in luce almeno tre fasi della Chiesa: la prima fase Alto
Medioevale e si vede chiaramente se si entra in chiesa, abbiamo una chiesa ad
un’unica navata, molto tozza con un’unica abside semicircolare, praticamente
7
uguale alla prima parte della Chiesa di San Severo di Bardolino, poi abbiamo un
ampliamento sempre in epoca Alto Medioevale, quindi prima dell’anno 1000 che
prevede un allungamento verso Ovest della Chiesa e l’erezione probabilmente di un
campanile sul lato Nord, il quadrato che si vede probabilmente è la fondazione del
primo campanile della Chiesa. Quindi presumibilmente intorno al XII Secolo c’è
l’ampliamento successivo che dà alla Chiesa l’aspetto architettonico che ancora oggi
vediamo: una Chiesa a due navate la cui suddivisione è data dalla successione si
settori di muro e di colonne con due absidi vere e proprie e con una piccola absidiola
laterale sulla destra che non corrisponde in realtà ad una navata. Probabilmente il
campanile è un inserimento un po’ tardivo, secondo me non è coevo. Entrando in
chiesa si vede l’abside semicircolare che era praticamente in prossimità di quella che
è l’absidiola laterale.
La facciata della Chiesa (Fig. 1 e 3) è stata rifatta in funzione dell’innalzamento della
torre campanaria. Questa torre campanaria è stata inserita nel corpo della chiesa
romanica e quindi la facciata che prima doveva essere a doppio spiovente è stata
modificata e anche lo spiovente di destra è stato abbattuto in parte e rialzato per
appoggiarsi al campanile mascherando un poco quella che era l’anomalia della
facciata della chiesa che si presentava praticamente menomata dal punto di vista
architettonico con l’inserimento appunto della torre campanaria, tra l’altro un
inserimento massiccio.
Sul lato posteriore della chiesa (fig. 2), il lato rivolto ad est dove vediamo le tre
absidi, in realtà l’abside maggiore è quella di centro poi vediamo l’abside
settentrionale che è in fondo alla navata mentre l’absidiola di sinistra è un po’ a sé
stante e probabilmente anche quella serviva ad ospitare un piccolo altare.
L’architettura romanica, di cui questa Chiesa ne è un bell’esempio, che è
fondamentalmente un’architettura sacra, ha delle caratteristiche come ogni arte
sacra, e queste sono:
è didascalica, vuol dare un insegnamento, un messaggio;
è simbolica, questo messaggio non è dato direttamente ma va interpretato. Un
esempio banale di uso della simbologia, quando vediamo l’aquila dipinta nell’abside,
non si voleva significare l’aquila come animale ma è un richiamo all’Evangelista
Giovanni;
8
è sostanzialmente un’arte povera, o meglio essenziale perché il concetto era che la
bellezza materiale non distraesse dalla bellezza dello spirito, questo detto in parole
molto semplici.
Aveva poi anche altre caratteristiche come:
la forma, è un’architettura solida, abbastanza robusta, contenuta, con l’uso di
colonne, di pilastri, con l’arco a tutto sesto, che è una delle caratteristiche
dell’architettura romanica;
l’orientamento della Chiesa, che è sempre, rigorosamente, con la facciata rivolta ad
Ovest in modo che l’abside coincida con l’Est i cui riferimenti simbolici sono evidenti:
l’Est indica il sorgere del sole e quindi chiaramente si fa sposare la posizione
dell’altare luogo sacro con il sorgere del sole quindi con la divinità e con il richiamo a
Gerusalemme con il Santo Sepolcro e tutto ciò che ne consegue, per non dire del
passaggio da Ovest a Est, il passaggio dal buio alla luce che simbolicamente è un
passaggio da una condizione di peccato alla redenzione.
La pianta stessa della chiesa sostanzialmente è data da una o più navate e
dall’abside che è semicircolare, quindi le figure geometriche sono il quadrato, per
estensione il rettangolo, e il cerchio. Nel linguaggio dei simboli il quadrato è un
simbolo terreno, materiale, umano, il cerchio è un simbolo del soprannaturale, del
divino ed ecco che la pianta della chiesa romanica è data dall’incontro del quadrato
con il cerchio quindi non raffigura altro che l’incontro dell’uomo con Dio all’interno
della chiesa.
Poi si evolverà in architetture più complesse, per esempio con le piante a croce, ma
già sostanzialmente anche nelle chiese più semplici, più povere, questi concetti
simbolici sono chiari e ripetuti fino alla nausea. Esempi: San Nicola ad Assenza, pur
essendo costruita già tardi perché adesso sappiamo quando è stata costruita questa
chiesa, che è una chiesa ancora in stile Romanico ma costruita nel 1349, cioè
quando il gotico era tardo, nelle città, da noi si costruiva ancora in stile Romanico.
Un esempio particolare è quello della Chiesa di San Michele di Gaium, che è
orientata con l’abside ad Est e quindi, quella che era la facciata era addossata alla
montagna, non si entrava da lì e infatti si entrava lateralmente o probabilmente
tramite una specie di struttura che faceva da scala dalla quale si scendeva e si
accedeva direttamente nella chiesa. Questo per spiegare questa aderenza alla
simbologia tipica dell’architettura Romanica anche nel nostro territorio.
9
Il lato della chiesa più antica, il lato meridionale, dove c’è una piccola monofora che
è originale della Chiesa nel periodo Alto Medioevale.
All’interno si vede la suddivisione in due navate tramite l’alternarsi di settori di muro
e colonne. Si può vedere che è stato rimosso il pavimento e sono emerse le
fondazioni dei vari interventi che la chiesa ha subito nel tempo. Si vede poi una
colonna che è un riuso di un capitello, datato al primo secolo dopo Cristo, più o
meno, chiaramente ripreso dalla Villa Romana che era lì a pochi metri, addirittura un
piccolo vano della Villa Romana è inglobato nella chiesa. Dall’abside maggiore
possiamo vedere che la chiesa era interamente decorata di affreschi, purtroppo
l’abside ha perso quasi completamente quello che era il motivo che l’adornava, nella
fascia inferiore abbiamo un velario dipinto, una successione di veli che fa un po’
quasi da cornice e nell’abside abbiamo una successione di apostoli, nella parte più
bassa mentre nella mandorla, all’interno nel catino absidale, abbiamo la figura del
Cristo Pantocratore o il Cristo Benedicente. Da dire che la Mandorla è un motivo
classico dell’arte Romanica e Bizantina che viene ripetuto appunto anche nella
pittura trecentesca, qui è raffigurata la liberazione divina, e di solito si trova al
centro in atteggiamento benedicente con il libro in mano, il libro della divinazione. Si
vede poi l’absidiola laterale di meridione dove è rimasto solo il velario. La parte più
interessante è l’abside che c’è in fondo alla navata di settentrione che raccoglie un
piccolo ciclo dedicato al Battista, di recente è stata fatta anche l’ipotesi che magari
questa cappella fosse adibita a fonte battesimale ma secondo me non è così perché
la fonte battesimale è rigorosa espressione della Pieve, non abbiamo chiese
battesimali che non siano state Pieve. Questo ciclo raffigurato è molto importante,
San Giovanni Battista è un Santo di culto soprattutto fra i Longobardi, è un Santo
Alto Medioevale, antico, pensiamo anche a Torri, all’antica Parrocchiale di Torri
intitolata a San Giovanni Battista, quella che c’è verso il cimitero, quindi era un culto
molto diffuso nel nostro territorio, un culto antico di origini Longobarde appunto
come San Michele e San Giorgio. Sulle pareti sono raffigurati alcuni momenti
importanti della vita del Battista, sulla parete di settentrione c’è un vecchio, c’è un
angelo che ha un cartiglio che mostra a questo vecchio Santo (ha l’aureola) la barba
bianca, una folla di persone che assiste a questo fatto, a questo avvenimento
eccezionale che è l’apparizione dell’angelo a Zaccaria che era vecchio, lui e la moglie
non potevano avere figli, e arriva l’angelo nel tempio, mentre il sacerdote si
apprestava a fare un sacrificio con l’incenso, e predice la nascita del figlio, Zaccaria
10
naturalmente rimane un po’ perplesso e dice “io sono vecchio e mia moglie lo
stesso, come faremo ad avere figli?” e viene punito, Zaccaria perde la parola.
C’è poi l’episodio che raffigura la nascita del Battista, è diviso in due sequenze, a
sinistra c’è il bambino nella culla, ci sono delle altre persone attorno quindi la
raffigurazione della nascita del Battista, sulla destra si vede lo stesso personaggio
che è Zaccaria, riconoscibile dall’aureola, dalla barba bianca, sta scrivendo su un
registro perché, sempre secondo il testo evangelico, quando chiedono che nome
dare a questo bambino, la moglie dice “lo chiameremo Giovanni” e i sacerdoti
chiedono “ma perché Giovanni che non c’è nessuno nelle vostre famiglie che si
chiama così?”, rimangono un po’ sorpresi, Zaccaria allora, che non può parlare
prende una penna e conferma, scrive “il suo nome è Giovanni” e quindi poi
riprenderà l’uso della parola. L’aderenza delle immagini è totale e uguale alle fonti
evangeliche.
Poi il Giovanni Battista ormai adulto compie la sua missione di profeta, di
anticipatore della venuta di Gesù e questa scena si riferisce alla predicazione del
Battista nel deserto, nel cartiglio si leggono solamente poche lettere ma
probabilmente si intuisce che il messaggio fa riferimento ad azioni dei penitenti
come si legge all’interno di quel cartiglio. Poi l’altro che chiude un po’ il cerchio,
l’epilogo dove abbiamo il Battista, se ci fossero equivoci c’è sopra la didascalia
Joannes, sopra l’aureola del santo, e viene decollato, viene il carnefice che taglia la
testa al Battista e quindi si è concluso il mini ciclo legato alla trasmissione
iconografica di San Giovanni Battista. Sono affreschi datati, è stato possibile farlo, in
passato si tendeva un po’ a postdatare questi affreschi, erano più le voci che li
attribuivano al XIII Secolo che non al XII, si parlava di dipinti del 1200, questo a causa
di accostamenti a volte impropri come quello degli affreschi di San Lorenzo di Tenno
dove c’è una decollazione che poi non è quella del Battista ma di San Romano e non
ha nulla a che vedere stilisticamente con questa e di recente l’esame dei caratteri
delle iscrizioni ha permesso ad uno studioso, Paolo Sartori, il quale confrontandoli
con altri, ha detto che queste iscrizioni sono della metà del XII Secolo. Quindi
affreschi del XII Secolo da mettersi in relazione con il Giudizio Universale della
Chiesa di Sant’Andrea di Sommacampagna, i caratteri che ci sono nei cartigli degli
angeli sono uguali, e secondo me, come ho detto di novità nel mio intervento sul
Gremal, li metto in riferimento con gli affreschi della Chiesa di San Fermo Maggiore,
la parte vecchia della chiesa, quella Benedettina, gli affreschi staccati (tolti e
11
conservati in altro luogo) dall’abside di destra, dove i personaggi hanno molto in
comune nelle fattezze come i caratteri dei carteggi.
Sulla navata maggiore è raffigurata l’offerta di Abele e di Caino. Abele sulla destra
che tiene in mano l’agnello mentre, molto stilizzato, Caino tiene un covone, Abele
era pastore, Caino era contadino quindi offre i frutti della sua terra.
La facciata, come spesso troviamo nelle chiese romaniche sopra l’ingresso c’è un
affresco in cui si vede il Cristo Benedicente, simbolo della vita e secondo me questo
è coevo agli affreschi dell’interno, sempre un affresco romanico, lungo l’extra dosso
in alto si vedono i resti di una croce gemmata mentre sulla sinistra c’è il frammento
di un volto e c’è un’iscrizione che si ricollega a “agnus dei” dove anche questi
caratteri sono uguali a quelli degli affreschi all’interno. C’è poi una pittura che
raffigura San Cristoforo con il Bambino che è sempre stata datata abbastanza
indietro nel tempo ma secondo me è del trecento, XIV Secolo. Si trova come nella
stragrande maggioranza delle chiese all’esterno, sui muri esterni, per il semplice
fatto che il Santo era invocato, nel Medioevo, contro quella che era chiamata “la
mala morte” cioè la morte cattiva, cioè la morte improvvisa, accidentale, perché non
dà il tempo per un pentimento, non si ha il tempo nemmeno di pensare a quello che
succede, muori e se la persona non è nella grazia di Dio, è in condizione di peccato
se ne va diritta all’Inferno. Un tempo credevano molto a questo e quindi una delle
paure era quella di morire nel peccato mortale con una morte accidentale, e difatti
abbiamo tanti Santi come San Cristoforo che sono dipinti sull’esterno perché anche
passando, nel caso di San Cristoforo, una persona potesse rivolgersi a lui, recitare
una preghiera, una devozione ed erano convinti che questo sarebbe bastato a
proteggerli nell’arco della giornata dalla morte accidentale. San Cristoforo è anche
invocato contro il dolore, contro la sofferenza fisica; nell’affresco che c’è nella
Chiesa della S.S. Trinità a Torri l Bambino tiene un cartiglio dove si dice che chi vede
la mano di San Cristoforo, questa mano è nemica del dolore, allontana il dolore
questo con una traduzione molto libera e quindi la sua raffigurazione era
diffusissima nel nostro territorio addirittura anche nelle abitazioni civili come
vediamo anche in Via Manzoni a Bardolino, sulla parete esterna di una casa molto
antica c’è ancora attualmente l’immagine di San Cristoforo.
12
CHIESA DI SAN NICOLA DI ASSENZA
FIG. 5 FIG. 6
FIG. 7 FIG. 8
Proseguendo in ordine cronologico andiamo ad Assenza. Sappiamo che la Chiesa di
San Nicola ad Assenza è documentata già dal 1159, ovviamente non aveva la
facciata che vediamo adesso in quanto ristrutturata in tempi molto più recenti in
stile Gotico per sposarla a quello che era stato l’ultimo intervento di ampliamento
della Chiesa. Comunque mantiene l’orientamento ad Ovest come appunto nelle
chiese Romaniche. Entrando si vede la zona Presbiteriale (Fig. 6) che è stata dovuta
ad un allungamento dell’originale Chiesa Romanica, l’abside era stato abbattuto e la
Chiesa è stata allungata in direzione Est, poi c’è stato un intervento più o meno
intorno al 1400 che ha allungato la Chiesa in direzione Ovest con gli “arconi Gotici”
che sono ben visibili e poi n linea con il campanile, dalla parte verso il lago, si è
aggiunto un altro corpo della Chiesa, quindi c’è stato un ampliamento ulteriore.
Gli affreschi dipinti sulle pareti risalgono all’ampliamento del 1300, esattamente al
1322 come anno di esecuzione. Sulla destra si vede la parete con un affresco tardo
quattrocentesco che richiama l’ampliamento della Chiesa anche laterale.
Per quanto riguarda gli affreschi abbiamo due momenti all’interno della Chiesa, sulla
parete settentrionale, a sinistra per chi entra, abbiamo quello che rimane di
13
un’Ultima Cena, c’è l’esposizione dei Santi, a tale riguardo ci si chiedeva chi fosse
uno dei Santi raffigurati, la soluzione è molto semplice n quanto si tratta di San
Bartolomeo essendo scritto Bertolomeo, anche se è vero che poi è scritto con la “a”
ma quello non è lo stesso affresco essendo del 1322 mentre questo dell’Ultima Cena
è antecedente. Ci sono altri affreschi risalenti a qualche decennio dopo, in alto si
vede l’iscrizione, si vede appunto al data 1322 ed è la raffigurazione di San Giovanni,
poi c’è una raffigurazione di San Martino nell’atto di donare il mantello al povero,
poi un’associazione di Santi fra i quali c’è Santo Stefano (figg. 7 e 8) al centro, poi
un’altra associazione con San Zeno al centro, San Giovanni a sinistra e a destra San
Bartolomeo. Per quanto riguarda San Bartolomeo, gli attributi che lo caratterizzano,
genericamente sono due: il coltello perché secondo la tradizione venne scuoiato e
l’abito a fiori o vesti con motivi floreali perché secondo la tradizione agiografica* San
Bartolomeo venne legato ai rami secchi di un albero e quando iniziò a subire il
martirio il suo sangue bagnò i rami e questi rami ripresero vigore e germogliarono i
fiori, questa è la tradizione leggendaria, non esiste nelle fonti canoniche però sta di
fatto che San Bartolomeo è sempre raffigurato con un abito che richiama motivi
floreali, oltre al coltello, addirittura in altre raffigurazioni ha la sua pelle scuoiata
sulla spalla.
Poi si vede San Zeno. C’è una raffigurazione di una Trinità al femminile con
Sant’Anna, la madre della Madonna, che è il personaggio con le dimensioni
maggiori, poi in basso la Madonna e in braccio alla Madonna c’è il Bambino, mentre
sulla destra abbiamo la raffigurazione della Crocifissione con il sole e con la luna che
sono caratteristiche simbolicamente stanno ad indicare la dignità della persona, poi
abbiamo un ultimo riquadro con i Santi monaci, il primo è San Caro, poi c’è San
Nicola e San Benigno e poi l’ultimo Santo è Sant’Antonio, San Bartolomeo e forse
ancora San Nicola, se non ci fosse il titolo sopra non si potrebbero riconoscere
perché non hanno attributi specifici.
Questi affreschi sono emersi dopo i restauri condotti da Erminio Signorini e anche
sulla parte meridionale della Chiesa sono emersi degli affreschi di cui in particolare
vediamo una bilancia con una testa che fa riferimento al passaggio di sinistra che è
San Michele Arcangelo che è colui che pesa le anime colui che accoglie le anime per
*agiogràfico agg. [der. di agiografia] (pl. m. -ci). – Che riguarda l'agiografia: ricerche,
leggende, tradizioni a.; scrittore a., autore di biografie di santi.
14
condurle al Cielo, è una figura importante è colui è a capo delle milizie celesti, è colui
che ha ucciso il drago, ma appunto è anche colui che pesa le anime e spesso viene
raffigurato con la bilancia, a fianco di San Michele Arcangelo abbiamo l’altro
Arcangelo, San Gabriele mentre la persona di lato è San Bartolomeo con ancora il
motivo vagamente floreale. Gli Arcangeli San Michele e San Gabriele sono anche
nella Canzone d’Orlando, nel passo della morte di Orlando, quando Orlando muore
lascia la sua anima a Dio e a prenderla vengono appunto i Santi Arcangeli Michele e
Gabriele che scendono e portano con sé l’anima nel Paradiso, questo appunto
secondo il testo della “Chanson de Roland”.
L’altra figura è Santa Lucia e sotto un frammento sempre della data 1322. Quello di
Santa Lucia è un culto molto diffuso nel Trecento nel nostro territorio, stranamente
dalla Sicilia arriva fin qua, anche la tradizione di portare doni ai bambini. Però c’è
stata una grande evoluzione nel culto di questa Santa Martire nel senso che è
diventata per antonomasia la protettrice della vista, dalle malattie degli occhi, in
realtà è stato un po’ un fraintendimento nel senso che il nome Lucia deriva da lux
cioè luce; i Romani davano questo nome a quelli che nascevano alla luce del giorno,
durante il giorno, Lucia o Lucio quindi significa “nato alla luce del giorno”. La luce
del giorno, nella prima età Cristiana diventa la luce della Fede, la luce della
Rivelazione, quindi è la luce interiore. Lucia quindi è la Martire che ha avuto la
rivelazione, la luce interiore, poi, in un periodo molto tardo, a partire dal Trecento
perché anche in questo caso non abbiamo gli occhi come attributo della Santa, a un
certo punto la tradizione vuole che Lucia si sia strappata da sola gli occhi e quindi
per questo viene evocata contro le malattie degli occhi e cominciano ad apparire
come attributo gli occhi sul piatto oppure gli occhi che tiene in mano ecc. e il dono ai
poveri, secondo Dino Coltro in un suo meraviglioso volume sui contadini veneti e i
Santi contadini ecc. diceva che questo deriverebbe da un’epidemia che accadde a
Verona intorno al Tredicesimo Secolo che colpiva soprattutto gli occhi e si dice che
appunto le madri avessero fatto un voto alla Santa perché proteggesse i bambini e
quindi che si fossero impegnate a dare dei doni e ciò spiegherebbe secondo lui la
tradizione di portare i doni nella ricorrenza di Santa Lucia, però c’è da dire che nella
tradizione agiografica di Santa Lucia lei, quando eredita dalla madre e si converte e
segue la sua via dona tutto ai poveri, quindi l’atto del dono è dovuto anche a questa
tradizione. C’è un’altra cosa significativa: le feste dei doni cadono tutte in dicembre
e al massimo a inizio gennaio, anche questo è un influsso di quello che c’era
15
antecedentemente con i miti pagani precristiani. Abbiamo Santa Lucia il 13
dicembre, il Bambinello il 25, l’Epifania il 6 Gennaio, e anche San Nicola per esempio
a Bardolino il 6 dicembre, San Nicola o Niccolò è un Santo tipicamente lacustre, è
evocato contro i pericoli dell’acqua, delle tempeste, l’abbiamo dappertutto, chiese e
immagini dedicate a questo Santo.
Altro affresco, chiaramente più tardo, intorno alla fine del Quattrocento, con la
raffigurazione della Madonna col Bambino, affiancata da Santa Caterina
d’Alessandria che la vediamo con la ruota e da San Lorenzo con la graticola. Santa
Caterina d’Alessandria è la Santa più raffigurata nel nostro territorio, è la Santa della
Buona Morte, è invocata per avere una Buona Morte, cioè la morte nella Grazia di
Dio, perché secondo la tradizione della passione di Santa Caterina, sembra che
durante il suo martirio abbia evocato Gesù chiedendo intercessione per tutti coloro
che si fossero ricordati di lei e Gesù avrebbe risposto alla Santa che sarà presente
nel momento della morte dei suoi fedeli, ecco perché viene invocata per la Buona
Morte, insieme alla Maddalena che vedremo raffigurata accanto perché la
tradizione ci dice che prima di morire venne confessata e quindi morì n Grazia di Dio
e andò direttamente verso il cielo e infatti la vediamo spesso raffigurata con due
angeli a fianco che la innalzano al cielo.
La Pala dell’altare, della seconda metà del Cinquecento dove c’è San Nicola,
Sant’Antonio Abate, La madonna col Bambino e il nome del Committente, che non si
riesce a leggere. Io avevo supposto che fosse un componente della Famiglia
Spolverini che hanno il Palazzo vicino, perché anche nella visita pastorale il Vescovo
si raccomanda a Spolverini perché venga eseguito il legato. Il pittore rimane ignoto
ma sembra appartenere alla Bottega dei Bisoffi. Pala sull’altare laterale,
settecentesca, dove è raffigurato San Francesco mentre riceve le stimmati.
16
CAMPO - CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI
FIG. 9
FIG. 10 FIG. 11
FIG. 12
La facciata (fig.9) è stata completamente rifatta nel Settecento e questo ha
comportato anche la perdita degli affreschi perché la Chiesa era interamente
affrescata, ora sono rimasti sulle pareti laterali, sull’altro lato mentre la facciata è
completamente spoglia. Lo stile è Romanico Campestre come anche a Biaza, quindi
con un’unica aula, l’abside semicircolare con l’orientamento sempre ad Ovest.
17
Entrando ci si rende subito conto di quanto la chiesa sia ricchissima: è un patrimonio
di affreschi enorme.
FIG. 13
Vediamo un po’ in particolare.
Si entra e si nota subito che la parte interna della facciata è rimasta spoglia per i
motivi detti prima.
Sulle due arcate abbiamo la figura di sinistra che è San Giacomo che è riconoscibile
dal bastone del pellegrino per cui Santiago de Compostela protettore dei pellegrini,
dopo l’immagine con San Giacomo abbiamo l’apparizione dell’Arcangelo Gabriele
che preannuncia alla Vergine la nascita del Bambino, la Vergine la vediamo dietro al
leggio con le mani in segno di sottomissione, c’è il raggio della colomba dello Spirito
Santo che si dirige verso il capo della Madonna e poi l cartiglio con il pavone che
ripete i passi evangelici, quindi abbiamo la scena dell’Annunciazione mentre sulla
parte estrema della spalla la raffigurazione di Sant’Antonio Abate, riconoscibile dal
mantello monacale e dal bastone col campanaccio attaccato. In mezzo abbiamo
l’immagine della Pietà, il Cristo che esce dal Sepolcro con in evidenza le piaghe della
Passione, questo è un tema che si ripete abbastanza spesso nel Trecento.
Nell’abside, in mandorla, abbiamo il Cristo che benedice, ai lati abbiamo le figure
dell’Apocalisse, cioè il Leone, l’Aquila in alto poi l’uomo alato o l’Angelo e poi quella
che doveva essere il Bue. Che poi queste figure che compaiono nel testo
Apocalittico. Queste figure che compaiono nel testo Apocalittico sono state
abbinate ai quattro Evangelisti quindi con Marco il Leone, Giovanni l’Aquila, Matteo
l’Angelo e Luca il Bue. Ai lati ci sono altre figure, sulla sinistra c’è la Madonna, a lato
18
si vede il frammento di un’altra testa che dovrebbe raffigurare San Giovanni
Battista. Anche questo è un tema riflessivo anche questo che viene chiamato in
gergo “desit” e praticamente non è altro che la raffigurazione del Cristo in mandorla
e della Vergine e di San Giovanni Battista che intercedono ai suoi piedi in favore
dell’Umanità, è un motivo abbastanza ricorrente nella pittura del Trecento.
Poi si vede la scritta che mi ha permesso, a suo tempo, di risalire all’autore perché
per fatalità conoscevo i pittori da un documento di Bardolino dove c’è Giacomo che
si firma come figlio di Federico e il documento era più tardo, quindi chiaramente si
tratta della Famiglia della Bottega dei Da Riva, originari di Riva col Maestro Federico
che si trasferisce nel nostro territorio e a Verona in seguito dell’acquisizione
dell’Alto Lago da parte della Signoria Scaligera, trovano ampia committenza nel
nostro territorio, pittori ai quali sono stati ricondotti anche altri affreschi, quelli di
Pai, quelli di San Nicola a Lazise, quelli della Chiesa di Sant’Apollinare in Prabi in
Trentino, nella Chiesa di Santa Lucia di Pescantina, quindi un pittore che dalla prima
apparizione a Campo si è un po’ irradiato e adesso è un nome noto fra gli studiosi
della pittura Veronese del Trecento.
In un altro riquadro si vede San Bartolomeo, ha il coltello e sulle spalle ha la pelle
che gli hanno levato, in mezzo c’è Cristo Crocifisso fra la Madonna e San Giovanni
Battista e poi c’è un Santo Vescovo. Ancora la raffigurazione San Bartolomeo sempre
sulla sinistra. San Bartolomeo era evocato soprattutto dai macellai, gente che aveva
a che fare con l’uccisione dei maiali, anche San Bortolo per esempio. Abbiamo una
prima raffigurazione di Santa Caterina d’Alessandria, Santa Lucia, quindi San
Giovanni Battista che tiene il cartiglio dove dice “io sono la voce di colui che grida
nel deserto”. Santa Caterina d’Alessandria è riconoscibile per la palma del martirio,
la palma è anche un segno di vittoria nell’arte classica, e la vittoria dei martiri è
quella del trionfo in nome di Dio sul suo stesso carnefice e quindi è un attributo del
martirio e nell’altra mano tiene il modellino di una ruota dentata che è lo strumento
con il quale la Santa ha subito il martirio.
Abbiamo poi un Santo Vescovo, un frammento di Madonna e un frammento di
iscrizione che mi ha permesso di poter datare, quello che si legge è una L, una X e
poi una L V e III e si vede il 58 in cifre romane naturalmente, che ovviamente
sottintende 1358, perché che sia una pittura del Trecento non ci sono dubbi.
Poi un’altra rappresentazione di un santo Vescovo che dovrebbe essere San
Bernardo, poi abbiamo San Pietro, poi abbiamo una Santa con una corona di fiori
19
che all’inizio avevo interpretato come Santa Dorotea ma ora da quello che si legge
non sembra che si possa associare l’iscrizione a Dorotea ma sembra Flora, io non ho
mai sentito parlare di Santa Flora nei nostri territori e non mi sembra che ci sia un
culto particolare riferito a lei, però è quello che si legge, io resto comunque del
parere che il motivo iconografico richiama sempre Santa Dorotea e anche quella è
una Santa invocata per la buona morte, poi ancora Santa Caterina d’Alessandria. I
Santi sono ripetuti perché sono riquadri votivi e quindi il committente diceva al
pittore quello che doveva rappresentare, anche perché questi affreschi sono
espressione di fede, di religione ma forse maggiormente di uno status symbol, è
come quando in chiesa si vedono i banchi con le targhette delle famiglie più
benestanti del paese che erano ovviamene alle prime file, quindi c’è anche una certa
esibizione di uno status sociale, facevano capire che loro potevano permettersi di
pagare un pittore che venisse a dipingere per loro. I nomi dei Committenti sono
scritti sotto, Pietro è naturalmente Petrus. Vediamo poi una rappresentazione di
Sant’Antonio Abate, in mezzo una delle rappresentazioni che cominciano a
diffondersi nel Trecento con la Madonna della Misericordia. Il Trecento è stato
considerato il Secolo crudele, il secolo difficile, il Secolo della grande Peste, quella
del 1348 e quindi nasce questo culto verso la Madonna che viene vista proprio come
la Madonna Ausiliatrice e difatti sotto le falde del suo mantello, in questa figura, si
raccoglie la comunità di Campo, quindi è la gente di Campo che si fa ritrarre sotto al
mantello confidando nella protezione della Vergine, della Madonna della
Misericordia. Ai lati vediamo ancora la raffigurazione di Santa Caterina d’Alessandria
e poi la Maddalena, i lunghi capelli biondi e i vasi degli unguenti, è uno dei suoi
attributi, a volte viene raffigurata con le mani in avanti, nel passo del Vangelo
quando vede Gesù che esce dal Sepolcro e le dice “non mi toccare” e la Maddalena
si ferma in questo gesto oppure come detto prima mentre gli angeli la sollevano
verso il Cielo. Poi vicino alla finestra l’immagine di San Pietro in carcere, quando
viene liberato; San Pietro in Vincoli significa San Pietro in catene.
20
BIAZA – CHIESA DI SANT’ANTONIO
FIG. 14
FIG. 15 FIG. 16
La Chiesa è stata dipinta nel 1322, lo stile è uguale a quello di San Pietro in Vincoli,
una unica navata e un’abside semicircolare e il campanile. Dopo i restauri sono
apparsi altri affreschi Trecenteschi che erano coperti dall’intonaco e sui quali era
stato sovrapposto un affresco di fine Quattrocento dovuto alla Famiglia Brenzoni, in
alto si vedono appunto gli affreschi del Trecento e sotto lo stemma dei Brenzoni.
C’è la raffigurazione dell’Ultima Cena dove, in particolare, si vede il momento
culminante, nell’immaginario Medioevale non è tanto l’atto in cui Gesù spezza il
pane e versa il vino, perché l’Ultima Cena è l’istituzione del Sacramento Eucaristico,
quindi dal punto di vista Liturgico Sacrale e per la Fede è quello il momento
fondamentale, ma tutti i dipinti si soffermano invece sul tradimento di Giuda, si
21
vede chiaramente la mano di Gesù che porge un boccone a Giuda che è raffigurato
dall’altra parte del tavolo, quindi già escluso dal gruppo degli Apostoli, questo
probabilmente perché siamo in un’Età in cui il tradimento viene visto come il reato
più grave, lo stesso Dante mette i traditori dei parenti in fondo all’Inferno. Ricordo
anche su una pergamena le due parti sottoscrivendosi dicono che chi non si fosse
tenuto fedele a quanto sottoscritto possa perire insieme a Giuda traditore tra le
fiamme dell’Inferno. Quindi questo aveva molto colpito l’immaginazione
Medioevale, poi anche in un Mondo che viveva ancora nel retaggio Feudale dove il
vincolo di sudditanza fra l Signore e il suo Vassallo era dato dalla fedeltà e quindi la
mancanza di fedeltà è uno dei misfatti più atroci. Anche nell’Ultima Cena prevale
quello che è un elemento della tradizione popolare ai danni dell’elemento Cristiano,
il tradimento di Giuda.
Si vede appunto Giuda e la mano di Gesù e appunto Giuda è dall’altra parte del
tavolo. Spesso n altri dipinti Giuda ha la borsa dei 30 Denari avuti per il tradimento.
In un altro riquadro vediamo la raffigurazione di San Giacomo, riconoscibile dal
bastone del pellegrino e San Bartolomeo sempre con l’attributo del coltello.
Vediamo poi l’iscrizione dove si legge che questa chiesa fu iniziata nell’anno 1322 di
mercoledì 22 aprile e quindi gli affreschi possono essere solamente di quell’anno o
dell’anno dopo.
La parte sottostante è un affresco che andava a ricoprire quello Trecentesco, dovuto
alla committenza della Famiglia Brenzoni e, proprio mentre preparavo le immagini
per questa serata mi sono accorto di una cosa abbastanza importante che non avevo
mai scritto, io ho sempre datato questo affresco intorno alla fine del Quattrocento
perché avevo trovato un documento, oltre all’aspetto stilistico c’è un testamento di
questo Adelaido che è datato 1503 e vuole essere sepolto nella Chiesa di
Sant’Antonio sotto il monumento funebre della sua famiglia, quindi il monumento
funebre era sotto questi affreschi, ma sulla cornice in alto si vede una data 1481
questa è la data che ha scritto l’artista sulla cornice dell’affresco Trecentesco,
questo significa che nel 1481 l’affresco dei Brenzoni non era ancora stato fatto
perché l’affresco va a ricoprire anche la cornice, adesso si vede perché è crollato,
quindi il fatto che nel 1481 venga scritta la data su questa cornice ci fa capire che
l’affresco della famiglia Brenzoni può essere stato fatto dopo il 1481 e prima del
1503 quindi abbiamo un lasso di tempo ben definito.
22
La pala dell’altare non ha grandi pretese, è una pala della fine del Settecento o primi
Ottocento e raffigura chiaramente il Santo Patrono quindi Sant’Antonio.
I termini per la comprensione del Romanico
Abside: parte semicircolare o poligonale della chiese posta in fondo alla navata maggiore o, talvolta, a quelle laterali Affresco: tecnica di pittura murale eseguita sull’intonaco fresco (infatti viene detto anche “a fresco”), in modo che i pigmenti colorati si leghino chimicamente all’intonaco in fase di asciugatura
Ambone: la tribuna o piattaforma rialzata usata per la lettura dei testi sacri e per la predicazione
Ambulacro: o deambulatorio, passaggio, interno ad una chiesa, che gira attorno all’abside
Antropomorfo: che ha sembianze umane Architrave: elemento posto orizzontalmente che chiude nella parte superiore un’apertura
Bassorilievo: decorazione scultorea in cui le figure emergono di poco in rilievo rispetto al piano di fondo Bifora: finestra divisa in due aperture grazie all’inserimento di una piccola colonna
Borghesia: Ceto medio cittadino, sorto nell’età comunale, che si posizionava ina fascia intermedia tra nobili e poveri
Campata: parte di costruzione architettonica delimitata da sostegni verticali (piedritti o colonne) Capitello: parte superiore della colonna, situata sopra al fusto, che funge da appoggio all'arco o all'architrave soprastante e riveste una grande importanza decorativa
Capriata: struttura tringolare, nelle chiese generalmente in legno, che ha la funzione di sorreggere il tetto
Cibòrio: edicola sostenuta da colonne che contiene un altare
Concio: blocco di pietra da costruzione, squadrato, solitamente usato per le pareti esterne
23
Contrafforti: sostegno in muratura, a sezione decrescente salendo verso l’alto, utilizzato in architettura per contrastare la notevole forza orizzontale di alcune murature Controfacciata: lato della facciata principale situato all’interno dell’edificio
Coro: parte dell'abside destinata ai cantori Cripta: ambiente ristretto situato al di sotto della navata di una chiesa, solitamente usato come luogo di sepoltura Croce greca: si dice di piante di chiese in cui la lunghezza del transetto è uguale a quella della navata
Croce latina: si dice di piante di chiese in cui la lunghezza della navata è maggiore rispetto a quella del transetto Cupola: copertura emisferica data dalla rotazione di una curva lungo un asse verticale Cuspide: caratteristica di una curva in cui la parte superiore risulta maggiormente acuta
Deambulatorio: o ambulacro, passaggio, interno ad una chiesa, che gira attorno all’abside
Feritoia: piccola apertura nello spessore murario, alta e stretta
Lanterna: parte terminale di una cupola, costituita da una specie di tiburio con finestre o aperture e copertura
Lesena: rilievo decorativo verticale di una parete muraria, a sezione semicircolare o rettangolare, solitamente ripetuto ritmicamente
Liberi comuni: tipo di governo medievale in cui il potere era assunto prima dalle famiglie più importanti poi dalle corporazioni artigiane Lingue volgari: lingua parlata dal popolo, in contrapposizione alla lingua latina che invece era utilizzata dai ceti colti
Loggia: galleria con arcate o pilastri posto nella parte superiore dell'edificio
24
Mandorla: motivo ornamentale, simile a una mandorla, che circonda la figura di Gesù, di Maria o dei santi
Matroneo: loggiato interno alla chiesa, situato al di sopra delle navate minori e affacciato sulla navata centrale; era riservato alle donne
Monofora: piccola finestra che si chiude, nella parte superiore, in forma semircolare
Nartèce: ambiente d’ingresso di una chiesa, in particolare di quelle paleocristiane, addossato all'esterno o immediatamente all'interno della facciata principale; era il luogo dove stavano i non-battezzati ed i penitenti, considerati non ancora degni di entrare nella casa di Dio
Navata: spazio interno di una chiesa delimitato da colonne o pilastri; le chiese possono essere a una o più navate, in cui la maggiore o centrale è quella che termina con l’abside maggiore
Neofita: detto di persona che si è recentemente convertito ad una specifica dottrina religiosa
Oculo: apertura a forma circolare
Opus sectile: mosaico composto da tessere di marmo e pietre tagliate in varie forme, disposte in
modo da creare disegni geometrici
Pala d'altare: dipinto di grandi dimensioni su tavola, tela o bassorilievo, raffigurante soggetti sacri, collocato sopra gli altari delle chiese
Paliotto: parte anteriore dell’altare che può essere costituito da diversi materiali Paramento: superficie di una struttura muraria
Parasta: pilastro di sostegno, dal profilo piatto, parzialmente sporgente dal filo di una parete
Polittico: pala d'altare divisa in più scomparti variamente decorati che sono dotati di una cerniera in modo da ruotare e potersi chiudere l'uno sugli altri
25
Presbiterio: ambiente della chiesa in cui è situato l’altare maggiore, a volte sopraelevato dal resto dell’edificio tramite alcuni gradini Prònao: portico anteriore di un edificio sacro Pròtiro: avancorpo che ripara l'entrata, solitamente formato da un arco sorretto da due colonne
Quadrilobato: detto di chiesa a pianta centrale con quattro semicerchi, rispettivamente uno per lato del quadrato
Quadriportico: portico costruito sui quattro lati di uno spazio quadrato, tipico dell’architettura paleocristiana e romanica
Rosone: grande finestra circolare, variamente decorata, presente in facciata
Scagliola: composto formato da stucco e pigmenti colorati che, lavorato, crea un materiale simile al marmo, usato come imitazione di quest’ultimo Semicolonna: elemento decorativo a sezione semicircolare addossato ad una parete Serizzo: varietà di granito
Strappo: metodologia usata nel restauro degli affreschi, in cui si separa lo strato di colore superficiale dal supporto originale per poi applicarlo su un altro supporto opportunamente preparato Strombatura: svasatura dei muro fatta in corrispondenza dell'apertura di una porta o di una finestra
Stucco: materiale costituito da un impasto di calce spenta, marmo, sabbia e altre componenti, usato per eseguire decorazioni in rilievo
Tiburio: copertura esterna della cupola
Timpano: parete di forma triangolare, liscia o decorata a rilievo, compresa tra la parte orizzontale sottostante ed i due lati obliqui che la concludono
26
Transetto: navata trasversale che interseca, solitamente all’altezza del presbiterio, la navata centrale; a seconda che sia lungo uguale o di meno rispetto alla navata centrale si parla di pianta a croce greca o latina Trifora: finestra divisa in tre aperture grazie all’inserimento di una piccola colonna
Vestibolo: vano di entrata di un edificio Volta: copertura curva di un ambiente
Zoomorfo: che ha sembianze di animale